- Ducea
dell'ammiraglio
H.
Nelson
CASTELLO
-
Il
complesso
denominato Ducea
Nelson,
si
trova
a
circa
13
chilometri
da
Bronte,
ubicato
su
un
terreno
pianeggiante
di
fondo
valle
sulla
riva
sinistra
del
torrente
Saraceno.
Comprende
l'ala
gentilizia,
un
tempo
residenza
dei
Nelson
(impropriamente
detta
il
Castello)
oggi
trasformata
in
Museo,
i
resti
dell’antica
abbazia
benedettina
dedicata
a
Maria
Santissima,
fatta
costruire
da
Guglielmo
II°
il
Buono,
la
chiesetta
di
Santa
Maria
di
Maniace
ed
un
grande
lussureggiante
parco.
Sorse
intorno
al 1173,
probabilmente
sulle
rovine
di
una
preesistente
costruzione
basiliana, per
volontà
della
Regina
Margherita,
per
durevole
memoria
della
battaglia
vinta
da
Giorgio
Maniace
contro
i
Saraceni.
Come
si
usava
all’epoca,
il
monastero
venne
dotato
di
castello
o
torre
difensiva.
Guglielmo
di
Blois
fu
il
primo
abate
del
monastero.
L’abbazia,
in
virtù
dei
privilegi
concessi,
aveva
rendite
ragguardevoli
e,
come
tutti
i
feudi,
contribuiva
alle
spese
della
Regia
Curia.
Molti
i
monaci,
e
di
diverso
Ordine,
che
lo
abitarono
nel
corso
dei
secoli.
Nei
secoli
successivi
alla
fondazione
conobbe
però
periodi
difficili:
venne
ridotta
in
uno
stato
miserevole
dai
"commedatari"
(l’ultimo
abate
"commendatario"
fu
il
cardinale
Rodrigo
Borgia,
il
futuro
papa
Alessandro
VI,
"di
nefanda
ed
infausta
memoria"),
ne
furono
dilapidati
i
patrimoni
e
lo
stato
malsano
dei
luoghi
accelerò
notevolmente
lo
spopolamento
delle
campagne
circostanti.
Alla
fine
del XV
secolo l’abbazia,
con
i
suoi
vasti
terreni,
divenne proprietà
dell'Ospedale
Grande
e
Nuovo
di
Palermo i
cui
rettori
dal
1491
al
1799
(quando
l'Abbazia
e
Bronte furono
donati
ad
Orazio
Nelson),
con
disinteresse,
ingordigia
e
un'incredibile
rapacità
condizionarono
per
secoli
la
vita
dei
brontesi generando
una
lite
che
si
trascinerà,
con
alterne
fortune
per
il
Comune,
fino
alla
metà
del
900.
Fra
le
migliaia
di
carte
e
documenti
dell'Archivio
storico
Nelson,
un
analitico
inventario
del
gennaio
del 1608 elencava
in
modo
minuzioso
i
beni
e
le
ricche
suppellettili
della
chiesa
di
Santa
Maria,
della
sacrestia,
della
"cocina"
e
della
dispensa
del
Monastero:
il
dormitorio
dei
monaci
era
costituito
da
sette
camere
con
due
letti
per
ognuno,
solo
una
ne
aveva
tre.
Il terremoto che
l’11
Gennaio
1693
colpì
la
Sicilia
Orientale, abbatté
anche
molte
parti
del
monastero. Il
sisma
colpì
specialmente
le
strutture
poste
ad
oriente
e
fece
rovinare
la
grande
torre
di
difesa
adiacente
l’abside
della
chiesa,
abbattendo
altre
parti
già
fatiscenti.
|
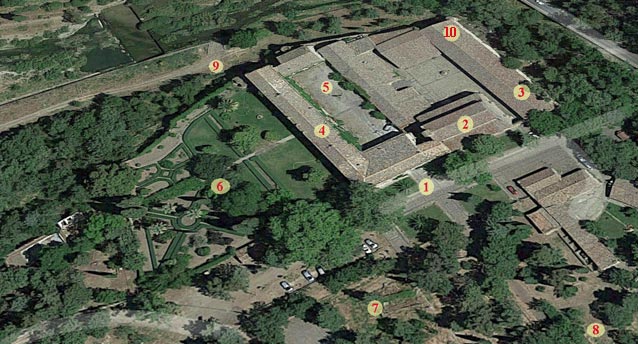
(1)
Ingresso;
(2) Chiesa
di
Santa
Maria;
(3)
Resti
dell'abside
della
chiesa;
(4) Museo
Nelson;
(5)
Croce
celtica
in
onore
di
H.
Nelson;
(6)
Giardino
inglese, voluto
da
Nelson;
(7)
Resti
del Borgo
Caracciolo;
(8)
Parco
esterno
con Museo
di
sculture
in
pietra
lavica;
(9)
Torrente
Saracena;
(10)
Antico
granaio
oggi
trasformato
in
sala
convegni.
|
I
padri
basiliani,
che
in
quel
periodo
reggevano
il
monastero,
furono
costretti
ad
abbandonarlo
ed
a
trasferirsi
a
Bronte
(ospitati
nella chiesa
di
San
Blandano,
con
la
facoltà
di
fabbricarvi
intorno
anche
un
piccolo
monastero).
Nei
nuovi
locali
i
monaci
benedettini
trasportarono
i
loro
oggetti
di
culto,
le
loro
reliquie
e
continuarono
a
chiamarsi
di
"Santa
Maria
di
Maniace"
(l’ultimo
loro
abate
fu
fra
Giacomo
Cimbali
nel
1900-1904).
Nel
1799
l'antica
Abbazia
di
Santa
Maria
di
Maniace fu
donata all’Ammiraglio
Horatio
Nelson da
Ferdinando
III
in
premio
della
soffocata
repubblica
partenopea.
 Oggi dell’antico
insediamento
benedettino
rimangono
il Castello
Nelson (con
il
relativo
Museo,
il
giardino
e
il
Parco), i
resti
della
vecchia
abbazia
e
la Chiesa
di
Santa
Maria
di
Maniace. Oggi dell’antico
insediamento
benedettino
rimangono
il Castello
Nelson (con
il
relativo
Museo,
il
giardino
e
il
Parco), i
resti
della
vecchia
abbazia
e
la Chiesa
di
Santa
Maria
di
Maniace.
Il
complesso
edilizio
è
diventato proprietà
del
Comune
di
Bronte
dal
4
Settembre
1981;
è
stato
recentemente
ristrutturato
ed
una
parte
adibita
a
museo
(gli
appartamenti
del
Duca)
e
come
centro
di
studi
e
di
congressi
(gli
antichi
granai).
Lo schema
planimetrico attuale
è
il
risultato
finale
dell’opera
di
insediamento
permanente
dei
Nelson,
succedutesi
dal
1799
al
1981.
La
ristrutturazione,
la
trasformazione
e
l'ampliamento
dell’antica
abbazia
furono
iniziate
già
da
Horatio
Nelson,
(ne
affidò
l'incarico
al
suo
primo
amministratore,
il
giardiniere Andrea
Graefer)
che
però
non
ebbe
il
tempo
né
la
fortuna
di
mettere
piedi
nei
possedimenti
siciliani
e
di
abitare
a
Bronte.
Morì
infatti
nell'ottobre
del
1805,
pochi
anni
dopo
l'ottenimento
del
titolo
di
Duca
di
Bronte.
I
suoi
eredi,
invece,
ed i
loro
vari
amminstratori,
abitavano
stabilmente
fino
a
pochi
decenni
fa
gli
appartamenti,
via
via trasformati
in
residenze
signorili, ora
destinati
a
Museo (la
prima
fu
Charlotte
Nelson-Bridport,
figlia
del
rev.
William
fratello
dell'Ammiraglio,
sposata
a
Samuel
Hood,
visconte
di
Bridport).
 Il
complesso
della
Ducea è
articolato
su
pianta
anulare
a
perimetro
quadrangolare
con
edifici
con
una
e
due
elevazioni,
allineati
lungo
i
fronti
perimetrali,
che
si
affacciano
sulla
campagna,
sul
lussureggiante
parco
e
sui
due
cortili
interni
a
pianta
rettangolare. Il
complesso
della
Ducea è
articolato
su
pianta
anulare
a
perimetro
quadrangolare
con
edifici
con
una
e
due
elevazioni,
allineati
lungo
i
fronti
perimetrali,
che
si
affacciano
sulla
campagna,
sul
lussureggiante
parco
e
sui
due
cortili
interni
a
pianta
rettangolare.
L’insieme
nella
sua
semplicità
ha
un
aspetto
maestoso.
Per
due
cancellate
si
accede
al
porticato
d’ingresso
e
quindi
ad
un
primo
cortile
dove
è
ubicata
la
croce
in
pietra
lavica
eretta
in
memoria
di
Orazio
Nelson.
Lateralmente,
a
destra,
si
accede
alla
interessante
chiesa
tardo-normanna
di
Santa
Maria
ed
al
cortile
quadrato
con
pozzo
in
pietra
lavica,
intorno
al
quale
originariamente
erano
raccolti
i
piccoli
laboratori,
i
magazzini,
le
stalle,
il
granaio.
Sulla
sinistra,
al
piano
sopraelevato,
erano
gli
appartamenti
signorili
dei
Nelson,
ora
adibiti
a
museo.
All’esterno del
complesso
sono
visibili
i
resti
di due
torrette facenti
parte
del
sistema
difensivo
dell’abbazia.
Un grande
parco,
che
si
estende
all'interno
e
all'esterno
per
circa
quattro
ettari,
arricchisce
il
Castello.
Con
accesso
dal
primo
cortile
è
possibile
visitare
il giardino
inglese,
voluto
dai
Nelson.
Si
estende
per
circa
cinquemila
metri
quadrati
ed
è
caratterizzato
dalla
presenza
di
secolari
piante
nostrane
ed
esotiche
(cipressi,
palme,
salici,
frassini,
ippocastani,
magnolie),
da
un
verde
prato
inglese
contornato
da
glicini,
rose
e
fiori
e
piante
varie.
I
giardini
sono
stati
ricreati
con
molta
cura,
con
un
formale
labirinto
e
una
vecchissima,
enorme
magnolia
che
è
certamente
l’orgoglio
del
luogo.
All'esterno,
di
fronte
all’ingresso
della
Ducea,
si
estende
un
lussureggiante parco,
diviso
da
un
viale
centrale
che,
in
mezzo
ai
maestosi
platani
e
agli
eucaliptos,
ospita
un museo
all’aperto
di
sculture
in
pietra
lavica con
opere
di
artisti
di
fama
mondiale.
Nel
parco
si
vedono
ancora
i
resti
del
borgo
contadino,
denominato
"Borgo
Caracciolo"
costruito
dal
1941
al
1944
dallo
stato
italiano
(la
Ducea
era
stata
sequestrata)
e
successivamente
demolito
nel
1964
dalle
ruspe
degli
eredi
Nelson.

Chiesa
di Santa
Maria
di
Maniace
La
Chiesa
di Santa
Maria
di
Maniace,
tipica
chiesa
basilicale,
è
inglobata
nelle
volumetrie
del
complesso
della
Ducea
Nelson.
Sorse
unitamente
all'Abbazia
benedettina
intorno
al 1173 sulle
rovine
di
una
preesistente
costruzione
basiliana, per
volontà
della
Regina
Margherita,
per
durevole
memoria
della
battaglia
vinta
da
Giorgio
Maniace
contro
i
Saraceni.
Come
si
usava
all’epoca,
l'abbazia
e
la
chiesa
vennero
dotati
di
castello
o
torre
difensiva.
Si
accede
alla
chiesa
da
un
piccolo
cortile
intercluso
fra
la
facciata
principale
e
la
porzione
porticata
della
Ducea.
Esternamente
è
visibile
soltanto
il
prospetto
sinistro
nella
parte
mediana
del
perimetro.
I
prospetti
laterali
sono
caratterizzati
da
finestre
ogivali
con
strombatura
modellata
in
laterizio
e
da
una
smensolatura
di
elementi
lavorati
in
pietra
lavica.
Sul
prospetto
posteriore
sono
visibili
gli
archi
ogivali
di
collegamento
con
le
parti
absidali.
La
chiesa
è
uno
splendido
esempio
di
architettura
normanna,
con
un prezioso
portale
in
calcare
e
tre
navate sorrette
da
poderosi
pilastri
in
pietra
lavica.
 All’interno
contiene
quadri
di
grande
valore,
tra
i
quali
un
trittico
gotico. All’interno
contiene
quadri
di
grande
valore,
tra
i
quali
un
trittico
gotico.
La
testimonianza
più
completa
di
come
dovesse
essere
la
chiesa
fino
al
secolo
XVII
è
di
Giovanni
Angelo
De
Cocchis
che
visitò
il
monastero
intorno
al 1741 e
riprese
alcune
testimonianze
fatte
da
altri
visitatori
nel
1579
prima
del
terribile
terremoto
del
1693.
Il
monastero
aveva
una
grande
torre
ad
oriente
attaccata
all’abside
della
chiesa.
All’interno
un
transetto
dava
origine
ad
un
grande
arco
al
centro
e
a
due
più
piccoli
in
corrispondenza
delle
due
navate
secondarie.
Il
devastante terremoto
del
1693 colpì
specialmente
la
struttura
del
monastero
posta
ad
oriente.
Fece
rovinare
la
grande
torre
di
difesa
attaccata
all’abside
della
chiesa
e
l’abside
stessa
(le
cui
fondamenta
sono
oggi
visibili,
portati
alla
luce
dagli
scavi
effettuati
all’interno
del
granaio).
Dal
1693
fino
ai
primi
anni
dell’ottocento,
quando
fu
ristrutturata
e
profondamente
trasformata
dagli
eredi
di
Nelson,
la
chiesa
rimase
allo
stato
di
rovina.
Degno
di
essere
definito
monumento
nazionale,
il
portale
di
Santa
Maria
è
opera
di
grande
valore
artistico
risalente
probabilmente
ai
primi
anni
della
fondazione
dell’abbazia.
La
volumetria
rientrata
ogivale
segue
la
nervosa
modulazione
dei
piedritti
su
cui
è
impostata.
La
cornice
è
adornata
di
vari
condoni,
grossi
e
piccoli,
vagamente
sagomati
e
sporgenti.
Tre
delle
modanature
centrali
riproducono
grosse
gomene
marine.
Due
gruppi
di colonnine
laterali lisce
e
rotonde,
costruite
con
pietra
arenaria,
marmo
e
granito,
sorreggono
il
grande
arco.
I capitelli che
raccordano
la
struttura
hanno
un
modulo
stilistico
che
rimanda
ad
analoghe
opere
eseguite
a
Monreale,
sede
della
giurisdizione
vescovile.
Le
figure
scolpite
sono
piccole
cariatidi
poggianti
su
splendidi
catini
ornati
di
foglie
d’acanto
lavorate
a
ricamo.
Raffigurano
scene
della
creazione
del
mondo,
ma
anche
scene
la
cui
interpretazione
rimane
molto
misteriosa
(come
i
corpi
di
donna
intrecciati
con
esseri
mostruosi),
malgrado
la
precisa
descrizione
che
ne
fece
lo
storico
brontese
Benedetto
Radice
nelle
sue Memorie
storiche
di
Bronte.
Sculture
simili
si
ritrovano
nelle
chiese
e
nei
monasteri
benedettini
sorti
nel
XII
secolo
in
Sicilia.
Sono
in
modo
particolare
le inquietanti
figure
rappresentate
nei capitelli
di
sinistra (per
chi
guarda)
a
porre
l’interrogativo
del
significato
complessivo
di
questa
rappresentazione
scultorea.
Ispirate
ai
"bestiari"
medievali le
figure
descrivono
esseri
mostruosi,
deformi,
forse
simboli
dei
vizi
del
genere
umano.
Narrano storie
di
lussuria viste
attraverso
l’intreccio
del
corpo
femminile
con
satiri,
dal
ventre
gonfio
e
dalle
zampe
pelose
di
grifo,
e
con
serpenti
avvolti
alle
membra.
Scene
disperate
di
dannati
e
scene
raccapriccianti
di
corpi
e
volti
deformi
e
d’ogni
altra
mostruosità
fisica.
 
Le
figure
di capitelli
di
destra,
simbolicamente
composte,
narrano
invece
le
vicende
del
genere
umano
a
partire
dalla
cacciata
dal
Paradiso
Terrestre
e
dall’uccisione
di
Abele.
Ogni
capitello
svolge
un
tema
diverso:
il
lavoro
dei
campi,
la
caccia,
la
guerra.
Mentre
i
capitelli
di
destra
raccontano,
quelli
di
sinistra
ne
sono
la
logica
contraddizione,
la
negazione
di
qualsiasi
narrazione
e
della
Storia
stessa,
l’allegoria
del
genere
umano
travolto
dalle
tentazioni
e
dal
peccato.
Così
lo
storico
B.
Radice
descrive
il
portale
nelle
sue Memorie
storiche
di
Bronte: «Mirabile
è
il
portale
della
chiesa
il
cui
arco
a
sesto
acuto
adorno
di
vari
cordoni
grossi
e
piccini,
sporgenti
nella
cornice
ogivale,
è
sorretto
da
dieci
colonnine:
cinque
per
ogni
lato,
delle
quali
tre
di
marmo
e
una
di
porfido,
e
le
altre
di
pietra
arenaria
giallognola,
di
media
grossezza.
 Le
colonne
non
sono
né
scanalate,
né
a
spirale,
ma
lisce
e
rotonde.
Le
basi
delle
colonne
sono
tagliate
e
modellate
e
somigliano
allo
stile
di
transizione
in
Inghilterra.
Tre
delle
modanature,
ora
sfaldate,
riproducono
la
gomena
normanna. Le
colonne
non
sono
né
scanalate,
né
a
spirale,
ma
lisce
e
rotonde.
Le
basi
delle
colonne
sono
tagliate
e
modellate
e
somigliano
allo
stile
di
transizione
in
Inghilterra.
Tre
delle
modanature,
ora
sfaldate,
riproducono
la
gomena
normanna.
Bellissimi
e
variati
i
capitelli
di
carattere
nordico,
o
meglio
romanico
dei
neo-campani,
la
cui
cimasa,
ornata
di
foglie
di
acanto
e
di
figure,
ricorda
alcuni
dei
più
vecchi
capitelli
delle
colonne
del
sontuoso
chiostro
di
S.
Maria
Nova
in
Monreale.
Nei
capitelli,
a
sinistra
dello
spettatore,
sono
scolpite
figure
di
uomini,
di
animali,
di
uccelli
con
volti
di
scimmia,
un
serpente
che
si
attorciglia
e
snoda
e
morde
la
bocca
a
un
mascherone:
sono
piccole
cariatidi
che
sostengono
l’arco
ogivale.
Le
foglie
dei
cinque
capitelli
delle
colonne
di
destra
sono
un
lavoro
di
fine
ricamo.
Una
figura
di
donna,
fra
due
uccelli,
è
riprodotta
nei
primi
due
capitelli.
Negli
altri
è
rappresentata
la
prima
storia
umana:
l’angelo
espelle
Adamo
ed
Eva
dal
paradiso
terrestre.
Il
lavoro
è
simboleggiato
da
una
filatrice,
da
uno
zappatore
e
da
due
opere,
che
abbicano
covoni
di
grano.
 Nel
capitello
centrale
è
scolpita
la
seminagione:
un
uomo
sparge
la
semente,
un
altro
colla
zappa
la
copre
e
spiana
le
porche. Nel
capitello
centrale
è
scolpita
la
seminagione:
un
uomo
sparge
la
semente,
un
altro
colla
zappa
la
copre
e
spiana
le
porche.
Nei
due
seguenti
capitelli
abbinati
è
la
caccia,
figurata
da
uno
che
suona
il
corno,
da
un
cinghiale
atterrato,
mentre
un
altro
cinghiale
salta
addosso
a
una
donna.
Due
guerrieri
imbraccianti
lo
scudo,
scolpiti
nell’ultimo
capitello,
simboleggiano
la
guerra,
l’eterna
guerra
del
genere
umano.
L’insieme
delle
sagome,
delle
cimase,
della
cornice
ogivale,
con
i
capitelli
variamente
scolpiti,
dà
un
aspetto
solenne
al
nordico
portale
e
alla
facciata.
Reputo
essere
l’opera
della
fine
del
secolo
XII,
coeva
del
famoso
tempio
e
chiostro
di
Monreale.»
Questa
l'interpretazione
che
delle
figure
scolpite
nei
capitelli
del
portale
dava
nel
1923
B.
Radice.
Ma
il
Radice
era
uno
storico
e
certamente
non
un
esperto
d'arte
medievale.
Nella
descrizione
andò
incontro
quindi
a
qualche
inesattezza.
L’interno
della
chiesa
di
Santa
Maria
di
Maniace,
illuminato
da
otto
finestre
ad
arco
poste
sopra
i
colonnati
è
molto
austero
e
seducente
anche
se
senza
il
coro
e
l'abside
crollati
nel
terremoto
del
1693
la
chiesa
sembra
strozzata.
Risultano
evidenti
le
affinità
spaziali
di
Santa
Maria
di
Maniace
con
la
cattedrale
di
Cefalù,
eretta
dal
1131
al
1148,
e
con
il
contemporaneo
Duomo
di
Monreale.
E'
nell'anno
1173
che
il
re
Guglielmo
e
la
sua
sposa
Margherita
determinano
di
costruire
in
Maniace
una
grande
chiesa
intitolata
a
S.
Maria
ed
un
annesso
Monastero
benedettino.
Un
anno
dopo,
nel
1174,
lo
stesso
re
consacrava
il
Chiostro
di
Monreale,
anch’esso,
dell’ordine
benedettino;
Bronte
e
Maniace
all'epoca
appartenevano
alla
stessa
diocesi
dell’Arcivescovo
di
Monreale.
Santa
Maria
di
Maniace
si
presenta
a tre
navate con
soffitto
in
legno
a
capriate,
con
archi
a
sesto
acuto
in
pietra
bianca,
poggianti
su otto poderose
colonne
in
pietra
lavica
esagonali
e
rotonde,
alternativamente,
tutte
sormontate
da
capitelli
dorici.
 La
copertura
in
legname
è
sostenuta
da
cavalletti,
correnti
e
travi.
È
discretamente
conservata
ed
è
stata
restaurata
nel
nell'aprile
del
1862. La
copertura
in
legname
è
sostenuta
da
cavalletti,
correnti
e
travi.
È
discretamente
conservata
ed
è
stata
restaurata
nel
nell'aprile
del
1862.
Sulla
parete
della
navata
destra
spiccano tre
tombe
in
marmo:
sono
di
Samuel
Grisley,
di
Filippo
Thovez
(commissario
della
marineria
inglese
e
governatore
generale
della
ducea)
con
la
moglie
Marianna
e
di
Rosaria
Fragalà,
moglie
di
Guglielmo
Thovez,
altro
amministratore.
Nella
chiesa,
sotto
l'altare
maggiore,
sono
conservati
anche
i
resti
del
primo
abate,
il
Beato
Gugliemo,
fratello
di
Pierre
du
Blois
di
Londra
nei
tempi
di
Re
Stefano.
In
fondo
alla
navata
principale
su
una
piatta
parete
troneggia
l'altare
maggiore
sopra
il
quale
sono
poste
prestigiose
opere
d'arte
d'antica
fattura.
Anche
se
ricca
d’opere
di
straordinaria
bellezza
ed
attrazione,
la
chiesa,
così
come
si
presenta,
senza
abside
e
il
coro,
sembra
però
tronca,
priva
di
profondità.
Recenti scavi
archeologici stanno
però
dando
risposta
esauriente
circa
la
forma
originaria:
è
stata
infatti
recuperata
la
parte
basamentale
di
tre
strutture
murarie
semicircolari
di
notevole
spessore
distanziate
fra
loro
come
quelle
esistenti.
Costituiscono
senza
dubbio
la
fondazione
di tre
absidi di
cui
i
grandi
archi
di
accesso
sono
ben
visibili
sulla
parte
posteriore
della
chiesa.
Gli
scavi
sono
visibili
all’interno
del
vecchio
granaio
del
Duca
(oggi
trasformato
dal
Comune
di
Bronte
in
un
grande
salone
con
un’unica
copertura
lignea
sostenuta
da
"capriate
composte
alla
palladiana"
ed
adibito
a
Centro
Congressi).
Sull’altare
maggiore sotto
un
trittico
del
XIV
secolo,
all'interno
di
una
preziosa
cornice
in
legno
scolpito,
si
trova
una
splendida
icona
di Madonna nell'atto
che
allatta
il
Bambino
(Santa
Maria
di
Maniace,
XII
sec.).
  La
tradizione
l'attribuisce
a
San
Luca
e
racconta
che
sia
stata
lasciata
sul
posto
dal
generale
bizantino
Giorgio
Maniace
in
ricordo
della
vittoriosa
battaglia
contro
gli
Arabi
(1040). La
tradizione
l'attribuisce
a
San
Luca
e
racconta
che
sia
stata
lasciata
sul
posto
dal
generale
bizantino
Giorgio
Maniace
in
ricordo
della
vittoriosa
battaglia
contro
gli
Arabi
(1040).
L’icona
della
vergine che
allatta
il
bambino
è
un
prezioso
dipinto
di
classica
bellezza
e
si
caratterizza
per
l’inequivocabile
presenza
di
canoni
figurativi
bizantini,
come
la
posizione
dei
corpi,
il
brillante
e
piatto
fondo
oro,
le
mani
lunghe
e
affusolate
della
Vergine,
il
drappo
rosso
che
avvolge
il
Bambino
e
le
sigle
in
lettere
greche.
Ma
in
questa
opera,
alle
figure
prive
di
volume
della
più
classica
tradizione
figurativa
bizantina,
si
sostituisce
un
uso
della
luce
tale
da
rendere
inconsueta
pienezza
e
corposità
ai
volti
e
morbide
ondulazioni
ai
panneggi.
Gli
schemi
iconografici
sono
rinnovati
dalla
diversa
maniera
pittorica
che
in
volto
usa
il
colore
con
profondi
contrasti
e
dure
lumeggiature,
con
figure
piene,
solenni,
cariche
di
serena
umanità
ed
una
sapiente
costruzione
del
disegno.
La
figura
acquista
la
sua
corposità
pittorica
sul
lucente
brillare
del
fondo
d’oro.
Il
velo
racchiude
il
piccolo
volto
con
il
panneggio
ritmato;
le
mani
esili
e
bellissime
sorreggono
il
lattante
privo
di
peso
avvolto
nel
fitto
intreccio
della
veste.
Nel
contesto
estremamente
composito
della
cultura
siciliana
del
XII
e
XIII
secolo,
quest’opera
assume
una
importanza
particolare
in
quanto
documenta
la
vitalità
e
la
viva
presenza
dei
canoni
figurativi
bizantini
nel
campo
della
pittura,
proprio
in
quella
fase
di
transizione
artistica
che
perdurerà
fino
alle
soglie
del
rinascimento
nell’opera
di
artisti
locali.
Il
trittico,
del
XIV
secolo,
dipinto
su
tavola in
stile
gotico, è
posto
sull’altare
maggiore
sopra
l'icona
di
santa
Maria.
Raffigura
al
centro
la
Madonna
in
trono
che
allatta
il
Bambino
e
sui
pannelli
laterali
i
padri
del
monachesimo
occidentale
ed
orientale: a
sinistra San
Benedetto in
cocolla,
piviale,
mitra
pastorale
e
libro
delle
(con
l'iscrizione Sanctus
Benedictus)
regole
nella
mano
sinistra;
a
destra,
è
raffigurato San
Basilio (per
il
Radice
trattasi
di
S.
Antonio
abate)
in
abito
monacale
con
cappuccio
da
cenobita
e
pastorale
a Tau e
un
libro
in
mano.
Nel
triangolo
superiore,
in
alto
nel
fastigio
centrale
è
la
crocifissione
di
Cristo,
con
la
Vergine
e
San
Giovanni
ai
piedi
della
croce.
 Nelle
lunette
laterali
è
rappresentato
(a
sinistra)
in
abiti
pontificali
alla
maniera
greca
un
vescovo,
con
pastorale
e
libro
(San
Nicola)
e,
a
destra,
un
guerriero
con
corazza,
scudo
crociato
e
lancia
(San
Giorgio
o
Guglielmo
II,
il
Buono). Nelle
lunette
laterali
è
rappresentato
(a
sinistra)
in
abiti
pontificali
alla
maniera
greca
un
vescovo,
con
pastorale
e
libro
(San
Nicola)
e,
a
destra,
un
guerriero
con
corazza,
scudo
crociato
e
lancia
(San
Giorgio
o
Guglielmo
II,
il
Buono).
Le
figure
dei
pannelli
spiccano
su
fondi
dorati
e
dimostrano
tratti
realisticamente
umani,
pur
conservando
una
forte
carica
simbolica.
Evidenti
analogie
stilistiche
e
compositiva
suggeriscono
l’ipotesti,
che
anche
la
pala
posta
sulla
navata
di
sinistra,
raffigurante
Santa
Lucia
con
gli
attributi
del
suo
martirio,
e
nelle
lunetta
l’Arcangelo
Gabriele,
appartenesse
al
polittico
dell’altare
maggiore.
La pala
a
forma
piramidale (del XI secolo),
facente
parte
originariamente
di
una
composizione
a
più
sezioni
dipinte
su
tavola,
rappresenta Santa
Lucia con
gli
attributi
del
suo
martirio
e,
nella
parte
triangolare
in
alto,
l’arcangelo
Gabriele con
in
mano
un
nastro
portante
il
saluto Ave
gratia
plena ed
alcune
lettere
dal
significato
indecifrabile
(I.S.A.Q.H.Th.H.).
L’immagine
della
Santa,
delimitata
in
alto
da
una
cornice
tribolata,
risalta
sul
fondo
d’oro
brillante.
La
figura
eretta,
variamente
mossa
da
un
voluminoso
manto
che
l’avvolge
fino
ai
piedi,
prende
fisicità
e
forza
nei
tratti
umani
e
ben
modellati
del
volto.
Il
dipinto,
indicato
di
scuola
bizantina,
sembra
eseguito
con
una
certa
autonomia
artistica,
specie
nell’uso
del
colore:
infatti,
un’alta
carica
vitale
ed
un
marcato
spessore
umano
modificano
qui
gli
schemi
compositivi
ed
i
modelli
iconografici
tradizionali.
Evidenti
analogie
stilistiche
e
compositive
suggeriscono
l'ipotesi
che
anche
questa
pala
appartenesse
al
polittico
dell'altare
maggiore.
Sulla
parete
di
fondo,
ai
lati
dell'altare,
si
trovano due
piccole
sculture in
marmo
bianco:
sono
il
gruppo
dell’Annunciazione
ed
i
frammenti
dell’originario
altare
maggiore,
costituiti
dal
paliotto
con
al
centro
l’Agnus
Dei
e
dal
leggio,
decorati
a
racemi.
Pregevole
esempio
di
sculture
romaniche
del XII secolo,
lavorate
a
bassorilievo,
le
due
statue
rappresentano
l’Angelo
Gabriele con
un
giglio
in
mano
e
la Vergine
Annunziata.
Nelle
ali
dell'angelo,
ma
specialmente
nel
volto
della
Vergine
e
nel
rigore
geometrico
della
sua
veste,
che
annulla
qualsiasi
senso
di
fisicità,
accentuando
la
carica
simbolica,
si
individuano
tratti
stilistici
e
figurativi
tipici
dell'arte
medievale
europea.
Il
corpo
della
Vergine,
senza
alcun
accenno
di
fisicità
sotto
la
veste
che
cade
giù
dritta,
perde
ogni
importanza,
annullato
nel
simbolo
che
rappresenta.
Sull’altare
della
navata
destra
è
posto
il
dipinto
della Vergine
della
Seggiola,
su
tavola
di
cm.
80x100
(probabilmente
del
XV
secolo).
Rappresenta
la
Vergine
Maria
seduta
con
il
Bambino
in
braccio,
ambedue
in
posizione
dritta
con
lo
sguardo
in
avanti.
In
alto
due
angeli
che
rimuovono
una
cortina.
 Le
figure
ben
disegnate
hanno
nel
portamento
solenne
ed
austero
i
segni
della
divina
natura.
I
volti
permeati
di
grande
serenità
risaltano
sul
disegno
essenziale
delle
vesti
avvolte
nei
colori
scuri
molto
accentuati.
Il
portamento
solenne
delle
due
figure
e
la
composizione
assiale,
che
ne
accentua
la
verticalità,
sottolineano
una
dimensione
spirituale,
contraddetta
dall’umanità
dei
volti. Le
figure
ben
disegnate
hanno
nel
portamento
solenne
ed
austero
i
segni
della
divina
natura.
I
volti
permeati
di
grande
serenità
risaltano
sul
disegno
essenziale
delle
vesti
avvolte
nei
colori
scuri
molto
accentuati.
Il
portamento
solenne
delle
due
figure
e
la
composizione
assiale,
che
ne
accentua
la
verticalità,
sottolineano
una
dimensione
spirituale,
contraddetta
dall’umanità
dei
volti.
Un
altro
dipinto,
probabilmente
del
sec.
XVI,
ma
che
richiama
la
scuola
raffaellesca,
rappresenta
una
Madonna
con
Bambino.
Il
Bambino,
nudo,
stretto
amorosamente
al
seno
della
madre,
guarda
con
occhi
piena
di
tenera
gratitudine
il
volto
di
lei,
porgendole
un
fiore.
Nei
femminei
e
delicati
lineamenti
della
faccia
della
Vergine
è
soffusa
una
spirituale
dolcezza,
una
celestialità
soave
che
ricorda
certe
pitture
dell’Italia
centrale.
L’ambientazione
naturalistica
dello
sfondo
completa
l’armoniosa
configurazione.
La
luminosità
dei
colori,
la
morbidezza
dei
lineamenti
e
dei
paesaggi
chiaroscurali,
la
sovrapposizione
delle
vesti
e
la
notevole
profondità
del
paesaggio,
donano
al
quadro
una
rara
bellezza
e
gli
conferiscono
una
chiara
identità
stilistica
e
figurativa
che
conduce
alle
sessioni
artistiche
dell’arte
dell’Italia
centro-settentrionale
del
‘500.
ABBAZIA
BENEDETTINA
-
Posto
all’interno
del
Castello,
l'Abbazia
di
Santa
Maria
di
Maniace costituisce
la
maggior
parte
del
complesso
edilizio
denominato Ducea o Castello
Nelson.
L’antica
abbazia,
dedicata
a
Maria
Santissima, fu
fatta
costruire
da
Guglielmo
II°
il
Buono nel 1174,
per
espresso
desiderio
della
madre,
la
regina
Margherita
di
Navarra, a
ricordo
della
sanguinosa
battaglia
vinta
da
Giorgio
Maniace
contro
gli
arabi nel
1040
sulla
strada
tra
Randazzo
e
Troina.
Costruita
su
una
rupe
basaltica,
è
ubicata
su
terreno
pianeggiante
di
fondo
valle
sulla
riva
sinistra
del
torrente
Saraceno,
luogo
estremamente
suggestivo
ed
anche
di
antiche
origini
e
ricco
di
testimonianze
archeologiche.
A
poca
distanza,
infatti,
nell’Aprile
del 1905 a
seguito
di
lavori
nei
campi,
furono
scoperti
ambienti
con
"bei mosaici
romani del
basso
impero,
istoriati
di
animali
e
figure
umane"
che,
a
detta
dell'archeologo
Paolo
Orsi
erano
parte
di
una
grande
villa.
 Esternamente
l'Abbazia
si
presenta
come
costruzione
bassa
con
tetto
alla
siciliana,
le
finestre
rettangolari
e
le
porte
incorniciate
in
pietra
lavica.
Il
complesso
degli
edifici,
nello
stato
in
cui
ci
è
pervenuto,
da
solo
una
vaga
idea
di
quella
che
era
la
struttura
originaria
della
chiesa
abbaziale,
della
sala
capitolare,
della
foresteria
e
del
chiostro
del
monastero.
Le
notizie
relative
ai
crolli
dovuti
ai
frequenti
terremoti
(fra
i
quali
quello
devastante
del
1693)
ci
fanno
supporre
che
ciò
che
noi
vediamo
corrisponda
in
minima
parte
alla
situazione
iniziale. Esternamente
l'Abbazia
si
presenta
come
costruzione
bassa
con
tetto
alla
siciliana,
le
finestre
rettangolari
e
le
porte
incorniciate
in
pietra
lavica.
Il
complesso
degli
edifici,
nello
stato
in
cui
ci
è
pervenuto,
da
solo
una
vaga
idea
di
quella
che
era
la
struttura
originaria
della
chiesa
abbaziale,
della
sala
capitolare,
della
foresteria
e
del
chiostro
del
monastero.
Le
notizie
relative
ai
crolli
dovuti
ai
frequenti
terremoti
(fra
i
quali
quello
devastante
del
1693)
ci
fanno
supporre
che
ciò
che
noi
vediamo
corrisponda
in
minima
parte
alla
situazione
iniziale.
E’
altrettanto
probabile
che
la
volumetria
più
consistente
del
monastero
–
denominata
Ducea
Nelson
-
sia
quella
arrivata
fino
a
noi
in
migliori
condizioni
in
quanto,
una
volta
passata
ai
Nelson,
fu
risanata
ed
adibita
a
residenza
permanente.
Tutte
le
altre
strutture
invece
rimasero
legate
alla
conduzione
del
vastissimo
fondo
agricolo.
Gli
ambienti,
organizzati
intorno
ad
un
cortile
centrale,
furono
adibite
dai
Nelson
a
deposito,
cantine,
stalle
e
granaio.
Al
centro
del cortile è
ubicato
un
pozzo
a
pianta
ottagonale
in
muratura
con
elementi
decorativi
di
coronamento
in
pietra,
perimetrato
da
una
pedana
ottagonale
con
cordolo.
Nel
lungo
ed
ampio
granaio
dei
Nelson,
recentemente
trasformato
in
un
grande
salone
con
un’unica
copertura
lignea
sostenuta
da
"capriate
composte
alla
palladiana", sono
stati
portati
alla
luce
interessanti
resti
dell’antica
chiesetta di
Santa
Maria
(tra
i
quali
l'abside).
Lo
schema
planimetrico
dei
locali
ed
alcuni
elementi
architettonici
del
cortile
fanno
pensare
che
l’abbazia
era
organizzata
su
pianta
anulare,
intorno
ad
un
cortile
centrale
(al
quale
si
accede
dal
cortile
principale
d’ingresso
alla
Ducea).
E’
evidente
anche
che
gli
antichi torrioni d’epoca
normanna
che
proteggevano
l’abbazia,
ed
ancora
visibili,
fecero
parte
di
un
complesso
edilizio
di
notevoli
proporzioni
ed
importanza.
Dei
torrioni,
quello
accanto
al
prospetto
principale
è
forse
l’unico
risalente
al
periodo
originario;
ha
struttura
solida
e
compatta
con
fessure
verticali
d’avvistamento
e
difesa
ed
è
forse
il
resto
più
consistente
della
robusta
fortificazione
andata
in
gran
parte
distrutta
dal
terremoto
del
1693.
 Le due
torrette
di
guardia
sul
fiume a
nord-ovest
e
a
nord-est
risalgono,
invece,
nella
veste
a
noi
pervenuta,
ad
epoca
più
recente.
Hanno
volumetria
cilindrica
con
muratura
grezza
di
grosso
spessore
coronata
da
una
merlatura
leggermente
in
aggetto
su
una
cornice
d’elementi
in
cotto. Le due
torrette
di
guardia
sul
fiume a
nord-ovest
e
a
nord-est
risalgono,
invece,
nella
veste
a
noi
pervenuta,
ad
epoca
più
recente.
Hanno
volumetria
cilindrica
con
muratura
grezza
di
grosso
spessore
coronata
da
una
merlatura
leggermente
in
aggetto
su
una
cornice
d’elementi
in
cotto.
Il
torrione
di
nord-ovest
è
stato
utilizzato
fino
a
tempi
recenti
come
stazione
meteorologica
permanente.
Questi
torrioni,
che
insieme
al
portale
della
chiesa
di
Santa
Maria
ricordano
il
passato
medievale
del
monumento,
han
fatto
sì
che
perdurasse
la
denominazione
impropria
di
"Castello"
pervicacemente
data
per
secoli
all'abazia
benedettina.
Il
Complesso
del
Castello
Nelson
presenta
una
consistenza
complessiva
di
oltre
3.000
mq.
di
superficie
utile
(di
questi
circa
350
mq.
sono
occupati
dalla
chiesa
e
circa
520
mq.
dal
museo
Nelson
che
occupa
tutto
il
primo
piano
dell'ala
Ovest).
Inoltre
il
complesso
è
servito
da
oltre
1.600
mq.
di
superficie
scoperta
(cortili
di
stretta
pertinenza
ai
fabbricati)
e
di
circa
4.200
di
giardino
e
da
un
parco
che
supera
i
12
ettari.
Museo
Nelson
L’ala
gentilizia
della
Ducea
che
oggi
ospita
il
Museo
era
la
residenza
brontese
dei
discendenti
di
Horatio
Nelson
(il
Castello)
ed
ancora
oggi
rimane
una
perfetta
documentazione
storica
di
vita
inglese.
Gli
ambienti
che
la
compongono
è
probabile
che
rappresentino
la
volumetria
più
consistente
del
vecchio
monastero
benedettino.
Sicuramente
sono
quelli
arrivati
fino
a
noi
in
migliori
condizioni
in
quanto,
una
volta
trasferiti
per
dono
regale
ai
Nelson,
furono
ristrutturati
ed
adibiti
a
residenza
permanente.
Molte
strutture
e
locali
che
compongono
il
complesso
edilizio
furono
costruiti
nella
prima
metà
dell’ottocento,
quando
fu
risanato
ed
inglobato
quello
che
restava
dell’antica
abbazia
benedettina;
furono
ristrutturati
soprattutto
gli
ambienti
che
si
dipartivano
dalla
destra
del
portale
della
Chiesa
e
circondavano
il
piccolo
chiostro.
Una
particolareggiata
descrizione
degli
ambienti,
dei
quadri
e
delle
suppellettili
ci
è
stata
lasciata
dal
V°
Duca,
Alexander
Nelson
Hood,
nel
suo
libro
"La
Ducea
di
Bronte", memorie scritte
per
la
famiglia"
nel
1924.
  L’ala
gentilizia,
posta
al
piano
superiore
oggi
destinato
a
Museo,
si
affaccia
sul
giardino
botanico
e
sul
cortile
principale
del
complesso
al
centro
del
quale
sorge,
in
onore
dell'ammiraglio
Nelson,
la
grande croce
celtica voluta
nel
1888
dal
suo
discendente,
il
IV
Duca
di
Bronte
Lord
Alexander
Nelson
Hood,
barone
Bridport. L’ala
gentilizia,
posta
al
piano
superiore
oggi
destinato
a
Museo,
si
affaccia
sul
giardino
botanico
e
sul
cortile
principale
del
complesso
al
centro
del
quale
sorge,
in
onore
dell'ammiraglio
Nelson,
la
grande croce
celtica voluta
nel
1888
dal
suo
discendente,
il
IV
Duca
di
Bronte
Lord
Alexander
Nelson
Hood,
barone
Bridport.
Un lungo
corridoio disimpegna
tutte
le
stanze,
esposte
a
ponente
sul
giardino
inglese,
nelle
quali
si
trovano
la
maggior
parte
degli
arredi
lasciati
dagli
eredi
della
famiglia
Nelson.
Assume
l'aspetto
di
un
vero
e
proprio
percorso
museale
ricco
di
cimeli,
reperti
archeologici,
con
le
pareti
coperte
di
quadri
e
marine
giganti
che
descrivono
le
vittorie
di
Nelson.
Un
ritratto,
a
figura
intera,
di
Nelson
e
Wellington,
l’uno
a
fianco
dell’altro,
è,
a
detta
di
tutti,
l’unico
in
cui
erano
stati
ritratti
insieme.
Nel
corridoio
sono
esposti
quadri
e
stampe
raffiguranti
l'ammiraglio
inglese
ed
i
suoi
discendenti,
lettere
autografe
dei
reali
inglesi,
medaglie
e
piani
di
battaglia
navali,
ordini
militari,
sarcofagi,
anfore
romane
e
reperti
archeologici
ritrovati
durante
i
recenti
scavi
eseguiti
per
la
ristrutturazione
della
Ducea.
Il
Museo
è
storicamente
interessante
ma
anche
ricco
di
straordinario
fascino
e
di
bellezza.
Sulla
sinistra
del
lungo
corridoio
si
aprono
i sontuosi
appartamenti dei
duchi
inglesi
ancora
ornati
delle suppellettili
originarie (le
camere
da
letto,
lo
studio,
la
sala
da
pranzo,
i
servizi,
i
bagni
etc.)
e
in
parte
piastrellati
con
pavimenti
originali
di
maiolica
del
secolo
XVIII.
  Le
stanze
stesse
sono
state
pure
restaurate.
Repliche
delle
originali
mattonelle
da
pavimento
sono
state
fatte,
per
ogni
camera,
e
una
sezione
delle
vecchie
mattonelle
è
stata
lasciata
nel
posto
come
paragone. Le
stanze
stesse
sono
state
pure
restaurate.
Repliche
delle
originali
mattonelle
da
pavimento
sono
state
fatte,
per
ogni
camera,
e
una
sezione
delle
vecchie
mattonelle
è
stata
lasciata
nel
posto
come
paragone.
Oltre
alle
stanze,
ai
servizi
ed
alle
cucine,
rigorosamente
ammobiliati
con
mobili
e
suppellettili
dell'epoca,
altri
numerosi
oggetti
d'arte
sono
conservati
nel
Castello.
Gli
ambienti
conservano
preziosi
cimeli,
oggetti
di
uso
comune
e
numerose
opere
d'arte
appartenuti
ai
Nelson:
ritratti
di
Lady
Hamilton
o
della
Regina
Vittoria
col
principe
consorte
Alberto,
lettere
autografe
dei
reali
d'Inghilterra,
arredi
e
mobili
di
grande
pregio
e
di
vario
stile,
vasi
ed
orologi
dell'ottocento,
cassapanche
di
pregevole
fattura,
maioliche
calatine
del
XVIII
secolo,
stampe
e
dipinti
di
autori
inglesi
(Luny,
Paton,
Spencer,
Elliot),
porcellane
napoletane
e
gli
stemmi
dei
Nelson.
Nelle
stanze
dei
Nelson
non
si
vedono
più
i
maggiordomi
o
la
numerosa
servitù,
le
cucine,
le
stufe
e
i
caminetti
sono
spenti
e
tutto
è
immobile,
ma
in
un
grande
silenzio
affiorano
alla
memoria
la
storia
e
la
magia
del
luogo
rimasta
immutata
ma
anche
le
sofferenze
del
povero
popolo
brontese
espropriato
per
secoli
delle
sue
ricchezze.
 La
mobilia
è
un
miscuglio
di
stili:
parte
di
essa
è
stata
portata
dall’Inghilterra,
parte,
come
il
tavolo
da
refettorio
del
VI
secolo,
si
crede
sia
parte
dell’originale
mobilia
del
convento.
Altri
pezzi
erano
stati
comprati
localmente
dai
Bridports
ed
includono
alcuni
magnifici
esempi
d’artigianato
siciliano.
La
casa
è
in
vari
modi
un
monumento
a
Horatio
Nelson,
con
ricordi
della
sua
vita
e
delle
sue
vittorie
dappertutto. La
mobilia
è
un
miscuglio
di
stili:
parte
di
essa
è
stata
portata
dall’Inghilterra,
parte,
come
il
tavolo
da
refettorio
del
VI
secolo,
si
crede
sia
parte
dell’originale
mobilia
del
convento.
Altri
pezzi
erano
stati
comprati
localmente
dai
Bridports
ed
includono
alcuni
magnifici
esempi
d’artigianato
siciliano.
La
casa
è
in
vari
modi
un
monumento
a
Horatio
Nelson,
con
ricordi
della
sua
vita
e
delle
sue
vittorie
dappertutto.
Purtroppo
il
museo,
appena
tre
anni
dopo l’acquisto
da
parte
del
Comune,
ha
subito
nel 1984
un
gravissimo
furto di
una
ventina
di
preziose
opere
(fra
dipinti
e
mobili
d'epoca)
che
ancora
non
sono
state
recuperate
e
che
difficilmente
potremo
un
giorno
vedere
esposte
ed
ammirare
nel
Museo
Nelson.
Pag.
2

 Pag.
4
Pag.
4
|