|
Granfonte
Fatta
costruire nel 1652 dal principe Placido Branciforti sui resti di una antica
fontana araba chiamata “Fonte di Tavi”, costituiva il luogo abituale di
riunione della popolazione e, con le sue ventiquattro cannelle, anche
l’abbeveratoio pubblico.
La sua acqua alimentava anche le numerose fontane dell’Orto Botanico.
Sembra che il suo disegno architettonico richiami un’analoga fontana che
si troverebbe ad Amsterdam, in Olanda. Più verosimilmente l’opera,
attribuibile all’architetto palermitano M. Smiriglio, si rifà alle
numerose creazioni di artisti fiamminghi allora molto diffuse in Sicilia.
Questa
maestosa fontana monumentale è di stile barocco; ha forma simmetrica e
presenta una lunghezza di 24.60 metri, una profondità di 2.55 metri, 22
arcatelle aperte a tutto sesto che lasciano intravvedere il paesaggio
agreste sottostante.
Da 24 cannelle di bronzo ogni giorno, tranne il Venerdì Santo in segno di
lutto per la morte del Cristo, sgorga ininterrottamente limpidissima acqua
che si raccoglie nella sottostante vasca rettangolare. Il prospetto con tre
alzate timpanate decorate con bassorilievi è raccordato ai lati con due
volute.
Monumento emblematico e significativo, “a brivatura” rappresenta la
memoria storica e il cuore stesso della Città. Non c’è casa di
leonfortese che non ne custodisca una riproduzione come a voler riaffermare
un’insopprimibile continuità con le proprie radici.
Nel
1910 furono messe in opera le lastre di pietra lavica lungo la vasca per
dare la possibilità di attingere più facilmente l’acqua; nel 1983è
stato consolidato il prospetto posteriore; ad intervalli non troppo lunghi
vengono programmati interventi di manutenzione e pulizia.
A
ridosso della Granfonte, un canale delle acque di scolo della fontana assume
la forma di lavatoio utilizzato a tale scopo fino alla metà del ‘900.
Qui, entrando dalla attigua Porta Garibaldi, accorrevano le massaie che in
tal modo avevano a disposizione acqua corrente in abbondanza, solidi
“pilieri” di pietra e massi sui quali fare asciugare al sole gli
indumenti.
Porta
Palermo o Porta Garibaldi
Il
Principe per proteggere i propri sudditi dalle rappresaglie di estranei e
per difendere dalla peste scoppiata in Sicilia il borgo che aveva fondato,
aveva fatto costruire nel 1624 una cinta muraria che lo delimitava con quattro porte
d’accesso: Porta Crocifisso ad est, Porta S. Rocco ad ovest, Porta S.
Filippo o “Pipituna” a nord (così chiamata per la presenza di due alti
pilastri) e Porta Palermo a sud, sulla strada che da Enna portava a
Leonforte.
 Di queste porte, le prime tre furono eliminate tra il 1875 e il
1877; la Porta Palermo, invece, continua a resistere alla inclemenza del
tempo e degli uomini e dopo il passaggio di Garibaldi avvenuto il 15 agosto
1862, ha assunto l’odierna denominazione di Porta Garibaldi. Di queste porte, le prime tre furono eliminate tra il 1875 e il
1877; la Porta Palermo, invece, continua a resistere alla inclemenza del
tempo e degli uomini e dopo il passaggio di Garibaldi avvenuto il 15 agosto
1862, ha assunto l’odierna denominazione di Porta Garibaldi.
Di
stile classicheggiante, fu costruita da maestranze locali.
E’ una porta ad
arco a tutto sesto affiancata dalla porta d’ingresso dell’Orto Botanico,
con conci squadrati e trabeazione classica. Termina in alto con due merli a
coda di rondine, di cui uno è andato perduto.
La porta si affacciava sul
“Piano S. Cristoforo” o “Piazza Sottana” delimitata dalla chiesa
della Madonna del Carmelo e dalla Granfonte che ne chiudeva la cornice
prospettica e che presentava altre due fontane dove poter attingere
l’acqua.
Queste fontane sono scomparse forse perché travolte e distrutte dal
catastrofico alluvione del 1740 o del 1809. Oggi la piazza risulta molto
modificata ed assomiglia più ad una via, essendo stato lo slargo
inesorabilmente assorbito dalle case.
Nel
1989 fu avviata un’opera di radicale risanamento del quartiere protrattasi
fino al 1993. In quella occasione, diverse Amministrazioni si avvalsero di
un progetto redatto dall’architetto leonfortese Mario Pisciotta il quale,
sulla scorta delle notizie storiche disponibili, fece anche il tentativo,
ribassando la quota stradale, di ricostruire il piano della “Piazza
Sottana”.
Restaurata
nel 1796, anno in cui vi fu apposta una lapide che con molta probabilità è
andata distrutta a seguito di una scossa tellurica. Più recentemente si è
tentato di consolidare la trabeazione, ma senza ricavame risultati
apprezzabili.
 Castello
di Tavi o “Castiddazzu” Castello
di Tavi o “Castiddazzu”
Questo
rudere è situato sul pizzo Castellaccio a meno di 2 km. ad
ovest dell’abitato di Leonforte, a m. 543 s.l.m., sulla sponda destra del
ramo superiore del fiume Dittaino (torrente Crisa) ed è raggiungibile
mediante la strada provinciale Leonforte – Calascibetta.
Forse esistente già nel periodo bizantino come avamposto fortificato della
città di Henna, divenne in seguito un elemento di difesa sia per gli arabi
che per i normanni.
La sua data di costruzione non è precisabile. Del castello, comunque, si ha
qualche traccia per la prima volta attorno alla metà del XII secolo.
Nel 1497 prende investitura per Tavi Belladama, moglie di N. Melchiorre
Branciforti e da questa data rimane feudo della famiglia fino
all’abolizione della feudalità.
Con la fondazione di Leonforte, il castello andò incontro alla distruzione,
in quanto perdette ogni importanza cedendo le sue prerogative al palazzo
Branciforti edificato in città.
Di
questo castello rimangono solo alcuni resti: una notevole cinta muraria che
a tratti si confonde con la linea naturale delle rocce su cui il castello è
ubicato, due grandi cisterne scavate nella roccia e un locale dalle medie
dimensioni dotato di volta a botte lunettata.
Castello
di Bozzetta
Il
castello sorgeva sulla Rocca Castellaccio di Bozzetta, nel Val di Noto a
circa 3 km. ad ovest di Leonforte, a m. 614 s.l.m., sulla sponda destra
dell’omonimo torrente Bozzetta.
Il castello è attestato per la prima volta nel 1326. Di origine bizantina,
è in completo abbandono. Il paesaggio è collinare ed è posto su una
sommità da dove si domina un ampio territorio.
Del castello restano solo pochi ruderi; in particolare è visibile un avanzo
di mura con una grande apertura con arco a sesto ribassato che la tradizione
identifica con il portone di accesso al complesso castrale. I resti fuori
terra visibili non consentono una lettura ricostruttiva dell’impianto.
Una
curiosità è rappresentata da una apertura praticata alla base del muro
orientale nel locale di piano terra, dalla quale risulta pressoché
impossibile vedere alcunché dall’interno verso l’esterno. Ritenuta
erroneamente una finestra, è in realtà un “buco del gatto” o
“gattaio” come veniva chiamato dai costruttori medioevali cioè una via
di comunicazione con l’esterno o una via di scampo in extremis qualora il
nemico avesse occupato il resto della fortezza.
Piazza
Carella, Palazzo Carella e Piazza IV Novembre

Le
due piazze in passato venivano chiamate “U chianu a scola” (il Piano
della scuola) poiché sin dalle origini del paese lo spiazzo costituiva il
maneggio del principe N. Placido Branciforti, il posto ove si svolgevano gli
esercizi di equitazione e le esercitazioni per domare ed educare alle
briglie i puledri dei suoi allevamenti. Nel 1812 con l’abolizione dei
diritti feudali, il Principe non ebbe più l’obbligo di assicurare il
servizio d’ordine nel feudo e “U chianu” perse il fascino che gli
davano le esercitazioni dei cavalieri. Tuttavia, continuò ad avere una
qualche utilità e funzione pubblica, in quanto la presenza di una fontana
costruita nel 1887 e sopravvissuta fino al 1933, assicurava a sufficienza
acqua potabile a decine e decine di famiglie che abitavano nei paraggi.
Anche per questo, per lungo tempo ancora le piazze furono il cuore pulsante
della città. Dalla piazza Carella nel 1922 partirono i contadini per
occupare le terre di Montagna d’Immenso e di Casuto.
Nella piazza 4 novembre il 18 dicembre 1935 i leonfortesi donarono le fedi
nuziali e gli oggetti d’oro alla patria. In seguito, con l’espansione
del paese vi si costruirono case e vie; tutt’intorno sorsero bar e negozi,
circoli e persino un cinema. Ancora oggi costituiscono il centro cittadino
su cui, notte e giorno, veglia una “Madonnina” posta in un punto
panoramico facilmente visibile dalle vie e dalle case del centro urbano.
Palazzo
Carella fu costruito sul “Piano della scuola” da Giovanni Carella dopo che
nel 1734 ebbe il titolo di barone dei Rossi Sottani. Di stile settecentesco,
è una costruzione lineare che conferisce una certa monumentalità alla
piazza. Presenta un prospetto ampio, evidenziato da bugnato nella zona
bassa, ad un solo piano sopraelevato con sette balconi marcati da archi e
sobrie decorazioni di corone di foglie.
Il balcone centrale è fregiato dallo stemma baronale della famiglia
Carella. Le aperture sono evidenziate con conci di pietra e con arcate
decorate e conchiglie intagliate. Il portale centrale è affiancato da due
colonne. Internamente è a pianta quadrata con cortile interno di forma
rettangolare. Gli ambienti, in parte adibiti ad uffici, in parte di proprietà
privata, non hanno più i mobili e i salotti originari. Tuttavia si possono
ammirare gli stucchi dei soffitti e le decorazioni pittoriche delle sale di rappresentanza che denotano una certa sensibilità di mano e di
gusto. Il 22 ottobre 1809 una pioggia torrenziale alimentò una fiumara
d’acqua che invase il paese, causando 132 morti e distruggendo numerose
abitazioni; in quella occasione, il “don Rosario Carella” vi fece
rifugiare molti abitanti del paese salvandoli da sicura morte.
Un fenomeno simile si registrò nel 1951 quando un diluvio di ampie
proporzioni provocò l’allagamento del vicino palazzo municipale. In quel
frangente più di 200 famiglie dovettero abbandonare le proprie abitazioni,
ma fortunatamente non si registrarono morti.
Di
forma rettangolare, parallele, una è denominata “Piazza Carella” perché
antistante all’omonimo palazzo; l’altra, chiamata “4 novembre”, è
delimitata da spazi verdi con alte palme e sedili. Al centro,
quest’ultima, presenta il Monumento ai Caduti della prima guerra mondiale
costruito nel 1932, le cui pareti sono impreziosite da solenni epigrafi e ai
lati, in modo simmetrico, vi sono due fontane con sculture ad imitazione
classica.
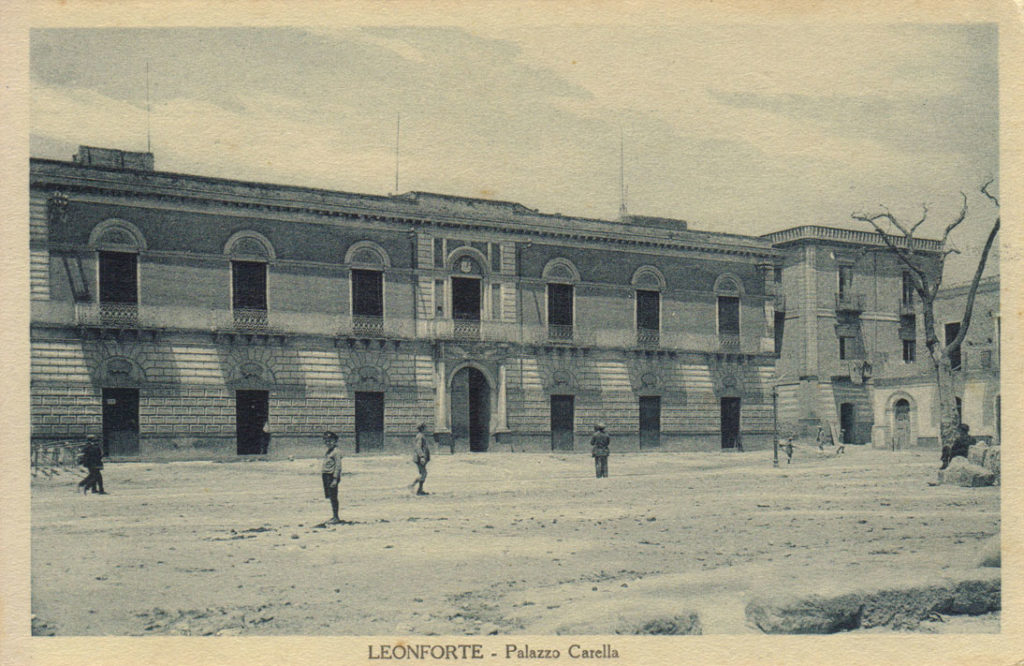
Piazza
Margherita o “Tornachiazza” -
Costituì
sin dall’inizio della sua costruzione il nucleo centrale delle locali
attività commerciali tanto da essere chiamata “Piazza del mercato”.
Solamente alla fine del IS00 prese, in onore della regina Margherita,
l’odierna denominazione. Anche se non si conosce il progetti sta, fu
ideata e voluta dal principe Placido Branciforti e dal figlio Giuseppe;
nel 1741 fu modificata dal principe Ercole che commissionò l’abbellimento
della “Piazza Rotonda” (come veniva anche chiamata) allo scultore
palermitano La Marca, secondo il disegno redatto dal noto ingegnere
militare M. Blasco.
Originariamente la piazza era circondata da sedici
botteghe di vario genere; successivamente queste costruzioni vennero
ristrutturate con l’aggiunta di abitazioni sulle botteghe in modo tale da
fare corrispondere sopra di queste sedici balconi balaustrati in pietra
intagliata di uguale disegno. Gli edifici infine terminavano in alto con un
cornicione e una balaustra scolpita, analoga ai balconi. La piazza risultava
divisa in quattro quarti di cerchio, marcati da pilastri che formavano
quattro cantoni.
Al
centro e fino alla fine dell’8OO vi era anche una fontana, considerata
come elemento di servizio per gli operatori commerciali e per gli abitanti
del borgo. Vero e proprio centro della vita politico – sociale della
collettività leonfortese per tre interi secoli e almeno fino agli anni
’60, con il continuo espandersi del paese verso nord, ha finito per
perdere molta parte della sua importanza e vitalità.

Villa
Bonsignore
Adibita
a residenza estiva del conte Bonsignore Giovan Calogero Li Destri, era
circondata da un giardino in parte all’inglese e in parte all’italiana,
ricco di piante e fiori con annesso un parco con pineta e viali di bosso e
di cipresso. Comprendeva anche la casa per il “massaro”, una grande
cisterna, la carretteria e le stalle. Il parco originarioè stato in buona
parte lottizzato e venduto a privati. Nel 1982, la residua porzione di 5000
mq., è stata acquistata dal Comune per destinarla a sede di attività
culturali e giardino pubblico.
Classica
villa fuoriporta dell’800 con elementi liberty rapportabile ad un moderno
chalet di caccia, è una palazzina a due piani ed un piano attico
direttamente collegato con l’esterno per mezzo di una scala a chiocciola
in ferro e con ingresso principale dal giardino.
Al
piano interrato vi sono le cantine, mentre al piano rialzato si possono
ammirare ampie sale con salone centrale, decorate con stucchi e pitture.
Al
primo piano troviamo le sale private; il piano attico, invece, con terrazze
laterali simmetriche, era adibito ai servizi: cucine, forno, dispense e
lavanderia.
Una
prima ristrutturazione con fondi dell’ Assessorato regionale per i
BB.CC.AA., si è avuta nel giugno del 1994 con il recupero statico
antisismico dell’ immobile e il restauro delle strutture murarie, degli
infissi esterni e dell’impiantistica di base. Recentemente (dicembre 2004)
sono stati ristrutturati e restaurati in modo funzionale i piani terreno e
rialzato. I lavori di progettazione e di restauro sono stati svolti sotto la
direzione dell’architetto leonfortese Antonino Mazzucchelli. La
realizzazione definitiva del progetto di recupero prevede il completamento
dei piani primo e secondo, la sistemazione del parco e la riannessione della
dismessa stazione di rifornimento.

Piazza
Branciforti o Caddivarizza, Palazzo Branciforti
La
“Piazza Soprana”, ubicata tra il palazzo, la scuderia ed altre
abitazioni di famiglie nobili, nei primi secoli di Leonforte rappresentò, a
dire così, l’angolo aristocratico del borgo. Era chiamata anche
“Caddivarizza” perché continuamente animata da carrozze e cavalieri e
cornice di feste ed addobbi sfarzosi. Epicentro reale del potere dei
Branciforti prima e della mondanità della famiglia Li Destri dopo,
presentava davanti al palazzo una fontana, oggi andata distrutta.
Realizzata
da maestranze romane e palermitane sotto la direzione del capomastro
Vincenzo Gianguzzo, la piazza, armoniosa nelle proporzioni, è rettangolare
e con una sistemazione scenografica data dai prospetti del palazzo e della
scuderia. Vi si svolgono concerti e manifestazioni musicali; ogni martedì
mattina ospita il mercato settimanale.

Il
palazzo fu
fatto costruire e completato dal principe fondatore Placido Branciforti
nel giro di quasi cinquant’anni con l’ausilio di maestranze romane e
palermitane sotto la direzione di tre capomastri ennesi: Gianguzzo, Inglese
e Calì.
Adibito ad abitazione privata non solo dello stesso Principe ma
anche dei suoi discendenti, nel 1842 fu venduto a Giovanni Calogero Li
Destri, conte Bonsignore.
Domina la zona bassa del paese, con una mole
inconsueta e stupefacente. Ha subìto manomissioni sia all’interno che nei
prospetti; un crollo avvenuto nel 1958 ha irrimediabilmente cancellato
l’ala ovest.
E’ stato sede di fastose mondanità documentate in
testamenti ed altre scritture e ha ospitato illustri personalità: valgano
per tutte, Giuseppe Garibaldi che tra il 15 e il 16 agosto 1862, da uno dei
balconi parlò al popolo di Leonforte e Amedeo diASavoia, duca di Aosta, che
nel 1923 si trovava a Leonforte per una battuta di caccia, ospite
dell’amico Giovanni Scelfo ufficiale di artiglieria.
Oggi, la parte
ancora abitabile è di proprietà privata.
Di
stile seicentesco è una costruzione quadrangolare a due piani con cortile
interno. Presenta una fila di finestre nel piano bas.so e balconi simmetrici
nel piano superiore con mensole scolpite. Al centro presenta un bellissimo
portale con bugne e decorazioni di pennacchi a bassorilievo.
Sul balcone centrale sono scolpite armi e trofei di guerra, opera dello
scultore romano Fabio Salviati. Dal lato sud presenta due bastioni di
fortificazione circoscriventi una villetta comunale che si affaccia sulla
via Garibaldi e che offre al visitatore l’originalissimo scenario
rappresentato dalle abitazioni del centro storico. Questa villetta è stata
realizzata nel 1878 a spese del Comune.
La facciata principale del palazzo, invece, si affaccia sulla piazza
Branciforti. Internamente è presente un ampio cortile quadrangolare con al
centro una profonda cisterna. Ai lati si aprono i magazzini, l’arsenale e
altri ambienti. Sull’ ala centrale, in corrispondenza del portone
d’ingresso, si erge uno scalone di accesso ai due piani superiori del
palazzo che costituivano la residenza del principe. Le sale di
rappresentanza, di cui una che poteva accogliere circa 400 persone, sono
,decorate con pregevoli stucchi. I sotterranei infine erano adibiti a
magazzini per conservare l’olio e a carcere. Quest’ultimo nel 1867 fu
trasferito in un vicino locale del quartiere di San Rocco.
Nel 1980 si è provveduto al consolidamento del tetto, mentre nel 1988 è
stato pavimentato il cortile interno con cotto a taglio.
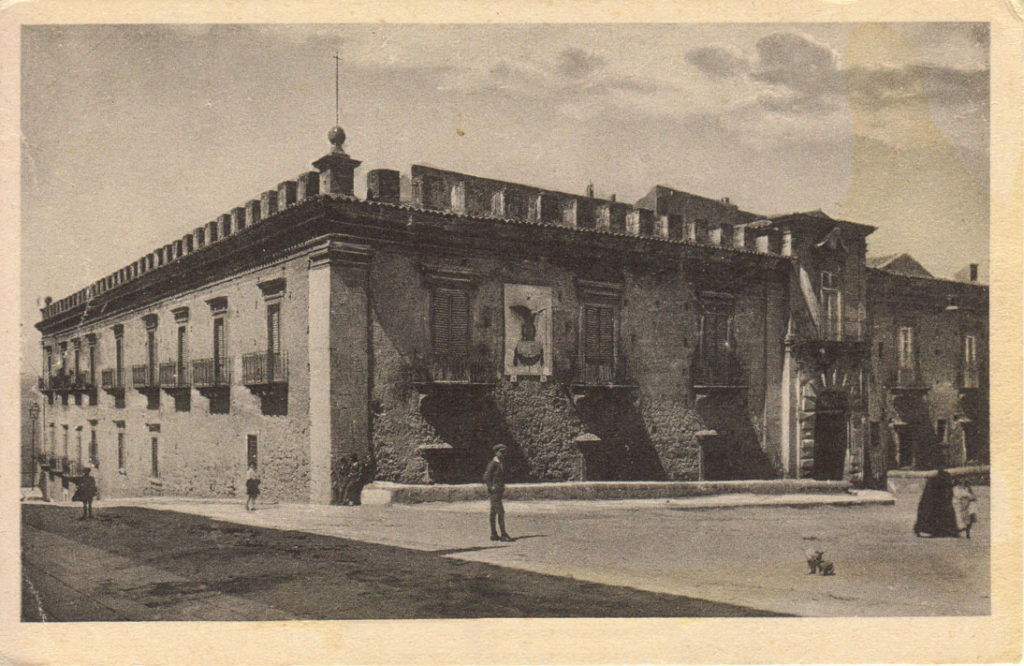
Fontana
delle Ninfe o Fonte di Crisa
Ubicata
dentro l’omonimo giardino era sicuramente alimentata dalle sorgenti del
monte Tavi. Celebra il mito del dio fluviale Crysa. Fu fatta erigere nel
1636 dal
principe Placido Branciforti sul modello di quella che papa Paolo V aveva
fatto costruire a Roma.
Costituisce
la prima monumentale fontana di Leonforte. Progettata da scultori romani, di
stile barocco classicheggiante, risulta ben equilibrata nella struttura
architettonica.
Rappresenta un arco trionfale che sormonta una roccia
artificiale da cui sgorgava l’acqua che, passando dalla bocca di un leone,
andava a yersarsi dentro una vasca poligonale rivestita con piastrelle in
maiolica smaltata dai colori bianco e azzurro.
E’ abbellita da due nicchie
laterali: la prima contiene una scultura in marmo di figura femminile che
rappresenta Artemide dea della caccia o Demetra dea delle messi (in questo
caso i pareri degli studiosi sono discordi); la seconda, ora vuota,
conteneva la figura nuda di una divinità fluviale con cornucopia,
denominata dal popolo “U santu misiru”, raffigurante probabilmente il
dio Crysa. Quest’ultima è collocata attualmente nella sala consiliare del
Municipio. Faceva parte della fontana anche l’ampio giardino che,
trasformato in agrumeto, è oggi di proprietà privata.
Nel 1986 è stata ripulita e resa visibile al pubblico. Nel mese di
settembre 2004 è stato finanziato il recupero del sito che prevede tra
l’altro la messa in funzione della fontana.
Secondo
le testimonianze di qualche studioso che ha indagato il monumento,
sull’arcata centrale della fontana avrebbe dovuto trovarsi un altorilievo
raffigurante la simbolica fenice in mezzo ai suoi pulcini; l’uccello che,
bruciato, ha la peculiarità di risorgere dalle proprie ceneri. Tuttavia non
è stato possibile riscontrare alcuna traccia visiva né del rilievo né
della iscrizione che lo avrebbe dovuto accompagnare.

Fonte
dei “Malati”
E’
situata in una stradina secondaria nella zona a sud dell’ abitato proprio
di fronte alla fontana delle Ninfe. Un cunicolo oltre lo stradale lungo il
tombino sotterraneo conduce a varie scaturigini, tra cui questa dei
“malati”.
Da questa sorgente che a dire il vero doveva essere alimentata da una vena
non molto ricca, sgorgava acqua che avrebbe avuto, secondo le credenze
popolari, qualità medicali e taumaturgiche. Tanti leonfortesi vi hanno
attinto acqua convinti di trovare in essa un aiuto ai loro malanni. In realtà si trattava di un’acqua più limpida e più leggera delle altre
acque potabili esistenti nel territorio circostante.
Di
questa fontana rimane soltanto qualche approssimato rudere a stento
visibile. Lungo il muro che costeggia la Fontana delle Ninfe è possibile
osservare ancora un piccolo cunicolo all’estremità del quale veniva
collocata una paletta di ferro per attingere più facilmente l’acqua che
andava a riversarsi in una piccola vasca circolare in discreto stato di
conservazione.
Fontana
della Morte
Vicinissima
alla Chiesa di Santo Stefano Protomartire, è costituita da una scaturigine
detta appunto della “morte” dove affiorano acque alle quali si
attribuiscono memorie vaticinanti e prodigiose: per esempio, quella di
avere, assieme ad altre sorgenti compresa quella del Fonte di Tavi,
riversato sangue a presagio del massacro dei coloni arabi da parte
dell’esercito normanno. Più scientificamente questo fenomeno troverebbe
spiegazione nella struttura geologica del terreno circostante ricco di
argilla rossa detta “taiu” che, sciolta e trascinata dalle acque
sotterranee, avrebbe dato la sensazione visiva del sangue.
Piccola
sorgente che tramite due cannelle riversa acqua in una vasca rettangolare
costruita in pietra. Si trova sul terreno di proprietà di Campagna Maurizio
che ne assicura la fruibilità. Il cancello d’ingresso viene aperto al
pubblico solo durante il giorno e fino al tramonto. Si tratta infatti della
sopravvivenza di un antico uso civico di cui la collettività usufruisce in
base a concessioni risalenti a norme di tipo feudale.
Originariamente
l’acqua che alimenta la fontana scorreva a fior di terra. Nel 1887,
l’Amministrazione apportò delle modifiche, facendo costruire un
recipiente a forma di fontanella e due canaletti di rame da cui attingere più
facilmente l’acqua.
Pag.
1 
- Fonte
- https://www.comune.leonforte.en.it/
- https://it.wikipedia.org
|