|
Su un promontorio che si
affaccia sul mare a 230 metri di altitudine sorge Tindari,
sede di uno dei santuari mariani più famosi di Sicilia e del quinto parco
archeologico siciliano, istituito da pochissimo tempo.
L'odierna Tindari è una
frazione di Patti e
si trova in una posizione attigua all'antica area archeologica di Tyndaris,
fondata nel 396
a.C. dal siracusano Dionisio
il Vecchio, tiranno di Siracusa, dopo aver sconfitto i Cartaginesi.
Il nome della città intendeva omaggiare il mitico Tindaro re di Sparta,
padre putativo di Elena, Clitennestra, Castore e Polluce.
La città divenne subito un avamposto d'importanza strategica perché si
affacciava direttamente sull'antica Mylae (Milazzo)
e le isole
Eolie, e il suo controllo era fondamentale per il monarca che voleva
dominare lo Stretto
di Messina e affermarsi nella Magna
Grecia.
Tyndaris fu
abitata dai Messeni provenienti
dalla Laconia,
regione del Peloponneso,
arrivati in Sicilia in seguito alla guerra fra Sparta e Siracusa.
I Messeni erano devotissimi ai Dioscuri
Castore e Polluce, ma anche ad Hermes, Artemide, Zeus, Apollo,
Poseidone e Dioniso e
vivevano di pesca, caccia e agricoltura coltivando cereali, ulivi e vite.
La città servì fedelmente
Siracusa e durante la prima guerra punica, nel 257
a.C., nelle sue acque si combatté una decisiva battaglia nella
quale la flotta romana mise in fuga quella cartaginese. Successivamente passò
nell'orbita romana insieme a Siracusa e nel 36
a.C., conquistata da Augusto e
trasformata in una delle cinque colonie siciliane, la 'Colonia
Augusta Tyndaritanorum', che fu citata da Marco
Tullio Cicerone come una nobilissima
civitas.
Nel I
sec. d.C. cominciò un periodo buio di declino a causa di una
grande frana che la danneggiò notevolmente e nel IV secolo fu soggetta a
due distruttivi terremoti. Divenuta sede vescovile, fu conquistata dai bizantini nel 535 e
dagli arabi che
la distrussero nell'836.
La tradizione tramanda che a queste catastrofi sopravvisse il santuario
dedicato alla Madonna
Nera di Tindari, che fu ingrandito nel 1979 perchè
diventato incapace di accogliere i tanti pellegrini che qui arrivavano da
ogni parte della Sicilia e non solo.
L'area
archeologica racchiude i resti dell'antica città, organizzata secondo un
ordinamento ortogonale impostato su tre decumani larghi fino a 8 metri in
direzione est-ovest, intersecati dai cardines: oltre a resti delle mura di
IV secolo a.C., poi restaurate nel III secolo d.C., spiccano il propileo
monumentale, costruito dai Romani con grosse pietre arenarie, che fungeva da
basilica per le pubbliche riunioni e da ginnasio per lo svolgimento di
esercizi; l'Antiquarium, all'ingresso degli scavi, in cui sono
esposti vari reperti, tra cui statue di personaggi togati e una statua
dell'imperatore Augusto; i resti di due abitazioni a peristilio e delle
terme cittadine; e, soprattutto, il celebre Teatro greco, risalente al IV
secolo a.C. e poi riadattato in epoca romana per ospitare i giochi dei
gladiatori, con la cavea scavata nella collina che poteva ospitare
all'incirca 3000 spettatori.
- Basilica
papale minore o Santuario della Madonna del Tindari

Il Santuario
di Tindari, divenuto Basilica papale minore l'8 settembre 2018, si trova
all'estremità orientale del promontorio, a strapiombo sul mare, in
corrispondenza dell'antica acropoli, dove una piccola chiesa era stata
costruita sui resti della città abbandonata.
L'edificio
attuale identifica e ricopre l'area ove è documentata la primitiva fortezza
o castello di Tindari. L'ipotesi dell'esistenza della fortezza o
castello di Tindari è supportata dalla presenza di merli o coronature nei
preesistenti edifici di culto che rafforzano la tesi di antiche chiese
ricavate in primitivi edifici fortificati.
L'acropoli di Tindari occupa
l'ampia parte sommitale costituita da un insieme di rocche tra loro
raccordate. L'attuale area archeologica, l'antica colonia greca
di Tyndaris, occupa la parte più pianeggiante sull'asse est - ovest
costituita dalla "strada imperiale", esposta a settentrione e
digradante in direzione Patti.
* 396 a.C.,
Tyndaris colonia greca è fondata dal tiranno di Siracusa Dionisio il
Vecchio per i profughi spartani alla fine della guerra del
Peloponneso 404 a.C. La colonia e la città, insediamento da
stanziamento di Locresi, Messeni e Medmei al
servizio di Aristotele, mercenari greci originariamente alleati dei
Tiranni di Siracusa nascono come concessione del territorio a
titolo di risarcimento per la mancata corresponsione dell'ingaggio dopo
l'allontanamento forzato del loro condottiero. I nuovi coloni
particolarmente devoti ai Dioscuri, Castore e Polluce, secondo la leggenda
figli di Giove e di Leda, già moglie di Tindaro re
di Sparta. Popolazioni altrimenti note come Tìndaridi, da qui la
denominazione della colonia in Tìndaride e della città chiamata
Tindari. I Dioscuri furono eletti protettori pagani della città,
circostanza attestata dalle riproduzioni raffigurate su monete rinvenute
durante gli scavi archeologici. Le accezioni Týndaris, Tindari, Tindaro, Tyndaritano furono
dunque estese alla diocesi e associate al particolare, sentito,
diffuso culto cristiano della Vergine Maria. Nucleo cittadino
costituito da: cinta
muraria della città; anfiteatro greco - romano; basilica; domus imperiali,
abitazioni e negozi; terme; mosaici; museo.
L'attuale
fulcro religioso, pur inserito all'interno delle fortificazioni, occupa
l'estremità orientale a picco sul mare. La posizione d'avvistamento
strategica spazia sulla porzione del golfo di Patti compreso tra
le Isole Eolie a nord, la penisola di Milazzo a est e
l'intera catena dei Peloritani a sud.
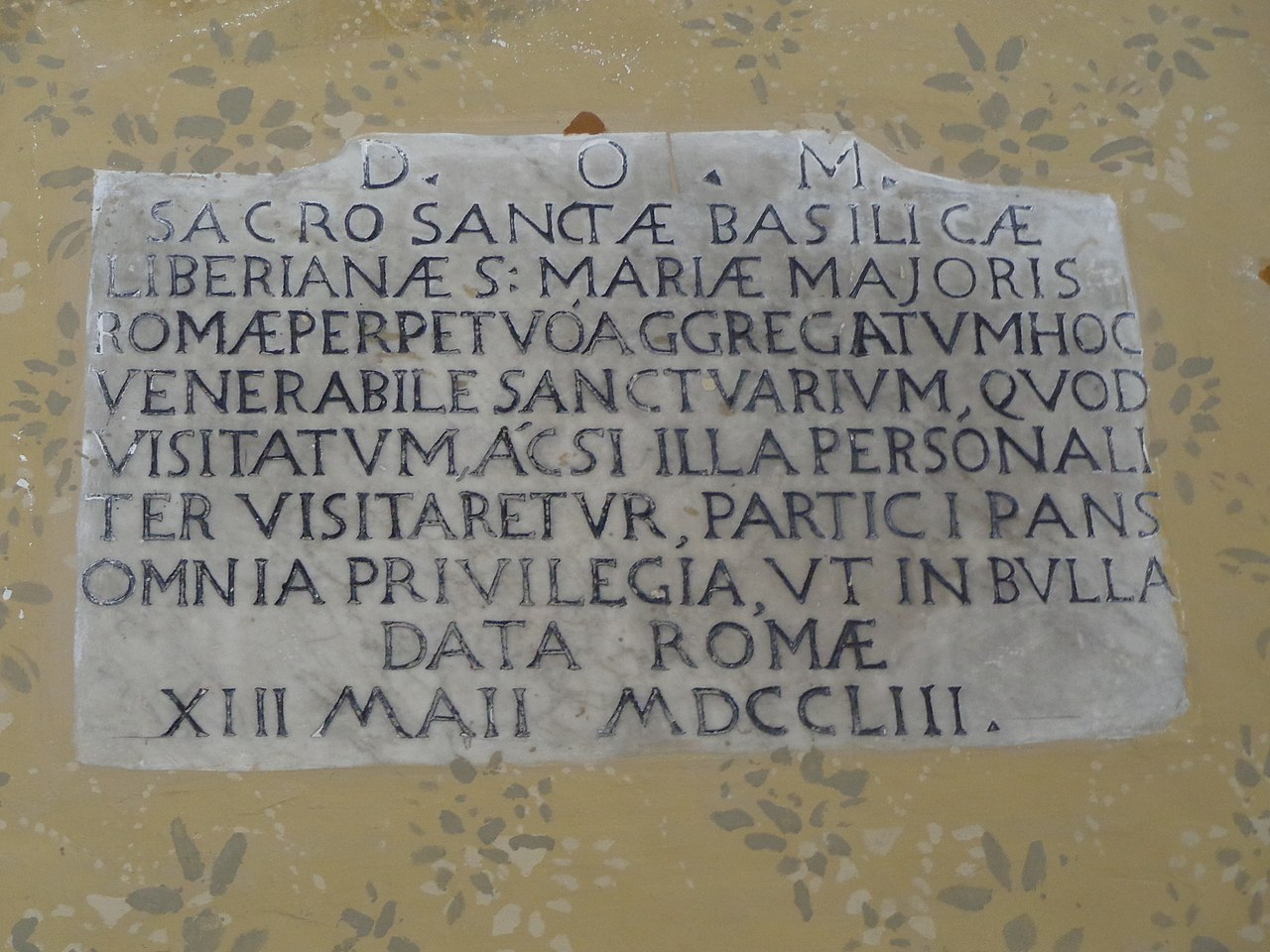
*
535 - 836, Diocesi di Tindari o Dioecesis
Tyndaritana. In epoca bizantina la città di Tindari è
sede episcopale già dal V secolo. La Cattedrale fortezza occupa e
ingloba l'area del tempio dedicato a Cerere posta sulla rocca di
levante.
Nell'ultimo
decennio del VI secolo, la corrispondenza personale di Papa
Gregorio Magno fa riferimento a due vescovi: Eutichio e Benenato, che
assieme ai due alti prelati Severino e Teodoro, costituiscono la cronotassi
della primitiva diocesi di Tindari.
* VIII
secolo ca., santuario primitivo, il simulacro è posto nell'area
del tempio dedicato a Cerere.
*
836 - 837, Soppressione della diocesi di Tindari. La
località è espugnata dall'armata di al-Fadl ibn Ya' qūb sostituito a settembre da un nuovo governatore, il
principe aghlabide Abū l-Aghlab Ibrāhīm b. 'Abd Allāh
b. al-Aghlab, cugino dell'emiro Ziyādat Allāh. La flotta
musulmana, condotta da al-Fadl ibn Ya' qūb, devasta le Isole Eolie, espugna diverse fortezze
sulla costa settentrionale della Sicilia, tra cui Tyndaris, come
riferisce lo storico Michele
Amari cultore orientalista di storia islamica. Per le
ben note vicende piratesche e corsare, assieme alla soppressa diocesi
di Taormina, Tindari è assorbita dalla diocesi di Messina. Anche la
corte vescovile di quest'ultima, per i continui assalti nello Stretto,
è costretta a riparare temporaneamente presso la protetta e
interna diocesi di Troina.
Nell'anno
886 Teodoro metropolita siracusano documenta la celeberrima Diva
Virgo in Castello Tyndaritano.
Il
viaggiatore storiografo Idrisi al servizio della corte normanna di
re Ruggero II di Sicilia dopo il 1145 documenta
nell'opera Il libro di Ruggero l'esistenza dei seguenti luoghi di
culto:
* 1110, nei
pressi delle rovine dell'antica Tindari sorge il monastero di Sant'Elia
di Scala o di Sant'Elia di Burracha di Oliveri, di rito greco.
*
1110, chiesa della Santa Genitrice di Dio o di Santa Maria de lo
Plano di Oliveri, dipendenza del monastero di Santa Maria di Gala
di Barcellona Pozzo di Gotto.
*
1178, chiesa di San Giovanni di Oliveri, edificata per
volontà di Ruggero II di Sicilia.

Assieme
alla fortificazione di Tindari:
* XII
secolo, castello di Adelasia di Patti, della primitiva
fortificazione araba costruita su
una necropoli del neolitico, identificabile nel periodo
normanno come la ricostruzione avvenuta per opera di Adelasia del
Vasto terza moglie del gran conte Ruggero madre
di Simone d'Altavilla e del re Ruggero II di Sicilia.
Sull'area delimitata dai ruderi e col materiale parzialmente riutilizzato,
oggi sorge la cattedrale di San Bartolomeo di Patti, una delle quattro
della provincia di Messina edificate espressamente per volontà
del gran conte Ruggero.
* XII
secolo, castello Liviri di Oliveri, costruzione edificata per
opera del gran conte Ruggero.
*
1148, tonnara medievale di Oliveri.
*
1105, mulini ad acqua medievali di Furnari. Concessione della
regina Adelasia del Vasto al monastero di Santa Maria di
Gala.
* XII
secolo, mulini ad acqua medievali di Patti. Concessione della
regina Margherita di Navarra moglie di Guglielmo I di Sicilia
al monastero del Santissimo Salvatore di San Marco del Casale di Palegre.
*
1282, Pietro III d'Aragona tramite il cronista Bartolomeo da
Neocastro documentano la chiesa dedicata alla Vergine contemplandola
da Argimusco nell'opera Historia sicula.
* XIV
secolo, Pietro II d'Aragona affida le terre al
cugino Bonifacio d'Aragona definito signore della rocca di Tindari.
* 1315, la
custodia del castrum di Tindari è a carico della diocesi di Patti,
re Federico IV d'Aragona ordina al vescovo di affidare terre
a Oddone Mancuso castellano di Tindari.

* 1359, la
città di Tindari è citata come castrum.
* 1360, il
possedimento è assegnato a Vinciguerra d'Aragona barone di
Militello regnante Federico IV di Sicilia.
* 1365, le
capitanie e castellanie di Patti, Tindari, Alcara li
Fusi e Sant'Angelo di Brolo sono concesse a vita
a Vinciguerra d'Aragona.
* XV
secolo prima metà, la fortificazione di Tindari è citata come
castello.
* 1409,
l'esistenza di una bombarda di metallo presso la fortezza
consolida l'ipotesi di fortificazione a carattere difensivo.
*
1502 - 1504, scorrerie compiute da Khayr al-Din
Barbarossa col fratello Aruj Barbarossa contro le località
di tutte le coste della Sicilia.
*
1510 - 1512 - 1514, raffica di assalti compiuti da Elias
insieme ai fratelli Khayr al-Din Barbarossa e Aruj
Barbarossa con attacchi sistematici dei porti e delle località
di Lipari e Tindari.

*
1544 luglio, l'assalto dell'armata corsara turco - ottomana capitanata
dall'ammiraglio Khayr al-Din Barbarossa e dal comandante
Rais Dragut futuro successore, insidia la costa tirrenica
siciliana, devasta l'isola di Lipari. Le scorrerie s'inseriscono in un
contesto molto ampio e comprendono il saccheggio della chiesa - fortezza
di Tindari, la distruzione dell'abitato e cittadella fortificata
di Patti, l'incendio della cattedrale di San Bartolomeo e
l'espugnazione di Lipari, l'assedio dell'abitato protetto
dal castello di Santa Lucia del Mela, la minaccia d'assalto
alla cittadella fortificata di Milazzo.
Le continue
incursioni s'inseriscono nel contesto delle dispute sul dominio
nel Mediterraneo tra flotte turco-ottomane contro spagnoli, annosa
questione risolta con la disfatta del fronte orientale nella battaglia
navale di Lepanto del 1571.
*
1552 - 1598, santuario antico, ricostruzione del luogo di
culto. Nel 1558 nel punto più alto della rocca, ove sorgeva la
fortezza, lo storico, archeologo e teologo Tommaso Fazello documenta
la chiesa di Santa Maria de Tindáro.
* 1578, i
cartografi architetti Tiburzio Spannocchi e Camillo
Camilliani documentano la chiesa del Tindaro come una fortezza merlata.
CULTO
DELLA MADONNA NERA
- Le origini della statua bizantina della Madonna
nera del Tindari sono legate ad una leggenda, secondo la quale la
scultura, trasportata per mare, impedì alla nave di ripartire dopo che si
era rifugiata nella baia dei laghetti di Tindari per sfuggire alla
tempesta. La statua aveva lasciato l'Oriente per sfuggire alla persecuzione
iconoclasta.
I
marinai, depositarono a terra via via il carico, pensando che fosse questo
ad impedire il trasporto, e solo quando vi portarono anche la statua, la
nave poté riprendere il mare. La statua è quindi stata portata sul colle
soprastante, dentro una piccola chiesa che dovette in seguito essere più
volte ampliata per accogliere i pellegrini, attratti dalla fama miracolosa
del simulacro.
La
scultura lignea (in cedro del Libano) è orientaleggiante, bizantina, ed è
databile tra la fine del secolo VIII e i primi decenni del secolo IX. La
Madonna è nera, con un caratteristico e originale volto lungo non
facilmente riscontrabile in altre statue religiose, ed è una Theotókos Odigitria rappresentata
come Basilissa ossia come "Regina seduta in trono",
mentre regge in grembo il Bambin Gesù tenendo la mano destra sollevata,
benedicente. In capo regge una corona o un turbante di tipo orientale. Sotto
il trono, la scritta "Nigra Sum Sed Formosa" riprende la frase del Cantico
dei Cantici 1,5, e 1,6, e significa "Sono nera ma formosa"
oppure, meno letteralmente "Sono bruna ma bella".

SANTUARIO
ANTICO - Sono
pochissimi i manufatti risparmiati dalla distruzione araba, alla
devastazione non scampa la chiesa ove probabilmente, sarebbe già stata
portata l'icona. Secondo la tradizione orale il simulacro approda a Oliveri ed
è custodito a Tindari nel periodo in cui la città è dominata dai
Bizantini 535 - 836, mentre in Oriente dilaga la persecuzione iconoclasta opera
dell'imperatore Leone III Isaurico.
*
1544, il saccheggio perpetrato dall'ammiraglio Khayr al-Din Barbarossa e
dal comandante Rais Dragut futuro successore, demolisce
parzialmente il santuario del Tindari, lo priva delle campane ma risparmia
la venerata immagine della Madonna bruna.
*
1552, Bartolomeo Sebastiani vescovo di Patti lo ricostruisce
ampliandolo con l'aggiunta dei locali per l'alloggio del personale addetto
al culto. Sulla bugna-chiave di volta del portale d'ingresso è
scolpito l'anno di completamento 1598.
*
1890-1908, Giovanni Previtera, vescovo di Patti, incrementò il
seminario, instituì ufficialmente il santuario di Tindari, e profuse somme
ingenti per il restauro e l'ampliamento del Santuario di Tindari e del
Palazzo Arcivescovile, trasformò il vecchio Monastero delle Clarisse nel
moderno Istituto della Sacra Famiglia, si adoperò per l'istituzione di
scuole umanistiche, religiose e professionali; fondò, per combattere
l'usura, una Banca Cattolica, fece costruire oratori e ricreatori per la
gioventù, promosse infine e diffuse con il giornale Il Tindari la
stampa cattolica.
*
1925 - 1927, fotografie d'epoca illustrano l'antico santuario come
un complesso fortificato, sulla spianata antistante sono documentate
svariate cappelle votive.
Facciata
- Il rilievo dell'arco del portale è realizzato in bugnato assieme
alla superficie del primo ordine della parete esterna della facciata. Il
secondo ordine è contraddistinto da un finestra circolare sovrastante
l'ingresso. Un timpano triangolare con la dedica "AVE MARIA"
costituisce il terzo ordine.
Semplici
cornici abbelliscono gli ordini inferiori dei campanili. Stelle a otto
punte, ricavate dalla sovrapposizione di quadrati sfalsati, ornano gli
ordini centrali. Al terzo ordine a destra monofore su ogni lato
arricchiscono la cella campanaria, a sinistra un oculo cieco
ospita il quadrante dell'orologio. Cuspidi con base quadrata chiudono il
quarto ordine delle torri, a sinistra è presente un incastellamento
campanario esterno minore.
Sulla controfacciata sormonta
il portale il dipinto raffigurante il Corteo processionale che
accompagna il simulacro dalla spiaggia all'acropoli. É documentato un olio
su tela raffigurante Santa Febronia, Patrona di Patti, condotta in
cielo da un angelo, opera di Guglielmo Borremans.
Santa
Febronia viene istituita Patrona di Patti dal vescovo Giovanni
Previtera.


L'altare
maggiore è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. L'elevazione è
costituita da una doppia coppia di colonne, quelle interne aggettanti
sormontate da timpani a ricciolo simmetrici. Al centro lo stemma con
fregi reca l'iscrizione "VENITE FILII, AVDITE ME, TIMORE DOMINI, DOCEBO
VOS". Temporaneamente l'ambiente ha ospitato il simulacro della
Madonna, oggi è presente la statua del Sacro Cuore di Gesù, al centro
un ricco tabernacolo argenteo. Uno degli ultimi baluardi dei riti
officiati ad orientem terminati con la realizzazione del moderno
altare versus populum.
Nel presbiterio due
quadroni raffigurano rispettivamente: Venerazione dell'icona raffigurante
gli attimi successivi l'apertura della cassa contenente il simulacro; il
recupero raffigurante il salvataggio della cassa con l'ausilio delle
reti dei pescatori.
Navata
destra
- Volta e nicchia contenente la statua raffigurante San
Giuseppe e Gesù fanciullo.
Cappella
di Maria Santissima del Tindari altare dedicato alla Madonna del
Tindari. Animati manufatti in stile barocco con baldacchino in altorilievo
di stucco e colonne tortili. Una prima coppia di putti alati sorreggono
il baldacchino coronato dal quale diparte un manto con motivi fitoformi che
svela la nicchia centrale nella quale è custodita una riproduzione
dell'icona realizzata da Salvatore Rizzuti nel 1997. Una
seconda coppia di putti sostiene e tende il drappeggio allargato e ricadente
in ricche pieghe esaltanti la frangia decorativa, che occupa tutta la parete
creando un effetto scenografico di elevato impatto artistico e visivo. Sulla trabeazione un'altra
coppia d'angioletti regge lo stemma coronato, sulle cimase del timpano a
riccioli, altri putti si protendono verso il soffitto riproducente la volta
celeste con l'enorme raggiera centrale. Un paliotto ad
intarsi marmorei con tre scene abbellisce la mensa. Numerose teste di putto
alate decorano i plinti e l'arco, frequente il tema della
conchiglia allegoria del pellegrinaggio terreno.
Un
varco sul lato sinistro conduce nell'ambiente con finestra sui laghetti,
alle pareti numerosi ex-voto.
Navata
sinistra - Volta
e nicchia contenente la statua marmorea raffigurante Gesù battezzato
da San Giovanni Battista nel fiume Giordano.
Cappella
del Coro: coro e cenotafio.
È
stato ripristinato come il primitivo altare meridionale lato catena peloritana-nebroidea con
sguardo volto idealmente sul mar Tirreno.
Entrambi
i santuari vantano il titolo di «chiese liberiane», appellativo che
affonda le sue origini nei primi secoli della Chiesa ed è strettamente
legato al sorgere della basilica di Santa Maria Maggiore in Roma considerata
il più antico santuario mariano d'Occidente. Precisamente al IV
secolo, sotto il pontificato di papa Liberio. Questa è la tradizione,
anche se non comprovata da nessun documento; le chiese sotto il medesimo
titolo sono dette "liberiane" dal nome del pontefice, dal popolo
sono chiamate familiarmente ad Nives, della Neve.


SANTUARIO
MODERNO - Il
22 gennaio 1943 le strutture del santuario furono requisite dal Regio
Esercito Italiano per essere in seguito occupate dai soldati inglesi, i
quali vi installarono un ospedale militare.
*
1953-1977, il santuario esistente è diventato insufficiente ad accogliere i
pellegrini. È individuata la soluzione più idonea per la nuova costruzione
senza compromettere l'esistenza dell'antica chiesetta.
* 1957 8
dicembre, posa della prima pietra proveniente dagli scavi archeologici e
benedetta da papa Pio XII il 30 dicembre 1956.
* 1975 6
settembre, monsignor Giuseppe Pullano benedice l'interno del nuovo
santuario, l'icona della Madonna è portata nel nuovo tempio e collocata sul
monumentale altare.
* 1979 1º
maggio, consacrazione e dedicazione del nuovo santuario da parte del
cardinale Salvatore Pappalardo, assistito dal vescovo di Patti Carmelo
Ferraro.
* 2018 30
luglio, con decreto della Congregazione per il Culto divino e la
disciplina dei Sacramenti n. 297/18, il Santuario è elevato a Basilica
Pontificia Minore (la notizia è stata resa nota l'8 settembre dello
stesso anno, in occasione dei tradizionali solenni festeggiamenti).

Il santuario ha
pianta a sviluppo basilicale, a croce latina, a tre navate, con transetto quadrato
e abside semicircolare. La chiesa è lunga 64 metri e larga 24. Il
basamento è in marmo di billiemi, le falde della copertura sono
rivestite di ceramiche azzurre. Sul fianco settentrionale, adiacente alla
navata sinistra, è costruito un loggiato lungo 76 metri e largo
8, che permette di ammirare il panorama dei laghetti di Marinello. Sotto il
loggiato è ricavato un ampio locale che, collegato alla cripta, forma
la penitenzieria del santuario.
Facciata
- La facciata con la parte centrale costituita da un corpo avanzato si
innalza sulla piazza antistante rivolta a occidente, la sopraelevazione
costituisce lo sviluppo della torre campanaria. Le porte sono in bronzo, ai
lati del portone centrale sono collocate, in apposite nicchie, le statue
raffiguranti San Pietro e San Paolo.
L'accesso
al santuario è garantito da un atrio decorato da vetrate istoriate, in esse
sono raffigurate le figure allegoriche delle virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza.
Le virtù teologali sono riprodotte sui varchi d'accesso: Fede entrata
sinistra, Carità varco centrale, Speranza ingresso
destro.
Organo
- Nella tribuna interna ricavata in prossimità dell'atrio è
installato un grande organo a canne.
Navata
centrale
-
La navata centrale è delimitata da colonne ottagonali
con basi di marmo bianco, sulla volta è incollata una tela di 75 m²
raffigurante Il trionfo della Madonna opera del pittore Fausto
Conti. Ai vertici della volta della navata centrale angeli sorreggono dei cartigli con
le frasi salienti tratte dal cantico del Magnificat: MAGNIFICAT
ANIMA MEA DOMINUM - BEATAM ME DICENT OMNES GENERATIONES - QVIA
FECIT MIHI MAGNA, QVI POTENS EST - ....
Dello
stesso autore l'affresco della cupola. Sulle pareti esterne delle campate
delle navate laterali, realizzati in grandi mosaici su cartoni del pittore
romano Fausto Conti, sono rappresentati i Misteri del Rosario.
Il tondo
mosaico dell'arcata d'ingresso raffigura San Michele Arcangelo. Nelle
vetrate è raffigurata l'allegoria della Carità attorniata da
schiere d'angeli.
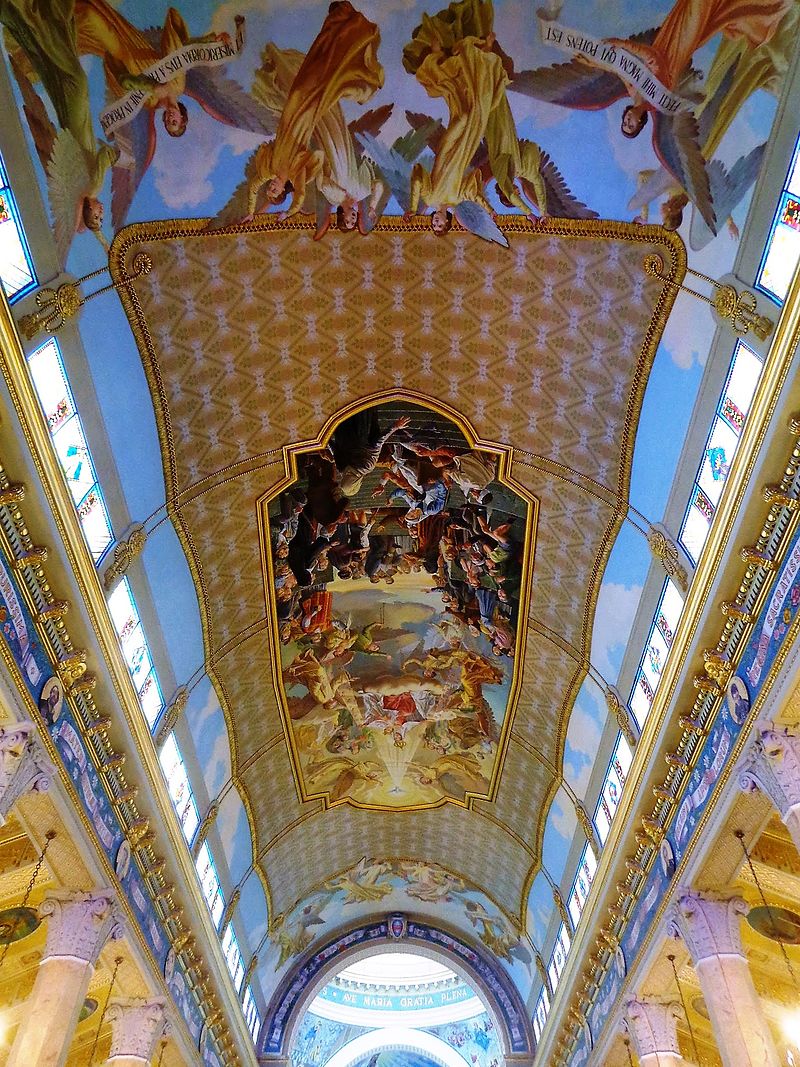
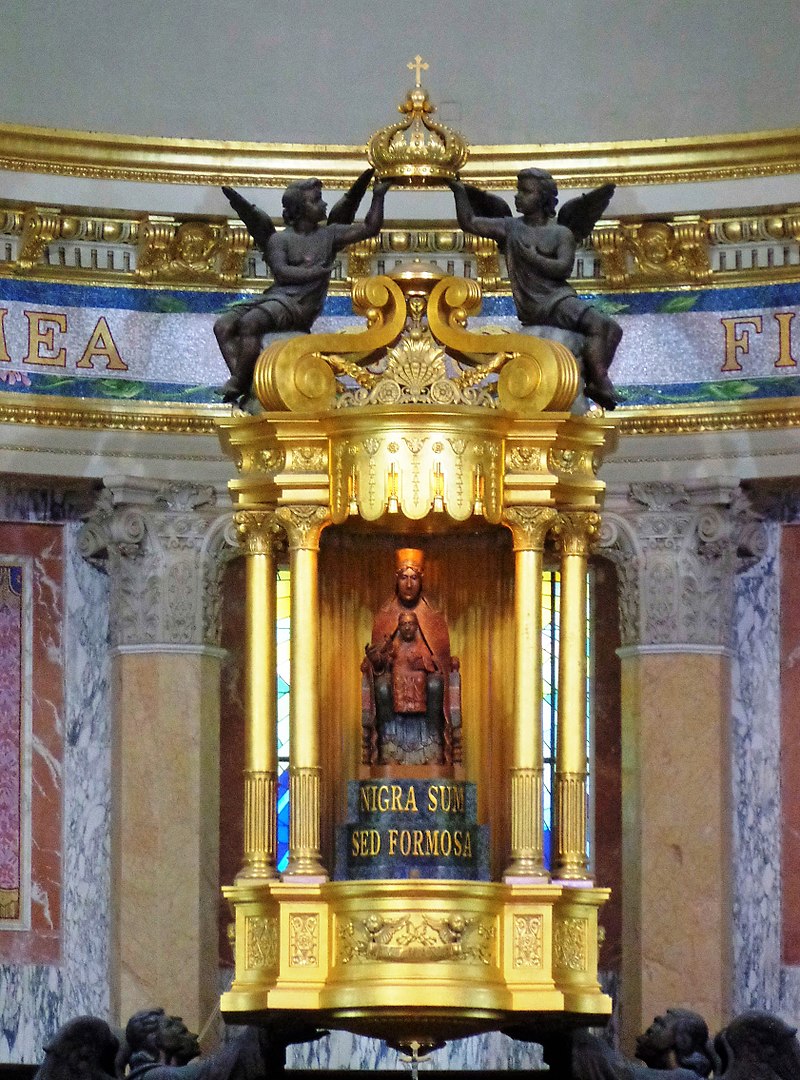
Altare
-
Il grande altare al centro del transetto, poggia su stipiti di
marmo giallo, sotto la mensa è posta una scultura in marmo bianco
raffigurante l'Ultima Cena. Sotto la cupola troneggia il dinamico e
artistico altare su cui è collocata l'immagine della Madonna del Tindari in
trono. Collocati su basi di bronzo raffiguranti nuvole, si ergono quattro
maestosi angeli bronzei in posizione eretta con mani protese, sorreggono una
bussola in cristallo contenente il simulacro della Madonna. Un'altra coppia
in posizione più avanzata regge il tabernacolo, l'angelo di destra è
genuflesso.
Dietro il
colonnato dell'abside, costituito da un ampio emiciclo, le cui pareti sono
decorate da mosaici (realizzati dalla scuola del mosaico di Montepulciano su
cartoni del pittore Fausto Conti) raffiguranti i momenti più salienti della
storia del santuario:
* Naufragio
dell'imbarcazione e il recupero dell'icona, evento documentato nel IX
secolo.
*
Intronizzazione della statua nel primitivo tempio pagano.
* Statua
della Madonna indenne dopo l'assalto dei pirati, episodio del 1544.
* Consegna
delle chiavi da parte dei giurati della città di Patti, evento del 1669.
*
Incoronazione della Vergine, una delle tre incoronazioni documentate nel 1886,
nel 1901 e nel 1940.
*
Processione nella diocesi.

Area
archeologica
I resti
della città antica si trovano nella zona archeologica, in discreto
stato di conservazione, per lo scarso interesse di un reimpiego dei blocchi
di pietra arenaria di cui erano costituiti.
I primi
scavi si datano al 1838-1839 e furono ripresi tra il 1960 e
il 1964 dalla Soprintendenza archeologica di Siracusa e ancora nel 1993, 1996 e 1998 dalla
Soprintendenza di Messina, sezione dei beni archeologici. Sono stati
rinvenuti mosaici, sculture e ceramiche, conservati in parte presso il museo
locale e in parte presso il Museo archeologico regionale di Palermo.
L'impianto urbanistico,
risalente probabilmente all'epoca della fondazione della città, presentava
un tracciato regolare a scacchiera. Si articolava su tre decumani,
strade principali (larghezza di 8 m), correvano in direzione sud-est -
nord-ovest, ciascuno ad una quota diversa, e si incrociavano ad angolo retto
e a distanze regolari con i cardini, strade secondarie e in pendenza
(larghezza 3 m). Sotto i cardini correva il sistema fognario della
città, a cui si raccordavano le canalizzazioni provenienti dalle singole
abitazioni. Gli isolati delimitati dalle vie avevano un'ampiezza di circa 30 m
e una lunghezza di 77 o 78 m.
Uno dei
decumani rinvenuti nello scavo, quello superiore doveva essere la strada
principale della città: costeggia ad una estremità il teatro, situato
più a monte e scavato nelle pendici dell'altura, e all'altra estremità
sfocia nell'agorà, oltre la quale, nella zona più elevata, occupata oggi
dal Santuario della Madonna Nera, doveva trovarsi l'acropoli.

Le
mura di cinta - Le
mura cittadine, i cui resti attualmente visibili sono dovuti ad una
ricostruzione del III secolo a.C. che ripercorre una cinta
precedente, probabilmente coeva alla fondazione, venne completata sul lato
verso il mare e rimaneggiata in epoca tardo imperiale e bizantina.
La cinta si
sviluppava per una lunghezza di circa 3 km ed era della tipologia
"a doppia cortina, con due muri paralleli (circa 0,70 m di
spessore) in opera quadrata di arenaria con disposizione isodoma,
separati da uno spazio, in origine riempito con terra o sassi (2,10 m
di spessore), raggiungendo un'altezza di 6,85 m. A distante diseguali
si innalzavano torri quadrate: una di queste (spazio interno di
6,5 x 5,15 m e con muri larghi 0,43 m e lunghi 0,87 m)
conserva un tratto della scala che portava alla sommità delle mura.
La porta
principale, sul lato sud-occidentale, era fiancheggiata da due torri e
protetta da un'antiporta a tenaglia di forma semicircolare, con l'area
interna lastricata con ciottoli. Altri piccoli passaggi si aprivano a fianco
delle torri della porta maggiore e venivano utilizzate per le sortite dei
difensori.


Il
teatro - Il teatro venne
costruito in forme greche alla fine del IV secolo a.C. e in
seguito rimaneggiato in epoca romana, con una nuova decorazione e
l'adattamento a sede per i giochi dell'Anfiteatro.
Rimasto a
lungo in abbandono e conosciuto solo per le illustrazioni del XIX
secolo era appoggiato alla naturale conformazione a conca della
collina, nella quale furono scavate le gradinate dei sedili (0,40 m di
altezza e 0,70 m di profondità) della cavea, che doveva
raggiungere una capienza di circa 3000 posti. In età romana vi si
aggiunse un portico in opera laterizia e la
ricostruzione della scena, di cui restano solo le fondazioni e un'arcata,
restaurata nel 1939. L'orchestra venne trasformata in un'arena,
circondando la cavea con un muro e sopprimendone i quattro gradini
inferiori.
Dal 1956 vi
ha sede un festival artistico che annovera tra le manifestazioni danza, musica,
e ovviamente teatro.
Isolato
romano - Nell'area
urbana è stata scavata, tra il 1949 ed il 1964, un isolato
completo (insula IV), delimitato dai tratti dei due decumani scavati e da
due strade secondarie. A causa della pendenza del terreno, i diversi edifici
che la compongono erano costruiti su terrazze a diversi livelli.
Sul
decumano inferiore si aprivano sei tabernae, o ambienti per il
commercio, tre delle quali erano dotate di retrobottega. Su queste poggiava
un'ampia domus (casa B) con peristilio a dodici colonne
in pietra con capitelli dorici. Il tablinium, o salone
(lunghezza 8 m e larghezza 4,60 m). Al livello più alto una
seconda domus, "casa C", con peristilio simile alla
precedente, presenta l'accesso al tablinio inquadrato da colonne con
capitelli corinzi italici in terracotta e basi
realizzate con mattoni di forma rotonda.
Le due case
vennero costruite nel I secolo a.C., su precedenti fasi abitative e
furono soggette a restauri e rimaneggiamenti: in particolare nella parte
superiore si impiantarono delle piccole terme e gli originali
pavimenti scutulati (scutulata con inserimento di piccole lastre di
marmi colorati) o in signino con inserimento di tessere di mosaico
bianche, o ancora con mosaici policromi, si sostituirono mosaici
in bianco e nero con figure.


Basilica
- La cosiddetta
"Basilica", in passato identificata anche con un ginnasio, è
un propileo di accesso all'agorà, situato nel punto in cui vi
entra il decumano massimo, la via principale della città. Si tratta di un
edificio a due piani, datato al IV secolo costruito in opera
quadrata di arenaria che presenta un ampio passaggio centrale
con volta a botte ripartito da nove arcate. Ai lati altri archi scavalcano
degli accessi secondari.
Statua
di Mercurio - Statua
collocata nel Ginnasio e citata nell'orazione di Cicerone "...
l'Africano ti aveva voluto nel ginnasio di Tindari, come protettore e
custode della sua gioventù ...".
La statua
donata da Scipione l'Africano, sottratta dai Cartaginesi e restituita
alla città da Scipione Emiliano per essere ricollocata nella
primitiva sede, è oggetto di reiterati bottini di guerra, come del resto
numerosi altri capolavori d'arte sparsi nei vari centri dell'isola.
Il propretore Gaio
Licinio Verre la fece asportare durante il suo mandato
dal 73 al 71 a.C. per adornare la sua dimora a
Messina. Il funzionario artefice di innumerevoli ingiustizie, bramoso
di potere, avido di possesso, mirò ad accrescere le sue ricchezze
personali. Compì concussioni, saccheggi e ruberie, pratiche piuttosto
comuni nel periodo, per le quali, accusato di corruzione e
illeciti arricchimenti, fu denunciato dai siciliani. Non bastò l'illecito
sopruso, come aggravante fece bastonare il magistrato Sopatro che si
opponeva all'atto illegale. La popolazione tindaritana reclamò allora
direttamente a Roma, chiamando in causa Marco Tullio
Cicerone quale difensore pubblico, che pronunciò contro Verre una
delle sue orazioni più famose (Verrine), tanto che questi fu
costretto, per sentenza del senato a lasciare l'isola e la carica di
pretore.
Il console
Cicerone, durante la sua visita a Tindari, effettuata per indagare sulle
malefatte di Verre, giudicò la città così prospera e bella che le diede
l'appellativo di "nobilissima civitas".
Tempio
di Venere Ericina - Al
termine delle guerre puniche Tindari è fra le 17 città siciliane
alleate e fedeli a Roma autorizzate a portare una corona a Venere
Ericina.
Erice figlio
di Bute, uno degli argonauti di Giasone, e
di Afrodite, fondò la città di Erice e in essa edificò un
tempio dedicato alla madre. Il culto della Venere ericina, praticato dai
marinai di passaggio, la cui devozione era fondata sulle bellissime ierodule,
giovani prostitute sacre alla dea dispensatrice di voluttà. Infatti
nella elima Erice, ancora prima che
i Fenici innalzassero un tempio ad Astarte, era noto il culto ed
il tempio dedicato a Venere Ericina, altrimenti noto come il luogo della dea
dell'amore. La fama e la ricchezza della colonia ericina crebbero in
funzione della diffusione del culto praticato a Roma ed esteso in molte
colonie dell'impero.

Patti
Tuttavia il
fascino pur innegabile di Tindari non può offuscare quello della vicina
Patti, che viene attestata per la prima volta in un documento del 1094,
quando Ruggero I di Sicilia vi fondò il monastero dedicato al Santissimo
Salvatore, affidato ai monaci benedettini, l'attuale Cattedrale di San
Bartolomeo: il sarcofago della regina Adelasia del Vasto (1074-1118), moglie
di Ruggero, è ospitata nella Cappella in marmo policromo di Santa
Febronia.
La
Basilica, con il prospetto di origine normanna, derivò dall'ampliamento di
una precedente abbazia bizantina. A testimoniare le origini più antiche del
centro sono però diversi ritrovamenti archeologici, tra cui in particolare
quello effettuato nel 1973, durante i lavori di costruzione di un tratto di
autostrada: ne emerse la Villa Romana di Patti, databile al IV secolo, una
delle testimonianze antiche più interessanti di questa parte di Sicilia.
Nonostante
questa abbondanza di ricchezze storiche e artistiche, è innegabile che la
notorietà di Patti e Tindari sia legata in larga parte alle bellezze
naturalistiche della zona. Lungo la costa, punteggiata di grotte, faraglioni
e ampie spiagge balneabili, si trovano infatti, tra gli altri, i 400
splendidi ettari della Riserva naturale orientata Laghi di Marinello.
Alla base
del promontorio si trova una zona sabbiosa con una serie di piccoli specchi
d'acqua, la cui conformazione si modifica in seguito ai movimenti della
sabbia, spinta dalle mareggiate. La spiaggia è conosciuta con il nome di Marinello o il
mare secco e vi sono legate diverse leggende.
Secondo una
di esse la spiaggia si sarebbe formata miracolosamente in seguito alla
caduta di una bimba dalla terrazza del santuario, ritrovata poi sana e salva
sulla spiaggia appena creatasi per il ritiro del mare. La madre della
bambina, una pellegrina giunta da lontano, in seguito al miracolo, si
sarebbe ricreduta sulla vera natura miracolosa della scultura, della quale
aveva dubitato a causa dell'incarnato scuro della Vergine.
Un'altra
leggenda narra della morte, avvenuta proprio su questa spiaggia di papa
Eusebio, il 17 agosto del 310, pochi mesi dopo la sua elezione,
avvenuta il 18 aprile, che sarebbe stato esiliato in Sicilia da Massenzio.
I laghetti
di Marinello sono parte del magnifico panorama che ispirò a Salvatore
Quasimodo la celebre Vento a Tindari. Originatisi tra il 1865 e il
1895 per l'azione combinata di mare, agenti atmosferici e processi
tettonici, rappresentano uno dei pochi ambienti salmastri giunti al giorni
nostri della Sicilia nordorientale e dal 1998 sono Riserva naturale.
Secondo la
leggenda, nella Grotta di Donna Villa, splendida cavità naturale a picco
sul mare in prossimità dei laghi, viveva una maga che attirava col suo
canto i marinai e poi li divorava, se le sfuggivano, si sfogava artigliando
le pareti: le impronte sarebbero ancora visibili.

|