|
Definita
la "capitale del Barocco", nel 2002 il suo centro
storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità da parte
dell'UNESCO, insieme con le altre città tardo barocche del Val di
Noto.
Il
sito originario della città, Noto antica, si trova 8 km più a
nord, sul monte Alveria. Qui si ritrovano i primi insediamenti umani, che
risalgono all'età del Bronzo Antico o Castellucciana (2200-1450 a.C.),
come testimoniato dai reperti archeologici rinvenuti. Secondo un'antica
leggenda, Neas, che sarebbe stato il nome della Noto più
antica, avrebbe dato i natali al condottiero siculo Ducezio, che nel V
secolo a.C. avrebbe difeso la città dalle incursioni greche. Questi la
trasferì dall'altura della Mendola al vicino monte Alveria, circondato da
profonde valli, in una delle quali scorre la fiumara di Noto. Ben presto Neas
o Neaton, ormai ellenizzata nei costumi, entrò a far parte della sfera
d'influenza siracusana.
Secondo Polibio e Tito
Livio, Neaton fu una colonia siracusana durante il regno di Gerone
II, riconosciuta nel 263 a.C. dai Romani con un trattato di pace.
Il Ginnasio, le mura megalitiche e gli Heroa ellenistici convalidano le
ipotesi degli storici.
Nel
214 a.C. circa, Neaton aprì le sue porte all'esercito del
console romano Marco Claudio Marcello, e venne così riconosciuta come
città alleata dai Romani (che la chiamavano Netum) come Taormina e Messina.
In quanto tale i Romani concessero ai netini un proprio senato, tanto che
ancora oggi, nei palazzi e nei portali risulta presenta la scritta SPQN (Senatus
PopulusQue Netinus). Subì, come le altre città isolane, le vessazioni
di Verre, descritte da Marco Tullio Cicerone.
 Durante
il periodo tardo-romano nella sua zona fu costruita la Villa Romana del
Tellaro (IV secolo). Dopo l'occupazione della Sicilia (535-555 circa)
da parte delle legioni bizantine dell'Imperatore Giustiniano, il
territorio di Noto fu arricchito di monumenti, come la basilica di Eloro e
la Trigona di Cittadella dei Maccari, l'Oratorio della Falconara e la Cripta
di S. Lorenzo Vecchio, il Cenobio di S. Marco, il Villaggio di contrada
Arco. Durante
il periodo tardo-romano nella sua zona fu costruita la Villa Romana del
Tellaro (IV secolo). Dopo l'occupazione della Sicilia (535-555 circa)
da parte delle legioni bizantine dell'Imperatore Giustiniano, il
territorio di Noto fu arricchito di monumenti, come la basilica di Eloro e
la Trigona di Cittadella dei Maccari, l'Oratorio della Falconara e la Cripta
di S. Lorenzo Vecchio, il Cenobio di S. Marco, il Villaggio di contrada
Arco.
Nell'864 Noto
fu occupata dagli Arabi del ras Khafaja ben Sufyan, che la
fortificarono. Data l'importanza attribuita alla città dagli Arabi, Noto
divenne, nel 903, capovalle e il suo territorio registrò la
razionalizzazione dell'agricoltura e la promozione dei commerci. Fu
insediata anche l'industria della seta, sfruttando la presenza di gelsi nel
territorio.
Si
registra a Noto, come in molte altre città siciliane delle stesso periodo,
la presenza di una notevole comunità ebraica, attestata anche da alcune
grotte quali, a Noto Antica, la Grotta del Carciofo.
Nel 1091 Noto
fu occupata dal Gran Conte Ruggero d'Altavilla, e venne infeudata al
figlio Giordano, che iniziò la costruzione del castello e delle chiese
cristiane. Durante il regno dell'imperatore Federico II di Svevia, a
Noto, governata dal conte Isinbardo Morengia, fu eretto il
monastero cistercense di Santa Maria dell'Arco.
Durante
il periodo angioino, il 2 aprile 1282, Noto partecipò all'insurrezione
dei Vespri Siciliani. Nel 1299, durante la guerra per il possesso
della Sicilia tra Federico III d'Aragona e Carlo II d'Angiò, il castellano
di Noto Ugolino Callari (o di Callaro) si ribellò al primo passando dalla
parte di quest'ultimo, e consegnò la città all'esercito di Roberto
d'Angiò, figlio di Carlo II.
Tornata
sotto il dominio aragonese, Noto fu poi governata da Guglielmo Calcerando.
Sotto il regno di Alfonso V d'Aragona fu Viceré di Sicilia Niccolò
Speciale, netino, che diede un importante contributo allo sviluppo della
città, governata al tempo dal duca Pietro d'Aragona, fratello del re.
Il
duca fece edificare nel 1431 la Torre Maestra del Castello di Noto
Antica. Nel 1503, per intervento del vescovo Rinaldo Montuoro Landolina,
il re Ferdinando II d'Aragona conferì conferì a Noto il titolo
di "Città ingegnosa" per i tanti personaggi che nel Quattrocento
si distinsero nel campo dell'Arte, delle Lettere e della Scienza, come
Giovanni Aurispa, Antonio Cassarino, Antonio Corsetto, Andrea Barbazio e
Matteo Carnalivari.
Nel 1542 il
Viceré Ferrante Gonzaga fortificò le mura della città.
Il
terremoto del 1693 distrugge completamente la città. Per la ricostruzione
viene scelto un luogo meno impervio e più vasto, che permetta la
realizzazione di un impianto semplice, lineare, con intersezioni ad angolo
retto e strade parallele ed ampli come vuole il nuovo gusto barocco. Tre le
strade principali che corrono da est a ovest perché il sole le illumini
sempre.
Padre
Angelo Italia posò il pennino e si passò
le mani sul viso. Erano ore che disegnava corsi, vie, piazze, e i suoi occhi
non erano più quelli di una volta. "D'altra parte", borbottò fra
sé, "ho 72 anni, alla mia età non dovrei stare seduto così a
lungo". Si alzò e andò alla finestra.
Era una bella giornata di
novembre, serena e brillante come lo sono spesso i giorni d'inverno in
Sicilia. Doveva andare al cantiere della nuova Noto, ecco cosa doveva fare.
Risoluto, raccolse intorno a sé le pieghe della lunga tonaca da gesuita e
uscì dalla stanza, chiamando a gran voce il servitore, che gli facesse
preparare la carrozza.
Quando
giunse nel cuore di quella che sarebbe diventata una città,
proprio di fronte all'abbozzo della futura cattedrale, vide l'ingegnere del
re di Spagna, il generale Carlos de Grunenbergh, venirgli incontro con un
sorriso soddisfatto: i lavori procedevano a dovere. Insieme entrarono nella
baracca dove, su un tavolo, erano stesi i disegni a cui avevano lavorato, e
padre Angelo li sfiorò appena con i polpastrelli: Noto, la sua creatura.
"E di de Grunenbergh", soggiunse fra sé, pentendosi subito di
quel moto di superbia.

Il
progetto era splendido, con la perfetta griglia di strade adagiata tra il
pendio e il pianoro del Meti, il colle scelto per ricostruire la città distrutta dal terribile terremoto del 1693.
Sulla carta lo sguardo poteva seguire le direttrici parallele e immaginare
il susseguirsi di chiese e palazzi che le avrebbero rese preziose. E poi le
piazze, da arredare con la vivace grammatica del barocco come fossero
eleganti salotti, le vie minori e i vicoli a incorniciare la stretta
ragnatela delle case del popolo. Al centro quasi geometrico di tutto, lungo
il corso principale, il grande palcoscenico che avrebbe visto sorgere la
chiesa madre, futura cattedrale, in vetta a un'ampia scalinata, il palazzo
Vescovile, quello della famiglia Landolina e, proprio dirimpetto, palazzo
Ducezio.
Il
duca Giuseppe Lanza, plenipotenziario del re di Spagna incaricato della
ricostruzione del vai di Noto dopo il terremoto, aveva dato loro carta
bianca, ordinando solo che Noto, la città più importante,
risorgesse più bella di prima. Per questo padre Italia e il generale
avevano lasciato che le scomposte rovine di Noto antica, sul monte Alveria,
si ricoprissero d'erba e avevano scelto un altro sito per la nuova città,
attingendo ai fondi stanziati dal re di Spagna. Il re stesso aveva dato
l'incarico a de Grunenbergh e il fiammingo stava tutto il giorno al
cantiere, dando addosso agli operai e agli scalpellini e litigando con gli
architetti che disegnavano chiese, palazzi, conventi.
Noto
cresceva elegante, regale, ricca di simbolismi eppure funzionale. Le sedi
del potere religioso accanto a quelle del potere civile, le abitazioni
aristocratiche immerse nel tessuto connettivo di quelle popolari: tutto
perfettamente disposto, come in una scenografia teatrale, ben visibile fin
da lontano a chiunque si approssimasse alla città.
A dare colore era la splendida pietra calcarea color miele estratta dalle
colline dei dintorni, docile ai capricci di quel barocco che gli
architetti avevano deciso di declinare in maniera così particolare, unendo a
canoni ben definiti elementi rinascimentali e spagnoleschi, alternando puri
divertimenti decorativi a dotte citazioni tratte dai palazzi romani, dalle
opere del Vignola e di Michelangelo. Di fatto, in questo modo si creò uno
stile del tutto nuovo e unico, ornamentale ma non privo di richiami alla
classicità.
Purtroppo,
Angelo Italia non riuscì a vedere ultimata la sua
creatura perché morì poco dopo aver consegnato gli ambiziosi progetti.
D'altra parte, sarebbe stato comunque impossibile: ci vollero circa cento
anni per costruire tutto quanto e via via che le opere venivano terminate,
le precedenti cominciavano a dare segni di invecchiamento.

Nell'Ottocento,
con la nuova riforma amministrativa, Noto perse il ruolo di capovalle, che
passò a Siracusa. Tuttavia nel 1837, a causa del moto carbonaro
di Siracusa, Noto divenne capoluogo di provincia, e nel 1844 anche
centro di una diocesi. Nel 1848 scoppiò la Rivoluzione siciliana
indipendentista e Noto vi partecipò, la rivolta venne repressa l'anno
successivo e il netino Matteo Raeli, ministro del governo
rivoluzionario, andò in esilio a Malta.
Nel 1861 Noto,
dopo la Spedizione dei Mille, entrò a far parte del Regno
d'Italia, conservando inizialmente il titolo di capoluogo di provincia, poi
trasferito a Siracusa nel 1865. Nel 1870 fu inaugurato il
Teatro Comunale; l'esiliato Matteo Raeli fu nominato ministro di Grazia e
Giustizia e dei Culti della nuova nazione. Intorno al 1880 a Noto fu
edificata la stazione ferroviaria.
Dopo
la seconda guerra mondiale iniziò il processo migratorio verso le regioni
settentrionali d'Italia, la Germania, la Francia, il Belgio, l'Argentina,
gli USA e il Canada e la città di Noto conosce qualche decennio di
decadenza. Nel 1977 si tenne a Noto un convegno “Simposio
sull'architettura di Noto”, organizzato da regista Corrado Sofia e
dall'allora sindaco Alberto Frasca (PCI), tale simposio portò
all'attenzione di vari studiosi, tra i quali André Chastel e Cesare
Brandi, il problema del barocco netino, determinando un rinnovato interesse
per la città e la sua storia millenaria.
Negli
ultimi anni si è registrata una ripresa economica, dovuta alla sviluppo del
turismo, che rappresenta la principale risorsa della città barocca. Il 13
marzo del 1996 la cupola della Cattedrale crolla a causa
di un difetto di costruzione e del sovraccarico strutturale determinato
dalla costruzione di un solaio in cemento sopra la navata centrale. La città
è stata inserita nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2002.
A conclusione di un lungo e complesso restauro, la chiesa è stata riaperta
dopo undici anni di lavori 18 giugno 2007.
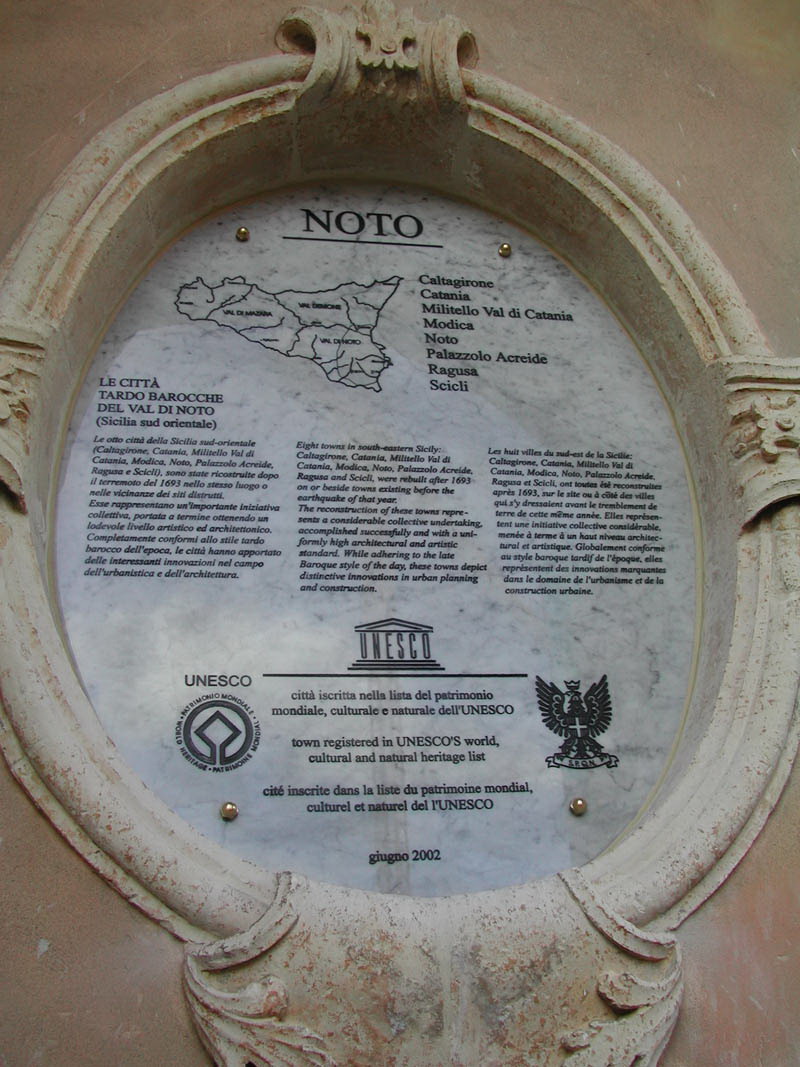 Simboli
- Antico simbolo della città era probabilmente il toro: ad avvalorare
questa tesi, peraltro sostenuta da diversi studiosi siciliani, sarebbe
un'antica medaglia raffigurante un toro ritto su due zampe con l'incisione
S.P.Q.N., di cui si sono perse le tracce. Durante il regno di Ferdinando
il Cattolico, insignita del titolo di urbs ingegnosa, la città ebbe il
proprio stemma ufficiale, che consisteva in uno scudo crociato bianco e
rosso/amaranto nei cui lati si trovava (su sfondo bianco) a volte
l'incisione Netum · urbs · ingegnosa · et · vallis · caput, altre volte
semplicemente S.P.Q.N. Simboli
- Antico simbolo della città era probabilmente il toro: ad avvalorare
questa tesi, peraltro sostenuta da diversi studiosi siciliani, sarebbe
un'antica medaglia raffigurante un toro ritto su due zampe con l'incisione
S.P.Q.N., di cui si sono perse le tracce. Durante il regno di Ferdinando
il Cattolico, insignita del titolo di urbs ingegnosa, la città ebbe il
proprio stemma ufficiale, che consisteva in uno scudo crociato bianco e
rosso/amaranto nei cui lati si trovava (su sfondo bianco) a volte
l'incisione Netum · urbs · ingegnosa · et · vallis · caput, altre volte
semplicemente S.P.Q.N.
Il
suddetto stemma rimase in vigore fino a pochi anni dopo l'unità d'Italia
(tant'è che tutt'oggi possibile vederlo sui prospetti di diversi monumenti
cittadini, come il municipio e la Cattedrale), quando, sulla scia di altri
comuni siciliani e, in particolare, siracusani, fu adottato lo scudo sabaudo
con l'aquila coronata, con l'antico scudo crociato (seppur modificato) posto
sull'addome del rapace. Solo alla fine dell'XIX secolo, per volere del
marchese del Castelluccio, fu aggiunta la dicitura S.P.Q.N. in ricordo degli
antichi fasti.
Le
vie della città sono intervallate da scenografiche piazze e imponenti
scalinate che raccordano terrazze e dislivelli. L'unitaria ricostruzione
produsse un tessuto urbano coerente e ricco di episodi architettonici. Venne
utilizzata la tenera pietra locale, di colore tra il dorato e il rosato,
riccamente intagliata. La ricostruzione avvenne unitariamente sotto la guida
del Duca di Camastra, che rappresentava a Noto il Viceré
spagnolo.
A
differenza di quanto accadde di solito nelle costruzioni barocche delle
province del Sud Italia, come soprattutto a Lecce e, in Sicilia, a Catania,
gli architetti che lavorarono a Noto non puntarono tutto sui motivi
ornamentali, i quali restano sempre ben controllati, senza squilibri
rispetto alle architetture nelle quali sono inseriti. Inoltre, gli
architetti attivi a Noto, Rosario Gagliardi, Vincenzo Sinatra e
Paolo Labisi, si impegnarono anche nella realizzazione di architetture
elaborate, con l'impiego di facciate concave (come nella chiesa del Carmine
o in quella di San Carlo Borromeo al Corso), convesse (come la chiesa
di San Domenico) o addirittura curvilinee, come nella torre campanaria del
seminario.
Il
barocco di Noto pervade l'intera città: gli elementi barocchi non sono
isolati all'interno di un contesto urbano caratterizzato da diversi stili,
ma sono collegati tra di loro in modo da realizzare quella che è stata
definita la "perfetta città barocca". A tal proposito Ugo
Ojetti sostenne: «Noto ai primi del Settecento è una delle nostre città
sorte d'un colpo, pel fatto sembra d'una volontà sola, immagine precisa del
gusto d'un'epoca. A visitarla, palazzi, chiese, conventi, teatro pare un
monumento unico, tutto costruito nello stesso tufo giallo, nello stesso
barocco, come dice bene il Fichera, fiammeggiante, con una grandiosità
senza pause e una regalità senza avarizia».
Dell'impegno
degli architetti netini per la creazione di grandi scenografie, in un'ottica
barocca pienamente consapevole e non provinciale, si accorse pure un maestro
dell'immagine come Michelangelo Antonioni, il quale in una scena de L'Avventura,
girata a Noto, fa dire al protagonista, interpretato da Gabriele
Ferzetti, intento ad ammirare la città dalla terrazza del campanile della
chiesa di San Carlo al Corso: «Ma guarda che fantasia, che movimento. Si
preoccupavano degli effetti scenografici. Che libertà straordinaria!»
Perla
del Barocco siciliano
La
prima cosa che ci colpisce di Noto è la materia di cui è fatta, una pietra
calcarea, tratta dai vicini monti Iblei, capace di assumere sfumature di
colore diverse secondo la luce del giorno. E poi i numerosi conventi, le
chiese, i palazzi nobiliari: camminare nel suo centro storico significa
posare a ogni passo lo sguardo su architetture di rara bellezza e
grazia.
Partiamo
dalla piazza centrale, in cui la grande cattedrale si contrappone
alla leggera loggetta del Palazzo Ducezio, sede del Comune. Da lì,
basta un breve cammino per incontrare due capolavori del grande architetto
Rosario Gagliardi: l’intima bellezza della chiesa di Santa Chiara,
con il suo zampillare di decorazioni delicate in un interno vestito da
preziosi stucchi, frutto di un alto artigianato, e la chiesa di San
Domenico che mostra una tra le più belle facciate di tutta la cultura
architettonica tardo barocca.
Molti
poi sono i palazzi che, magari per anni abbandonati a causa dei costi
proibitivi della loro ristrutturazione, sono stati di recente restituiti a
nuova vita. È il caso di Palazzo Nicolaci, residenza nobiliare
urbana della famiglia omonima, risalente ai primi decenni del Settecento
che, con i suoi novanta ambienti, è stato acquistato dal Comune di Noto.
Ancora
una volta opera dell’architetto Gagliardi, Palazzo Nicolaci comincia a
stupirci fin dall’esterno dove, sotto i balconi della facciata, domina una
fila di mensole, sulle quali una serie di figure, scolpite in pietra,
racconta, come in un grande spettacolo, storie con protagonisti fantastici o
grotteschi come sirene, leoni, sfingi, ippogrifi, cavalli alati e angeli. Un
vero racconto di avventura, immobile nei secoli eppure pieno di vita. Ancora
più affascinante è il salone delle feste: se alziamo lo sguardo al
soffitto, totalmente affrescato, possiamo “leggere” l’allegoria del
carro di Apollo che insegue l’Aurora, una copia dell’originale del
pittore e incisore italiano seicentesco Guido Reni.
Così
tanta arte in un piccolo spazio è giustificata dal desiderio
di rinascita di una città, anzi di un’intera zona che sembrava in
ginocchio: il devastante terremoto del 1693, infatti, rase al suolo circa
sessanta centri urbani del sud-est siciliano provocando oltre cinquantamila
vittime. Una tragedia cui seguì però una reazione altrettanto potente: le
popolazioni colpite, abbandonate le vecchie strutture medievali, puntarono
sul nuovo, sul moderno. E in quegli anni, il nuovo era proprio il barocco.
Così, in Sicilia, passato e futuro si incontrano, si compenetrano, si danno
a vicenda forza e magia.
Cattedrale

La cattedrale
di San Nicolò è il luogo di culto cattolico più
importante della città di Noto, nonché sede vescovile dell'omonima
diocesi, in Sicilia. È ubicata sulla sommità di un'ampia scalinata,
sul lato nord di piazza Municipio (area domus-ecclesiae), ed è
dedicata a san Nicolò, vescovo di Mira.
La
costruzione del tempio iniziò nel 1694, e fu completata nel 1703,
anno in cui fu aperta al culto con la solenne dedicazione. Nel corso dei
secoli, tuttavia, sia la facciata che l'interno hanno subito numerosi
rimaneggiamenti, che le hanno conferito l'aspetto attuale solamente alla
fine del XIX secolo, con l'erezione della nuova cupola, opera del
netino Cassone.
L'interno,
a tre navate, custodisce numerose opere d'arte, alcune delle quali
provenienti da Noto Antica, fra le quali l'urna argentea contenente le
spoglie mortali di san Corrado Confalonieri. Il disastroso crollo del 1996,
tuttavia, ha causato la perdita dell'intero apparato iconografico, il cui
rifacimento, tuttora in corso, fa del tempio uno degli ultimi grandi
cantieri d'arte sacra contemporanea. Il 21 gennaio 2012 papa
Benedetto XVI ha elevato la cattedrale a basilica minore.
La
facciata risponde alla "tipologia con le due torri laterali" e
presenta evidenti analogie con la parrocchiale di Versailles e le incisioni
della chiesa di Saint Roch a Parigi. Essa è frutto di un
corposo rimaneggiamento attuato da Vincenzo Sinatra nella seconda
metà del '700 (su un campanile è riportata la data 1768) nella
preesistente facciata incompiuta di Rosario Gagliardi, che a sua volta
aveva rielaborato il progetto originario (forse opera di Fra Angelo Italia).
La successiva aggiunta di nuovi elementi rende evidenti le incongruenze
linguistiche tra i diversi elementi e l'eclettismo della composizione.
Nella
sopraelevazione delle due torri campanarie, ad esempio, le paraste non
sono ripetute come alla base, mentre i timpani arricciati indicano
un'influenza del Settecento catanese. Le porte principali sono inoltre di
ispirazione neocinquecentesca (tratte da Vignola o Domenico Fontana).
Il finestrone centrale con "orecchie" e timpano curvilineo è
ripreso invece dal repertorio di Andrea Pozzo ed è vicino ad
alcune realizzazioni netine di Francesco Paolo Labisi (chiesa del
Carmine).
Il
tempio fu completato verosimilmente alla fine del XVIII secolo, anche se nel
secolo successivo fu ricostruita la cupola, in stile neoclassico con tracce
neobarocche, per sostituire la precedente (che non era quella originaria),
crollata a causa dei terremoti.
Nel
secolo scorso, intorno agli anni cinquanta, furono apportati vari
rifacimenti e modifiche nell'apparato decorativo, non sempre ben riusciti,
come il trompe-l'oeil delle strutture verticali e la
decorazione a tempera delle volte da parte dei pittori Arduino e Baldinelli,
le radicali modifiche dell'altare maggiore e dell'antico organo e inoltre la
sostituzione dell'originaria copertura a falde (con struttura in
legno) della navata centrale con un pesante solaio latero-cementizio che
probabilmente fu una delle cause principali del crollo del 1996.

In
seguito al terremoto del 13 dicembre 1990 la chiesa subì alcuni
danni strutturali e già allora si pensò di chiuderla al culto e di
sottoporla a restauri. Tuttavia non si fece in tempo a prendere tali
provvedimenti. La sera del 13 marzo del 1996, a causa di un grave difetto
costruttivo dei pilastri della navata centrale (riempiti "a sacco"
con sassi di fiume anziché con conci in pietra squadrati), il primo dei
piloni di destra che fa da sostegno alla cupola "per
schiacciamento" rovinò al suolo, trascinando con sé nel crollo la
cupola stessa e per effetto domino l'intera navata destra, la
navata centrale e il transetto destro lasciando miracolosamente in piedi
solo una piccola parte del tamburo. Fortunatamente non vi furono
vittime, poiché a quell'ora la chiesa non era aperta al pubblico. L’area
interessata dal crollo era di 1000 m², con un volume di circa 6000 m³. La
richiesta ai progettisti incaricati fu un progetto “Com’era,
dov’era”.
Nel
gennaio del 2000, dopo una prima fase di sgombero delle macerie, hanno avuto
inizio i lavori di ricostruzione e di restauro, eseguiti da maestranze
locali, addestrate per l'occasione nell'utilizzo della pietra calcarea e
delle tecnologie antiche. Inizialmente sono stati riedificati con conci
squadrati in pietra e senza alcun uso del calcestruzzo armato i nuovi
pilastri di destra, che conservano la forma e le fattezze di quelli
originari, ma senza il difetto costruttivo che aveva causato il crollo della
basilica. Quindi si è passati alla demolizione e alla successiva
ricostruzione dei pilastri della navata sinistra, che riportavano le stesse
gravi imperfezioni di quelli crollati. Successivamente sono ritornate
all'antico splendore la navata centrale, la navata destra, i cupolini di
destra, i contrafforti, gli archi trasversali e longitudinali.
Ultimo
capitolo della ricostruzione della cattedrale è stato l'elevazione della
nuova cupola, pressoché identica all'originale: da essa differisce solo per
piccole correzioni, come l'ispessimento di pochi millimetri della base del
tamburo. La nuova struttura di copertura della chiesa non è di tipo
latero-cementizio (come il solaio crollato risalente agli anni cinquanta),
ma è stata ricostruita come era originariamente con capriate in
legno e manto in coppi siciliani, mentre le volte sono realizzate con il
tradizionale incannucciato e gesso. Una volta completati i lavori di
ricostruzione in muratura, sono stati ripristinati infine gli apparati
decorativi in stucco, come capitelli, trabeazione e cornici.
La
ricostruzione è stata dunque eseguita con gli stessi materiali e con le
tecniche del Settecento, all'interno di un cantiere in cui si è coniugato
tradizione e innovazione. Sono state utilizzate pietre locali come la pietra
calcarea bianca per le strutture verticali, l'arenaria per le strutture
archivoltate e la pietra di Modica per la pavimentazione,
assemblate però con moderni metodi antisismici. Proprio per migliorare la
resistenza ai forti terremoti si è fatto ricorso infatti a materiali come
la fibra di carbonio.
A
conclusione di questo lungo e complesso lavoro di ricostruzione e di
restauro dell'esistente, dopo undici anni dal crollo, il 18 giugno 2007,
la chiesa è stata riaperta al culto. Alla cerimonia erano presenti gli
allora presidente del Consiglio Romano Prodi e capo della protezione
civile Guido Bertolaso e gran parte delle autorità civili e
religiose regionali e nazionali.

Una
nuova decorazione pittorica è iniziata nell'estate 2009 dai pennacchi della
cupola. Nella cerimonia tenutasi domenica 13 febbraio 2011 e presieduta dal
vescovo di Noto Antonio Staglianò alla presenza delle autorità
civili, tra le quali il commissario Vittorio Sgarbi e il ministro Stefania
Prestigiacomo, è stato inaugurato il grande affresco della cupola,
raffigurante "La Pentecoste", e dei pennacchi, con i quattro
evangelisti, del pittore russo Oleg Supereko. Nella stessa occasione
sono state inaugurate le vetrate del tamburo, realizzate dall'artista
toscano Francesco Mori, già autore della copia della fenestra
rotunda magna di Duccio di Buoninsegna nel coro del duomo
di Siena, e sono stati benedetti il nuovo altare, la croce e l'ambone in
bronzo argentato di ispirazione berniniana dello scultore romano Giuseppe
Ducrot.
L'8
aprile 2016 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita
ufficialmente la cattedrale assieme a Vittorio Sgarbi.
Esterno
- La
facciata in pietra calcarea tenera è un esempio di stile tardo barocco, cui
non mancano elementi eclettici ed una marcata aspirazione neoclassicista. Si
erge sulla sommità di una scenografica scalinata composta da tre rampe
risalenti al Settecento ma ristrutturate agli inizi dell'Ottocento.
La
tipologia della facciata è a torri laterali ed è riferibile ad alcune
composizioni francesi del Settecento, cui si ispiravano gli architetti del
tempo. È coronata da quattro statue tardo settecentesche (eseguite nel 1796
dallo scultore Giuseppe Orlando e raffiguranti gli evangelisti) e presenta
nel primo ordine, fiancheggiati da slanciate colonne corinzie, tre maestosi
portali: quello centrale è in bronzo e rappresenta episodi della vita di san
Corrado Confalonieri da Piacenza, opera dello scultore siciliano
Giuseppe Pirrone (1982).
Interno
- L'interno,
a croce latina con tre navate, delle quali quella centrale più grande delle
due laterali, ha subito numerosi rimaneggiamenti, raggiungendo le attuali
sembianze solamente nel 1899, quando fu costruita la cappella del SS.
Sacramento. Quasi completamente disadorno fino alla metà del secolo scorso,
fu affrescato dal torinese Nicola Arduino e dal bolognese Armando
Baldinelli, fra il 1950 e il 1956, a seguito di un voto fatto
dal sindaco della città a san Corrado Confalonieri durante la guerra. La
ricostruzione in seguito al crollo del 1996 e alla conseguente
perdita dell'apparato iconografico ha restituito l'interno all'originario
candore.
Nell'abside
sono posti due troni vescovili con relativi sgabelli in legno scolpito e
dorato (secc. XVIII-XIX), un coro ligneo, lo stemma in marmo del vescovo Angelo
Calabretta al centro della pavimentazione, l'altare maggiore in marmo
policromo con alle spalle il trittico del maestro Arduino (la cui cornice
proviene dall'antico organo) raffigurante san Nicolò al centro, san Corrado
a sinistra, e san Guglielmo a destra.


Nelle
navate laterali è possibile ammirare le opere preesistenti restaurate che
sono scampate al crollo.
Nella navata destra si trovano le seguenti opere:
Fonte
battesimale in marmi policromi, Immacolata con Santi Martiri, dipinto olio
su tela (sec. XVIII);
Adorazione
dei pastori, dipinto olio su tela di Giovanni Bonomo (1783); accanto
all'ingresso laterale è stato ricomposto un mausoleo in marmo policromo del
preposito Giovanni Di Lorenzo;
Madonna
delle Grazie, bassorilievo in marmo dipinto (sec. XVI), decorazioni in
stucco e sculture in stucco di Santa Lucia e Sant'Agata, Assenza (1924);
Consegna
delle chiavi a San Pietro, dipinto olio su tela di Giuseppe Patania (1827).
Sull'altare del transetto destro è collocata una statua lignea dorata e
policromata raffigurante San Nicolò (sec. XVIII). La cappella di fondo
della navata destra custodisce la preziosa arca cinquecentesca in legno
rivestito in lamina d'argento, finemente lavorata a sbalzo e cesello,
contenente le spoglie di San Corrado Confalonieri, patrono della città e
della Diocesi di Noto (visibile solo in occasione delle festività dedicate
al santo nei mesi di febbraio ed agosto).
Nella
navata sinistra si trovano le seguenti opere:
Miracolo
di San Francesco di Paola,
dipinto olio su tela, attr. Costantino Carasi (sec. XVIII);
Spasimo
di Sicilia, dipinto olio
su tela, Raffaele Politi (1809);
Sacro
Cuore, scultura lignea
policroma (sec. XIX);
Madonna
e anime purganti, attr.
Costantino Carasi (sec. XVIII), San Michele, scultura in marmo di scuola
gaginiana (sec. XVI). Sull'altare del transetto sinistro è collocato un
Crocifisso, in legno policromo, proveniente dalla Chiesa della SS.
Provvidenza in Noto Antica. La cappella di fondo della navata sinistra
è dedicata al SS. Sacramento ed è ornata da stucchi realizzati nel 1899
dagli scultori Giuliano da Palazzolo e Senia da Noto.
 Le
opere d'arte contemporanea - Nella
volta della navata centrale, dove prima del crollo campeggiava la tempera
con la "Gloria di San Corrado" dell'Arduino, è collocata una tela
polilobata di 110 m² raffigurante l'Assunzione della Madonna e le quattro virtù
cardinali. Nei pennacchi sono raffigurati i quattro evangelisti, mentre
sulla superficie della cupola è rappresentata la Pentecoste, del russo Oleg
Supereko (2011). Le
opere d'arte contemporanea - Nella
volta della navata centrale, dove prima del crollo campeggiava la tempera
con la "Gloria di San Corrado" dell'Arduino, è collocata una tela
polilobata di 110 m² raffigurante l'Assunzione della Madonna e le quattro virtù
cardinali. Nei pennacchi sono raffigurati i quattro evangelisti, mentre
sulla superficie della cupola è rappresentata la Pentecoste, del russo Oleg
Supereko (2011).
Nell'area
del presbiterio sono posti l'altare, l'ambone e la croce in bronzo argentato
con basi in diaspro di Sicilia realizzati da Giuseppe Ducrot. Nel catino
absidale è stato dipinto dal marchigiano Bruno d'Arcevia l'affresco
del Cristo Pantocratore: la figura centrale del Cristo trionfante sulla
morte è affiancata alla destra da San Giovanni Battista, il
precursore, e alla sinistra dalla Vergine Maria. Sopra di essi una fiamma
con la colomba simbolo dello Spirito Santo e la figura dell'Eterno Padre.
Nei riquadri sottostanti, come a partecipare della Gloria del Pantocrator,
l'artista marchigiano ha dipinto i dottori della chiesa, con al centro
Sant'Agostino e Sant'Ambrogio (2013).
Lo
stesso Bruno D'Arcevia ha ricevuto l'incarico di affrescare "L'attesa
del Giudizio Universale" o "Etimasia" nella volta del
presbiterio, tra il catino absidale e la cupola, a raccordo delle due
superfici pittoriche di diversa ascendenza artistica, dove ha posto un trono
vuoto con le insegne di Cristo: un cuscino con il mantello da giudice, un
libro chiuso (il Libro della Legge), la Croce e gli strumenti della
Passione, come la corona di spine, con la lancia e la canna con la spugna,
ed inoltre i sette sigilli, la colomba dello Spirito Santo e ai piedi del
trono un vasetto nel quale sono contenuti i quattro chiodi della
crocifissione.
Sono
diciassette in tutto le nuove vetrate di Francesco Mori: nove nella navata
centrale raffiguranti i Santi Patroni delle città della Diocesi (tutte
rifatte per coerenza, in quanto quelle esistenti sulla destra andarono
distrutte durante il crollo), sei nei due transetti e due (ovali)
nell'abside, mentre sopra il portone centrale è stata ricollocata, dopo un
restauro, la vetrata preesistente al crollo che ritrae San Corrado.
Nel
luglio 2013 viene ultimata la posa in opera, all'interno delle nicchie delle
navate laterali, delle dodici sculture in gesso bianco (come quelle del
Serpotta), alte un metro e ottanta centimetri, alle quali si aggiungono i
due Santi Patroni d'Italia, che sono collocati ai lati dell'ingresso
principale. Filippo Dobrilla ha realizzato San Mattia; Livio Scarpella, San
Bartolomeo e Sant'Andrea; Demetrio Spina, San Taddeo e San Simone; Vito
Cipolla, San Filippo e San Giacomo minore; Tullio Cattaneo, San Matteo e San
Giacomo maggiore; Giuseppe Ducrot, San Pietro e San Tommaso; Giuseppe
Bergomi, San Giovanni e Santa Caterina; Gaspare da Brescia, San
Francesco.
L'ispirazione
del barocco emerge con forza, soprattutto nelle opere di Cattaneo e
Scarpella, costruite su contrapposti, torsioni e ricchezza dei panneggi,
mentre nella Santa Caterina e nel San Giovanni Bergomi ha insistito sui
tagli decisi nel blocco plastico del volume, che creano ombre profonde, e su
dettagli espressivi come le mani e il libro che si aprono come un fiore.
Sulle pareti delle navate laterali sono poste le tele raffiguranti le
stazioni della Via Crucis di Roberto Ferri.
La
scelta delle opere del nuovo apparato iconografico e decorativo - Una
commissione di consulta per l'eccellenza estetica, istituita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e nominata dal Dipartimento nazionale
di protezione civile, ha dato incarico ad artisti contemporanei di fama
nazionale ed internazionale per la esecuzione degli affreschi sulla cupola,
dei bozzetti per la realizzazione delle tele ad olio destinate agli altari
del transetto e delle sculture da collocare nelle nicchie delle navate
laterali.
Ventisei
artisti di chiara fama hanno concorso alle nuove decorazioni. Obbligatori,
per partecipare al concorso per la decorazione del catino absidale, alcuni
elementi da tenere in considerazione, relativi al contesto sacro e messi a
punto a suo tempo da Monsignor Carlo Chenis: la presenza centrale del Cristo
Pantocratore, dei quattro dottori della chiesa, i santi Ambrogio,
Crisostomo, Agostino, Gregorio Magno, la presenza della Madonna Scala del
Paradiso, co-patrona di Noto, e ancora san Corrado Confalonieri. I bozzetti
sono stati esposti dal 30 settembre al 27 novembre 2011 a Palazzo Grimani a
Venezia in occasione della 54ª edizione della Biennale in una mostra
curata da Vittorio Sgarbi. Alcuni progetti tra quelli selezionati sono
stati realizzati, mentre non è stato possibile realizzare altre opere
importanti, come le grandi tele del transetto per la scomparsa
dell'ottantaseienne maestro Ottavio Mazzonis.

 Pag. 2
Pag. 2
Agosto 2019
|