|
Per alcuni secoli il regno
di Abomey (anche Dahomey), affacciato sul Golfo
di Guinea, fu uno degli stati schiavisti più
importanti del continente. Il Paese prosperava
grazie agli introiti derivanti dalla vendita ai
negrieri bianchi di prigionieri di guerra,
avversari politici e delinquenti, ma anche di
persone comuni rapite per incrementare il
commercio. Su questa attività, controllata e
gestita da un unico gruppo etnico, i Fon, si
fondò una salda dinastia che non conobbe mai
dispute tribali al suo interno e il cui potere
si protrasse fino agli albori del XX secolo.
UNA
DINASTIA SCHIAVISTA
Sull'origine dei Fon si sa
molto poco. Una leggenda attribuisce a una
principessa chiamata Aligbono, una figura simile
la Eva
biblica, la maternità dei capostipiti. Esiste
comunque la certezza storica dell'affinità dei
Fon con gli Ewe del vicino Togo, che si
distribuirono verso est, dove si scontrarono con
gli Yoruba.
Successivamente gli Ewe si
divisero in tre grandi tribù: Allada,
Porto-Novo e Abomey. All'inizio del XVII secolo
un ribelle chiamato Doghari lasciò gli Allada e
si trasferì verso nord, portando con sé un
nutrito gruppo di seguaci. Nel territorio dei
Guederi, tra i fiumi Cuffo e Uemè, Doghari fondò
il regno di Abomey.
La potenza dei Fon derivava
da una forte coesione interna, incentrata
sull'identità linguistica e culturale e sul
rigido rispetto delle gerarchie. Un'efficiente
organizzazione militare garantiva la dominazione
su tutto il Paese. Il regno di Abomey si dedicò
alla tratta degli schiavi fino agli inizi del
XIX secolo, quando il re Gezo, per primo,
rinunciò alla consuetudine di far deportare i
propri sudditi per approvvigionare le casse
reali.
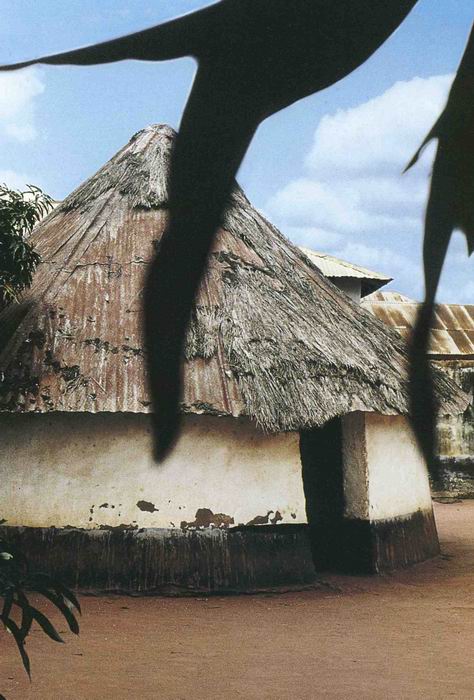
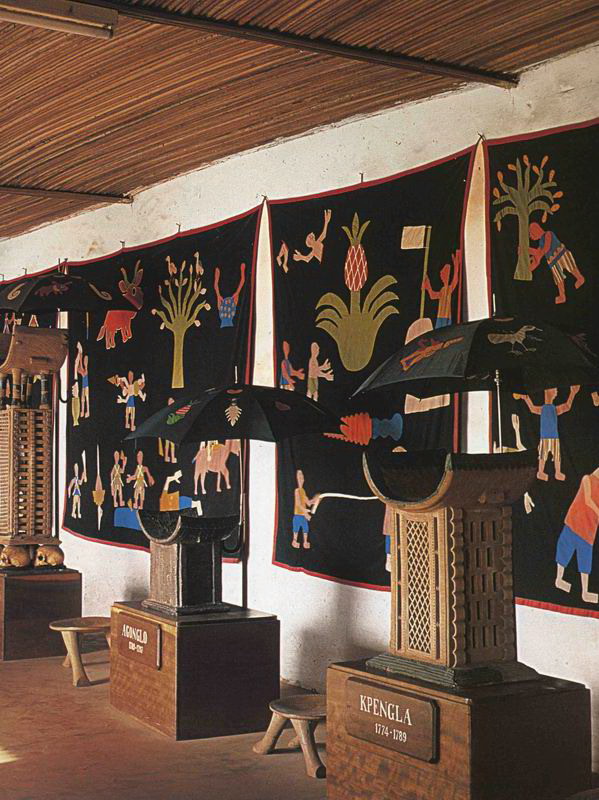
L'epoca di maggiore
splendore si ebbe durante il regno di Agadja
(1708-1732), il quinto monarca della dinastia,
che incorporò altri piccoli reami indipendenti
o tributari e riuscì a estendere i confini di
Abomey fino al mare. Il porto di Ouidah fu
trasformato nel principale mercato di schiavi
provenienti dall'interno e destinati alle isole
caraibiche. Alla morte di Agadja il Paese subì
un lungo periodo di decadenza, protrattosi fino
al 1818, quando salì al trono Gezo, il decimo
re della dinastia, che regnò per quarantanni
rinverdendo l'antico splendore. Gezo centralizzò
il potere statale facendo leva su un potente
esercito, impose forti tributi ai sudditi e
intraprese diverse guerre contro i regni vicini.
Contemporaneamente cercò di
svincolare l'economia del Paese dal commercio
degli schiavi, introducendo coltivazioni
differenziate (palma da olio, banane, mais e
tabacco) e instaurando un proficuo clima di
contatti e di scambi con il governo francese.
Il figlio Gléglé
(1858-1889) intensificò i rapporti con gli
Europei, sempre più presenti nella regione, ma
non riuscì comunque ad assicurare al Paese la
prosperità degli anni precedenti. I rapporti
con i Francesi erano infatti destinati a
deteriorarsi: l'ultimo vero sovrano abomey,
Behanzin (1890-1894), si oppose strenuamente
alla penetrazione coloniale sempre più
invadente, ma, dopo due anni di intensa
guerriglia, fu costretto ad arrendersi. Venne
catturato e deportato ad Argel dal colonnello
Alfred-Amédée Dodds che, al comando di una
spedizione francese, conquistò in breve tutto
il Paese. Fu designato re Agoliagbo, che accettò
il protettorato francese sul regno di Abomey,
incorporato ufficialmente nell'Africa
Occidentale Francese.
Nel frattempo, nel 1861, gli
Inglesi si erano stabiliti nella vicina Lagos
(Nigeria), monopolizzando il commercio degli
schiavi e, quando poco più tardi fu abolita la
schiavitù in tutto il Commonwealth britannico,
i regni della costa del Golfo di Guinea videro
seriamente minacciata la loro "migliore
risorsa economica".

RESIDENZE
REALI
All'interno della cinta
muraria della capitale Abomey sorgono dodici
palazzi, uno per ogni sovrano della dinastia. Lo
spazio, che copre un’area di
44 ettari, è diviso in due grandi zone: la prima
comprende undici residenze reali con i
rispettivi santuari, le tombe e gli edifici di
servizio, mentre la seconda è occupata dal
Palazzo di Akaba (1685-1708), quarto re di
Abomey e padre di Agadja, morto combattendo
contro la tribù degli Uemenù. Tutti i palazzi
sono strutturati secondo un unico schema. Ognuno
è circondato da un muro esterno di protezione e
si sviluppa intorno a tre cortili: quello
esterno per le parate militari e le cerimonie,
un secondo di uso comune e poi il cortile
interno privato, al quale potevano accedere solo
il sovrano e le sue spose. Le pareti in mattoni
crudi, le finestre senza serramenti e i tetti in
paglia, talvolta sostituita da lamiere metalliche, danno
un'idea della semplicità di queste residenze.
Le strutture sono in legno di tek o in bambù.
Non mancano aneddoti che hanno dell'incredibile.
Si tramanda, ad esempio, che Behanzin pretese,
per la costruzione del suo palazzo, che la
paglia e la terra fossero impastate con il
sangue: l'acqua, infatti, non gli sembrava
all'altezza del suo prestigio e, anziché dai
pozzi, si rifornì dalle vene di duemila
prigionieri. Il valore di Abomey risiede
soprattutto nelle decorazioni, costituite da
bassorilievi policromi e da figure di argilla
che rappresentano le imprese militari dei
sovrani locali. Si tratta di piccoli rilievi
(spesso non arrivano a
75 centimetri
di lunghezza), eseguiti su terracotta al sole e
dipinta con colori vivaci, che raffigurano
cruente scene di guerra o illustrano proverbi e
motti, spesso connessi con la figura del re,
oppure riproducono stemmi reali, con la loro
caratteristica simbologia zoomorfa e allegorica.
Le immagini sono piuttosto elementari e pesanti,
ma ricche di vitalità e di movimento. Purtroppo
l'uso di materiali fragili come il mattone crudo
e il legno, soggetti nel tempo a un notevole
deterioramento, e restauri approssimativi hanno
provocato seri danni ai capolavori artistici dei
palazzi di Abomey.
Attualmente alcuni edifici
del recinto principale sono occupati dai
discendenti dell'antica casa reale, che si
dedicano all'agricoltura coltivando piccoli
lotti di terreno, mentre un'altra zona è stata
trasformata in museo etnografico che accoglie
opere, sculture, tessuti, pitture dell'arte
africana. Per resistere all'occupazione francese
nel 1892, il re Behanzin ordinò che la città,
palazzi inclusi, fosse bruciata. La Sala dei
gioielli è una delle poche strutture in cui è
possibile osservare l'effetto dell'incendio.
 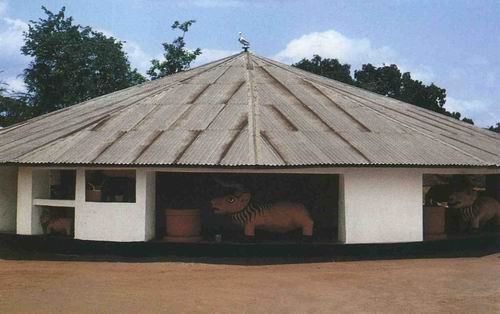
L'OPERA
DI TUTELA
Il
sito fu iscritto contemporaneamente nella lista
del Patrimonio dell'umanità e nella lista del
Patrimonio in pericolo nel 1985, dopo che un
tornado colpì Abomey il 15 marzo 1984. Secondo
il rapporto effettuato all'epoca, il complesso
monumentale reale e i musei, il Guezo Portico,
la Sala del trono, la tomba del re Glèlè e la
Sala dei gioielli subirono diversi danni. Da
allora numerosi programmi di restauro furono
effettivamente messi in atto a favore del sito.
Nel 1994 la commissione dell'Unesco si mobilitò
alla ricerca di aiuti presso diversi Stati e
istituzioni per mettere in atto un programma di
manutenzione del monumento. In quell'anno prese
avvio il Prema (Prevention in thè Museums of
Africa) in cooperazione con le autorità del
Benin. Una ricerca di tre anni finanziata dal
ministero degli Affari Esteri italiano e dall'Unesco
produsse circa 2500 pagine di documentazione
sull'architettura del luogo, coprendo un periodo
che inizia dal 1731 e giunge fino a oggi.
Il
materiale raccolto fu copiato, rilegato e
successivamente conservato nelle biblioteche del
Benin, ma anche in Francia, Italia e Stati Uniti
d'America. Dopo aver visitato Abomey nel 1993,
una missione del Getty Conservation Institute
lanciò una campagna di restauro dei
bassorilievi che decoravano i palazzi. Durante
questo lavoro durato quattro anni, cinquanta dei
cinquantasei bassorilievi originari che
decoravano le pareti del palazzo di Glèlè
furono ricollocati sul monumento e i funzionari
del Patrimonio culturale del Benin furono
istruiti nella pianificazione e negli aspetti
pratici del programma di conservazione. Le
autorità del Benin hanno raccolto ulteriori
fondi per proseguire il piano di conservazione
aumentando le risorse del museo, migliorando la
preparazione del personale del centro culturale
e creando un programma digitale di
documentazione per far sì che
l'area esca dalla lista del Patrimonio in
pericolo.
|