|
Cartagine
fu
una
una
colonia
fondata
dai
Fenici
di
Tiro,
nei
pressi
dell'attuale
città
di
Tunisi,
che
costituì
un
impero
marittimo
nel
Mediterraneo
occidentale,
prima
di
essere
distrutta
dai
Romani.
La
fondazione
di
Cartagine
(Qart
Hadesht,
la
città
nuova)
sembra
essere
stata
una
conseguenza
del
sovrappopolamento
e
dell'insicurezza
del
paese
di
Canaan
e
di
una
discordia
in
seno
all'aristocrazia
della
potente
città
fenicia
di
Tiro.
Secondo
la
tradizione,
un
gruppo
di
cittadini
di
Tiro
avrebbe
abbandonato
la
metropoli
al
comando
di
Didone,
figlia
di
Belo,
regina
di
Tiro,
riparata
in
Africa
per
sfuggire
al
fratello,
Pigmalione,
che
le
aveva
ucciso
il
marito
Sicheo.
Il
gruppo
si
installò
in
prossimità
di
Utica,
uno
dei
numerosi
scali
dei
marinai
fenici
che
praticavano
i
commerci
nel
Mediterraneo
occidentale
e
qui,
nell’825-
819
a
.C.,
fondarono
il
nuovo
insediamento.
Cartagine
fondava
le
sue
credenze
religiose
sul
culto
fenicio
del
dio
del
sole
Baal-Ammone,
mentre
Melkart,
il
cui
culto
era
presente
anche
a
Gades,
divenne
per
i
Romani
e
per
i
Greci
il
semidio
Ercole
(Eracle).
Tra
il
V
e
il
IV
secolo
a.C.
la
mitologia
cartaginese
subì
influssi
provenienti
dalla
Grecia:
la
dea
della
fecondità
Astarte,
l'antica
Ishtar
dei
Babilonesi,
divenne
la
dea
Tanit,
che
occasionalmente
arrivò
addirittura
a
rivaleggiare
con
Baal
nel
fervore
popolare.
In
una
terza
fase
i
dogmi
e
gli
dei
punici
furono
nuovamente
interpretati
in
chiave
ellenistica:
è
il
caso,
ad
esempio,
dei
riti
agrari,
molto
simili
a
quelli
celebrati
in
onore
di
Demetra.
Gli
scavi
hanno
riportato
alla
luce
solo
alcuni
resti,
per
la
maggior
parte
di
importanza
secondaria,
dell'immenso
patrimonio
artistico
di
Cartagine.
L'analisi
archeologica
di
un
tophet
("santuario")
ha
rivelato
il
maggior
numero
di
informazioni
sulla
cultura
di
questa
città.
Le
sue
stele
votive,
arricchite
di
iscrizioni
e
sculture,
hanno
rivelato
l'usanza
invalsa
nella
religione
cartaginese
di
praticare
sacrifici
propiziatori
di
bambini
(detti
sacrifici
molk,
o
molkomor,
termini
da
cui
deriva
moloch).


Il
santuario
esaminato,
dedicato
a
Baal
e
quindi
a
Tanit,
era
un
vasto
cimitero
di
100
x
200
metri
e
venne
chiamato
tophet
a
causa
della
sua
somiglianza
con
il
santuario
di
Ben
Hinnon
a
Gerusalemme,
dove
pure
venivano
praticati
sacrifici
di
bambini.
Inizialmente
in
questo
luogo
esisteva
soltanto
un'area
sacra
che
racchiudeva
grandi
pietre
rituali
destinate
a
placare
le
forze
soprannaturali
o
ad
attirarne
la
benevolenza.
Successivamente
venne
utilizzato
per
seppellire
sotto
le
stele
le
urne
contenenti
le
ceneri
dei
bambini
di
famiglie
nobili
sacrificati;
l'area
veniva
poi
ricoperta
da
un
nuovo
strato
di
terra.
Tuttora
sono
riscontrabili
strati
di
sepolture
per
uno
spessore
totale
di
3
metri
e
mezzo.
La
religione
cartaginese
era
imperniata
sul
timore
e
sul
terrore:
timore
reverenziale
degli
dei
esigenti
e
crudeli,
di
cui
si
temeva
la
collera
piuttosto
che
attendersi
le
benedizioni.
Religione,
inoltre,
impregnata
di
superstizione:
ne
fanno
testimonianza
le
maschere
di
terracotta
dalle
fisionomie
contratte
in
smorfie
grottesche,
destinate
a
mettere
in
fuga
i
demoni.
In
seguito,
al
tempo
delle
corse
con
i
carri
romani,
gli
stessi
geni
malefici
verranno
evocati
con
incantesimi
incisi
su
rotoli
di
piombo,
nell'intento
di
far
cadere
i
concorrenti
della
fazione
avversaria.
La quasi totalità delle
stele
ritrovate
era
dedicata
a
Baal
Hammon,
il
cui
nome
significa
«signore
degli
altari
profumati»
e
corrisponde
al
dio
El
dei
Fenici,
oltre
che
a
Tanit,
dea
lunare,
identificata
in
seguito
con
Juno
caelestis
(Lucina)
che,
a
partire
dal
V
secolo,
divenne
la
divinità
più
importante.
Eshmun,
più
tardi
assimilato
a
Esculapio,
era
venerato
in
un
tempio
che
dominava
la
città.
Le
altre
divinità
fenicie,
incluso
Melqart,
protettore
di
Tiro,
ricoprivano
una
funzione
accessoria.
La
religione,
già
modificata
rispetto
alle
origini
da
influenze
egiziane,
accolse
poi
anche
le
divinità
greche:
nel
396
venne
introdotto
il
culto
di
Demetra
che
liberò
dai
riti
più
barbari.
Nei
pressi
del
santuario,
sulla
collina
di
Bordj
Djedid,
si
innalza
il
Tempio
di
Demetra.
Sulla
collina
del
teatro
sorge
invece
il
Tempio
di
Esmun,
la
cui
costruzione
è
attribuita
a
Esculapio.
La
necropoli,
le
cui
tombe
raccolgono
tutta
la
storia
della
città
dal
VII
al
II
secolo
a.C,
sorge
sulle
colline
di
San
Luigi;
vi
sono
stati
rinvenuti
splendidi
sarcofagi
di
sacerdoti
e
sacerdotesse,
alcune
sculture
funerarie,
nonché
stele
e
vasi
in
ceramica
e
in
bronzo.
Sulle
stesse
colline
e
nella
pianura
di
Dermech
si
conservano
vestigia
di
residenze
risalenti
agli
ultimi
tempi
dell'Impero.
Il
porto
di
Cartagine
aveva
due
darsene:
una
rettangolare
per
il
commercio
marittimo
e
un'altra
circolare
per
le
navi
da
guerra.

LA
STORIA
E
IL
PREDOMINIO
DEL
MARE
Secondo
lo
storico
greco
Timeo,
la
fondazione
di
Cartagine
risalirebbe
all'814
a.C.,
mentre
per
Giuseppe
Flavio
la
data
di
fondazione
sarebbe
l'826
a.C.
Cartagine
venne
fondata
da
coloni
fenici
provenienti
dalla
città
di
Tiro
che
portarono
con
loro
il
dio
della
città
Melqart.
Secondo
la
leggenda
mitologica
a
capo
dei
coloni
(o
forse
profughi
politici)
era
Didone
(conosciuta
anche
come
Elissa).
Numerosi
sono
i
miti
relativi
alla
fondazione,
che
sono
sopravvissuti
attraverso
le
letterature
greca
e
latina.
Uno
di
questi
narra
che
il
fratello
di
Elissa,
Pigmalione
di
Tiro,
capo
dell'omonima
città,
fece
uccidere
il
marito
della
sorella
per
carpirne
le
ricchezze.
Elissa
lasciò
quindi
la
città
e,
dopo
lunghe
peregrinazioni,
approdò
sulle
coste
tunisine,
dove
fondò
Cartagine.
La
potenza
marittima
e
commerciale
di
Cartagine
fu
davvero
enorme:
le
sue
navi
si
spingevano
oltre
le
Colonne
d'Ercole
(Gibilterra),
porta
d'accesso
verso
le
coste
atlantiche,
raggiungendo
anche
il
Camerun
e
l'Islanda.
Coltivavano
la
terra
con
tecniche
raffinate
e
commerciavano
con
tutti
i
popoli
del
bacino
del
Mediterraneo.
Sulle
loro
navi
viaggiavano
il
ferro
della
Sardegna,
l'argento
della
Betica,
lo
stagno
della
Cornovaglia,
l'oro
del
Sudan,
l'avorio
e
gli
schiavi
dell'Africa.
Le
esplorazioni
dei
Cartaginesi
-
famosa
quella
compiuta
da
Annone
nel
VI
secolo
a.C.
verso
la
Guinea
e
il
Camerun
-
raggiunsero
il
Niger
e
il
Sahara.
Dal
punto
di
vista
politico
Cartagine
era
una
repubblica
aristocratica
governata
da
un
senato
dominato
da
potenti
famiglie
di
mercanti,
alcune
delle
quali
cercavano
l'appoggio
della
plebe
per
ottenere
il
potere,
stabilire
la
propria
supremazia
e
poi
inviare
nelle
colonie
lontane
uomini
di
fiducia
che
garantissero
l'ordine.
Grandi
famiglie
si
succedettero
al
potere
di
Cartagine.
Dalla
metà
del
VI
secolo
alla
metà
del
V,
quella
dei
Magoni
favorì
l'espansione
commerciale,
poi,
a
partire
dal
III
secolo,
i
Barca
(Amilcare,
Asdrubale
e
il
grande
generale
Annibale),
appoggiando
il
loro
potere
sull'esercito
e
sulle
conquiste
in
Spagna,
condussero
una
politica
estera
antiromana
e
si
distaccarono
da
obiettivi
puramente
mercantili.
Tuttavia,
Cartagine
rimase
soprattutto
una
città
di
commerci
e
i
primi
cittadini,
sia
proprietari
terrieri
che
membri
del
clero,
erano
in
particolare
finanziatori
di
traffici
marittimi.
Tra
il
235
e
il
220,
col
pretesto
di
assicurarsi
lo
sfruttamento
dell'argento
in
Betica
per
pagare
le
indennità
di
guerra,
i
Cartaginesi
conquistarono
gran
parte
della
Penisola
Iberica
fino
al
fiume
Ebro
e
fondarono
Cartagena
(Cartago
Nova).
L'impero
commerciale
cartaginese,
alle
origini,
dipendeva
strettamente
dalle
relazioni
economiche
con
Tartesso
e
altre
città
della
Penisola
Iberica.
Da
qui
Cartagine
otteneva
grandi
quantità
di
argento
e,
cosa
molto
più
importante,
di
stagno,
determinante
per
la
fabbricazione
di
oggetti
di
bronzo
in
tutte
le
civiltà
antiche.
Cartagine
seguiva
le
rotte
commerciali
della
città-madre,
Tiro.
Alla
caduta
di
Tartesso
le
navi
cartaginesi
risalirono
direttamente
alla
sorgente
primaria
dello
stagno
nella
regione
nord
occidentale
della
Penisola
Iberica
e
in
seguito
fino
alla
Cornovaglia.
Altre
navi
cartaginesi
si
inoltrarono
nella
costa
atlantica
dell'Africa
tornando
con
l'oro
fin
dall'odierno
Senegal.

Se
la
poesia
epica
greca
e
gli
storici
contemporanei
a
Roma
imperiale
ricordano
l'opposizione
militare
di
Cartagine
alle
forze
delle
città-stato
greche
e
della
Repubblica
Romana,
è
vero
che
il
teatro
greco
e
le
sue
commedie
ci
hanno
tramandato
l'immagine
del
commerciante
cartaginese,
con
le
sue
vesti,
anfore
e
gioielli.
Generalmente
veniva
dipinto
come
un
tipo
divertente,
un
venditore
relativamente
pacifico
e
colorato,
attento
a
trarre
profitto
scucendo
al
nobile
e
innocente
Greco
ogni
suo
singolo
centesimo.
Evidente
simbolo
di
ogni
tipo
di
scambio,
dalle
grandi
quantità
di
stagno
necessarie
a
una
civiltà
basata
sul
bronzo
a
tutti
i
manufatti
tessili,
di
ceramica
e
di
oreficeria.
Prima
e
durante
le
guerre
si
vedevano
mercanti
cartaginesi
attraccare
in
ogni
porto
del
Mediterraneo,
comprando
e
vendendo,
stabilendo
magazzini
dove
potevano,
oppure
dandosi
al
commercio
spicciolo
nei
mercatini
all'aperto
appena
scesi
dalle
loro
navi.
O
anche
entrambe
le
cose.
La
lingua
etrusca
non
è
ancora
stata
del
tutto
decifrata
ma
scavi
archeologici
nelle
loro
città
mostrano
che
gli
Etruschi
furono
per
parecchi
secoli
clienti
e
fornitori
di
Cartagine,
molto
prima
della
espansione
di
Roma.
Le
città-stato
etrusche
furono
partner
commerciali
di
Cartagine
oltre
che,
a
volte,
alleate
in
operazioni
militari.
Il
governo
di
Cartagine
era
un'oligarchia,
non
diversa
da
quella
di
Roma
repubblicana,
di
cui
conosciamo
però
pochi
dettagli.
I
Capi
dello
Stato
erano
chiamati
"suffeti"
che
verosimilmente
era
il
titolo
del
governatore
della
città-madre
Tiro.
"Suffeti"
letteralmente
si
traduce
con
"giudici",
carica
che
ricorda
i
"Giudici"
citati
nella
Bibbia.
Gli
scrittori
romani
invece,
utilizzavano
il
termine
"reges"
(Re);
ma
non
dimentichiamo
il
forte
senso
spregiativo
che
la
parola
"re"
aveva
per
i
romani,
accesi
repubblicani.
Più
tardi
uno
o
due
suffeti,
che
si
suppone
esercitassero
il
potere
giudiziario
ed
esecutivo,
ma
non
quello
militare
(quest'ultimo
affidato
a
dei
generali
di
nomina
pluriennale
chiamati
"strategoi"),
cominciarono
ad
essere
annualmente
eletti
fra
le
famiglie
più
potenti
e
influenti.
Queste
famiglie
aristocratiche
erano
rappresentate
in
un
consiglio
supremo,
comparabile
al
Senato
di
Roma,
che
aveva
un
ampio
spettro
di
poteri.
Oltre
al
senato
con
300
membri,
vi
era
un'altra
assemblea
aristocratica:
il
Consiglio
dei
Cento.
Non
si
sa,
però,
se
i
suffeti
venissero
eletti
dal
consiglio
o
direttamente
dal
popolo
in
assemblea.
Anche
se
il
popolo
poteva
avere
qualche
influenza
sulla
legislazione,
gli
elementi
democratici
erano
piuttosto
deboli
a
Cartagine
e
l'amministrazione
della
città
era
sotto
il
fermo
controllo
degli
oligarchi.
Nonostante
l'iniziale
debolezza
di
questi
elementi
democratici,
pare
che
a
partire
dal
IV
sec
a.C.
l'assemblea
democratica
si
fosse
rafforzata.
La
Cartagine
fenicia
aveva
una
fama
sinistra
per
i
sacrifici
dei
bambini.
Plutarco
(46
-
120)
parla
di
questa
pratica,
come
fanno
Tertulliano,
Paolo
Orosio
e
Diodoro
Siculo.
Per
contro
Tito
Livio
e
Polibio
non
ne
parlano.
Scavi
archeologici
moderni
tendono
a
confermare
la
versione
di
Plutarco.
In
un
solo
cimitero
per
bambini
chiamato
"Tophet"
("area
sacra")
è
stata
deposta
fra
il
400
a.C.
e
il
200
a.C.
una
quantità
-
stimata
-
di
20.000
urne.
Queste
urne
contenevano
le
ossa
calcinate
di
neonati
e
in
qualche
caso
di
feti
o
di
bimbi
attorno
ai
due
anni.
Questo
indica
che
se
i
bambini
erano
piccoli,
quelli
più
giovani
venivano
sacrificati
dai
genitori.
D'altra
parte,
in
uno
studio
del
2010
è
stata
mostrata
l'evidenza
che
quelle
trovate
sono
probabilmente
le
ossa
cremate
di
bambini
morti
naturalmente.
Questa
tesi
è
discordante,
d'altra
parte,
con
ritrovamenti
precedenti
cananei.
Inoltre,
i
pochi
testi
cartaginesi
che
ci
sono
rimasti
non
fanno
mai
menzione
a
sacrifici
di
bambini.
Il
dibattito
fra
gli
storici
e
gli
archeologi
rimane
aperto.

Cartagine
venerava
molti
dei.
La
suprema
coppia
divina
era
formata
da
Tanit
e
Baal.
Diversamente
dalla
maggioranza
della
popolazione
i
sacerdoti
si
radevano
il
viso.
Nei
primi
secoli
i
rituali
della
città
includevano
danze
ritmiche
tratte
dalla
tradizione
fenicia
e
sembra
che
la
dea
Astarte
fosse
molto
popolare.
Nel
periodo
di
massimo
splendore
Cartagine
ospitava
un
grande
numero
di
divinità
provenienti
dalle
civiltà
greca,
egizia
ed
etrusca.
Il
successo
di
Cartagine
portò
alla
creazione
di
una
potente
flotta
atta
a
scoraggiare
sia
i
pirati
che
le
nazioni
rivali.
Questa
potente
flotta,
insieme
al
successo
e
alla
crescente
egemonia
portò
Cartagine
verso
un
sempre
crescente
conflitto
con
la
Grecia,
l'altro
maggior
concorrente
per
il
controllo
del
Mediterraneo
Centrale.
L'isola
di
Sicilia,
posta
alle
porte
di
Cartagine,
divenne
il
teatro
dove
sarebbe
scoppiato
questo
conflitto.
Fin
dai
primi
giorni
sia
Greci
che
Fenici
furono
attratti
dalla
grande
isola,
lungo
le
coste
della
quale
stabilirono
un
grande
numero
di
colonie
e
stazioni
di
posta.
Nel
corso
dei
secoli
furono
combattute
piccole
battaglie
fra
questi
insediamenti
ma
nel
480
a.C.
la
Sicilia
divenne
il
terreno
principale
per
la
prima
grande
campagna
militare
cartaginese.
Gerone,
tiranno
di
Siracusa,
in
parte
aiutato
e
supportato
dai
Greci,
tentava
di
unire
l'isola
sotto
il
suo
governo.
Questo
imminente
pericolo
non
poteva
venire
ignorato
da
Cartagine
che,
forse
come
parte
di
un'alleanza
con
la
Persia
al
momento
in
guerra
con
la
Grecia,
mise
in
campo
il
più
grande
esercito
che
avesse
mai
formato,
al
comando
del
generale
Amilcare.
Anche
se
le
cifre
tradizionali
indicano
un
numero
di
300.000
uomini,
quasi
sicuramente
esagerato,
certo
Cartagine
mostrò
una
forza
formidabile.
Nella
navigazione
verso
la
Sicilia,
comunque,
Amilcare
subì
delle
perdite
(probabilmente
severe)
a
causa
delle
avverse
condizioni
atmosferiche.
Perciò,
sbarcato
a
Panormum,
il
generale
fu
pesantemente
sconfitto
nella
battaglia
di
Imera
dove
trovò
la
morte
o
per
le
ferite
o
per
suicidio
suggerito
dalla
vergogna.
Cartagine
fu
severamente
indebolita
dalla
sconfitta
e
il
vecchio
governo,
allora
nelle
mani
della
nobiltà,
fu
sostituito
dalla
Repubblica
Cartaginese.

Nel
410
a.C.,
nondimeno,
Cartagine
aveva
recuperato
la
sua
potenza
sotto
una
serie
di
governanti
di
successo.
La
città
aveva
conquistato
la
maggior
parte
della
moderna
Tunisia,
aveva
rafforzato
alcune
colonie
e
ne
aveva
fondato
di
nuove
nel
Nordafrica.
Erano
stati
sponsorizzati
i
viaggi
di
Magone
Barca
[da
non
confondere
con
Magone
Barca
figlio
di
Amilcare
e
fratello
di
Annibale
vissuto
secoli
dopo]
attraverso
il
deserto
del
Sahara
e
di
Annone
il
navigatore
lungo
le
coste
atlantiche
dell'Africa.
D'altra
parte,
in
quell'anno
si
verificò
la
secessione
delle
colonie
iberiche
e
questo
diminuì
drasticamente
la
fornitura
di
argento
e
rame.
Annibale
Magone
il
nipote
di
Amilcare
cominciò
la
preparazione
per
reclamare
il
possesso
della
Sicilia
mentre
altre
spedizioni
furono
inviate
verso
il
Marocco
e
il
Senegal
e
perfino
nell'Atlantico.
Nel
409
a.C.
Annibale
Magone
guidò
la
nuova
spedizione
in
Sicilia
riuscendo
a
conquistare
le
piccole
città
di
Selinunte
(antica
Selinus)
e
Imera
prima
di
rientrare
trionfalmente
a
Cartagine
con
le
loro
spoglie.
Siracusa,
la
principale
nemica,
rimase
però
intoccata
e
nel
405
a.C.
Annibale
Magone
guidò
una
seconda
spedizione
per
conquistare
l'intera
isola.
Questa
spedizione
incontrò
una
feroce
resistenza
armata
e
fu
colpita
dalla
pestilenza.
Durante
l'assedio
di
Akragas,
Annibale
Magone
morì
per
la
peste
che
decimò
le
forze
cartaginesi.
Il
successore
di
Annibale
Magone,
Imilcone
riuscì
a
riportare
la
campagna
su
migliori
binari
rompendo
l'assedio
dei
Greci,
conquistando
Gela
e
sconfiggendo
ripetutamente
le
forze
di
Dionisio
il
nuovo
Tiranno
di
Siracusa.
Ciononostante,
con
l'esercito
indebolito
dalla
peste,
fu
costretto
a
chiedere
la
pace
prima
di
ritornare
a
Cartagine.
Nel
398
a.C.
Dionisio,
riacquistata
la
sua
potenza,
ruppe
il
trattato
di
pace
colpendo
la
fortezza
cartaginese
di
Motya.
Imlico
rispose
con
decisione
guidando
una
spedizione
che
non
solo
riprese
Motya
ma
conquistò
Messina
e,
infine,
pose
l'assedio
a
Siracusa
stessa.
L'assedio
terminò
con
successo
nel
397
a.C.
ma
l'anno
successivo
la
peste
colpì
ancora
l'esercito
di
Imlico
che
collassò.
D'altra
parte,
la
conquista
della
Sicilia
era
diventata
un'ossessione
per
Cartagine.
Nel
corso
dei
successivi
60
anni
Greci
e
Cartaginesi
si
scontrarono
in
un'incessante
serie
di
scaramucce.
Nel
340
a.C.
Cartagine
era
attestata
nell'intero
sudovest
della
Sicilia
e
una
fragile
pace
regnava
sull'isola.

Nel
315
a.C.
Agatocle
tiranno
di
Siracusa,
assediò
Messana
(oggi
Messina).
Nel
311
a.C.
invase
gli
ultimi
possedimenti
cartaginesi
in
Sicilia
rompendo
i
correnti
accordi
di
pace
e
mise
Akragas
sotto
assedio.
Amilcare,
nipote
di
Annone
il
Navigatore,
guidò
la
risposta
cartaginese
riscuotendo
un
enorme
successo.
Nel
310
a.C.
controllava
pressoché
l'intera
Sicilia
e
pose
ancora
sotto
assedio
Siracusa.
Con
una
mossa
disperata
Agatocle,
nel
tentativo
di
salvare
il
suo
potere,
guidò
una
contro-spedizione
di
14.000
uomini
contro
la
stessa
Cartagine.
Fu
un
successo.
Per
fronteggiare
questo
inaspettato
attacco
Cartagine
dovette
richiamare
Amilcare
e
la
maggior
parte
del
suo
esercito
di
stanza
in
Sicilia.
La
guerra
terminò
con
la
sconfitta
di
Agatocle
nel
307
a.C.
Le
forze
siracusane
dovettero
ritornare
in
Sicilia
permettendo
però
ad
Agatocle
di
negoziare
una
pace
che
manteneva
a
Siracusa
il
controllo
del
potere
greco
in
Sicilia.
Fra
il
280
a.C.
e
il
275
a.C.,
Pirro
dell'Epiro
mosse
due
grandi
campagne
nel
tentativo
di
proteggere
ed
estendere
l'influenza
greca
nel
Mediterraneo
Occidentale.
Una
campagna
venne
scatenata
contro
Roma
con
il
proposito
di
difendere
le
colonie
greche
del
sud
Italia.
La
seconda
campagna
venne
mossa
contro
Cartagine
nell'ennesimo
tentativo
di
riportare
la
Sicilia
interamente
sotto
controllo
greco.
Pirro,
pur
vincendo
alcune
battaglie
sia
in
Italia
che
in
Sicilia
(i
cartaginesi
si
arroccarono
a
Lilibeo
dove
respinsero
l'assedio),
non
riuscì
a
portare
a
termine
gli
obiettivi
che
si
era
prefisso.
Dove
per
Cartagine
questo
significò
il
mero
ritorno
allo
status
quo,
per
Roma
significò
la
conquista
di
Taranto
e
una
robusta
ipoteca
sull'intera
Italia
meridionale.
Il
risultato
finale
mostrò
quindi
un
nuovo
bilanciamento
del
potere
nel
Mediterraneo
Occidentale:
i
Greci
videro
ridotto
il
loro
controllo
sul
sud
Italia
mentre
Roma
crebbe
come
potenza
e
le
ambizioni
territoriali
la
portarono
per
la
prima
volta
direttamente
allo
scontro
frontale
con
Cartagine.
Una
nutrita
compagnia
di
mercenari
era
stata
assunta
al
servizio
di
Agatocle.
Alla
morte
del
Tiranno
nel
288
a.C.,
questi
si
trovarono
improvvisamente
senza
lavoro.
Anziché
lasciare
la
Sicilia
si
posero
all'assedio
di
Messina,
conquistandola.
Con
il
nome
di
"Mamertini"
(figli
di
Marte),
si
posero
al
comando
della
città
terrorizzando
i
territori
circostanti.
Dopo
anni
di
scaramucce,
nel
265
a.C.
Gerone
II,
nuovo
Tiranno
di
Siracusa,
entrò
in
azione.
Trovandosi
di
fronte
a
forze
preponderanti
i
Mamertini
si
divisero
in
due
fazioni.
Una
pensava
di
arrendersi
ai
cartaginesi,
la
seconda
preferiva
chiedere
aiuto
a
Roma.
Così
due
ambasciate
furono
inviate
alle
due
città.
Mentre
il
Senato
di
Roma
dibatteva
sul
comportamento
da
tenere,
i
cartaginesi
decisero
rapidamente
di
inviare
una
guarnigione
a
Messina.
La
guarnigione
fu
ammessa
in
città
e
una
flotta
cartaginese
entrò
nel
porto
di
Messina.
Poco
dopo,
però
i
cartaginesi
cominciarono
a
negoziare
con
Gerone
mettendo
in
allarme
i
Mamertini
che
inviarono
un'altra
ambasciata
a
Roma
chiedendo
l'espulsione
dei
cartaginesi
da
Messina.

L'arrivo
dei
cartaginesi
aveva
posto
notevoli
forze
militari
proprio
attraverso
lo
Stretto
di
Messina.
Per
di
più
la
flotta
cartaginese
deteneva
l'effettivo
controllo
dello
Stretto
stesso.
Era
chiaro
ed
evidente
il
pericolo
per
i
vicini
di
Roma
e
per
i
suoi
interessi.
Come
risultato
il
Senato
di
Roma,
anche
se
riluttante
ad
aiutare
una
banda
di
mercenari,
inviò
una
spedizione
per
restituire
il
controllo
di
Messina
ai
Mamertini.
Le
due
maggiori
potenze
del
Mediterraneo
Occidentale
si
fronteggiavano.
Era
l'inizio
delle
Guerre
Puniche.
Durati
complessivamente
circa
un
secolo,
questi
tre
grandi
conflitti
fra
Roma
e
Cartagine
hanno
avuto
un'importanza
cruciale
per
l'intera
civiltà
occidentale.
-
Prima
guerra
punica
(dal
264
a.C.
al
241
a.C.)
-
Seconda
guerra
punica
(dal
218
a.C.
al
202
a.C.)
-
Terza
guerra
punica
(dal
149
a.C.
al
146
a.C.)
Con
le
Guerre
Puniche
Roma
annientò
Cartagine.
La
fine
della
Seconda
Guerra
Punica
segnò
la
fine
della
potenza
cartaginese
mentre
con
la
Terza
Guerra
Punica
ci
fu
la
completa
distruzione
della
città-Stato
da
parte
di
Publio
Cornelio
Scipione
Emiliano,
su
ordine
del
senato.
I
soldati
romani
andarono
casa
per
casa
uccidendo
i
cartaginesi
e
rendendo
schiavi
i
sopravvissuti.
Il
porto
di
Cartagine
fu
bruciato
e
la
città
rasa
al
suolo.
Varie
fonti
moderne
riportano
che
furono
tracciati
solchi
con
l'aratro
e
sparso
sale
a
terra,
dichiarando
il
luogo
maledetto.
Lo
stesso
Scipione
sarebbe
stato
riluttante
ad
eseguire
tali
ordini.
È
da
rimarcare
però
che
nessuna
fonte
dell'antichità
menziona
questo
rituale
e
i
primi
riferimenti
allo
spargimento
di
sale
risalgono
solo
al
XIX
secolo.
Cartagine
non
sarebbe
mai
più
stata
rivale
di
Roma.
Meno
di
una
generazione
più
tardi
Caio
Gracco
tentò
tuttavia
di
fondarvi
una
colonia.
Verso
il
44
a.C.
Cesare
ne
assicurò
la
realizzazione
sui
luoghi
degli
antichi
sobborghi.
Nel
33
a.C.
Augusto
la
completò
con
la
fondazione
della
colonia
julia,
che
si
estendeva
sul
centro
della
città
vecchia.
Il
terreno
porta
ancora
molto
nette
le
tracce
delle
sovrapposizioni
successive
e
soprattutto
delle
vestigia
delle
costruzioni
massicce
dell'epoca
imperiale
romana.
Risalgono
a
questo
periodo
le
rovine
in
cui
nel
XIX
secolo
alcuni
hanno
creduto
di
identificare
la
casa
di
Annibale,
il
tempio
di
Eshmun
o
altri
monumenti
cartaginesi.
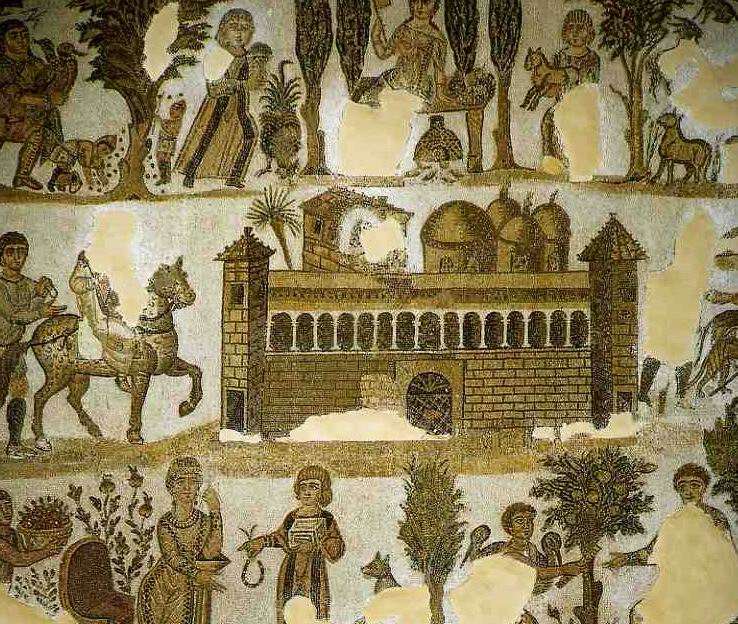 
Cartagine
tornò
quindi
ad
essere
una
città
importante,
perché
esportava
il
grano
africano,
che
costituiva
una
quota
notevole
degli
approvvigionamenti
di
Roma,
e
là
dove
si
trovava
il
tophet,
immense
costruzioni
servivano
forse
da
depositi
e
magazzini.
I
porti
antichi
tornarono
in
attività.
Vicino
al
mare
si
apriva
una
vasta
spianata,
che
avrebbe
potuto
essere
il
foro.
Sulla
costa
vennero
costruite
anche
le
terme
di
Antonino,
alimentate,
come
tutta
la
città,
dall'acquedotto
di
Zarhuan
e
da
grandi
cisterne.
Rimangono
ancor
oggi
visibili
i
resti
del
teatro,
dell'odeon,
del
circo,
dell'anfiteatro
e
di
numerosi
edifici
o
abitazioni
private,
ricche
di
mosaici
(casa
dei
Cavalli),
e
tutto
ciò
attesta
un
cambiamento
radicale
del
genere
di
vita
rispetto
all'epoca
punica.
Sopravvivevano
tuttavia
testimonianze
del
passato:
la
lingua
semitica
dell'antica
Cartagine
era
ancora
usata
ai
tempi
di
Apuleio
e
anche
più
tardi.
Cartagine
non
riuscì
per
questo
a
beneficiare;
ai
tempi
della
pace
romana,
di
un
periodo
di
tranquillità.
Subì
invece
le
sanguinose
conseguenze
dei
sommovimenti
politici
che
la
agitavano,
così
come
accadde
nelle
altre
grandi
città
del
mondo
romano,
che
essa
eguagliava
per
importanza:
Antiochia
e
Alessandria.
Nel
238,
venne
saccheggiata
dai
soldati
e
i
porti
furono
demoliti
sistematicamente
verso
il
300,
forse
da
un
usurpatore
africano
che
la
voleva
sottrarre
a
Roma.
Nel
311
venne
punita
per
le
sue
velleità
autonomiste
con
un
saccheggio.
Dopo
queste
devastazioni
e
dopo
un
grande
incendio
sotto
Antonino
Pio,
la
città
risorse
e
si
abbellì.
Nel
IV
secolo
divenne
un
centro
cristiano,
sede
del
primate
d'Africa.
La
sede
episcopale
era
già
stata
resa
illustre
da
san
Cipriano,
ai
tempi
delle
persecuzioni,
e
vi
si
tennero
dal
200
numerosi
concili.
Le
chiese
e
le
basiliche,
fra
cui
la
più
importante
era
la
Domus
Caritatis
(Damous
el-Kari),
erano
localizzate
soprattutto
a
nord,
cosa
che
ha
permesso
di
supporre
che
i
quartieri
popolari
fossero
stati
convcrtiti
al
cristianesimo
molto
prima
del
centro.
È
certo
che
la
città
rimaneva
impregnata
di
una
mentalità
pagana
ai
tempi
in
cui
sant'Agostino
vi
sentiva
ribollire
il
«calderone
(sartago)
degli
amori
peccaminosi».
Si
continuavano
a
costruire
edifici
lussuosi.
 Nel
439
giunse
il
re
vandalo
Genserico,
che
conquistò
Cartagine
e
ne
fece
la
propria
capitale.
Ma
ciò
non
aveva
impedito
al
suo
popolo
di
radere
al
suolo
tutti
gli
edifici,
forse
con
qualche
scopo
strategico:
nelle
terme
di
Antonino
le
volte
erano
state
sfondate
per
provocarne
il
crollo.
La
storia
dei
Vandali
a
Cartagine
coincide
con
quella
della
spietata
persecuzione
dei
cattolici
da
parte
dell'arianesimo,
di
cui
il
re
Unerico
fu
il
più
sanguinario
difensore. Nel
439
giunse
il
re
vandalo
Genserico,
che
conquistò
Cartagine
e
ne
fece
la
propria
capitale.
Ma
ciò
non
aveva
impedito
al
suo
popolo
di
radere
al
suolo
tutti
gli
edifici,
forse
con
qualche
scopo
strategico:
nelle
terme
di
Antonino
le
volte
erano
state
sfondate
per
provocarne
il
crollo.
La
storia
dei
Vandali
a
Cartagine
coincide
con
quella
della
spietata
persecuzione
dei
cattolici
da
parte
dell'arianesimo,
di
cui
il
re
Unerico
fu
il
più
sanguinario
difensore.
Nel
533-34,
Belisario
sbarcò
alla
testa
delle
truppe
bizantine.
Cartagine
doveva
conoscere
sotto
questa
dominazione
una
nuova
epoca
di
prosperità,
terminata
con
l'arrivo
degli
Arabi
verso
il
695.
Una
buona
parte
della
popolazione
si
era
allora
data
alla
fuga.
Il
luogo
sembra
essere
stato
abbandonato
definitivamente
all'epoca
in
cui
san
Luigi,
durante
la
crociata,
morì
di
peste
nel
campo
insediato
sui
fianchi
della
collina
di
Birsa
ARTE
E
ARCHEOLOGIA
Nel
corso
della
storia,
Cartagine
non
apparve
mai
come
la
culla
di
un'arte
originale,
in
grado
di
imporsi
alle
rivali
egiziana,
greca
ed
etrusca.
La
documentazione
è
abbondante,
ma
limitata
agli
arredi
funerari,
a
ex-voto
provenienti
da
santuari
e
a
muri
delle
abitazioni
saccheggiate.
Si
devono
distinguere
tre
periodi:
arcaico,
classico
ed
ellenistico.
Il
primo
va
dalla
fondazione
della
città
fino
al
480
a.C,
data
della
sconfitta
di
Imera.
È
un'era
coloniale
durante
la
quale
Cartagine
svolge
la
funzione
di
conservatrice
del
passato.
Le
più
antiche
vestigia
puniche
conosciute
sono
monumenti
votivi
eretti
nel
santuario
di
Salambò,
situato
a
sud
dei
porti,
dove
i
neonati
delle
famiglie
nobili
venivano
gettati
nel
fuoco,
secondo
il
rituale
dei
sacrifici
molek
(moloch,
nella
Bibbia).
Durante
l'epoca
persiana
(seconda
metà
del
VI
secolo
a.C),
i
punici
producono
maschere
di
terracotta:
facce
di
demoni
grinzose
e
contratte
in
smorfie,
coperte
di
verruche,
oppure
ritratti
idealizzati
di
uomini
e
donne
sorridenti.
L'oro
massiccio
è
lavorato
secondo
una
tecnica
venuta
da
Cipro,
che
unisce
lo
sbalzo
alla
perlinatura.
Orecchini
in
stile
egiziano,
anelli
con
un
sigillo
che
reca
incastonato
uno
scarabeo,
medaglioni
decorati
con
simboli
religiosi
adornano
i
morti.
L'avorio
è
di
solito
inciso.
 Dopo
il
480
a.C.
gli
artisti
cartaginesi,
interrotti
i
contatti
con
la
Gre
cia,
abbandonano
le
arti
figurative.
Nel
tophet,
a
sud
della
città,
le
figure
umane
scolpite
sui
cippi
diventano
sempre
più
schematiche
e
si
trasformano
in
«segni»
geometrici
agli
inizi
del
IV
secolo
a.C:
le
«bottiglie»
hanno
il
collo
e
la
pancia
rettilinee;
Tanit,
divenuta
protettrice
della
città,
è
invocata
da
un
triangolo
sormontato
da
una
retta
e
un
cerchio.
La
falce
lunare
con
i
corni
abbassati
domina
questi
emblemi,
che
decorano
ormai
le
stele
a
frontone
triangolare
di
stile
greco,
sostituite
ai
naos
e
ai
troni.
La
concezione
sobria
ed
equilibrata
di
tali
composizioni
corrisponde
all'estetica
classica,
ma
la
loro
trasposizione
lineare,
originale,
è
l'espressione
del
genio
mistico,
imbevuto
di
trascendenza
divina,
dei
Punici. Dopo
il
480
a.C.
gli
artisti
cartaginesi,
interrotti
i
contatti
con
la
Gre
cia,
abbandonano
le
arti
figurative.
Nel
tophet,
a
sud
della
città,
le
figure
umane
scolpite
sui
cippi
diventano
sempre
più
schematiche
e
si
trasformano
in
«segni»
geometrici
agli
inizi
del
IV
secolo
a.C:
le
«bottiglie»
hanno
il
collo
e
la
pancia
rettilinee;
Tanit,
divenuta
protettrice
della
città,
è
invocata
da
un
triangolo
sormontato
da
una
retta
e
un
cerchio.
La
falce
lunare
con
i
corni
abbassati
domina
questi
emblemi,
che
decorano
ormai
le
stele
a
frontone
triangolare
di
stile
greco,
sostituite
ai
naos
e
ai
troni.
La
concezione
sobria
ed
equilibrata
di
tali
composizioni
corrisponde
all'estetica
classica,
ma
la
loro
trasposizione
lineare,
originale,
è
l'espressione
del
genio
mistico,
imbevuto
di
trascendenza
divina,
dei
Punici.
A
a
partire
dalla
fine
del
V
secolo
a.C,
Cartagine
è
tornata
in
Sicilia
e,
dopo
ogni
vittoria,
artisti
e
opere
d'arte
insulari
giungono
in
città.
Un
tempio
in
stile
greco
viene
costruito
verso
il
396
a
.C.
in
onore
di
Demetra;
l'ellenismo
torna
a
dominare
le
arti,
ma
ha
tratti
provinciali
e
desueti.
L'industria
del
bronzo
produce
ora
oggetti
di
lusso.
Vasi,
maschere
e
amuleti
di
vetro
rimangono
fedeli
alla
tradizione
siro-fenicia.
Cartagine,
alleata
con
l'Etruria
agli
inizi
dell'età
ellenistica,
e
poi
all'Egitto
è
molto
potente
e
si
sforza
di
integrarsi
con
il
mondo
contemporaneo.
Artigiani
greci
aprono
in
città
botteghe
che
fanno
scuola
e,
sotto
il
loro
impulso,
il
marmo,
l'avorio,
il
bronzo
e
il
vetro
vengono
lavorati
con
talento
e
secondo
nuove
tecniche.
I
porti
si
arricchiscono
di
porticati
ionici.
Le
tendenze
mistiche
e
simboliche
dell'arte
ellenistica
ne
favoriscono
l'espansione,
ma
questa
conversione
è
più
apparente
che
reale
e
i
Punici
restano
legati
alla
cultura
semitica.
Si
assiste
allora
alla
nascita
di
un'arte
«periferica»,
composita,
esotica,
arte
illusionistica
in
cui
l'astratto
si
mescola
al
concreto
per
evocare
il
soprannaturale.
Stele
votive,
lame
di
rasoi,
ornamenti
di
cofanetti
in
avorio,
appliques
su
mobili
si
coprono
di
decorazioni
ellenizzanti,
ma
queste
immagini
si
sovrappongono
a
miti
fenici.
Tanit
assume
indifferentemente
i
tratti
della
Iside
alessandrina
e
della
Demetra
siciliana;
Nike
affianca
Baal
Hammon;
Shadrapa,
identificato
con
Dioniso,
ne
prende
a
prestito
gli
emblemi,
il
cratere
e
l'edera,
così
come
i
suoi
compagni,
i
satiri
e
le
baccanti.
I
sarcofagi
dei
notabili,
in
marmo,
riproducono
una
cella
greca;
alcuni
portano
sulla
copertura
l'effigie
del
defunto
coricato
in
posizione
ieratica
di
orante
orientale,
con
la
mano
destra
levata.
Sugli
ex-voto
del
tophet,
composizioni
architettoniche
fantastiche,
ispirate
dalle
pitture
vascolari
italiane,
oppure
capitelli
eolici
recanti
a
volte
una
nota
punica,
incorniciano
gli
emblemi
sacri.
Nel
corso
del
II
secolo
a.C.
si
viene
a
formare
un'arte
africana,
popolare
ed
esuberante,
che
sopravviverà
per
qualche
tempo
alla
caduta
di
Cartagine
(146
a.C).


Si
trattò
di
una
fine
prematura:
gli
artisti
punici,
infatti,
non
avevano
ancora
trovato
una
via
propria.
Il
ruolo
di
Cartagine
nella
storia
dell'arte
universale
rimane
nondimeno
essenziale:
senza
la
sua
azione
educatrice,
l'arte
romana
d'Africa
non
avrebbe
mai
conosciuto
una
simile
fioritura.
Della
Cartagine
punica,
distrutta
prima
dai
romani
e
poi
definitivamente
dagli
arabi
intorno
al
700
d.C,
non
restano
che
poche
rovine.
Le
più
interessanti
si
trovano
sulla
collina
di
Birsa,
dove
sorgeva
l'acropoli,
all'epoca
circondata
da
una
cinta
di
mura.
Vi
sono
state
trovate
alcune
sepolture,
ma
nessuno
degli
edifici
pubblici
e
delle
abitazioni
è
sopravvissuto
alle
conquiste.
Poche
tracce
indicano
il
santuario
di
Tophet,
il
luogo
destinato
alle
sepolture
sacrificali,
nei
cui
pressi
sorgeva
un
tempio
dedicato
agli
dèi
fenici
Tanit
e
Baal,
per
i
quali
venivano
immolati
i
figli
dei
nobili
cartaginesi.
Individuato
nel
1921,
ha
permesso
di
portare
alla
luce
numerose
stele
che
sono
servite
a
ricostruire
almeno
in
parte
i
costumi
dell'epoca.
Uno
stagno
in
riva
al
mare,
poco
più
a
nord,
è
quel
che
resta
dei
due
grandi
porti,
quello
mercantile
e
quello
militare,
che
avevano
fatto
la
grandezza
di
Cartagine.
Qualcosa
di
più
è
rimasto,
invece,
a
ricordare
l'epoca
romana;
come
le
vestigia
delle
imponenti
terme
di
Antonino,
costruite
tra
il
146
e
il
162
d.C.
Oggi
è
visibile
soltanto
il
basamento,
dove
sorgevano
le
stanze
degli
inservienti
e
i
forni
in
cui
si
scaldava
l'acqua
(poi
inviata
alle
sale
termali,
situate
al
piano
superiore),
sorretto
da
colonne
che
dovevano
avere
un
diametro
di
2
metri
e
un
peso
di
70
tonnellate.
In
anni
recenti
ne
è
stata
ricostruita
una
colonna,
che
raggiunge
un'altezza
di
15
metri,
mentre
la
volta
del
frigidarium,
in
fase
di
ristrutturazione,
dovrebbe
superare
i
20
metri.

Poco
distante
si
trova
la
basilica
di
Damus
el
Karita,
il
cui
nome
è
probabilmente
una
storpiatura
del
latino
"Domus
Charitatis",
dove
Sant'Agostino
predicò
tra
il
399
e
il
413.
L'anfiteatro,
dove
si
svolgevano
spettacoli
di
gladiatori
e
combattimenti
di
belve
famosi
in
tutto
il
mondo
romano,
è
stato
celebrato
come
uno
dei
più
grandi
dell'impero,
ma
oggi
è
appena
visibile
nel
verde
dei
pini,
poiché
la
maggior
parte
delle
pietre
è
stata
asportata
nei
secoli
per
essere
destinata
ad
altre
costruzioni.
A
nord-est
dell'anfiteatro
si
trova
una
serie
di
gigantesche
cisterne
che
costituivano
la
principale
fonte
idrica
della
città
in
epoca
romana.
Scarsi
sono
i
resti
del
teatro
fatto
costruire
da
Adriano,
come
pure
dei
templi
e
delle
abitazioni
di
quell'antica
potenza
del
Mediterraneo.
A
ricordare
la
grandezza
di
Cartagine
rimangono
piuttosto
le
collezioni
conservate
nel
Museo
Nazionale,
che
occupa
i
locali
del
Seminario
dei
Padri
Bianchi
accanto
alla
cattedrale
di
San
Luigi,
costruita
dai
francesi
nel
1890.
Qui
si
trovano
vasi,
sculture,
iscrizioni
e
ceramiche
scoperti
durante
gli
scavi,
ultime
testimonianze
della
Cartagine
punica,
romana
e
araba:
vestigia
di
un
impero
scomparso.








|