Chankillo è
un
antico
complesso
monumentale
nel
deserto
costiero
del Perù,
nella
valle
di
Casma,
dipartimento
di Ancash.
Le
rovine
rimaste
sono
l'osservatorio solare
(Tredici
Torri)
e
le
zone
residenziali.
Le
Tredici
Torri
vennero
forse
costruite
nel
quarto
secolo
a.C.
Sulla
costa
peruviana,
circa
400
chilometri
a
nord
di
Lima,
si
erge
il
complesso
di
Chankillo,
la
cui
età
è
stimata
in
23
secoli. La
sua
funzione
è
stata oggetto
di
varie
ipotesi:
si
è
immaginato
che potesse
servire
da
fortezza,
rifugio,
monastero
di clausura,
o
persino
che
fosse
un
luogo
deputato allo
svolgimento
di
battaglie
rituali.
Le
ricerche suggeriscono
invece
che
si
trattasse
di
un
grande
complesso cerimoniale
dedicato
al
culto
del
Sole.
In
altri
termini,
lo
si
potrebbe definire
l’osservatorio
solare
più
antico
d’America.
Nel
campo
dell’archeoastronomia,
il
termine
«osservatorio» va
usato
con
cautela,
dato
che
spesso
evoca
immagini
di
antichi «astronomi».
Tuttavia
lo
studio
dei
luoghi
dai
quali
le
civiltà
primitive scrutavano
la
volta
celeste,
insieme
alla
natura
e
al
contesto di
tali
osservazioni,
fornisce
informazioni
preziose
sul
modo
in
cui queste
civiltà
percepivano,
ordinavano
e
controllavano
il
mondo. Oggi
sappiamo
che
i
calendari
solari
orizzontali
(basati
sull’osservazione delle
posizioni
di
alba
e
tramonto
all’orizzonte
nel
corso dell’anno)
godevano
di
grande
importanza
tra
le
popolazioni indigene
d’America.
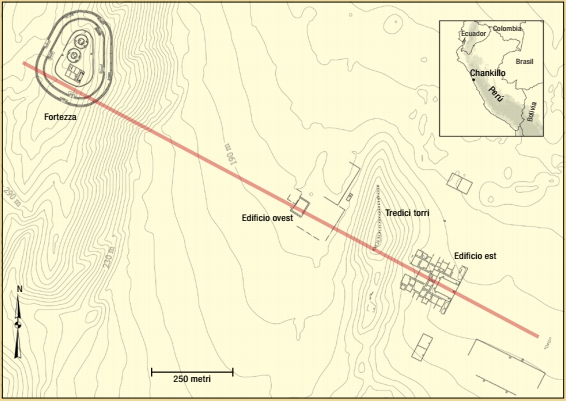 Nella
civiltà
maya,
l’individuazione
e
la
previsione dei
cicli
celesti,
con
fini
divinatori
e
predittivi,
si
spinsero molto
al
di
là
della
necessità
di
regolare
le
attività
annuali
cicliche in
funzione
dei
mutamenti
stagionali.
In
altre
parti
dell'America
centrale
lo
studio
dell’orientamento
degli
edifici
sacri
e
delle
piante urbane
suggerisce
l’esistenza
di
calendari
solari
orizzontali,
nei quali
si
attribuiva
particolare
importanza
a
date
chiave. Oltre
ai solstizi,
queste
includevano
i
passaggi
dallo
zenit
e
altre
date
calcolate a
partire
dalle
prime
a
intervalli
specifici,
il
tutto
nell’ambito dei
complessi
cicli
incrociati
del
calendario
mesoamericano.
Nella
civiltà
maya,
l’individuazione
e
la
previsione dei
cicli
celesti,
con
fini
divinatori
e
predittivi,
si
spinsero molto
al
di
là
della
necessità
di
regolare
le
attività
annuali
cicliche in
funzione
dei
mutamenti
stagionali.
In
altre
parti
dell'America
centrale
lo
studio
dell’orientamento
degli
edifici
sacri
e
delle
piante urbane
suggerisce
l’esistenza
di
calendari
solari
orizzontali,
nei quali
si
attribuiva
particolare
importanza
a
date
chiave. Oltre
ai solstizi,
queste
includevano
i
passaggi
dallo
zenit
e
altre
date
calcolate a
partire
dalle
prime
a
intervalli
specifici,
il
tutto
nell’ambito dei
complessi
cicli
incrociati
del
calendario
mesoamericano.
In
Sud
America
i
reperti
documentano
l’esistenza
di
pratiche
rituali e
credenze
cosmologiche
relative
a
un
culto
solare
regolato dai
sovrani
inca.
Ciò
indica
un
grande
interesse
per
il
movimento dei
corpi
celesti
e
per
il
calendario,
suggerendo
che
i
rituali
del
culto solare
fossero
orchestrati
dai
governanti
per
riaffermare
la
loro
origine
divina,
accentrare
il
potere
e
legittimare
la
propria
autorità.
Sono
state
avanzate
diverse
ipotesi
sui
possibili
schemi
usati
dagli Inca
per
regolare
il
calendario
mediante
il
paesaggio,
ipotesi
che prendono
le
mosse
da
documenti
storici
e
dall’analisi
della
disposizione spaziale
degli
edifici
sacri,
come
il
sistema
di
ceque
(linee
immaginarie lungo
le
quali
erano
disposti
i
luoghi
sacri)
di
Cuzco.
I
pilastri
del
Sole,
per
esempio,
sono
stati
descritti
da
vari testimoni
come
grandi
colonne
di
pietra
ubicate
in
modo
da
essere visibili
all’orizzonte
da
Cuzco.
Sarebbero
servite
a
scandire
i
tempi della
semina
e
del
raccolto
e
a
regolare
altre
pratiche
stagionali,
ma purtroppo
sono
sparite
senza
lasciare
traccia;
la
loro
posizione
precisa è
tuttora
sconosciuta.
Di
conseguenza
oggi
non
c’è
consenso sulla
possibile
funzione
svolta
dai
pilastri
nell’osservazione
del
Sole (e
forse
anche
della
Luna).
Il
complesso
contiene
numerosi edifici,
piazze
e
logge
costruiti
con
pietre
squadrate
e
fango
essiccato, e
occupa
una
superficie
di
circa
4
chilometri
quadrati.
Il
terreno su
cui
si
erge
è
composto
da
banchi
di
sabbia,
affioramenti rocciosi,
dune
e
boschi
di
carrubo.
L’edificio
più
noto
è
la
cosiddetta
«fortezza»:
un’imponente struttura
lunga
300
metri,
situata
strategicamente
in
cima
a
una collina
e
difesa
da
grandi
muraglioni,
accessi
ristretti,
parapetti
e, molto
probabilmente,
da
un
fossato
a
secco.
La
sua
funzione
è
stata oggetto
di
numerose
ipotesi:
fortezza,
caserma
o
centro
cerimoniale. Le
ultime
ricerche
archeologiche,
tuttavia,
suggeriscono
che forse
si
trattava
di
un
tempio
fortificato.

Un
settore
molto
meno
conosciuto
è
la
vasta
area
a
uso
civile
e cerimoniale
a
est
della
fortezza,
che
include
numerosi
edifici,
piazze, cortili
e
depositi.
Il
suo
elemento
caratterizzante
sono
le
Tredici Torri:
una
fila
di
tredici
costruzioni
cubiche
di
pietra
squadrata
e fango
collocate
sulla
cresta
di
una
collinetta,
che
sorge
pressappoco al
centro
dell’intero
complesso
di
Chankillo.
La
fila
è
orientata sull’asse
nord-sud,
sebbene
le
torri
numero
11,
12
e
13
(la
numero 1
è
quella
situata
più
a
nord)
inclinino
a
sud-est.
Le
torri
configurano un
orizzonte
artificiale
«dentellato»,
con
punte
e
spazi
vuoti disposti
a
intervalli
regolari.
Benché
le
torri
si
siano
conservate
abbastanza
bene,
gli
angoli superiori
e
alcuni
muri
interni
sono
parzialmente
collassati.
Le
costruzioni non
sono
identiche:
la
loro
pianta
è
rettangolare
o
romboidale, l’altezza
varia
tra
i
2
e
i
6
metri
e
il
volume
oscilla
tra
150 e
750
metri
cubi.
Ciò
che
invece
si
presenta
estremamente
regolare è
lo
spazio
fra
le
torri,
compreso
tra
4,7
e
5,1
metri.
Ogni
torre è
munita
di
due
scale
–
una
sul
lato
nord,
l’altra
su
quello
sud –
strette
e
ripide,
che
portano
in
cima.
A
differenza
delle
scale
sul lato
meridionale,
che
risultano
spostate
verso
est,
la
maggior
parte di
quelle
poste
sul
lato
settentrionale
è
collocata
in
posizione
centrale. Le
sommità
delle
costruzioni,
il
cui
pavimento
è
composto
di sabbia
o
piccole
lastre
di
pietra,
si
presentano
nel
complesso
ben conservate.
L’esistenza
di
scale
d’accesso
suggerisce
che
in
cima alle
torri
si
svolgessero
specifiche
attività.
Circa
250
metri
a
ovest
delle
torri
si
trova
un
gruppo
di
recinti e
altre
strutture,
tra
cui
spicca
un
edificio
composto
da
due
cortili rettangolari
adiacenti.
Il
cortile
a
sud-est,
che
misura
53,6
per
36,5 metri,
fu
costruito
con
attenzione,
intonacato
e
dipinto
di
bianco. Al
muro
perimetrale
sud
è
addossata
una
costruzione
molto
particolare: un
camminamento
lungo
40
metri
e
largo
2,5,
anch’esso intonacato
e
dipinto
di
bianco.
Curiosamente,
questo
corridoio non
porta
all’interno
dell’edificio,
ma
si
limita
a
collegarne
l’entrata nordorientale
(ristretta
mediante
appositi
muri)
con
un’apertura
a sud-est,
che
guarda
direttamente
alle
Tredici
Torri.
A
differenza
degli altri
ingressi
di
Chankillo,
è
privo
delle
classiche
nicchie
che
alloggiavano i
cardini
di
pietra
su
cui
poggiavano
le
porte
in
legno. Ne
possiamo
quindi
dedurre
che
il
corridoio
servisse
solo
per condurre
dall’accesso
ristretto
all’apertura
rivolta
alle
Tredici
torri. L’altezza
originaria
delle
pareti,
stimata
in
2,2
metri,
non
consentiva di
guardare
all’esterno;
tuttavia,
una
volta
giunti
all’apertura
in fondo
si
godeva
di
una
vista
piena
e
incontrastata
delle
torri.
 Scavi effettuati
in
prossimità
dell’apertura
hanno
portato
alla
luce
offerte di
ceramica,
molluschi
e
utensili
in
pietra,
il
che
suggerisce
l’esistenza di
un
rituale
associato
all’atto
di
attraversare
il
corridoio
e fermarsi
sulla
soglia
a
contemplare
le
torri.
Questa
apertura
è
stata ribattezzata
«punto
di
osservazione
ovest».
Scavi effettuati
in
prossimità
dell’apertura
hanno
portato
alla
luce
offerte di
ceramica,
molluschi
e
utensili
in
pietra,
il
che
suggerisce
l’esistenza di
un
rituale
associato
all’atto
di
attraversare
il
corridoio
e fermarsi
sulla
soglia
a
contemplare
le
torri.
Questa
apertura
è
stata ribattezzata
«punto
di
osservazione
ovest».
A
est
delle
Tredici
Torri
c’è
un
vasto
spazio
aperto,
contenente un
complesso
di
locali
interconnessi,
altri
edifici
minori
e
depositi, posti
intorno
a
una
grande
piazza.
Questa
non
è
delimitata
da
muri
o
edifici
su
tutti
i
lati;
tuttavia
il
suo
perimetro
è
ben
evidenziato dalla
natura
del
terreno,
che
in
corrispondenza
del
piano
calpestabile è
stato
in
parte
spianato,
in
parte
riempito
e
completamente ripulito
dai
detriti.
In
vari
punti
della
piazza
sono
state
trovate apparenti
offerte
di
flauti
in
ceramica
e
conchiglie
del
bivalve Spondylus
princeps;
nei
dintorni,
piccoli
immondezzai
contenenti resti
di
vasellame,
flauti
e
mais.
Tutto
sembra
indicare
che
in quest’area
avessero
luogo
grandi
adunate
e
banchetti
cerimoniali.
Le
Tredici
Torri,
per
la
loro
ubicazione
elevata
e
il
carattere
monumentale, sono
uno
degli
elementi
dominanti
del
paesaggio.
Tuttavia, un
piccolo
edificio,
relativamente
isolato
a
un
estremo
del foro,
suscita
particolare
interesse.
La
sua
collocazione
rispetto
alle torri
è
speculare
a
quella
del
punto
di
osservazione
ovest,
essendo collocato
quasi
sul
medesimo
asse
est-ovest,
alla
stessa
altezza
e
a una
distanza
molto
simile.
Gli
scavi
archeologici
effettuati
presso
questa
costruzione
hanno rivelato
una
pianta
rettangolare
incompleta,
larga
6
metri.
La
struttura è
in
cattivo
stato
di
conservazione
poiché,
oltre
ad
aver
subito le
ingiurie
del
tempo,
in
un
dato
momento
successivo
al
suo
abbandono sembra
essere
stata
smantellata
fin
quasi
alle
fondamenta. Analogamente
al
camminamento
che
conduce
al
punto
d’osservazione ovest,
l’edificio
presenta
un
accesso
ristretto
da
un
apposito muro.
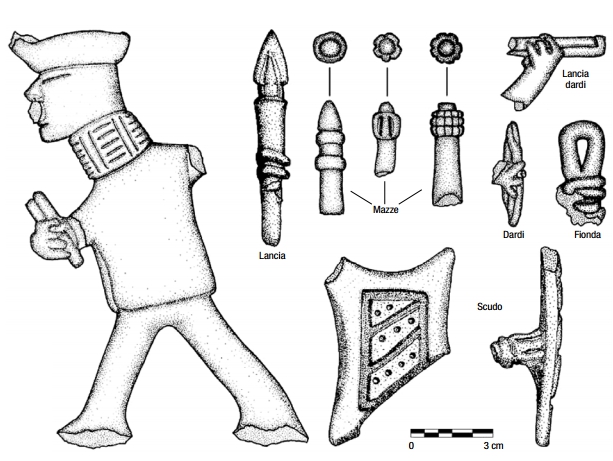 Tutto
indica
che
nelle piazze
e
negli
edifici
adiacenti
alle
Tredici
Torri
avessero
luogo banchetti
e
rituali
connessi
all’osservazione
e
interpretazione dei
movimenti
del
Sole,
a
cui
prendeva
parte
un
gran
numero
di persone.
Viceversa,
l’accesso
ai
punti
di
osservazione
era
verosimilmente riservato
a
pochi
individui,
il
cui
status
consentiva
loro di
accedere
agli
osservatori
e
officiare
le
cerimonie,
che
avevano
il potere
di
regolare
il
tempo,
l’ideologia
e
i
rituali
legati
al
calendario che
scandivano
la
vita
sociale.
Tutto
indica
che
nelle piazze
e
negli
edifici
adiacenti
alle
Tredici
Torri
avessero
luogo banchetti
e
rituali
connessi
all’osservazione
e
interpretazione dei
movimenti
del
Sole,
a
cui
prendeva
parte
un
gran
numero
di persone.
Viceversa,
l’accesso
ai
punti
di
osservazione
era
verosimilmente riservato
a
pochi
individui,
il
cui
status
consentiva
loro di
accedere
agli
osservatori
e
officiare
le
cerimonie,
che
avevano
il potere
di
regolare
il
tempo,
l’ideologia
e
i
rituali
legati
al
calendario che
scandivano
la
vita
sociale.
Gli
scavi
hanno
portato
alla
luce
guerrieri
di
ceramica
provvisti non
solo
di
armi
di
offesa,
ma
anche
di
scudi
e
altre
forme
di
protezione del
corpo.
Le
figure
esibiscono
inoltre
indumenti
che
ne
attestano lo
status,
come
copricapi
elaborati,
camicie
varie
e
ornamenti
per
il
collo, il
torso
e
il
naso,
la
cui
funzione
è
sia
decorativa sia
difensiva.
La
rappresentazione
dei
guerrieri
indica
una
preoccupazione per
la
loro
integrità
fisica:
i
simboli
del
loro
alto
rango riflettono
la
possibile
ascesa
di
una
classe
di
capi
guerrieri
e
il parallelo
accentramento
del
potere
nelle
mani
di
pochi.
È
quindi plausibile
che
a
Chankillo
il
culto
del
Sole
e
le
credenze
cosmologiche siano
serviti
a
legittimare
l’autorità
di
una
élite
guerriera,
come accadde
quasi
2000
anni
dopo
nella
società
inca.
In
quest’ottica, le
Tredici
Torri
non
sarebbero
solo
l’espressione
monumentale di
una
conoscenza
astronomica
ancestrale,
ma
anche
uno
strumento per
scandire
il
calendario
cerimoniale
e
legittimare
una
gerarchia sociale
consolidata.
Sono
sempre
di
più
gli
indizi
che
il
culto
del
Sole
assurto
a
rango ufficiale
nell’impero
inca
ebbe
dei
precursori.
Ne
sono
un
esempio le
cerimonie
sull’Isola
del
Sole,
nel
lago
Titicaca.
Data
la
somiglianza tra
l’osservatorio
solare
di
Chankillo
e
i
pilastri
del
Sole
documentati a
Cuzco
quasi
2000
anni
dopo,
sembra
molto
probabile
che pratiche
di
questo
genere
fossero
comuni
alle
civiltà
andine.
