|
La
Città Proibita, il maggior complesso politico-religioso di tutta
l’architettura cinese, sorse praticamente dal nulla su iniziativa
dell’imperatore Yongle, il terzo e più potente sovrano della dinastia
Ming.
All’inizio
del XV secolo Yongle decise di trasferire la capitale al Nord sia per
scongiurare la minaccia rappresentata dai popoli della steppa, sia per
creare un nuovo nucleo rituale da cui rifondare la propria dinastia, che
allora aveva sede a Nanchino.
Per
difendere la nuova capitale, Pechino (nome con cui gli Occidentali
chiamano Beijing), fu sufficiente ricostruire con pietra e mattone
quella parte della Grande Muraglia che la proteggeva. Per offrire un
alloggio sicuro al Figlio del Cielo, invece, fu necessario ricorrere a
tecniche che i ritualisti cinesi avevano perfezionato nel corso dei
millenni.
Una
tradizione millenaria – Quando, circa 3000 anni fa, si diede
inizio alla fondazione delle prime città e dei primi palazzi cinesi, lo
si fece seguendo alcuni schemi ben determinati: un recinto murato
circondava un grande spazio aperto, nel centro del quale, su una
piattaforma, si costruivano, allineati secondo una direttrice nord-sud,
gli edifici principali.
Il
grande spazio interno a questi cortili faceva presagire l’importanza
che secoli più tardi i taoisti avrebbero assegnato al “vuoto”,
concetto centrale nella loro dottrina.
D'altra
parte, l'esatta disposizione da nord a sud degli alti palazzi obbediva a
una visione cosmologica del potere che si sarebbe concretizzata mezzo
millennio più avanti, negli enunciati di Confucio e dei suoi discepoli,
per i quali la società e lo Stato, come anche l'universo, erano
rigorosamente organizzati in senso gerarchico. Questi principi
dell'architettura cinese erano già chiaramente definiti durante la
dinastia Han, contemporanea all'Impero Romano.
A
essi si aggiungeva un altro aspetto molto importante: il frequente
ricorso al legno. In Cina infatti la muratura e il mattone venivano
utilizzati per la costruzione delle muraglie difensive, delle mura
circostanti le costruzioni, di terrazzi e balaustre, di alcuni edifici
funerari e di pagode e, in genere, per opere di ingegneria, come i
ponti. Gli edifici, invece, venivano eretti utilizzando pilastri e travi
di legno. E non perché di legno ve ne fosse in abbondanza (la terra del
loess, le fertili pianure dove tanta fortuna ebbero i modelli
architettonici cinesi, ne era completamente sprovvista), ma perché
questo materiale presentava alcuni vantaggi rispetto alla pietra e alla
muratura e inoltre si adattava meglio all'organizzazione socioeconomica
dei cinesi: forte e leggero, era trasportabile in modo economico via
fiume, era facile da lavorare e, soprattutto, adatto per la produzione
di numerosi edifici costruiti in serie.
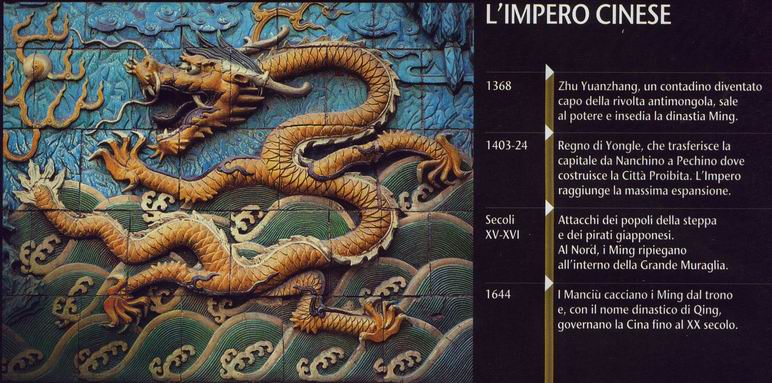
L'aspetto
negativo di questa scelta architettonica è che le costruzioni in questo
materiale sono di gran lunga meno resistenti di quelle fatte in pietra:
anche se la lacca con cui si tratta il legno può durare millenni, il
fuoco è il loro peggiore nemico. Per questo motivo contrariamente a
quanto è avvenuto in Europa, in Cina sono rimasti pochissimi edifici
antichi: non esiste niente che abbia l'età del Partenone o del
Colosseo, e neppure delle nostre cattedrali. Rimangono solo alcune
testimonianze a partire dall'epoca dei Ming, per altro molto rare in
quanto dell'architettura cinese non restano rovine e non solo per il
fatto che il legno dura di meno: i cinesi non volevano costruzioni
eterne. Preferivano, come accade nel secolo XXI, il costante
rinnovamento. In tal senso, l'aspetto attuale degli edifici della Città
Proibita è frutto delle ricostruzioni e dei cambiamenti intrapresi
dagli imperatori saliti sul trono dopo Yongle.
Gli
spazi del potere - Gli elementi architettonici ricorrenti negli
edifici del XV secolo erano pochi e semplici. In primo luogo c'era una
piattaforma che isolava dall'umidità e la cui altezza e complessità
dipendevano dall'importanza dell'edificio. Per esempio, le Tre Sale
dell'asse centrale della Città Proibita sono situate su una terrazza di
marmo a tre piani lunga 230 metri.
Nella
piattaforma, su basi di pietra o bronzo, si fissavano, unite alla sommità
da travi, le colonne di legno di "nanmu", un albero simile al
cedro, molto alto e resistente, che costituiva il materiale preferito
per la costruzione dei grandi palazzi. Nella Città Proibita è
possibile vedere delle particolarità della tradizione architettonica
cinese: travi di dimensioni decrescenti univano colonne anch'esse di
dimensioni decrescenti, creando una navata principale che poteva essere
ampliata in tutte le direzioni semplicemente aumentando il numero di
colonne e di travi, fatte con sezioni di legno di misura standard. La
combinazione di colonne e travi di diverse lunghezze consentiva al tetto
di avere spioventi curvilinei o diritti.
L'edificio,
sostenuto dalle colonne, non aveva pareti portanti né interne né
esterne. Infine, gli edifici erano completamente colorati con modelli
decorativi già in uso sette secoli prima di Cristo: il podio e le
pareti esterne di un solo colore, spesso rosso; le balaustre, di colore
naturale, in marmo nel caso di edifici di grande importanza, come quelli
della Città Proibita; colonne di un singolo colore, generalmente rosso;
mensole e travi, di colori vivaci, con la predominanza dell'azzurro e
del verde; tetto di un solo colore, verdazzurro per le costruzioni
comuni o i palazzi più piccoli, giallo a partire dall'epoca Ming per le
grandi sale imperiali. Fu sempre con i Ming che la tendenza
all'orizzontalità divenne assolutamente predominante: soltanto le
pagode si elevavano in verticale, contrastando con un mare di case e
palazzi di un solo piano.

Tra
le prime cronache antiche cinesi, Memorie di uno storico, scritto da Si
Ma Qian della dinastia Han ci racconta che come il Dio del Cielo
dimorava nel Purpureo Recinto, una costellazione formata di quindici
corpi celesti raggruppati intorno alla Stella del Mirto Purpureo, cioè
la Stella Polare, così il Figlio del Cielo, cioè l’imperatore doveva
dimorare in una città purpurea che doveva essere il centro del mondo
terrestre.
In
effetti, la parte vecchia di Pechino, o per meglio definire il centro
storico di Pechino, costruito all’inizio della dinastia Ming, era
ideato secondo tale antica tradizione e composto da 4 città distinte,
una dentro l’altra come la Stella del Mirto Purpureo immaginata
dall’uomo di allora in modo da confermare la stretta relazione fra il
Dio del Cielo e il figlio del Cielo. Durante le due ultime dinastie
imperiali Ming (1368 – 1644) e Qing (1644 – 1911), si potevano
distinguere una città esterna rettangolare situata nella parte
meridionale e una città interna quadrata nella parte settentrionale,
all’interno della quale si trovava la città imperiale, che
racchiudeva, a sua volta, il vero e proprio Palazzo Imperiale, chiamato
appunto la Città Proibita Purporea.
La
Città Proibita Purporea era la residenza imperiale delle ultime due
dinastie cinesi, nella quale vissero 24 imperatori, di cui 14 Ming e 10
Qing. Era un mondo chiuso e vietato, cui non poteva penetrarvi, nemmeno
avvicinarsi nessun suddito e per questo motivo, si chiamava La Città
Proibita.
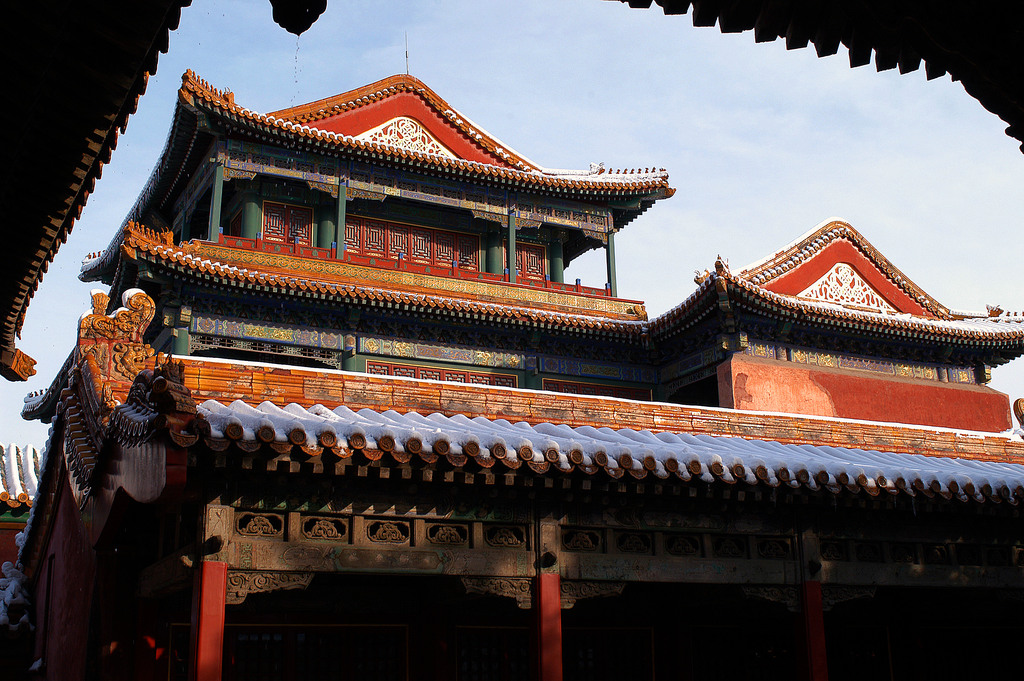
Una città nuova - Quando, a partire
dal XII secolo, i popoli del Nord occuparono parti sempre più vaste
della Cina settentrionale, la convergenza su Pechino di tutte le vie di
comunicazione che collegavano la Mongolia e la Manciuria con le grandi
pianure della Cina del Nord venne decisamente apprezzata.
L'importanza
di Pechino, che nel secolo XI era una piccola città mercato, crebbe in
concomitanza di ogni nuova invasione: i Kitàn la nominarono loro
capitale secondaria e la chiamarono Nanjing ("capitale del
Sud") o Yanjing ("capitale di Yan", dal nome di un antico
regno della regione).
Gli
Jűrchen, fondatori della dinastia Jin, la denominarono Zhongdu
("capitale centrale"), rimodellarono i suoi laghi e al centro
eressero il palazzo imperiale con i relativi giardini, devastato poi dai
Mongoli.
Nel
1261 Kubilay Khan, il sovrano mongolo, si accampò nelle vicinanze, si
innamorò del luogo e decise di stabilirvi la propria capitale, Dadu (la
"Gran Capitale", a cui Marco Polo attribuì il nome di
Khanbalic, "la città del Khan").
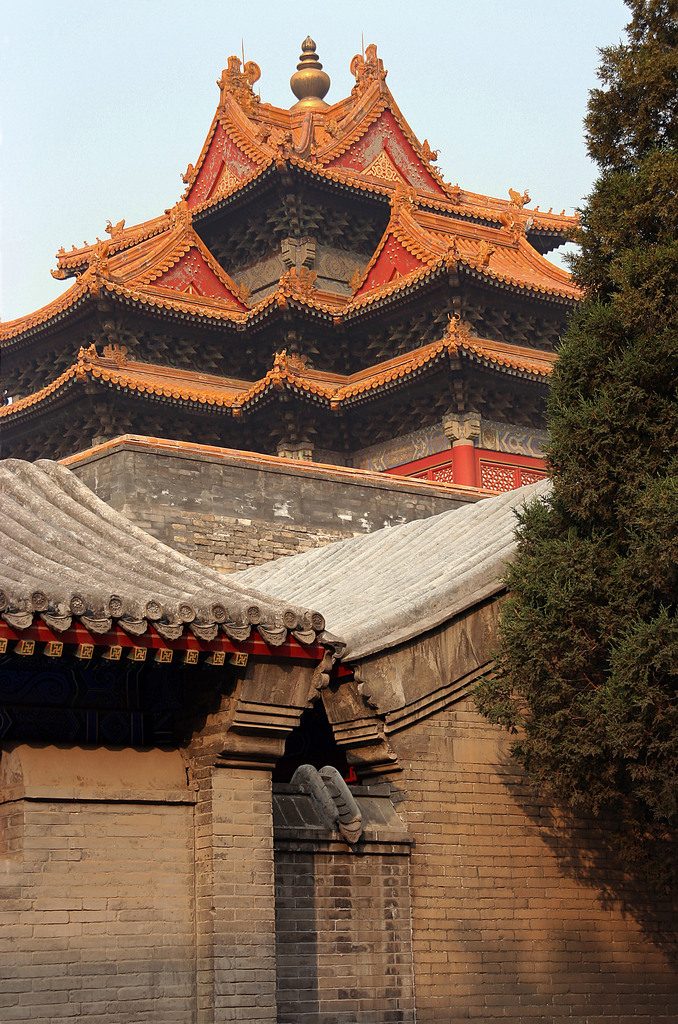 Nel
1368, quando i Ming cacciarono i mongoli, la capitale divenne Nanchino,
eretta sulle sponde del fiume Yangzi, diventato cuore economico della
Cina. Il fondatore del nuovo Impero, Zhu Yuazhang, volle accanto a sé
il suo primogenito e, quando questi morì, preferì a tutti il
primogenito di quest'ultimo, senza tenere conto degli altri suoi figli.
Il suo quarto figlio, Zhudi, venne mandato nell'antica città di Dadu,
ora ribattezzata Beiping ("Pace del Nord") e gli conferì il
titolo di principe di Yan. Fu proprio da questo luogo che, poco dopo la
morte del padre, Zhudi, il futuro imperatore Yongle, mosse una rivolta
contro il nuovo giovane imperatore, suo nipote. Dopo tre anni di guerra
e morte e la scomparse del nipote e di molti dei suoi stessi fratelli,
si proclamò imperatore della Cina. Nel
1368, quando i Ming cacciarono i mongoli, la capitale divenne Nanchino,
eretta sulle sponde del fiume Yangzi, diventato cuore economico della
Cina. Il fondatore del nuovo Impero, Zhu Yuazhang, volle accanto a sé
il suo primogenito e, quando questi morì, preferì a tutti il
primogenito di quest'ultimo, senza tenere conto degli altri suoi figli.
Il suo quarto figlio, Zhudi, venne mandato nell'antica città di Dadu,
ora ribattezzata Beiping ("Pace del Nord") e gli conferì il
titolo di principe di Yan. Fu proprio da questo luogo che, poco dopo la
morte del padre, Zhudi, il futuro imperatore Yongle, mosse una rivolta
contro il nuovo giovane imperatore, suo nipote. Dopo tre anni di guerra
e morte e la scomparse del nipote e di molti dei suoi stessi fratelli,
si proclamò imperatore della Cina.
Nanchino
uscì malmessa dalla guerra e Yongle, forzato anche dagli attacchi dei
mongoli nel nord, decise, nel 1406, di trasferire la capitale verso il
suo antico feudo, che ribattezzò Pechino, “capitale del Nord”.
La
nuova capitale, situata alquanto a sud rispetto a quella dei Mongoli, fu
concepita come una serie di rettangoli concentrici. Nel centro si
trovava la Città Proibita Purpurea (Zijincheng), il grande centro
cerimoniale della nuova Cina, che noi chiamiamo la Città Proibita.
Attorno
a essa, separata da un muraglione, si estendeva la Città Imperiale
(Huangcheng), circondata a sua volta da mura e in cui, oltre alle
residenze di alcuni dei grandi del regno e a diversi templi connessi
alla funzione imperiale, come l'Altare della Terra e il Tempio degli
Antenati, risiedevano le corporazioni che lavoravano senza sosta alla
ricostruzione e alla manutenzione dei palazzi: carpentieri, muratori,
pittori, tessitori... Il timore, più che giustificato, dei pericoli
causati dal fuoco causò ben presto l'espulsione dei ceramisti fuori dal
recinto.
Al
di là della Città Imperiale si estendeva, protetta anch'essa da una
cinta muraria, la Città Interna (Neicheng), chiamata Città Tartara
dopo che i Manciù, conquistata la Cina nel secolo XVII, vi fecero
stabilire la loro élite politica e militare.
La
nuova Pechino crebbe velocemente e a metà del secolo XVI anche i
quartieri a sud della Città Interna elevarono delle mura, creando un
nuovo spazio rettangolare: la Città Esterna (Waicheng) o Città Cinese.
Nel 1860, durante la seconda
guerra dell'oppio, l'esercito britannico penetrò nella Città proibita
e la occupò fino alla fine delle ostilità. Dopo essere stata la
residenza di 24 imperatori (14 della Dinastia Ming e 10 della Qing), nel
1912
la Città
proibita cessò di essere il centro del potere politico cinese, con
l'abdicazione del giovane imperatore Pu Yi. Egli ottenne però di poter
continuare a vivere all'interno della "parte interna" della
Città proibita con la sua famiglia, mentre la "parte esterna"
venne occupata dal governo della Repubblica di Cina e vi venne istituito
un museo nel 1914.
Pu Yi restò nella Città
proibita fino al 1924, quando Feng Yuxiang prese il controllo di Pechino
per mezzo di un colpo
di stato, espellendo l'ex imperatore. Poco dopo venne istituito
il "museo nazionale del palazzo", in cui erano esposti i
numerosissimi tesori raccolti dagli imperatori nei cinque secoli in cui
avevano dominato
la Cina. Durante
la seconda guerra sino-giapponese la sicurezza di tutti questi tesori
venne messa in pericolo, quindi si prese la decisione di riportarli
nella Città proibita.
Nel 1947, dopo che erano stati
spostati in numerosissime località della Cina, Chiang Kai-shek ordinò
che tutti i manufatti che si fosse riusciti a trasportare (provenienti
sia dalla Città proibita che dal palazzo imperiale di Nanchino)
dovevano venire portati sull'isola di Taiwan. Questi oggetti formano il
cuore del "museo nazionale del palazzo" di Taipei.
Oggi
la Porta Tiananmen
è decorata con un enorme ritratto di Mao Zedong, affiancato da due
manifesti. quello di sinistra reca la scritta zhōnghuá rénmín gònghéguó
wànsuì, che significa "lunga vita alla Repubblica Popolare
Cinese", mentre su quello di destra c'è scritto shìjiè rénmín
dà tuánjié wànsuì, cioè "lunga vita alla grande unità
delle popolazioni del mondo". Queste frasi hanno un enorme
significato simbolico, poiché la frase "lunga vita" era
tradizionalmente riservata all'Imperatore della Cina, mentre oggi è
utilizzabile anche per la gente comune, esattamente come è successo per
la Città
proibita.

La Città
proibita si trova immediatamente a
nord della Piazza Tiananmen e vi si può accedere attraverso il
Tiananmen, cioè
la Porta
della pace celeste. Intorno ai palazzi imperiali si trova
un'amplissima area chiamata "Città imperiale".
La Città
proibita è di forma rettangolare, il
più grande complesso di palazzi del mondo con i suoi circa
72 ettari
. È circondata da un fossato profondo
6 metri
e da un muro alto
10 metri
. Tutto il complesso è diviso in due parti:
- la "parte
esterna", che comprende le zone meridionali e centrali, è centrata
su
3 ampie sale che venivano usate per scopi cerimoniali (come per esempio
l'incoronazione, le investiture e i matrimoni imperiali). Una di queste
3 sale è la splendida Sala della suprema armonia. Oltre alle
sale da cerimonia, qui si trovano la Libreria
imperiale e gli archivi.
- la "parte
interna", che comprende le zone settentrionali, orientali e
occidentali della Città proibita; essa è centrata su altre
3 ampie sale, utilizzate per gli affari giornalieri dello stato. Il
palazzo più importante di questa parte, in cui viveva l'imperatore con
la famiglia, gli eunuchi e i servi, è il Palazzo della purezza
celeste.
I
palazzi della Città proibita
sono allineati lungo tre direttrici nord-sud. Quella centrale ospita i
palazzi più importanti; nella direttrice orientale si trovano alcuni
cortili semi-indipendenti; nella direttrice occidentale si trovano
diversi giardini ed edifici religiosi. La maggior parte di questa
direttrice non è aperta al pubblico, poiché alcuni edifici sono
pericolanti e altri vennero distrutti da un incendio nel 1923 e mai
ricostruiti. Nelle sue memorie, Pu Yi si dice convinto che il fuoco sia
stato appiccato da alcuni eunuchi che volevano cancellare le prove del
trafugamento di alcuni tesori dal Palazzo imperiale.
Le
mura che circondano
la Città
proibita hanno una porta su ogni lato. A sud si trova la "Porta
meridiana". A nord si trova la "Porta del volere divino"
(la distanza fra queste due porte è di
960 metri
). Le mura sono molto spesse, progettate specificamente per resistere ad
attacchi di cannoni. Ai quattro angoli della cinta muraria si trovano 4
torri, che permettevano un'ottima visuale sia all'interno che
all'esterno.
Tra la "Porta
meridiana" e la "Porta Tiananmen" si trova un'ampia
piazza in cui spesso venivano eseguite le punizioni corporali inflitte
dall'imperatore. Questa è la stessa piazza in cui Mao Zedong fece il
suo celebre discorso sul comunismo.
Tutta
la Città
proibita è circondata da giardini. Nella parte settentrionale si trova
il Giardino imperiale: qui sono ospitate moltissime piante
secolari, oltre a numerose specie rare. Gli edifici della parte
occidentale sono disposti intorno a due laghi, e servono come quartier
generale del Partito comunista cinese.

I cinesi non amano dare indicazioni usando i concetti di
sinistra e destra: preferiscono quelli di est e ovest, quindi gioverebbe
girare con una bussola in tasca, ricordando però che quella cinese
indica il sud... Tuttavia, lungo gli itinerari della Città Proibita,
una serie di simboli vi rammenta continuamente la vostra posizione:
basta saperli interpretare. Può essere dunque utile osservare come
l'imperatore si incastonava in una vera e propria "pianta
cardinale": una volta assiso in trono, egli volgeva il viso verso
il fiume dalle acque d'oro (jinshuihe) che i turisti varcano su cinque
ponti, a sud, indicato dall'uccello vermiglio; la schiena era invece
rivolta al nord, da cui provengono gli influssi negativi. Per questo era
dispiegato alle spalle del Figlio del Cielo un grande paravento, e
analogamente, alle spalle dell'intera Città Proibita, abbiamo visto
come fosse stata innalzata la Collina del Carbone, non a caso a cinque
picchi; simbolo austero del settentrione è il carapace della testuggine
nera.
 Il lato sinistro dell'imperatore si trovava così rivolto a
est, segnalato da un drago blu; sempre a est trovavano la propria sede i
dicasteri civili, definiti "dello Sbocciare delle Lettere". A
occidente, punto cardinale indicato dalla tigre bianca, erano ubicati i
dicasteri militari. Anche l'asse verticale era investito di una precisa
simbologia: sul soffitto, sopra la testa dell'imperatore, si sviluppava
una volta emisferica a cassettoni, rappresentante la volta celeste, con
un drago scolpito al centro. C'è drago e drago: quello imperiale
sfodera zampe a cinque artigli ed è giallo oro. Lo schermo dei nove
draghi, ad esempio, è un muro di trentun metri, alto sei, con nove
draghi di colori diversi su uno sfondo di duecentosettanta mattonelle
smaltate a comporre flutti marini sul registro inferiore e nuvole in
quello superiore. Se avete un'impressione di déjà vu, avete ragione -
oltre a un'ottima memoria: esistono in Cina altri due schermi simili,
uno al parco Beihai a Pechino e l'altro a Datong, nello Shaanxi. Questo
fu costruito nel 1774, sotto Qianlong. Il lato sinistro dell'imperatore si trovava così rivolto a
est, segnalato da un drago blu; sempre a est trovavano la propria sede i
dicasteri civili, definiti "dello Sbocciare delle Lettere". A
occidente, punto cardinale indicato dalla tigre bianca, erano ubicati i
dicasteri militari. Anche l'asse verticale era investito di una precisa
simbologia: sul soffitto, sopra la testa dell'imperatore, si sviluppava
una volta emisferica a cassettoni, rappresentante la volta celeste, con
un drago scolpito al centro. C'è drago e drago: quello imperiale
sfodera zampe a cinque artigli ed è giallo oro. Lo schermo dei nove
draghi, ad esempio, è un muro di trentun metri, alto sei, con nove
draghi di colori diversi su uno sfondo di duecentosettanta mattonelle
smaltate a comporre flutti marini sul registro inferiore e nuvole in
quello superiore. Se avete un'impressione di déjà vu, avete ragione -
oltre a un'ottima memoria: esistono in Cina altri due schermi simili,
uno al parco Beihai a Pechino e l'altro a Datong, nello Shaanxi. Questo
fu costruito nel 1774, sotto Qianlong.








Vale la pena attardare lo sguardo
sugli acroteri, le tegole che occupano la posizione più avanzata sul
tetto. È una posizione "critica" per molte culture, non
soltanto per quella cinese: un punto attraverso cui spiriti nefasti
potrebbero insinuarsi nella vita dei residenti. Meglio affidare al ruolo
apotropaico di figure mostruose il compito di stornare tali ospiti
indesiderati. Per decorare questi acroteri, sin dall'epoca Ming si usa
la tecnica sancai (a tre colori), con accorgimenti di produzione rimasti
praticamente invariati sino a oggi.
Vuole la leggenda che nel 283 a.C. il
crudelissimo principe Min dello Stato di Ji, sconfitto, sia stato appeso
a un angolo del tetto del suo palazzo e lì lasciato morire di fame. I
sudditi, ancora scottati dalla sua tirannia, collocarono a dileggio, sui
tetti delle proprie abitazioni, la sua immagine a cavallo di una
gallina, cui poi avrebbero aggiunto un drago mostruoso per non farlo
scappare. Solo molto più tardi, in epoca Ming, il corteo sarebbe
divenuto più sostanzioso.
Le decorazioni in ceramica smaltata
sono in grès: cotto a 1400°C, poi vetrificato, si rivela durissimo,
resistente agli attacchi del tempo.
L'ingresso al neiting era limitato
non solo per le persone ma anche per le suppellettili. La corte ordinava
a specifici forni delle forme di vasi di cui aveva il monopolio, il che
garantiva l'irriproducibilità del pezzo: nessun altro nell'Impero di
Mezzo avrebbe così potuto vantarsi di maneggiare opere simili a quelle
del Figlio del Cielo. Faceva eccezione un genere per cui diversi
imperatori Qing, soprattutto il curioso Qianlong, andarono pazzi: si
tratta degli orologi meccanici, provenienti soprattutto dalla Sassonia,
che affollano in diversi esemplari le collezioni imperiali ancor oggi in
bella mostra a palazzo.
Qiancbao e neiting sono nettamente
separati da un palazzo-membrana, la porta della Purezza Celeste la cui
versione odierna risale al 1655.
SIMBOLISMO - Il colore
reale era il giallo, colore che domina i tetti della Città proibita. In
ogni angolo dei tetti si trovano piccole statuette, il cui numero era un
chiaro segno del potere della persona che viveva nell'edificio. Il
numero 9 era riservato esclusivamente all'Imperatore. Solo un edificio
ha 10 statuette ad ogni angolo.
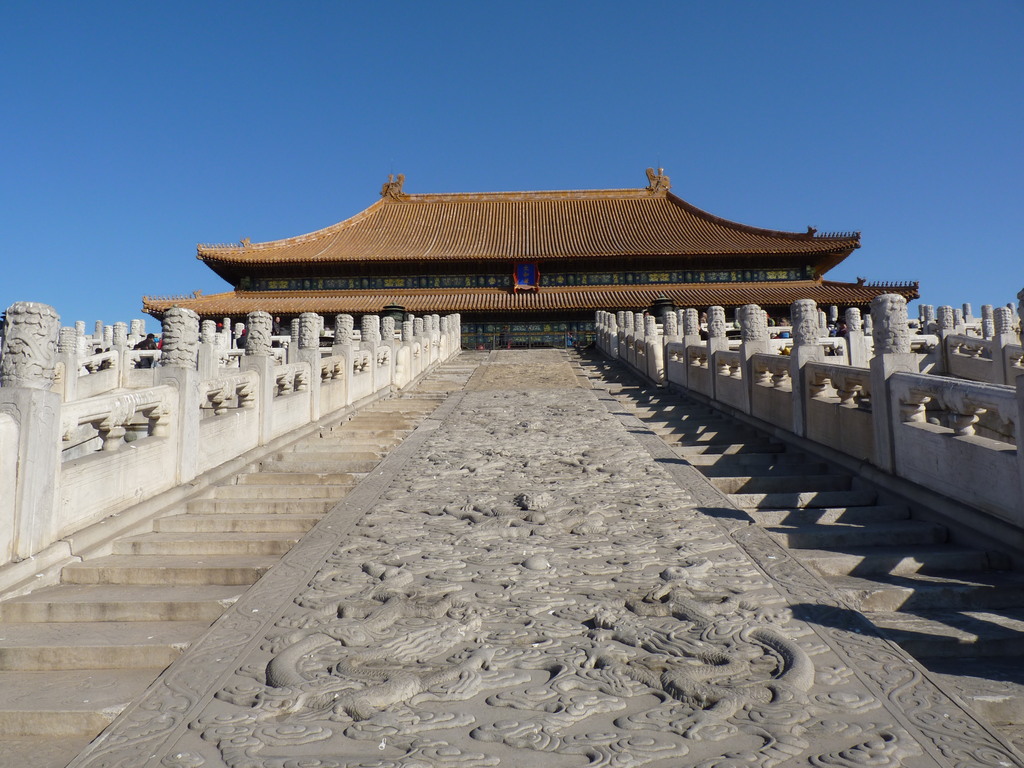
Circondato
da un fossato, l'insieme di palazzi servì come residenza a 24
imperatori. Ci sono 4 porte di accesso, una su ogni lato:
-
a sud, Wumen (Porta di Mezzogiorno);
- a nord, Shenwumen (Porta della Grandezza Divina);
- a est, Donghuamen (Porta Fiorita dell'Est);
- a ovest, Xihuamen (Porta Fiorita dell'Ovest).
La
Wumen è la porta
più grande del Palazzo è una costruzione massiccia, con 2 ali,
sormontata da 5 padiglioni, uno al centro, rettangolare, e 4 più
piccoli e quadrati, a ogni angolo. Qui l'imperatore presenziava
alle cerimonie militari e proclamava il nuovo calendario. Alla fine di
ogni battaglia le armate sfilavano davanti a questa porta in presenza
dell'imperatore a cui offrivano i loro prigionieri che egli poteva sia
condannare che graziare.
Dall'alto
della Porta, in epoca imperiale, gli editti, posti e calati in una
scatola di legno dorato venivano consegnati ai funzionari che li
ricevevano su di un vassoio e li portavano in processione al Ministero
dei Riti dove venivano copiati in migliaia di esemplari e spediti in
tutto il Paese. Varcata Wumen, si entra in un ampio cortile dove scorre
il Jinshuihe (Ruscello dalle Acque d'Oro). Lo si attraversa mediante 5
ponti di marmo.
Al
centro si aprono 3 porte. Queste immettono nel più grande cortile del
Palazzo, fiancheggiato a est e a ovest da due ali di costruzioni a un
piano, in cui un tempo si trovavano i depositi imperiali. Al centro
del
cortile, su una terrazza, si trovano le tre grandi sale. L'imperatore
accedeva a questa terrazza, seduto su una portantina, da una rampa
formata da una grande lastra di marmo bianco su cui è scolpito il
drago, la fenice, la perla e le nubi ordinate. I portatori salivano
sulla terrazza per mezzo delle 2 scale di marmo porte ai lati della
rampa stessa.

Taihedian
(Sala dell'Armonia Suprema) - Vi si accede salendo tre scale di
marmo di cui quella centrale era riservata all'imperatore. Lo
spiazzo antistante questa sala è ornato da 18 bruciaprofumi in bronzo
nei quali si bruciava legno di sandalo; ognuno rappresenta una delle 18
province della Cina antica. Un'edicola in pietra contenente una
misura per il grano a ovest e a est una meridiana simboleggiano la
giustizia e la rettitudine imperiali.
Un drago-tartaruga, animale mitologico, incarna la longevità e
l'immortalità. Quattro giade di rame dorato ricoperte da
18 kg
d'oro si trovano da una parte e dall'altra
del
padiglione. Esse servivano da riserva e deposito d'acqua in previsione
di incendi e assedi, dato che l'insieme della città è costruito quasi
interamente di legno massiccio. Durante l'inverno alcuni eunuchi erano
incaricati di accendere dei fuochi sotto le giare per evitare che
l'acqua si trasformasse in ghiaccio.
Il
Palazzo della Suprema Armonia è
sorretto da 24 colonne in legno massiccio di laurocanfora, di
28 m
di altezza, provenienti dal sud della Cina e trasportate via fiume fino
a Beijing: 6 colonne centrali dorate e decorate con il motivo del drago,
simbolo dell'Imperatore, e 18 pilastri laterali coperti di lacca rossa.
I
mattoni lisci che sono serviti alla pavimentazione di questo palazzo
sono stati anch'essi importati dal sud della Cina: venivano bagnati dopo
la cottura in un liquido oleoso che li rendeva brillanti e lisci.
Questa
sala, terminata nel 1669, è stata completamente restaurata a più
riprese. L'insieme di questa costruzione è a incastro: nessun chiodo
entra nella sua edificazione.
Al
centro
del
soffitto, un magnifico drago dorato sporge al di sopra
del
palco in legno di palissandro e
del
trono dorato dove prendeva posto l'imperatore. Dietro a questo, un
paravento ornato da nove draghi (il 9 era la cifra suprema, simbolo
del
cielo e della terra), e due elefanti - simboli della pace - che
vegliavano ai piedi
del
seggio imperiale. E' proprio su questo trono che l'imperatore regolava
gli affari di stato.
Al tempo delle grandi cerimonie (festa di primavera, celebrata secondo
il calendario lunare; solstizio d'inverno, anniversario
dell’incoronazione dell'imperatore, nomina dei generali, promulgazione
delle nuove leggi o proclamazione di decreti importanti...) una quantità
impressionante di legno di sandalo e di pino si consumava nei
bruciaprofumi; orchestre riempivano il palazzo di suoni, suonando su
campane d'oro e su carillon di lastre di giada (litofoni). Funzionari e
dignitari venivano allora a prostrarsi davanti al palazzo dove sedeva
l'imperatore, ma nessuna donna poteva assistere a questa cerimonia. Sul
suo trono, immerso in un fumo irreale, il "Figlio del Cielo",
intermediario tra Dio e gli uomini, poteva assaporare a piacere
l'"Armonia Suprema"; da qui il nome di questo padiglione.

Zhonghedian
(Sala dell'Armonia Perfetta) - E'
una sala meno importante e più intima della precedente. Il trono eretto
al centro è circondato da 2 bracieri e da 4 bruciaprofumi dorati.
Questa sala era innanzitutto un luogo di riposo e di riflessione. L'imperatore
vi metteva a punto il protocollo delle cerimonie che dove presiedere,
prima di recarsi in gran pompa alla Sala dell'Armonia Suprema.
E' qui che egli stendeva i messaggi che venivano letti nel Tempio degli
Antenati ed è qui che venivano esaminate una
volta
all'anno le sementi dei raccolti. Qui accettava anche le
felicitazioni dei suoi ministri e le lettere credenziali degli
ambasciatori stranieri. Gli imperatori bambini ricevevano qui
l'educazione relativa alle loro funzioni. Due portantine sono situate ai
fianchi
del
trono.
Praticamente l'imperatore non camminava mai al di fuori delle stanze o
dei giardini imperiali. Tutti i personaggi importanti si spostavano in
portantina; quella di un mandarino di distretto veniva portata da 4
uomini; da 8 uomini quella di un mandarino di provincia. Un ministro o
un ufficiale superiore aveva diritto a 16 portatori, l'imperatrice a 32
e l'imperatore a 48.
Baohedian
(Sala dell'Armonia protetta) - Questa sala servì per le udienze
fino ai tempi di Qianlong (1736-1796), quarto imperatore della dinastia
Qing. Vi
si celebrava anche la festa delle lanterne, il 15° giorno della prima
luna. In quest'occasione, l'imperatore offriva sontuosi banchetti alla
nobiltà delle minoranze nazionali e ai suoi ministri. Le colonne
che sostengono il tetto qui sono più antiche e meno numerose che nella
Sala della Suprema Armonia, in modo da permettere grandi ricevimenti.
Gli esami imperiali si svolgevano in questa sala.
Ogni tre anni, secondo la tradizione confuciana, l'imperatore sceglieva
i candidati solitamente tra i nobili e gli aristocratici per mantenere
sempre meglio il suo potere. La selezione si basava dapprima su esami
locali (i candidati riconosciuti divenivano letterati), poi su quelli
provinciali (gli intenditori) e infine su quelli imperiali. Quest'ultimo
esame era presieduto dall'imperatore. Ai lati del trono sono esposti
alcuni reperti archeologici scoperti nel 1976, come pure si possono
ammirare dei rari ornamenti risalenti a più di 5000 anni or sono. Un
bronzo funebre rappresenta due cavalieri armati di lancia che precedono
un carro tirato da due cavalli che trasporta un funzionario protetto da
un parasole. Un cavallo che galoppa su una rondinella risale alla
dinastia degli Han dell'ovest.
Si
possono ugualmente ammirare doni offerti dalle delegazioni straniere che
venivano a Beijing per negoziare accordi commerciali con l'Impero di
Centro. La maggior parte di questi doni è stata ritrovata ancora nelle
relative casse d'imballaggio. Questo padiglione delimita la parte
ufficiale del Palazzo. Un'imponente lastra di marmo di 200 tonnellate e
di
170 cm
di spessore, ornata da 9 draghi, conosciuta come il tappeto di marmo,
conduce alla parte nord di questo palazzo. La lastra, composta di un
solo pezzo di marmo, scolpita sotto i Ming, proviene da una cava situata
a una cinquantina di chilometri da Beijing. Gli operai approfittarono
della rigidità dell'inverno per trasportarla. Essi scavarono pozzi ogni
500 m
. e versarono sul percorso, in grande quantità, dell'acqua in modo da
formare uno spesso strato di ghiaccio: il marmo, depositato su un carro
senza ruote trainato da buoi, fu spostato così più facilmente.

Attraversando
la Qianqingmen
(Porta della Purezza Celeste) si arriva alle tre sale private
dell'imperatore.
Le
differenze di stile tra la prima parte della Città Proibita, maestosa e
grandiosa, e la seconda più intima e di dimensioni più umane,
permettono di immaginare i contrasti che separavano gli affari pubblici
e la vita privata dell'imperatore.
La
vita pubblica si svolgeva nel fasto e nella grandezza; la vita
familiare, in appartamenti, giardini e corridoi più intimi, trascorreva
più semplicemente.
Sulla terrazza ci sono quattro bruciaprofumi dorati. Qui, gli
imperatori Ming avevano la loro stanza da letto. Poi, con i Qing,
divenne sala di udienze in cui si ricevevano gli ambasciatori stranieri.
Al
centro vi è il trono imperiale con bruciaprofumi in "cloisonné";
durante i Ming era l'abitazione dell'imperatrice. Sotto i Qing,
l'imperatore e l'imperatrice vi trascorrevano la loro prima notte di
nozze.
Uscendo
dalla "Porta
della Tranquillità Terrestre" si giunge al
Giardino Imperiale, costruito in epoca Ming.
La
parte nord-ovest del Palazzo Imperiale è una successione di corti e
padiglioni. Qui vivevano le concubine, le favorite e gli eunuchi. Se
ufficialmente un imperatore poteva avere 3 mogli, 6 favorite e 72
concubine, alcuni di essi possedevano fino a 3.000 concubine. Oggi la
maggior parte dei palazzi è adibita a musei. troviamo:
Yangxindian
(Palazzo del Nutrimento dello Spirito) qui vissero gli ultimi 3
imperatori Qing:
I
6 Palazzi dell'Ovest (Xiliugong)
dove risiedevano l'imperatrice, le vedove, le inservienti e le
concubine;
Zhaigong
(Palazzo dell'Astinenza), dove la corte si felicitava quando
nasceva l'erede al trono; adibito a museo degli oggetti di bronzo;
I
6 palazzi dell'Est (Dongliugong)
custodiscono collezioni di oggetti preziosi(ceramiche, porcellane
d'epoca Yuan, Ming, Qing, stoffe e sete); Va notato che gran parte
del tesoro di arte del Palazzo Imperiale è stato portato a Taiwan dai
nazionalisti nel 1949 e si trova attualmente nel Museo Nazionale Cinese
a Taipei;
Ningshougong
(Palazzo della Tranquillità e della Longevità) - Si
trova nella parte nord-est del Palazzo Imperiale, in esso si compivano i
sacrifici. Fu da qui che l'imperatrice Cixi nel 1900 decise di
lasciare Beijing con la corte quando gli Europei stavano entrando in
città.
Attraverso
la Yangxingmen
(Porta del Nutrimento del carattere) si arriva alle 3 sale che
costituivano gli appartamenti privati dell'imperatore Qianlong e
dell'imperatrice Cixi. In queste 3 sale sono conservati ed esposti parte
dei tesori imperiali: oggetti in oro, giada, corallo, doni che
funzionari o dignitari civili e militari cinesi o capi di stato e
diplomatici esteri hanno inviato agli imperatori.
A
ovest della "Porta del Nutrimento del Carattere" vi è un
giardino con alberi e colline artificiali. Vicino c'è il Pozzo della
concubina Zhenfei.
In esso l'imperatrice Cixi nel 1900 fece gettare la favorita
dell'imperatore perché aveva cercato di persuadere il "Figlio del
Cielo" a restare nel palazzo imperiale con lei anziché fuggire
davanti al nemico.
Nella
Jianting (Sala delle Frecce) sono
esposti i tamburi di pietra. Si tratta di 10 blocchi di pietra la cui
forma richiama solo vagamente quella di un tamburo. Ciascuno ha
un'iscrizione che ricorda una battuta di caccia fatta da un duca di Qin.
Sono le più antiche epigrafi cinesi su pietra che ci siano pervenute e
sono state scoperte sotto i Tang nel VII sec. nel distretto di Fengxiang
nel Shaanxi.

Nella
parte ovest troviamo:
-
Xihuayuan (Giardino dell'Ovest);
- Yuhuage (Padiglione della Pioggia di Fiori), tempio lamaista decorato
con trofei di ossa umane;
- Cininggong (Palazzo della Tranquillità e della Pace), il più
importante dei palazzi dell'ovest;
- Dafotang (Sala del Grande Buddha).
Al
Parco di Sun Yatsen vi si accede da una porta collocata a ovest della
Tian’anmen. Nel
1421 l
'imperatore Yongle vi eresse l'Altare del sole e del raccolto diviso in
5 sezioni ciascuna contenente terra di colore diverso a indicare che
tutti i continenti della terra appartengono all'imperatore. A nord
dell'altare sorge la "Sala della Preghiera". qui si svolgono
generalmente le cerimonie funebri di eminenti uomini del partito o del
governo.
Al
Parco della Cultura del Popolo vi si può accedere da una porta a est
della Tian’anmen. Nel 1544 vi venne edificato il "Tempio degli
Antenati Imperiali" dove i Ming e i Qing venivano a onorare i loro
morti.
Sebbene
in Cina raramente si conoscano i nomi degli architetti, alcuni dei nomi
dei progettisti del complesso sono oggi noti.
Le
arti praticate dai nobili, dai funzionari e persino dagli imperatori
erano la pittura, la calligrafia e la poesia: gli architetti non
nascevano in questi ambiti, ma si formavano tramite la tradizione orale
degli artigiani ed erano regolati da usi e leggi onerose che
determinavano i gradi e le distinzioni fra i servi imperiali. Sappiamo
tuttavia, che la Città Proibita fu progettata dall'eunuco vietnamita
Nguyen An e che il coordinamento di tutta l'opera fu effettuato sia dal
ministero dei Lavori Pubblici sia da quello della Giustizia,
responsabile della dislocazione di decine di migliaia di famiglie nei
dintorni di Pechino, destinate alla produzione degli alimenti che gli
esigenti abitanti della nuova città avrebbero consumato, e della
precettazione delle centinaia di migliaia di condannati assegnati al
trasporto e alla costruzione: da tempo immemorabile tutte le capitali
cinesi sono state costruite in questa maniera, combinando spostamenti
obbligati a lavori forzati.
|
La
grande residenza imperiale
Eretta
da Yongle, terzo sovrano della dinastia Ming, 1 Httà
Proibita fu utilizzata quale residenza imperiale e sede a corte
fino al 1912, anno in cui Puyi, l'ultimo imperatore, abdicò. Il
suo progetto rispondeva ad antichi principi religios e magici:
orientata da nord a sud, organizzata ortogonalmen il suo ordine
rifletteva quello dell'universo stesso. Al centro si trovava il
trono dell'imperatore, mediatore fra Ciclo e Terra, la cui
figura veniva associata alla Stella Polare, attorno alla quale
giravano le altre stelle. Allo stesso modo la Città Proibita si
struttura intorno allo spazio centrale occupato dalle Tre Sale,
in cui si trova il trono imperi Un protocollo rigoroso regolava
l'accesso ai diversi spazi del recinto, vietato alla gente
comune.
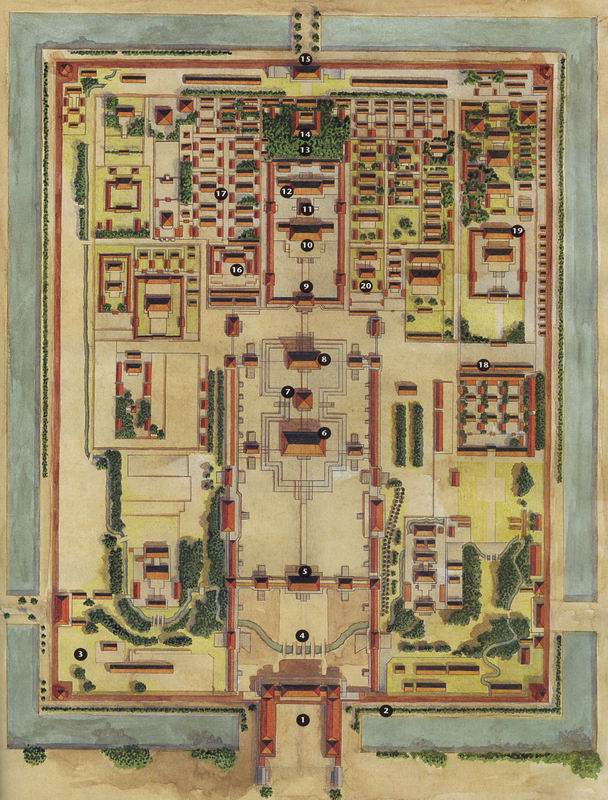 1.
Porta di Mezzogiorno - La Città Proibita ha quattro
porte che si aprono in concomitanza dei quattro punti cardinali.
Questa porta è alta 35 metri. 1.
Porta di Mezzogiorno - La Città Proibita ha quattro
porte che si aprono in concomitanza dei quattro punti cardinali.
Questa porta è alta 35 metri.
2.
Muraglione e fossato - Il complesso imperiale è circondato
da un muraglione alto 12 metri e un fossato largo 50 metri.
3.
Le abitazioni degli eunuchi - Con i Ming, gli eunuchi
acquisirono un'importanza crescente negli affari di Stato.
4.
Fiume delle Acque d'Oro - Qualsiasi fosse il suo stato o
funzione, i sevi dell'imperatore lo attraversavano transitando
su uno o l'altro dei cinque ponti.
5.
Porta dell'Armonia Imperiale - Introduce in un cortile di
30.000 metri quadrati, circondato da due gallerie destinate a
magazzini imperiali.
6.
Sala dell'Armonia Suprema - In essa il sovrano presiedeva le
grandi cerimonie, il proprio compleanno, l'arrivo del Nuovo
Anno..
7.
Sala dell'Armonia Perfetta - Il sovrano preparava in questa
sala le suppliche rituali prima di effettuare i sacrifici
annuali.
8.
Sala dell'Armonia Perfetta - Accoglieva eventi quali i
banchetti per i dignitari stranieri e gli esami di alti
funzionari..
9.
Porta della Purezza Celeste - Da qui si accedeva ai tre
Palazzi interni, residenza ufficiale della famiglia imperiale.
10.
Palazzo della Purezza Celeste - Qui erano dislocate le
stanze private del'imperatore. Nel XVIII secolo fu utilizzato
per scopi amministrativi.
11.
Sala dell'Unione - Era la sala del trono dell'imperatrice,
dove venivano ricevute le concubine durante le grandi
celebrazioni annuali.
12.
Palazzo della Tranquillità Terrestre - Accoglieva le stanze
dell'imperatrice. Qui i sovrani passavano la prima notte di
nozze.
13.
Giardino imperiale - Ha una superficie di 7000 metri
quadrati e ospita padiglioni, stagni, colline artificiali....
14.
Sala della Pace Imperiale - In questo tempio taoista gli
ultimi imperatori Ming si esercitavano in pratiche quali
l'alchimia e la divinazione.
15.
Porta della Grandezza Divina - Di fronte a essa, oltre il
recinto, si alza la collina del Carbone, dove si impiccò
l'ultimo imperatore Ming.
16.
Sala del Nutrimento dello Spirito - I sovrani si ritiravano
qui per dedicarsi allo studio e per esercitarsi nella
calligrafia e nella pittura.
17.
Sei Palazzi Occidentali - In questo complesso, interamente
restaurato nel XIX secolo, risiedevano le concubine imperiali.
18.
Muraglione dei Nove Draghi - Di 4 metri per 30, è decorato
con mattonelle che rappresentano nove draghi fra le onde del
mare.
19.
Palazzo della Serena Longevità - Costruito nel XVII secolo,
un muro preservava l'intimità dei sovrani.
20.
Palazzo dell'Astinenza - I sovrani si ritiravano in questo
palazzo per digiunare prima della celebrazione di vari riti
annuali. |
 I
VESTITI DI CORTE I
VESTITI DI CORTE
I vestiti sfoggiati dai funzionari a corte risentono della
moda mancese, determinata dalla lunga pratica d'equitazione di questa
popolazione nomade: sembrano pastrani per cavallerizzi, con le loro
maniche strette che terminano "a zoccolo", lo spacco laterale,
un cappello da cavaliere e gli stivali. Il drago a cinque artigli sul
busto è appannaggio del solo imperatore. Spesso i draghi sono
raffigurati in coppia, affrontati, e si disputano la perla, simbolo del
potere.
Lungo l'abito si affollano i dodici motivi creati dal
leggendario sovrano Shun già 4500 anni fa: la montagna, segno di
costanza e stabilità; il drago, simbolo di vigilanza;
il fagiano, la combattività in guerra; le coppe per i riti ai
penati, simbolo di purezza e disinteresse; la fiamma, che rappresenta lo
zelo e l'onore per la virtù; il riso, ciò che l'imperatore deve
procurare in abbondanza al popolo; le alghe, il rispetto per
l'equilibrio delle distese marine; l'ascia, il simbolo della
giustizia... Tali simboli venivano sì ricamati sui vestiti, ma per
essere intagliati nel cuore. Il vestito si sublimava in un continuo
memento di rettitudine per chi lo indossava, e solo gli atelier di tre
città potevano confezionare le uniformi imperiali: Suzhou, Hanzhou e
Jianning.
Il chaozhu, la collana cerimoniale, valeva un po' come i
galloni per i militari. Il colore dei fili di seta che collegavano i
vari rami della collana rivelava lo status di chi la indossava: giallo
brillante era il colore dell'imperatore, della sua sposa e della sua
concubina; oro per i familiari e i principi; turchese per gli altri. La
collana derivava dal rosario buddhista, religione che - influenzati dai
mongoli - i mancesi avevano fatto propria. Le centootto perle scandivano
l'eliminazione dei dieci desideri impuri. Ogni ventisette perle ve n'era
una più grande, la "testa di buddha". La testa di buddha che
cadeva al centro della nuca sfoggiava un pendente, la "nuvola
dorsale", con uno stupa in miniatura.
Il materiale delle perle cambiava non solo in relazione a
chi le indossava, ma in relazione allo scopo della cerimonia: quando
l'officiante sacrificava al Cielo, la collana era in perle di turchese,
per la Terra aveva grani d'ambra, per il tempio del Sole era in corallo,
in malachite per il tempio della Luna. La numerologia della collana può
essere letta anche in un'altra chiave: il numero 108 potrebbe richiamare
la scansione temporale-meteorologica del mondo in dodici mesi,
ventiquattro atmosfere e settantadue climi. In passato, le campane
buddhiste - la cui superficie è decorata da 108 punzoni - suonavano
centootto volte alla mattina e altrettante alla sera, per scacciare il
male. Infatti, secondo un sutra buddhista, la campana ha valore
apotropaico. Oggi vengono battute per centootto volte solo all'ultimo
dell'anno e in occasioni speciali, per fugare le centootto
preoccupazioni mondane dell'anno vecchio.
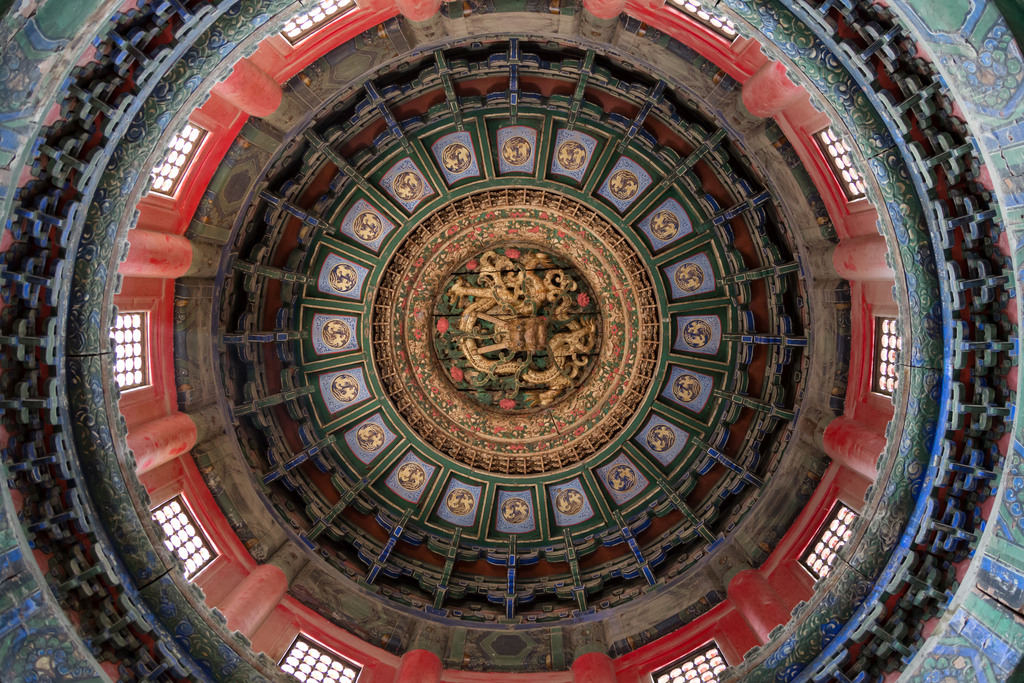
LA PAGODA
Alla morte del Buddha, il suo corpo venne cremato su una
pira funebre; i pochi resti ossei vennero distribuiti fra i discepoli
che si disseminarono sul suolo indiano. Quando arrivavano in un
territorio dove la loro predicazione attecchiva, costoro seppellivano la
reliquia del Buddha in loro possesso e vi edificavano sopra a
commemorazione un cenotafio, una "tomba vuota", lo stupa,
attorno al quale si sviluppava la comunità monastica. La forma della
torre reliquiaria, cioè quella che viene comunemente chiamata pagoda da
una lettura errata del cinese dagoba, deriva dall'incontro dello sikhara
indiano con il lóu cinese, una sintesi avvenuta a partire dal III
secolo d.C. Lo sikhara è la torre reliquiaria indiana, e deriva da uno
sviluppo ipertrofico del pinnacolo sopra lo stupa. Lo stupa è la tomba
a cumulo eretta per i grandi leader politici o spirituali, come il
Buddha ad esempio. Il lóu è la torre militare cinese d'avvistamento.
La piattaforma circolare, che evoca una muratura di
mattoni, sostiene undici devoti o monaci in atteggiamento di preghiera.
La rappresentazione muove secondo un procedimento metonimico, che usa
cioè la parte per il tutto. L'area del monastero è riecheggiata dalla
semplice menzione del gatha (cancello), di un recinto, dei monaci, di
due alberi simmetrici e tre fiori. L'albero è una delle possibili
rappresentazioni aniconiche del Buddha, come del resto la pagoda
medesima. Le campanelle agli acroteri di ciascun tetto diffondono
preghiere ogniqualvolta vengano sollecitate dal vento. Siamo dunque di
fronte a una rappresentazione sintetica, metonimica di un convento, e
insieme dell'ekklesia buddhista. L'origine della pagoda come torre
reliquiaria è svelata in un piccolo particolare: se guardate
all'interno della torre, scorgerete un piccolo deposito: è la
"cassaforte" della reliquia.
Palazzo
Mukden

Il Palazzo
Mukden, chiamato anche Shenyang
Gugong, è l'antico palazzo imperiale della Dinastia Qing (1616 -
1910). Si trova nel centro della città cinese di Mukden, oggi Shenyang,
in Manciuria.
Il palazzo si estende su di
una superficie di circa
70.000 metri quadrati
e consta di 70 edifici, a loro volta composti da 300 stanze.
La costruzione del palazzo
iniziò nel 1625, durante il regno del fondatore della Dinastia Qing,
Nurhaci. Nel 1631 vennero aggiunti ulteriori edifici per ordine
dell'imperatore Huang Taiji. I primi 3 imperatori Qing vissero qui fra
il 1625 e il 1644.
  Il palazzo venne progettato
per assomigliare alle tende del popolo Manchu,
mentre l'allargamento ordinato da Huang Taiji aveva lo scopo di
copiare
la Città
proibita di Pechino. Il palazzo venne progettato
per assomigliare alle tende del popolo Manchu,
mentre l'allargamento ordinato da Huang Taiji aveva lo scopo di
copiare
la Città
proibita di Pechino.
Nel palazzo sono evidenti
alcuni elementi dello stile architettonico proprio delle popolazioni
Manchu e del Tibet.
Nel 1644, quando
la Dinastia Qing
prese il posto della Dinastia Ming a Pechino, il palazzo perse il suo
status di residenza ufficiale dell'imperatore e divenne un semplice
palazzo regionale.
Nel
1780 l
'imperatore Qianlong fece costruire ulteriori edifici che ampliarono il
palazzo. I successivi imperatori Qing presero l'abitudine di passare
parte dell'anno in questo palazzo.
Nel
1955 il palazzo Mukden venne trasformato in un museo.

|