|
Mentre la parabola
dell’impero Gupta (240 – 550 d.C.) compiva il suo corso e prendevano
forma le soluzioni architettoniche e scultoree che avrebbero generato
l’arte dell’induismo, il mondo buddista entrava nelle sue fasi
tarde. I monaci buddisti del Deccan, sotto il patrocinio di dinastie
locali legate o meno al potere imperiale del Gange, diedero vita a
straordinari complessi monastici, scavati in forma di insieme di grotte
nei banchi di roccia vulcanica che formano la penisola indiana.
Nella
regione nord-occidentale dell'India, corrispondente allo stato di
Maharashtra avente per capitale Bombay, sorge lo straordinario complesso
sacro di Ajanta: in una valle rocciosa attraversata da un corso d'acqua,
il fianco semicircolare di una collina ospita una trentina di grotte
scavate nella pietra e disposte su più ordini. La datazione di questo
importante insediamento buddista è di difficile determinazione, dal
momento che il centro di culto fu attivo dal I secolo a.C. al VII d.C,
subendo nel corso dei secoli continue estensioni e abbellimenti.
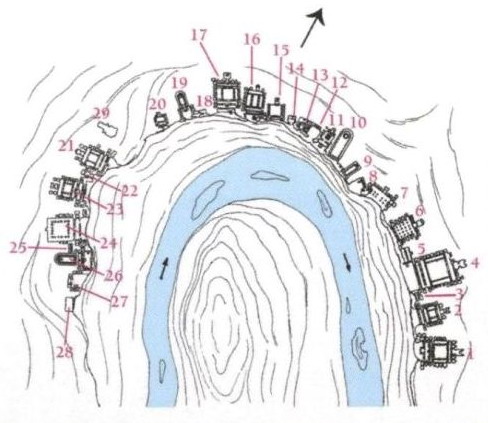 Ajanta
si risvegliava da un sonno durato mille anni e fin dal primo momento fu
oggetto dei sentimenti più contraddittori che un'opera d'arte possa
suscitare. La squisita sensualità delle sue figure scandalizzò la
puritana società vittoriana, quando le prime riproduzioni furono
esposte al Crystal Palace di Londra. Ajanta
si risvegliava da un sonno durato mille anni e fin dal primo momento fu
oggetto dei sentimenti più contraddittori che un'opera d'arte possa
suscitare. La squisita sensualità delle sue figure scandalizzò la
puritana società vittoriana, quando le prime riproduzioni furono
esposte al Crystal Palace di Londra.
Negli
anni della lotta per l'indipendenza i dipinti di Ajanta divennero
un'arma politica destinata a risvegliare l'orgoglio del popolo indiano
per la propria tradizione culturale. Seguendo la campagna di
non-cooperazione voluta dal Mahatma Gandhi, gli studenti delle scuole
d'arte si rifiutarono di copiare le opere occidentali e preferirono
ispirarsi alle pitture e alle sculture di Ajanta. In breve tempo
assursero a capolavori dell'arte universale, paragonabili alle massime
espressioni dell'arte europea.
Il sito
archeologico è costituito da una serie di trenta grotte scavate a vari
livelli in un anfiteatro roccioso di 76 metri di altezza che si affaccia
sul letto del torrente Waghora. Ritenuto sacro da tempo immemorabile,
l'idilliaco luogo fu scelto dai monaci buddhisti per il ritiro durante
il periodo monsonico.
Le
grotte, un tempo collegate singolarmente al torrente da scale in pietra
o in legno e oggi raccordate le une alle altre da un camminamento in
cemento, si estendono per mezzo chilometro: la 9, la 10, la 19, la 26 e
la 29 sono chaitya, ovvero luoghi di culto, mentre le restanti
sono vihara o sangharama, cioè monasteri adibiti ad
abitazione.
I chaitya
sono riconoscibili dall'imponente facciata, dominata da un timpano che
include un'apertura a ferro di cavallo, il kudu, sovrastante il
portale d'ingresso, talvolta preceduto da un protiro sostenuto da due
colone. Sulla facciata dei chaitya più tardi compaiono figure
del Buddha in varie posizioni e di varie altezze, accompagnate da altri
personaggi buddhisti. L'interno è generalmente a pianta rettangolare,
con tre navate separate da colonne molto ravvicinate, la cui funzione è
puramente ornamentale. La navata centrale è di larghezza doppia,
absidata e con soffitto a carena rovesciata, mentre le laterali sono più
basse e con soffitto a mezza botte o piatto. Al centro dell'abside,
illuminato dalla luce che entra dal kudu, domina uno stupa
(reliquiario campaniforme la cui forma deriva da quella del tumulo
funerario eretto sui resti della cremazione del Buddha, in seguito
assurto a simbolo cosmico), attorno al quale avveniva la deambulazione
rituale, la pradakshina, effettuata tenendolo alla propria
destra.
I vihara
si articolano in una grande sala centrale a pilastri, coperta da un
soffitto piatto a cassettoni, sulla quali si affacciano su tre lati le
celle dei monaci, minuscoli vani scavati nella roccia viva. Talvolta
nella parete opposta a quella d'ingresso è inserita una cappella che
ospita lo stupa e - nei vihara più recenti - la figura
del Buddha. La sala è spesso preceduta da una veranda ipostila che si
apre sulla facciata mediante uno o tre ingressi, riccamente ornata con
decorazioni a intreccio che imitano gli intagli lignei.
Nei soffitti dei vihara
prevale l’aspetto decorativo, con motivi floreali e astratti, e
comparse solo episodiche di temi zoomorfi e umani. I vivaci colori e le
rigide geometrie dei soffitti suggeriscono la comparsa dei paradisi
celesti. Sulle pareti, invece, si estendono le composizioni ispirate
alle vicende terrene della vita di Buddha e soprattutto a innumerevoli jataka,
ossia le storie delle vite precedenti del Buddha Shakyamuni e degli
altri Illuminati che lo avevano preceduto.

Le
figure dei Buddha e dei Bodhisattva, in ossequio alla concezione
soprannaturale che presiede alla generazione delle icone religiose, non
venivano trattate in modo realistico, con giochi di luce e di ombre. Le
figure sacre, al contrario, emettono la propria luce, a stento contenuta
da sottili linee di contorno, e spiccano con forza come silhouettes
sulle tonalità scure degli sfondi. I giochi di chiaroscuro sono
limitati a modulazioni nei tratti del volto e anche gli occhi dei
personaggi, spesso socchiusi, ricordano stati di meditazione e sembrano
trattenere con difficoltà l’emanazione di arcane energie interiori
Alcune
figure del Buddha recano principesche corone, segno del carattere
universale del loro dominio. Non mancano poi i Nagaraja, i Re dei
serpenti e degli spiriti ctoni, accompagnati dalle loro consorti,
simboli delle antiche religioni e della conversione del mondo intero al
credo di Siddarta.
Le
figure sono atteggiate in pose morbide e flessuose, tipiche dell’arte
del periodo Gupta, con i corpi appena coperti da tessuti diafani,
immateriali, quasi a sottolineare il conforto della religione del Buddha
e la naturalezza della sua condizione illuminata; i temi narrativi
vertono intorno alla promessa dell’ottenimento del Nirvana,
l’annullamento individuale nell’assoluto, la più elevata meta
spirituale dei buddisti e soprattutto dei monaci che risiedevano nel
complesso.
Nell’interno,
attorno allo stupa e sui capitelli dei colonnati, si affacciano ancora
altre immagini del Buddha, forse riflessi degli infiniti Buddha preposti
agli infiniti mondi in cui, secondo i buddisti del Mahyana o Grande
Veicolo, si dilatava l’universo. In origine, le sculture delle
facciate, come quelle dell’interno, erano coperte di vivaci
policromie, una componente fondamentale dell’arte indiana di ogni
tempo. Mura, soffitti, pilastri compositi a figure geometriche
sovrapposte, centinature, nicchie e statue erano vivacizzate dagli
artisti tramite colori semplici ma contrastanti.
Le
grotte più recenti, scavate tra la fine del V e gli inizi del VI secolo
d.C., già anticipavano l’esuberanza figurativa degli sviluppi più
tardi dell’arte buddista e induista. Nelle facciate, il portico viene
sostituito da una più ambiziosa veranda che, con le sue ombre, funge da
spazio intermedia tra l’assoluto esterno e l’oscurità della grande
sala interna, che dà adito alle celle dei monaci e alla sala absidata
con il colonnato interno e lo stupa.

L’interno
comunica un’inedita impressione di vastità: le sue superfici sono ora
affollate di immagini di Buddha e Bodhisattva e, nella grotta 26, lo
stupa stesso si trasforma in una specie di facciata templare dalla
quale, tra fregi finemente scolpiti, si materializza la figura dello
stesso Buddha, seduto in trono. Dallo stupa si affaccia una serie di
ombrelli sovrapposti, simbolo della progressiva ascesi del fedele verso
il Nirvana, che sembrano sfondare la volta stessa della sala, percorsa
da una fitta trama di centinature che ne accentuano l’illusione di
sfondamento spaziale.
Nella
stessa grotta, si apre nella parete una grande scultura a sviluppo
orizzontale, rappresentante il Buddha Shakyamuni nel Prininirvana,
l’Ottenimento della salvezza. La scultura è un colosso lungo sette
metri, che il fedele, costretto nel corridoio, poteva vedere solo poco a
poco: quasi un’ammissione di umiltà da parte dello spettatore.
Nei
monasteri vengono ora scolpite celle e nicchie nelle quali le immagini
sacre ricorrono a profusione: da semplice luogo di raccoglimento,
meditazione e cult, il monastero si trasforma in una materializzazione
dei molti paradisi buddisti, dove il Buddha del Grande Veicolo insegnano
ai Bodhisattva e quindi ai fedeli, tramite il dharma,
le vie più opportune per il raggiungimento della salvezza. Molte delle
celle interne ai monasteri diventano veri e propri sacelli: siamo di
fronte a una dilatazione del ritualismo e delle pratiche devozionali.
Lo
scavo delle grotte di Ajanta si articolò in due grandi periodi: il
primo è collocabile fra il II e il I secolo a.C. e coincide con la
dominazione della dinastia Shatavahana e con la diffusione del Buddhismo
hinayana, o del "piccolo veicolo" (Grotte 8, 9, 10, 12, 13,
15); mentre il secondo, fiorito dopo una stasi di quattro secoli durante
la dinastia locale dei Vakataka, fedeli vassalli dei principi Gupta,
raggiunse l'apogeo nella seconda metà del V secolo d.C. e sono
ascrivibili all'ambito del Buddhismo mahayana o del "gran
veicolo".
 Tale
datazione si basa su una serie di elementi: in primo luogo le iscrizioni
votive, piuttosto numerose; quindi la comparazione della statuaria e
della pittura con esempi affini già datati e l'osservazione dei
soggetti trattati, collegati all'evoluzione del buddhismo; infine,
l'analisi dell'ambiente raffigurato. Tale
datazione si basa su una serie di elementi: in primo luogo le iscrizioni
votive, piuttosto numerose; quindi la comparazione della statuaria e
della pittura con esempi affini già datati e l'osservazione dei
soggetti trattati, collegati all'evoluzione del buddhismo; infine,
l'analisi dell'ambiente raffigurato.
Dimenticate
per più di mille anni, le grotte di Ajanta furono riscoperte nel 1819
da John Smith, un soldato inglese del 28° Cavalleria, durante una
battuta di caccia alla tigre. I primi maldestri restauri, eseguiti nel
1875 con vernice gialla, si devono a Griffith, mentre lavori assai più
adeguati vennero condotti fra il 1930 e il 1955 sotto la direzione di
Yazdani, direttore del centro archeologico di Hyderabad, assistito da
due italiani, Orsini e Cecconi.
Alcuni
ambienti rimasti incompiuti permettono di comprendere il metodo di
scavo: il lavoro iniziava dall'alto e il primo elemento a essere
terminato era il soffitto. Si procedeva senza impalcature, asportando
progressivamente il materiale con il piccone e lasciando in loco i
blocchi che avrebbero poi costituito le colonne, elementi raffinatissimi
che potevano avere fino a sessantaquattro facce. Il pavimento veniva
realizzato per ultimo.








Più
gruppi di esecutori lavoravano contemporaneamente alle finiture, alla
stuccatura e alla pittura. La prima a essere ultimata era la facciata,
con l'eventuale veranda; seguivano il vestibolo, la sala principale, le
cappelle e le celle. Benché l'architettura e la statuaria rivestano
notevole importanza, le grotte di Ajanta sono famose soprattutto per le
loro pitture murali.
La
tecnica è desunta dalla grotta n. 4, ove gli affreschi non sono
terminati. L'esecuzione avveniva dopo che la parete rocciosa era stata
pareggiata con uno strato di 2 o 3 centimetri di terra mista a sabbia,
paglia tritata, fibre vegetali e talvolta peli di animali, il tutto
lasciato ruvido in modo da offrire maggiore presa allo strato
successivo, costituito da un impasto simile al primo, ma più fine. Il
terzo e ultimo supporto erano costituiti da un sottile velo di calce,
che serviva da intonaco ed era livellato con una spatola di legno.
La
sinopia era eseguita dapprima in polvere di ematite sullo strato umido,
quindi, dopo avere passato una mano di bianco, ripresa con il cinabro.
Si procedeva poi a campire le varie parti del disegno: è da notare che
i colori sono sempre ben delimitati e non sfumano mai fra loro, in un
tentativo di ricreare i volumi tridimensionali della scultura tramite un
modellato tonale che scurisce le parti "vicine" e tondeggianti
e schiarisce invece quelle più lisce e "lontane", con effetti
di rilievo.
 I
colori fondamentali impiegati, tutti di derivazione minerale o vegetale,
erano cinque, rosso-ocra, nero-fumo, azzurro-lapislazzulo e bianco.
Infine, si accentuavano i contorni liberi in nero o rosso; eventuali
riprese erano eseguite a tempera a secco, purtroppo molto
deperibile. I
colori fondamentali impiegati, tutti di derivazione minerale o vegetale,
erano cinque, rosso-ocra, nero-fumo, azzurro-lapislazzulo e bianco.
Infine, si accentuavano i contorni liberi in nero o rosso; eventuali
riprese erano eseguite a tempera a secco, purtroppo molto
deperibile.
La
superficie veniva infine lucidata con un'agata o con un dente di
elefante, in modo che la pressione facesse affiorare l'umidità, carica
di particelle calcaree, dall'intonaco; questo sottile strato,
cristallizzandosi, dava all'insieme la lucentezza dello smalto.
I
soggetti più comuni degli affreschi di Ajanta sono scene ispirate ai Jataka,
i racconti delle vite precedenti del Buddha, inserite in un contesto che
illustra il vivere quotidiano dell'epoca, nella città e nei villaggi,
fra i ricchi e i poveri, in un campionario di abiti, gioielli, oggetti,
ambienti e personaggi di incredibile varietà, che costituisce una
preziosissima fonte di informazione ambientale e antropologica.






Attorno
al mondo umano si agita quello divino, popolato non solo dalle figure
del Buddha e dai bodhisattva, illuminati che restano nel mondo a
soccorrere l'umanità, ma da tutti quegli esseri mitologici che il
buddhismo eredita dal contesto indù: splendide ninfe e geni panciuti,
esseri in parte animali e divinità celesti. Il profano si accompagna al
sacro senza soluzione di continuità: il fascino del mondano sottolinea
così la grandezza della rinuncia monastica.
I
dipinti
nelle 30 grotte di Ajanta, sono una straordinaria testimonianza
artistica e religiosa. E, allo stesso tempo, sono cammei che forniscono
una vivida immagine degli usi e costumi nell'India all'epoca della
dinastia Gupta. Nelle più antiche, l'iconografia seguì i dettami della
scuola Hinayana - in cui il Buddha poteva essere rappresentato solo
mediante simboli - mentre in quelle dipinte più tardi a prendere il
sopravvento fu la più libertaria scuola Mahayana, e le vite del Buddha
vennero descritte in ogni dettaglio figurativo.
Sono
immagini bellissime, scene corali - di volta in volta serene, crudeli,
sensuali, a volte con sottintesi erotici - animate da un'infinità di
personaggi. Donne, uomini, demoni, creature dal volto umano e dal corpo
di uccello (yaksha), suonatori (gandharva) e danzatrici celesti
(apsara), insieme a fiori, frutti, alberi e animali.
In molte
delle grotte furono introdotti elementi architettonici e sculture che si
fondono alla perfezione con i dipinti, creando spazi di grande
suggestione. Notevole è anche il sincretismo iconografico delle
pitture, dato che, soprattutto nel IV e V secolo - quando Ajanta
ospitava stabilmente 200 monaci - a realizzarle furono in gran parte
maestranze indù.
Nel
1866 l
'artista inglese Robert Gill, che aveva trascorso 26 anni ad Ajanta per
riportare le pitture su carta, vide il suo lavoro andare perduto
nell'incendio del Chrystal Palace di Londra.
Dieci
anni dopo, un altro incendio divampato nel Victoria and Albert Museum
ridusse in cenere le fatiche del suo assistente. E produssero più danni
che benefici i primi, rozzi tentativi di restauro promossi nel 1920 dal
nizam di Hyderabad, che a quel tempo regnava sul territorio di Ajanta.
Oggi il sortilegio sembra terminato e l'opera di conservazione
dell'Archeological Survey of India sta dando ottimi frutti.


|