|
Nel cuore dell'isola di Giava si erge
il Borobudur, il più grande tempio buddhista del mondo. Fatto
costruire dalla dinastia dei Sailendra, probabilmente fra il 760 e
l'810 d.C., è situato in una pianura circondata da vulcani e
montagne, non lontano dalla costa che si affaccia sull'oceano
Indiano.
Rappresenta un'importante
testimonianza dei regni di Giava centrale, di cui mancano quasi del
tutto documenti scritti o altro materiale utile alla ricostruzione di
quel periodo. La presenza di questi imponenti luoghi di culto si può
spiegare infatti solo con l'esistenza di organizzazioni statuali in
grado di produrre un surplus di ricchezza così grande da giustificare
opere di tali dimensioni e impegno. Sappiamo che in quell'epoca alcune
dinastie si contendevano il dominio sul territorio di Giava centrale,
dove da secoli, grazie soprattutto allo sviluppo della tecnica di
coltivazione del riso in campi allagati (sawah), avevano preso forma
grandi insediamenti, organizzati in regni spesso in conflitto tra di
loro.
All'inizio della nostra era risalgono
le prime tracce di contatti con la cultura indiana; attraverso le
rotte commerciali marittime, infatti, gruppi di mercanti indiani
seguiti da individui appartenenti alle caste più elevate, tra i quali
dei Brahmani, erano giunti presso le corti dei regni dell'arcipelago
indonesiano, come quelle di Srivijaya e Sumatra e della regione di
Giava Centrale. E' soprattutto a livello delle corti, infatti, che
avviene una graduale diffusione delle religioni provenienti
dall'India: il buddhismo e l'induismo.
Tra la fine dell'VIII e l'inizio del
IX secolo la dinastia dei Sailendra (Signori della Montagna) di
religione buddhista, aveva probabilmente preso il sopravvento sui
gruppi rivali e governava su buona parte di Giava. E' in questo
periodo che prende corpo il Borodudur, luogo di culto del buddhismo
Mahayana che, oltre alla funzione religiosa, rappresenta un'occasione
di celebrazione dei sovrani di allora nel momento di massimo sviluppo
del regno.

La sua realizzazione richiese uno
sforzo immane considerando le tecniche allora disponibili; la
costruzione che poggia su una piccola collina è infatti costituita da
più di un milione di blocchi di pietra, ciascuno del peso di 100
chilogrammi che, trasportati faticosamente sul posto dal letto di un
vicino fiume, venivano tagliati, lavorati e decorati dagli artigiani.
Possiamo immaginare pertanto quanti uomini fossero coinvolti in questa
attività per un periodo di lavoro che si calcola intorno ai
trent'anni, compresi tra il 760 e l'830 d.C. Il regno dei Sailendra
doveva essere in un momento d grande splendore per potersi permettere
uno sforzo di tali proporzioni. Alcuni sostengono addirittura che le
oscure vicende che seguirono furono determinate proprio dall'eccessivo
sforzo prodotto in quegli anni, Infatti, alcuni decenni dopo il
termine dei lavori, l'intero territorio di Giava centrale cadde nella
più profonda oscurità e il nucleo propulsore della civiltà giavanese
si spostò verso la parte orientale dell'isola.
Non
si conosce ancora la ragione di questo abbandono e numerose sono le
ipotesi: un'eruzione vulcanica, un terremoto, una carestia, un insieme
di fattori, tra i quali poteva avere influito anche l'immane sforzo
prodotto per realizzare le grandi opere architettoniche di Giava
centrale, fra le quali il complesso induista di Prambanan.
Il
Borobodur stesso cadde nell'oblio e bisogna andare all'inizio del
XVIII secolo per ritrovare testimonianze locali della sua presenza. Ma
la vera riscoperta e valorizzazione del tempio è opera di un europeo,
sir Thomas Stamford Raffles, a quel tempo - i primi anni del XIX
secolo -, vice-governatore inglese in quella parte del mondo
normalmente controllata dagli olandesi, allora in grave difficoltà a
causa delle campagne napoleoniche e che per questo avevano di fatto
ceduto i controllo di quell'area agli inglesi.
Il
giovane Raffles, oltre che un efficiente funzionario, era una persona
di grande cultura, attratto dalle civiltà dei Paesi in cui operava.
Egli incaricò un esploratore militare, Colin MacKenzie, che aveva
trascorso diversi anni in India e che conosceva l'arte di ispirazione
buddhista e induista, di formare un gruppo di ricerca sui resti delle
civiltà antiche presenti nell'isola. Fu uno dei suoi membri, un
ingegnere olandese di nome H.C. Cornelius che, guidato da abitanti del
luogo, trovò nel 1814 le rovine del Borobudur.
Fu
necessario circa un mese e mezzo di lavoro con duecento uomini perché
il tempio fosse liberato dalla copertura vegetale che lo aveva
avvolto. I primi lavori di recupero terminarono con gli ultimi rilievi
intorno al 1870 ma, ironia della sorte, questo ritorno alla vita
determinò l'inizio della sua rovina. Infatti la vegetazione e la
cenere depositata da antiche eruzioni, oltre che nascondere la
costruzione, l'avevano protetta dagli agenti atmosferici e pertanto
quando sole, pioggia, vento e sbalzi i temperatura ricominciarono a
infierire sull'edificio, questo iniziò a deteriorarsi soprattutto per
il pessimo drenaggio dell'acqua che, nella stagione delle piogge,
cadeva copiosa.

Nel 1900
venne nominata una commissione per la conservazione del sito, a capo
della quale venne posto l'ingegnere Thadeus Van Erp. Van Erp si trovò
subito di fronte a una gravissima urgenza: nel 1907, dopo sette mesi
di scavo, si rese conto che i muri perimetrali rischiavano di cedere e
l'intera struttura minacciava di afflosciarsi su sé stessa; non esitò
quindi a stendere una colata di cemento sul pavimento della galleria
per assestarlo. Attorno al plinto fu necessario porre una cinta di
contenimento in pietra per rafforzarlo, che ancor oggi impedisce la
contemplazione del livello inferiore dei bassorilievi.
Nei primi anni sessanta la ripresa del restauro, resa
necessaria da infiltrazioni d'acqua che rischiavano di far collassare
la struttura, fu impedita da due terremoti. Nel 1973 un'associazione
di ventisette nazioni, il governo dell'Indonesia, l'Unesco e qualche
mecenate privato si lanciarono in un restauro decennale del costo di
25 milioni di dollari, uno sforzo pari allo spostamento di Abu Simbel
nel 1966 dalle piene della diga di Assuan.
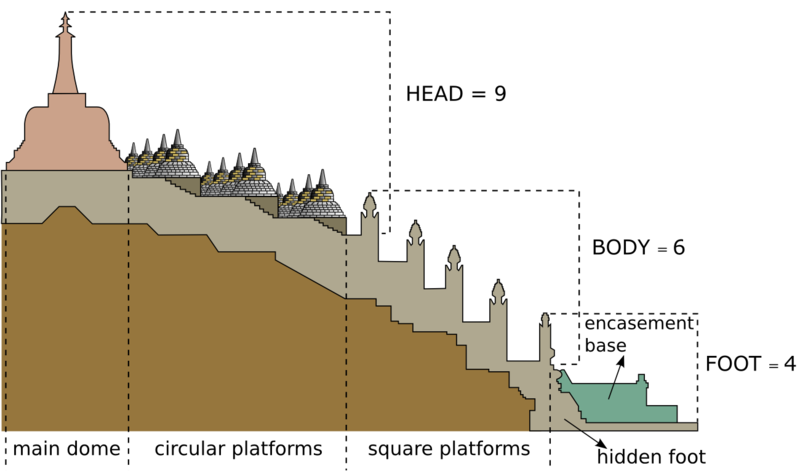 Circa
un milione di pietre dell'edificio venne rimosso, alcune di esse
furono trattate e rimodellate, tutte infine vennero riposizionate
nell'ordine precedente. Grazie a questa operazione fu possibile
attivare vari accorgimenti per risolvere il problema delle
infiltrazioni d'acqua e così oggi l'intera costruzione del Borobudur
si presenta completamente restaurata nella sua magnificenza. Circa
un milione di pietre dell'edificio venne rimosso, alcune di esse
furono trattate e rimodellate, tutte infine vennero riposizionate
nell'ordine precedente. Grazie a questa operazione fu possibile
attivare vari accorgimenti per risolvere il problema delle
infiltrazioni d'acqua e così oggi l'intera costruzione del Borobudur
si presenta completamente restaurata nella sua magnificenza.
Ogni
anno più di un milione di visitatori si recano ad ammirarla, tra
questi ben pochi sono pellegrini buddhisti, i più sono individui
attratti dalla bellezza e dalla magia della costruzione intesa come
opera d'arte e come testimonianza di un passato di cui poco si
conosce, ma anche affascinati dalla profonda religiosità per pervade
i luogo.
Borobudur è spesso tradotto come "tempio sul
colle", ma il termine vale in realtà come abbreviazione di
Bhumisan Brabadura, "la montagna ineffabile dell'accumulazione
delle virtù": Borobudur intendeva cioè echeggiare una montagna
- non una qualsiasi, bensì una montagna di iniziazione, che proponeva
un itinerario di formazione dal molteplice all'uno. Lo stupa di
dimensioni inusitate si propone come una replica dell'universo secondo
la visione cosmogonica del buddhismo mahayana: il Borobudur è un
esempio di mandala tridimensionale.
Tale microcosmo è organizzato su tre registri decorativi:
il primo, kàmadhatu, la "sfera dell'amore fisico",
rappresenta il mondo del desiderio influenzato da impulsi negativi, ed
è un livello in parte interrato; quello mediano, rupadhatu, la
"sfera della forma", raffigura uno stato esistenziale, più
che uno spazio geografico, ove l'uomo arriva a controllare gli istinti
negativi e cavalca quelli positivi; il registro superno celebra un
mondo in cui l'uomo non è più legato a desideri fisici.
Osservato
dall'alto il Borobudur ci appare come un immenso mandala, insieme di
forme geometriche che delimitano un territorio sacro, che dal centro
in cui vi è la parte più importante, si sviluppa in aree sempre più
ampie, geometricamente delimitate con precisi riferimenti ai quattro
punti cardinali.

La
forma di buddhismo che si propagò a Giava fu prevalentemente quella Mahayana
o del Grande Veicolo, la forma quindi della grande compassione, più
aperta ai percorsi individuali che i fedeli potevano intraprendere
anche nel corso di una sola vita verso il Nirvana, l'interruzione del
ciclo delle reincarnazioni. Sappiamo inoltre che nel periodo compreso
fra i secoli VII e XIV, grande diffusione ebbero anche forme
esoteriche, fra le quali il tantrismo, che attraverso riti e pratiche
di vario genere consentiva percorsi più rapidi verso l'illuminazione
e il Nirvana. In questo contesto va inteso il Borobudur che bene
esprime queste concezioni del buddhismo.
Il
tempio è costituito da quattro terrazze quadrate e tre circolari,
sormontate dal piccolo stupa terminale. Nella sua pradakshina,
la circoambulazone rituale in senso orario, il pellegrino doveva
percorrere le gallerie delle prime quattro terrazze riccamente
decorate con pannelli sia verso il lato interno, sia sulla balaustra.
Essendo la prima galleria abbellita con quattro serie di pannelli e le
successive con due ciascuna, il pellegrino doveva percorrerle dieci
volte, osservando e apprendendo quanto rappresentato nei bassorilievi
per poter accedere alle terrazze circolari superiori.
Secondo
il simbolismo cosmico del buddhismo Mahayana, al centro
dell'universo vi è la Montagna Sacra, il monte Meru, intorno al quale
ruotano mondi, cieli e mari. Il percorso verso l'illuminazione
corrisponde metaforicamente all'ascesa della montagna quale viene
inteso il Borobudur. La base del tempio rappresenta il mondo della
materia, della forma, della sfera dei desideri e delle sofferenze
della vita: il Karmadhatu.
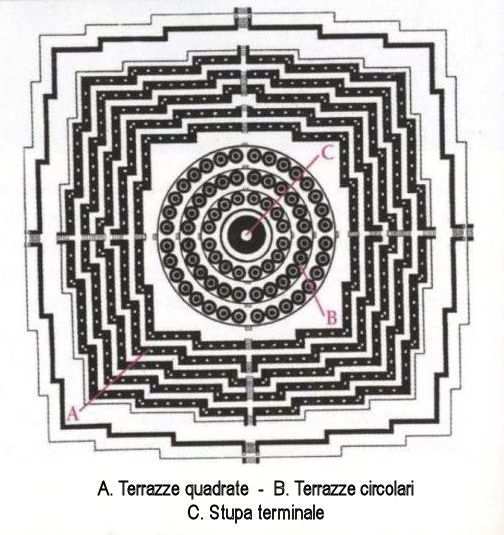 Le
pareti della base, che misurano 113 metri per lato, appaiono oggi
quasi completamente prive di decorazioni infatti, per ragioni ancora
non del tutto chiare, i circa 160 pannelli che vi sono stati
realizzati sono stati coperti da un muro e sono giunti a nostra
conoscenza soltanto nel 1885. Le
pareti della base, che misurano 113 metri per lato, appaiono oggi
quasi completamente prive di decorazioni infatti, per ragioni ancora
non del tutto chiare, i circa 160 pannelli che vi sono stati
realizzati sono stati coperti da un muro e sono giunti a nostra
conoscenza soltanto nel 1885.
Qualunque
fosse il motivo, una maggiore stabilità dell'edificio o il desiderio
di nascondere ai religiosi la parte riguardante la sfera dei desideri
e delle passioni terrene, vi era infatti una parete protettiva intorno
alla base; questa, dopo essere stata smantellata per consentirne una
documentazione fotografica, è stata ricostruita e oggi solo quattro
pannelli sono stati lasciati scoperti per renderli visibili.
Vi
sono riportate scene tratte da un testo buddhista, il Mahakarmavibbangga,
su paradiso e inferno, peccati e pene, buone azioni e premi.






Nel
mezzo di ogni lato della base una stretta scala consente l'accesso
alla terrazza superiore; per un corretto percorso si deve accedere dal
lato orientale, il più sacro. Osservato dall'esterno, il tempio non
rivela alcun bassorilievo, ma numerose statue del Buddha; appare come
un immenso stupa. Lo stupa è impenetrabile come il Borobudur, che
sappiamo essere adagiato su una collina, privo
di parti interne. Per accedere agli insegnamenti rappresentati nei
pannelli, è però necessario entrare nelle gallerie superiori. E'
quindi una costruzione molto particolare, inaccessibile a prima vista
dall'esterno, chiusa per chi non desideri entrare nelle gallerie per
appendere gli insegnamenti e quindi procedere nel suo percorso di salvazione.
Per seguire tutte le metope nell'ordine corretto, occorre
partire dalla scalinata sud della facciata est, tenendo l'edificio
alla propria destra e girando verso destra in senso orario, seguendo
cioè il corso del sole. Tale attività prende infatti il nome di pradaksinàpatha, "camminata verso sud", e nella cultura
indiana è un atto di devozione nei confronti dell'oggetto attorno al
quale si gira. Alla fine del percorso si saranno compiute ben dieci
circumdeambulazioni attorno allo stupa, per un totale di cinque
chilometri di percorso e 2500 metri quadrati di bassorilievi,
distribuiti in 1460 metope di due metri ciascuna.
Ogni
terrazzamento è circondato da patii scoperti, con registri di
bassorilievi. Le scene rappresentate nei terrazzamenti inferiori sono
più mondane e hanno un intento didattico-morale; più si sale più la
narrazione si rarefa per lasciare posto a una rappresentazione
statica, ieratica, epifanica della figura del Buddha. I pannelli delle
terrazze inferiori sono fonti preziose per gli oggetti della vita
quotidiana a cavallo fra l'VIII e il IX secolo a Giava: edifici, navi,
armi, strumenti musicali, utensili.

Probabilmente, tutti i bassorilievi erano stuccati e
colorati; ancora oggi riportano screziature di colore, dovute però a
muschi e licheni che, complice il clima, si adagiano sulla loro
superficie sfalsando un poco la percezione dei bassorilievi. I
contorni dei rilievi sono rotondi, pieni, in accordo con il canone
dell'arte indiana classica Gupta.
 I percorsi sono organizzati in gallerie larghe due metri
che invitano alla meditazione. La
prima galleria presenta un perimetro più ridotto - 88 metri per lato
- della base, nella quale è contenuta e così è per quelle dei livelli
superiori, ugualmente ridotte in modo progressivo. Le quattro terrazze
quadrate rappresentano il Rupadhatu, la forma fisica del
Buddha: percorrendole, il pellegrino ha già imboccato la via verso il
Nirvana, si trova nella fase di crescita interiore in cui deve
apprendere gli insegnamenti, ma ha già cominciato il suo distacco
dalla vita materiale quale viene rappresentata nella base. I percorsi sono organizzati in gallerie larghe due metri
che invitano alla meditazione. La
prima galleria presenta un perimetro più ridotto - 88 metri per lato
- della base, nella quale è contenuta e così è per quelle dei livelli
superiori, ugualmente ridotte in modo progressivo. Le quattro terrazze
quadrate rappresentano il Rupadhatu, la forma fisica del
Buddha: percorrendole, il pellegrino ha già imboccato la via verso il
Nirvana, si trova nella fase di crescita interiore in cui deve
apprendere gli insegnamenti, ma ha già cominciato il suo distacco
dalla vita materiale quale viene rappresentata nella base.
Solo
percorrendo tutte e quattro le gallerie nella maniera corretta, può
accedere all'ultimo livello: quello dell'Arupadhatu, cioè
della non forma. Qui vi sono le tre terrazze circolari con una serie
di stupa disposti in modo concentrico contenenti statue del
Buddha che si vedono attraverso piccole aperture di forma geometrica.
Non vi è alcuna rappresentazione iconografica, la fase
dell'apprendimento è terminata e si può giungere così all'ultimo
grande stupa centrale che è impenetrabile. L'ascesa al monte
Meru è conclusa: si è nello stato della non forma,
nell'annullamento.
Il
Borobudur è quindi una costruzione dai molteplici significati, la cui
struttura risulta assai complessa. Può essere vissuto in diversi
modi: apprezzato per la sua bellezza, per il valore artistico delle
sue decorazioni oppure come testimonianza storica di un passato
glorioso di cui si sono smarrite le tracce. Il suo senso più profondo
va però letto in questa triplice immagine di stupa, monte Meru
e mandala, tre aspetti di uno stesso percorso che, nelle
intenzioni dei costruttori, doveva probabilmente consentire ai
pellegrini di illuminarsi, di avvicinare il proprio spirito al Buddha.

Dall'aereo, il tempio sembra un loto pronto a sbocciare che
galleggia sul terreno. Ed è più di un'impressione, perché
probabilmente tutt'attorno, un millennio fa, si stendeva un lago: i
geologi hanno infatti verificato che tutti i villaggi circostanti,
compresi i templi Pawon e Mendut che sorgono nella medesima area, si
attestano a 235 metri sul livello del mare.
Il solo terrapieno di pietre che avvolge il plinto ha un
volume di 11.600 metri cubi; affollano il perimetro delle terrazze un
centinaio di doccioni per il drenaggio dell'acqua; il Buddha è celebrato in cinquecentoquattro statue alte non
meno di un metro e mezzo nel terrazzamento mediano, il rupadhatu. Ogni
faccia accampa novantadue stupa con un Dhyani Buddha all'interno,
atteggiato in un mudra diverso a segnalare i punti cardinali, cinque
nella tradizione indiana: indica l'est con il bhumisparsa mudra (il
mudra della "chiamata a testimonianza della Terra"); il sud
con il gesto della benedizione; l'ovest con il mudra della
meditazione; il nord con il mudra del "non aver paura"; il
centro se sfoggia il gesto dell'insegnamento.
Il tempio di Borobudur misura 123 metri di base e si ergeva
originariamente per quarantadue metri di altezza; oggi, parzialmente
infossato, non supera i 31,5. Con i suoi 55.000 metri cubi di pietra,
pari a un milione di pezzi da un quintale, non solo si pone per
dimensioni al livello dei complessi di Pagan in Birmania e di Angkor
in Cambogia, ma è in assoluto il monumento antico più grande dell'emisfero australe, una testimonianza dell'ineguagliabile bacino
di forza lavoro su cui i Sailendra poterono contare.


I
BASSORILIEVI - I bassorilievi narrano la storia del Buddha
divisa in vari passaggi:
-
Il karma (Karmavibhangga)
- Questa serie di bassorilievi illustra il Karma, le sue
caratteristiche e la sua natura, vale a dire il rapporto di
causa-effetto secondo cui una buona azione porta dei benefici nelle
vite future mentre una cattiva azione avrà effetti sicuramente
negativi per le vite future di chi la esegue, questi bassorilievi
illustrano quali sono le azioni migliori e quali le peggiori. In
sostanza questa parte del tempio è una specie di "manuale"
sul Karma.
-
La nascita del Buddha (Lalitavistara)
- E' la storia della gravidanza della Regina Maya, moglie del re
Suddhodana, e dell'attesa per la nascita dell'erede al trono da parte
degli esseri viventi sulla terra e da parte delle creature superiori,
la storia prosegue con la cronaca della nascita del piccolo e con i
suoi primi anni di vita fino a quando decide di intraprendere il suo
viaggio. La storia continua nella sezione successiva della sequenza di
bassorilievi del tempio.
-
La storia del principe Siddharta (Jataka) e altre leggendarie persone
(Avadana) - E' la storia
del principe Siddharta e di altri importanti personaggi della storia e
della religione buddhista.
-
Sudhana cerca la verità finale (Gandavyuha)
- Durante la sua ricerca, Sudhana si reca da non meno di 30 saggi, ma
nessuno di questi riesce a soddisfare appieno la sua sete di sapere.
Nel suo viaggio Sudhana incontra Supratisthita, Muktaka, Saradhvaja
(un eremita), Upasika, Bhismottaranirghosa (un brahmino), Jayosmayatna,
Maitrayani (una principessa), Sudarsana (un eremita), Indriyesvara (un
ragazzo), Upasika Prabhuta, Ratnachuda, King Anala, il dio Siva
Mahadeva, Maya, Maitreya e di nuovo Manjusri. Ognuno di questi
incontri ha permesso a Sudhana di apprendere qualcosa di nuovo. Questi
incontri sono narrati nella terza galleria. Dopo l'ultimo incontro con
Manjusri, Sudhana va a casa di Bodhisattva Samantabhadra. Tutta la
quarta galleria è dedicata agli insegnamenti di Samantabhadra. La
storia finisce quando Sudhana apprende la suprema conoscenza e la
verità finale.

|