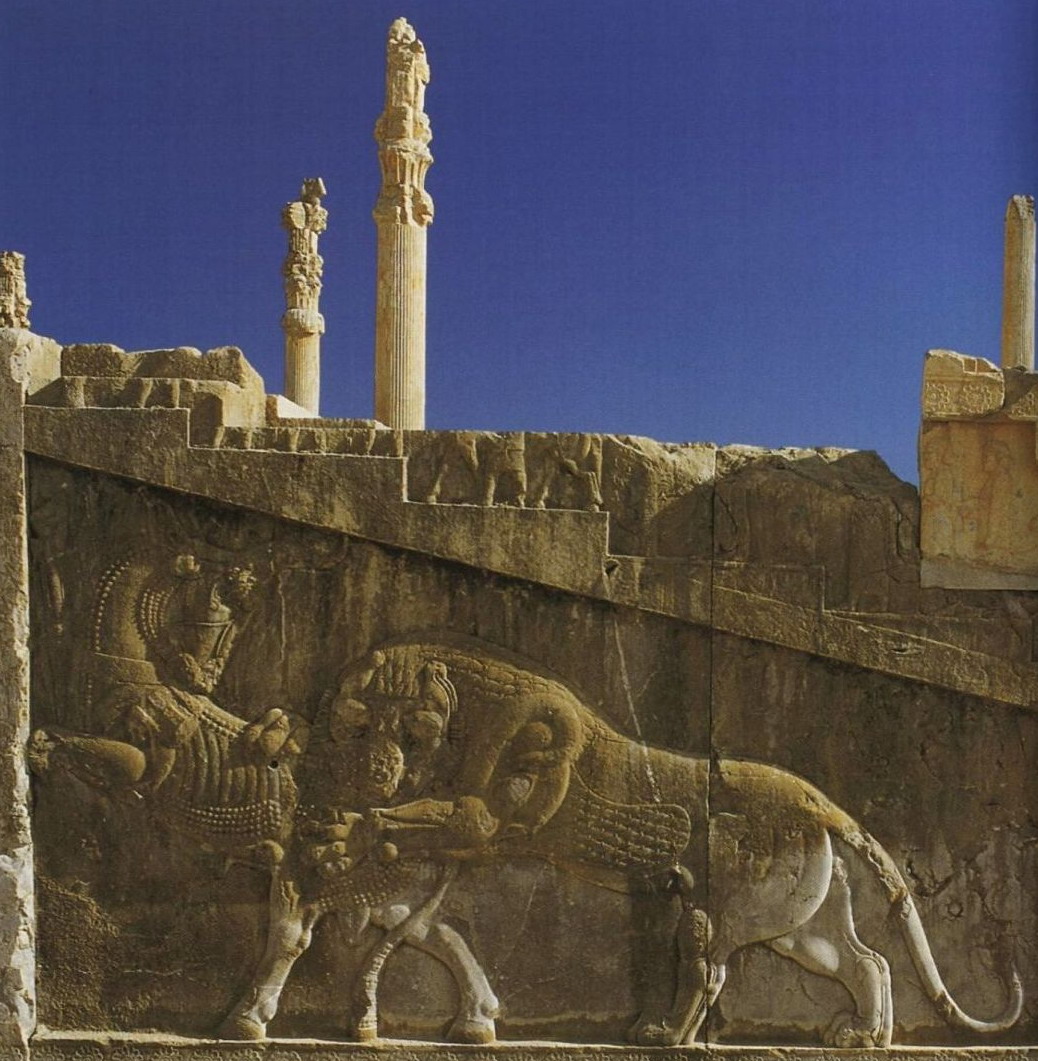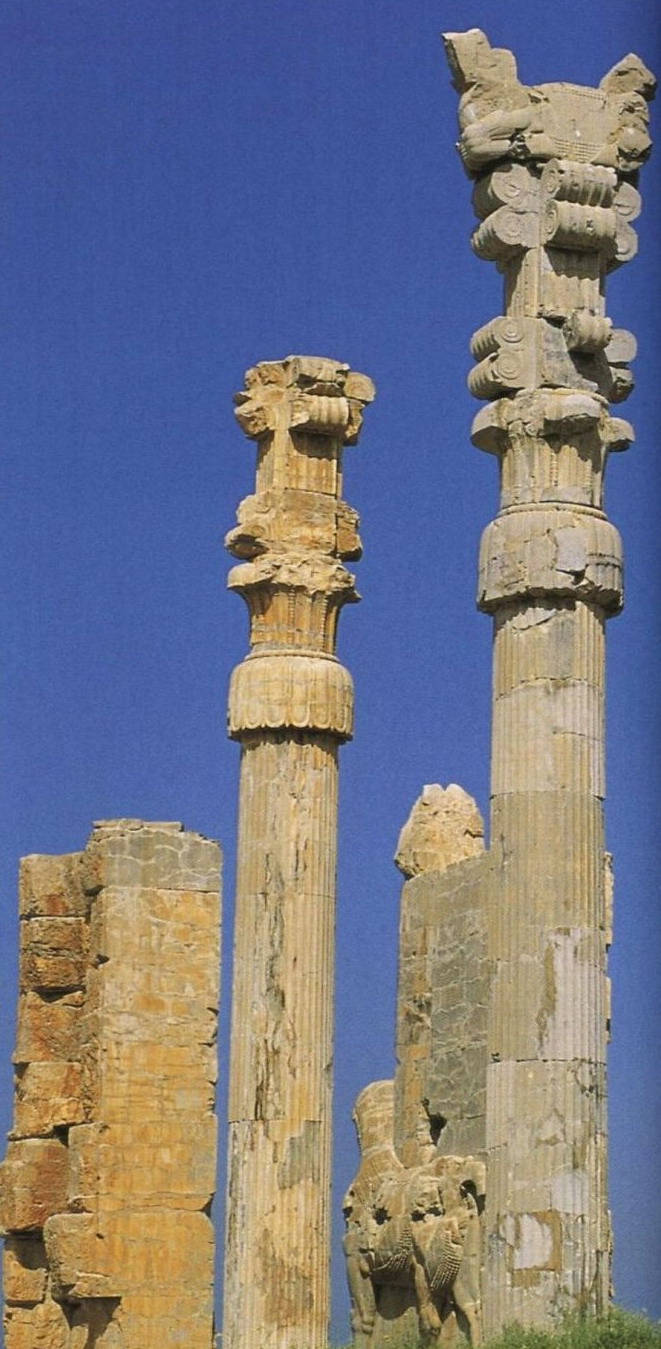TACHARA
- Così
chiamato dall'iscrizione presente su un montante della sua porta sud, il
Tachara, o Palazzo di Dario, si trova a sud dell'Apadana. Si tratta
dell'unico palazzo ad avere accesso da sud tramite un portico.
L'ingresso del palazzo era in origine da questo lato a mezzo di una
doppia scalinata. Costruito da Dario I, il palazzo è stato poi
completato da Serse I, e ampliato poi da Artaserse III,
che aggiunge una seconda scala ad Occidente. Questo nuovo ingresso creò
un'asimmetria inedita. Abbigliamento dei personaggi medi e arachosi,
sono diversi da quelli di altre scale precedenti, il che suggerisce un
cambio nella moda, e rafforza l'idea che sia stata costruita
successivamente.
Le
decorazioni della scalinata sud presentano dei simboli di Norouz:
un leone che divora un toro. Le parti ascendenti rappresentano dei medi
e arachosi che portano animali, barattoli e bottiglie. Questi sono
probabilmente sacerdoti provenienti da luoghi sacri zoroastriani, come
il lago
di Urmia in Media e
il Lago
di Helmand in Arachosia,
che portano oggetti necessari per le cerimonie.
Il pannello centrale mostra due gruppi di nuove guardie e tre pannelli
con iscrizione trilingue di Serse II, indicante che il palazzo fu
costruito da suo padre; il tutto è sormontato dal disco alato, simbolo
o di Ahuramazda o della gloria reale, fiancheggiato da due sfingi.
L'ingresso
al palazzo avviene attraverso una sala sulla cui porta vi è un
bassorilievo rappresentante delle guardie. Questa sala è seguita da
un'altra apertura che da nella sala principale; sugli stipiti della
porta c'è un bassorilievo del re che combatte contro il male sotto
forma di un animale. Questo tema si declina anche su altre porte del
palazzo, nel Palazzo delle 100 colonne, e nell'harem. La figura del male
a volte è simboleggiata da un leone, un toro o da un animale chimerico.
Il tipo di figura può essere legata alla funzione della parte in
questione, o con riferimento a carte astrologiche.
Una
porta si apre sulla sala da bagno reale ed è decorata con bassorilievo
che mostra un re abbigliato per una cerimonia e seguito da due servi in
possesso di un ombrello e uno scacciamosche.
Il re è coronato, vestito con un ricco abito decorato con pietre e
monete preziose. Indossa anche bracciali e gioielli appesi alla barba
intrecciata.
Un altro bassorilievo mostra, probabilmente, un eunuco, unica
rappresentazione imberbe del sito. Egli porta una bottiglia di unguento
e un asciugamano. La circolazione dell'acqua era fornita da un canale
coperto e interrato che passava nel mezzo della sala. Si possono
osservare i resti di cemento rosso che costeggiavano il pavimento del
bagno.
Iscrizioni incise del periodo islamico si trovano sugli stipiti del
palazzo.

Il
palazzo ha anche altre due sale più piccole situate ai lati. Il portico
a sud si apre in un cortile circondato da altri palazzi. Sull'architrave di
ogni porta e finestra è incisa una curiosa scritta:
Dario
il grande re, il re dei re, il re dei popoli, il figlio di Vistaspa,
l'Achemenide, che fece Tachara.
Tuttavia,
non è certo che questa frase, il cui significato esatto non è noto, si
riferisca all'edificio stesso: infatti, sono state trovate basi di
colonne, in altre parti di Persepoli, con iscrizioni di Serse che
dicono:
Sono
Serse, il grande re, il re dei re, il re del popolo, il re su questa
terra, il figlio del re Dario, l'achemenide.
Il re Serse dichiara: Ho costruito questo Tachara.
TRIPYLON
-
Prendendo
il nome dai suoi tre ingressi, il Tripylon o sala delle udienze di
Serse, o Palazzo centrale, è un piccolo palazzo nel centro di
Persepoli, che probabilmente serviva come accesso al palazzo di Serse.
Risulta accessibile a nord da una scala intagliata con bassorilievi che
mostrano principalmente guardie medie e persiane. Altri rilievi
rappresentano nobili e cortigiani che si recano ad un banchetto. Le
scale sud del Tripylon si trova al Museo
Nazionale dell'Iran di Teheran.
Un corridoio si apre ad est su una porta decorata con un bassorilievo
mostrante:
-
Sopra,
Dario sul suo trono con il principe ereditario Serse, al riparo sotto un
baldacchino ornato di simboli divini, tori, leoni e ghiande; il re e il
principe tendono in mano delle foglie di palma, simboli di fertilità;
-
In
basso, emissari delle ventotto nazioni che costituivano l'impero
persiano.
Questo
bassorilievo si riferisce chiaramente alla volontà di Serse di nominare
Dario come suo legittimo successore al trono.

PALAZZO
HADISH -
L'Hadish,
o Palazzo di Serse, si trova a sud del Tripylon; è costruito su un
piano simile al Tachara ma
due volte più grande. La sua sala centrale era costituita da trentasei
colonne di pietra e legno. Queste erano realizzate con tronchi di alberi
di grandi dimensioni e di grande diametro, dei quali non resta più
nulla.
 È circondato ad est e ad ovest da piccole stanze e corridoi, e
sulle porte vi sono dei bassorilievi. Sono rappresentate processioni
reali con Serse I accompagnato da servitori che sostengono un
baldacchino. La parte meridionale del palazzo è composta da
appartamenti la cui funzione è controversa: una volta descritti come
quelli della regina, nel ventunesimo secolo sono considerati dei negozi
o appendici del Tesoro.
È circondato ad est e ad ovest da piccole stanze e corridoi, e
sulle porte vi sono dei bassorilievi. Sono rappresentate processioni
reali con Serse I accompagnato da servitori che sostengono un
baldacchino. La parte meridionale del palazzo è composta da
appartamenti la cui funzione è controversa: una volta descritti come
quelli della regina, nel ventunesimo secolo sono considerati dei negozi
o appendici del Tesoro.
L'accesso all'Hadish avviene tramite una scalinata monumentale, ad
Oriente, con rampe doppie divergenti e convergenti, e una scala più
piccola a rampe convergenti ad Occidente; entrambe hanno lo stesso
arredamento come le scale a sud del Tachara: tori e leoni, guardie
persiane, disco alato e sfingi.
Hadish è
un'antica parola persiana che appare su un'iscrizione trilingue in
quattro copie sotto il portico e la scalinata: significa
"palazzo". Gli archeologi citano questo palazzo con il nome di Hadish,
ma il nome originale non è noto. L'assegnazione a Serse è certa in
quanto oltre a queste quattro iscrizioni, aveva inciso il suo nome e il
suo titolo non meno di quattordici altre volte.
PALAZZO
DELLE 100 COLONNE -
Il
palazzo delle 100 colonne o anche Sala del Trono, ha una forma quadrata
con lati di 70 metri: è il più grande dei palazzi di Persepoli. In
occasione del suo primo scavo parziale, emerse che era coperto da uno
strato di terra e di ceneri di cedro
del Libano di
più di tre metri di spessore. Gravemente danneggiati dal fuoco, solo le
basi delle colonne e gli stipiti sono sopravvissuti.
Due
tori colossali costituiscono le basi delle colonne principali, alte 18
metri, che sostenevano il tetto del portico d'ingresso, a nord del
palazzo. L'ingresso avveniva attraverso una porta riccamente decorata
con bassorilievi.
Tra queste rappresentazioni, si descrive l'ordine
delle cose, mostrato da cima a fondo: Ahuramazda, il re sul suo trono,
poi diverse file di soldati che lo sostengono. Il re detiene quindi il
suo potere, che gli proviene da Ahuramazda che lo protegge, e controlla
l'esercito che porta il suo potere.
Il
palazzo è decorato con numerosi bassorilievi in perfetto stato di
conservazione, che rappresentano tori, leoni, fiori e ghiande.
La
porta meridionale del palazzo presenta dei bassorilievi completamente
diversi. Essi simboleggiano il sostegno dato al re dalle diverse nazioni
che compongono l'impero. I soldati dei cinque ranghi inferiori infatti
appartengono a molte nazioni, riconoscibili dai loro berretti, uniformi
e armi. Rivolto verso l'edificio del Tesoro, questo messaggio è
piuttosto dedicato ai servi e ricorda loro che la ricchezza che passa
attraverso questa porta serve alla coesione dell'impero. Le tavolette
cuneiformi che dettagliano gli archivi dei tributi, danno una panoramica
delle ricchezze che sono passate attraverso queste porte.
Se
i bassorilievi degli ingressi nord e sud del palazzo riguardano in primo
luogo l'affermazione della regalità, quelli della parte orientale e
occidentale hanno, come gli altri palazzi, scene eroiche di lotta contro
il male.

TESORO
-
Costruito
da Dario
il Grande,
è costituito da una serie di camere situate nell'angolo sud-est della
terrazza, che si estende su una superficie di 10.000 m². Il tesoro
comprende due sale più importanti il cui tetto era sostenuto
rispettivamente da 100 e 99 colonne di legno.
Sono state ritrovate delle tavolette di legno e d'argilla, che
specificano l'ammontare dei salari e dei benefici pagati ai lavoratori
che costruirono il sito.
Secondo Plutarco,
10.000 muli e 5.000 cammelli furono necessari a Alessandro
Magno per
trasportare il tesoro di Persepoli.
Secondo quanto indicato in alcune tavolette, 1.348 persone
lavorarono alla Sala del tesoro nel 467
a.C.
Il
Tesoro venne più volte ricostruito e modificato. Diverse iscrizioni
sono state trovate sui blocchi massicci di diorite,
menzionanti re Dario.
Sono stati inoltre ritrovati due bassorilievi, uno dei quali proviene
dalla scala nord dell'Apadana. Quest'ultimo è ora al Museo
Nazionale dell'Iran e
rappresenta il re, probabilmente Serse
I (o
il padre Dario
I)
sul trono. Il re riceve un ufficiale medio inclinato in avanti mentre
porta la mano destra alle labbra in segno di rispetto. Potrebbe essere
un tribuno, un comandante di 1.000 guardie, o un governatore del
Tesoro (o Ganzabara). Il principe ereditario e un
nobile persiano si trovano in piedi dietro al sovrano. Due portatori di incenso sono
tra il re e i dignitari.
Durante
gli scavi, questo edificio è stato subito identificato come il Tesoro,
perché nonostante la sua vasta area, l'accesso è costituito solo da
due piccole porte strette.
GUARNIGIONE
E SALA DELLE 32 COLONNE -
Sul
versante est del complesso, tra il Palazzo delle 100 colonne e la
montagna, si trovavano diverse sale che costituivano il quartiere dei
servitori e dei soldati, la cancelleria e gli uffici.
Sono state
ritrovate più di 30.000 tavolette di argilla e frammenti di esse,
in lingua
elamica.
Secondo Quinto
Curzio Rufo e Diodoro
Siculo,
Alessandro lasciò sul posto 3.000 uomini, cosa che dà l'idea
della capacità della guarnigione di Persepoli.
A nord di queste caserme, si trovano i resti di una sala costituita da
32 colonne, la cui funzione non è nota.

GINECEO
E MUSEO - L'accesso
al gineceo,
erroneamente chiamato harem,
avviene dalla porta sud del palazzo delle cento colonne. L'edificio ha
una forma di "L", la cui ala principale ha un orientamento
nord-sud. Il suo centro è composto da una sala con colonnati, aperta a
nord su un cortile con un portico. La sala aveva quattro ingressi, le
cui porte erano decorate con bassorilievi. Quelli laterali mostrano
ancora scene di lotta eroica ricordando quelle dello Tachara o palazzo
delle 100 colonne. Il re è infatti mostrato alle prese con un animale
chimerico (leone-toro cornuto e alato, collo corbino e coda di
scorpione) che potrebbe essere una rappresentazione di Ahriman,
divinità malvagia. L'eroe affonda la spada nel ventre della bestia che
gli sta di fronte. Il bassorilievo a sud mostra Serse I, seguito dai
servi, in una scena identica a quella del palazzo Hadish. La parte
meridionale dell'ala e l'altra ala che si estende ad Occidente
presentano una serie di venticinque appartamenti ipostili con sedici
colonne ciascuno. L'edificio dispone anche di due scale che lo collegano
con l'Hadish, e due cortili che potrebbero corrispondere ai giardini
chiusi.
Non
è certo che il gineceo potesse essere un luogo di residenza delle
donne. Secondo alcuni, la sezione centrale avrebbe potuto essere
destinata alla regina e al suo seguito. Altri credono che le donne
vivevano al di fuori delle mura.
La funzione dell'edificio rimane controversa. La presenza di
bassorilievi elaborati, così come la sua posizione a livello elevato
evoca un edificio con una funzione importante. Al contrario, le sue
dimensioni e la posizione, suggeriscono piuttosto una funzione
amministrativa.
Difatti, è probabile che il nome di gineceo sia erroneo, come quello di
harem: i ricercatori occidentali hanno proiettato la loro visione di
harem Ottomano sulla
Persia achemenide, ma ciò non ha senso.
Il
gineceo venne scavato e parzialmente restaurato da Herzfeld in
un processo di anastilosi.
Ricostruì diverse sale che usò come laboratori di restauro e per la
presentazione dei pezzi trovati nel complesso. Parte del gineceo venne
trasformata in museo.
Il
museo presenta una grande varietà di oggetti trovati in loco:
ceramiche,
piatti e bicchieri di terra cotta, piastrelle in ceramica;
monete
d'epoca;
utensili
di ogni genere: da muratura, da taglio, da cucina, da macellaio e altri;
ferramenta,
punte di lancia e frecce, frammenti o ornamenti metallici, perni
metallici;
resti
di stoffa e di legno componente della struttura;
finimenti
per cavalli;
tavolette
incise.Sono state trovate anche monete di periodi successivi (sassanidi e arabi),
precedenti, e persino preistorici..
L'ampia
varietà di elementi appartenenti agli usi di tutti i giorni, è molto
importante per avere un'idea della vita in quel periodo. Inoltre, alcune
parti delle rappresentazioni pittoriche (mascelle, lance) danno un'idea
della completezza del lavoro dei lavoratori che le scolpirono.

ALTRE
COSTRUZIONI -
Un
palazzo sembra sia stato costruito in un angolo sud-occidentale della
terrazza, appartenente ad Artaserse I.
Le rovine, però, non corrispondono al palazzo, ma ad un palazzo
residenziale post-achemenide chiamato H. Delle sculture dotate di corna
sono state collocate vicino al muro della terrazza, figure delle quali
non si conosce la funzione; sono state trovate sepolte ai piedi della
terrazza.
Un'altra
struttura chiamata palazzo G si trova a nord dell'Hadish, corrispondente
anch'essa a una costruzione post-achemenide. Sembra sia stata realizzata
sul sito di una struttura distrutta che potrebbe essere stato il palazzo
di Artaserse
III.
Allo stesso modo, i resti di un edificio chiamato Palazzo D sono stati
trovati ad oriente dell'Hadish. Come i precedenti, era stato costruito
dopo la fine della dinastia achemenide riutilizzando detriti e ornamenti
presenti tra le rovine della terrazza.

LE TOMBE REALI
- Poco lontano da Persepoli, a
Naqs-i-Rustam nella valle di Husain Kuh, si trova la spettacolare
necropoli reale achemenide. Le quattro tombe rupestri con facciate
cruciformi, scavate nell'alta parete rocciosa, appartengono a Dario I e
verosimilmente a tre dei suoi successori (Serse, Antaserse I e Dario
II).
Il primo a scegliere questa
valle come luogo di sepoltura fu Dario I. La facciata della sua tomba
scolpita nella pietra presenta un'enorme croce al centro della quale
stava un finto colonnato dai capitelli a forma di animale. Tra le due
colonne centrali si apre la porta d'accesso alla camera funeraria
scavata in profondità nella roccia. Nel pannello centrale sopra
l'ingresso si trova un rilievo rappresentante il re stante su un
piedistallo a tre gradini di fronte a un altare. La mano accenna un
gesto di adorazione verso il disco solare che
lo sovrasta, simbolo del dio Ahura Mazda.
Lo circondano ventitré personaggi rappresentanti le nazioni soggette a
Dario. Nei pannelli laterali compaiono i soldati e la guardia imperiale
persiana.
La
facciata è ulteriormente decorata da una dedica trilingue in caratteri
cuneiformi che enumera le nazioni appartenenti al regno glorificando il
ruolo del sovrano. Tracce di pigmento sul fondo e sui rilievi dimostrano
che tutta la facciata o parte di essa fu dipinta.
I
successori Serse, Artaserse I e Dario II seguirono la scelta del grande
sovrano non solo per
il luogo, ma anche nella decorazione dell'ingresso. Sulla facciata di ciascuna di
esse capeggiano le immagini dei sovrani in adorazione del fuoco di Ahura
Mazda, sostenuti come di consueto dai rappresentanti delle nazioni
assoggettate all'Impero.
I sovrani sassanidi scelsero
di sottolineare il loro legame con l'antico Impero facendo scolpire al
di sotto delle tombe dei re achemenidi alcuni dei più celebri rilievi
del tempo: l'investitura di Ardashir I, una battaglia combattuta da
Baharam IV e la celebre scena della sottomissione dei Romani in cui due
personaggi, gli imperatori Valeriano e, probabilmente, Filippo l'Arabo,
si chinano umilmente davanti al poderoso cavallo di Shahpur I. Davanti
alla tombe e ai sottostanti rilievi sassanidi, si erge una torre
popolarmente nota come Kaaba-i-Zardust o Cubo di Zarathustra, forse un
tempio funerario archemenide destinato al culto reale.
Altre tombe reali scavate
nella roccia si trovano nei pressi della terrazza di Persepoli, a est, e
sono state attribuite ad Artaserse II e a Artaserse III. Esse
seguono in generale lo schema classico delle tombe rupestri achemènidi
con facciate cruciformi. Ma, a differenza delle tombe di Naqsh-i Rustam,
manca qui il braccio inferiore della croce, di modo che la porta di
ingresso appoggia direttamente sul terreno. I rilievi commemorativi che
adornano la parte alta dei due monumenti non si discostano dalla usuale
iconografia e rappresentano il re sul trono portato in trionfo da un
gruppo di tributarî di fronte ad un altare del fuoco.
A sud
della terrazza si trova anche la tomba di Dario III Codomanno (336-331
a. C.), rimasta incompiuta a causa della conquista di Alessandro.
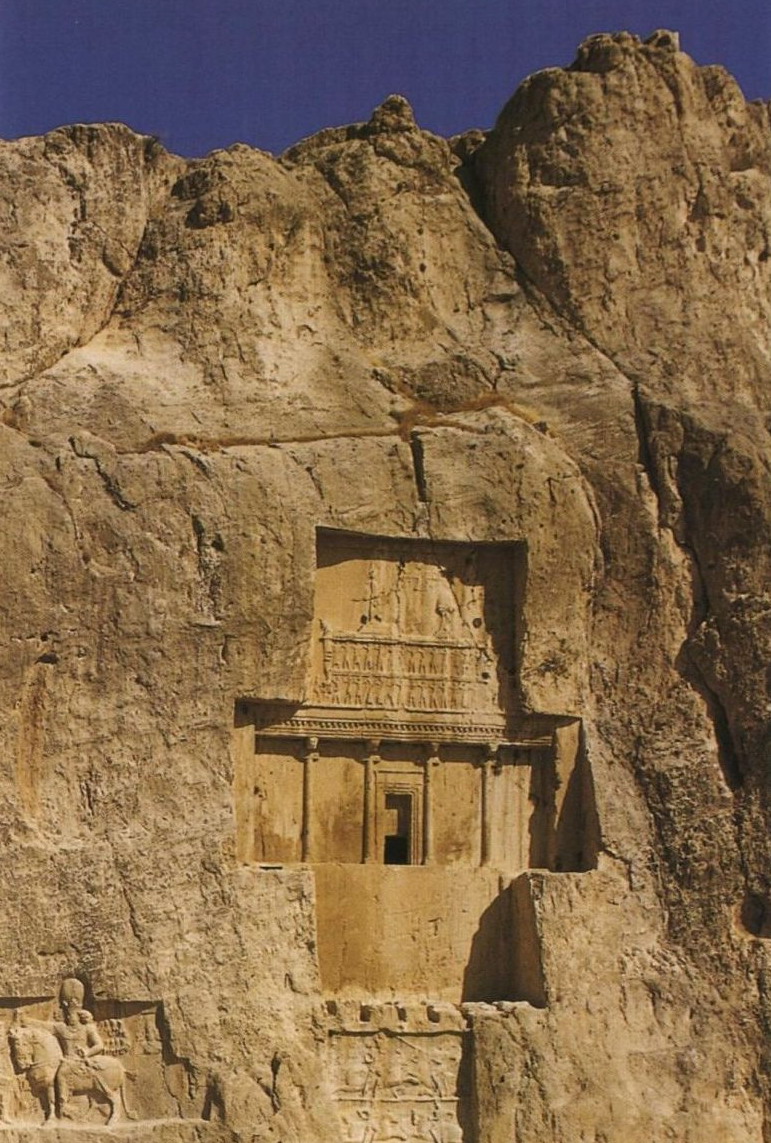
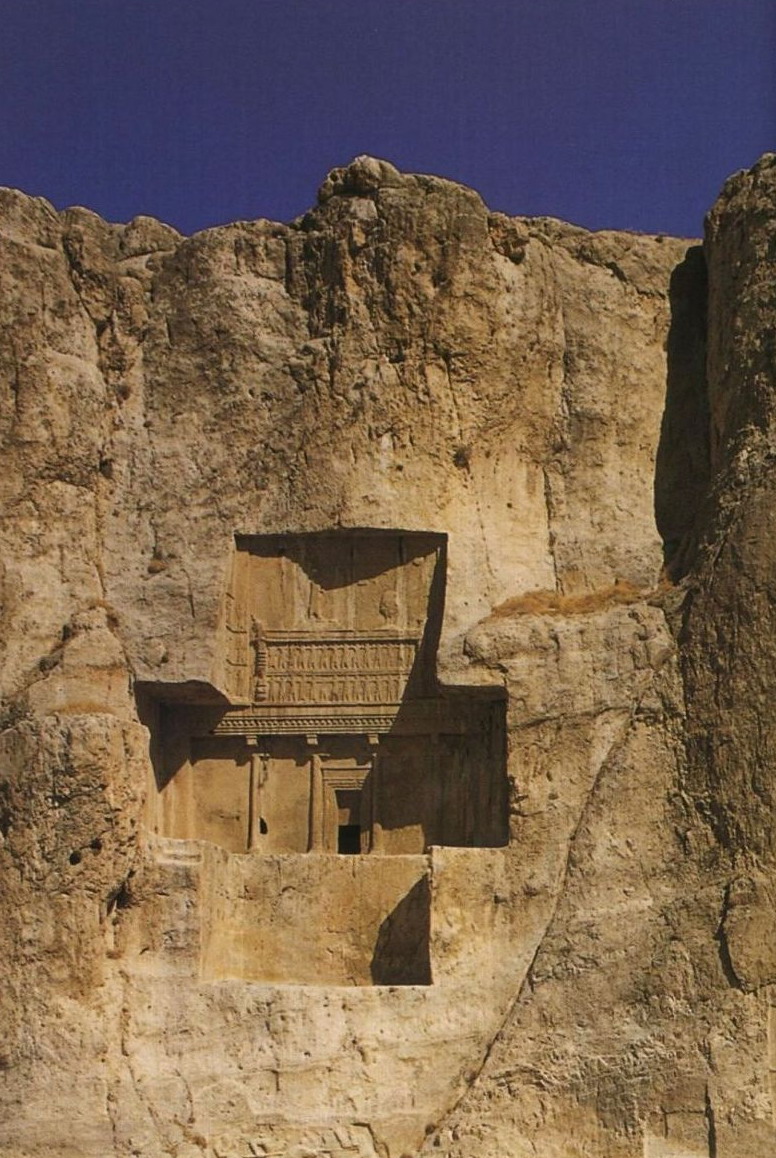
L'ANTICA PERSIA
- Il territorio iraniano
corrisponde quasi completamente all'estensione del regno persiano alla
sua origine durante la metà del VI secolo a.C. quando divenne re Ciro
II, discendente della casa reale del popolo dei medi, la prima etnia
indoeuropea stanziatasi nella pianura della "Mezzaluna
fertile". Le conquiste che portarono la sottomissione della Media,
dell'Asia Minore, della Mesopotamia, con l'impero babilonese (539 a.C.) e della Siria con le città fenicie valsero l'appellativo di
"Grande" al capostipite della dinastia degli Achemenidi. Alla
sua morte l'impero passò a Cambise II (529-521 a.C).
Il
successore Dario I il Grande (521-485 a.C.) per ristabilire l'ordine nel paese divise il territorio in 20
satrapie, circoscrizioni amministrative e militari affidate al governo
di un satrapo tenuto a prestare obbedienza al re. Si dedicò quindi
all'espansione dell'impero conquistando la Russia
meridionale e sottomettendo il popolo degli sciti. Estese il suo potere
sulle città greche della costa anatolica obbligandole a versare
tributi. La rivolta di queste ultime diede origine alle cosiddette
guerre persiane. La prima, combattuta nel
490 a.C, vide la vittoria degli ateniesi a Maratona.
Le
successive, combattute e perdute tra il 480 e il
478 a.C, furono intraprese dal figlio Serse (485-465 a.C). Con gli ultimi Achemenidi Artaserse I (465-424 a.C), Dario II (424-404 a.C), Artaserse II (404-358 a.C), Artaserse III (358-338 a.C.) l'impero decadde lentamente fino alla
definitiva sconfitta di Dario III da parte di Alessandro Magno nel 331
a.C. Alla morte del sovrano macedone l'impero fu diviso tra i suoi
generali e il territorio dell'antica Persia passò sotto il potere di
Seleuco.
Durante il regno di Antioco II seleucide (261-246 a.C.) l'altopiano iranico si rese indipendente creando il regno dei parti
comandato da Arsace, capostipite della dinastia degli Arsacidi, e, dal
226 d.C, dai Sassanidi. Contro questi sovrani combatterono più volte
gli imperatori romani senza mai vincerli. La battaglia dello Yarmuk, nel
636, aprì il territorio iranico al dominio degli arabi musulmani.


ARCHITETTURA
PERSIANA - I grandi palazzi di Persepoli, costruiti in pietra e
mattoni crudi, rappresentano quel che di meglio seppe creare
l'architettura imperiale persiana. Da un punto di vista stilistico le
loro strutture generali, così come le loro decorazioni, non rivelano
alcuna evoluzione interna: solo le iscrizioni permettono di attribuire
questo o quell'edificio a Dario o a Serse I anziché ai loro pronipoti
Artaserse I o III. Basta ciò per indicare in quale clima culturale
operassero gli anonimi artisti che edificarono P. e come fosse radicata
in loro la convinzione di avere raggiunto un ideale di perfezione
estetica insuperabile e perciò stesso immutabile.
Le
vicine civiltà della Mesopotamia, dell'Urartu, dell'Egitto, della
Grecia, fecero sentire il peso delle loro più evolute esperienze
sull'architettura e sulla scultura achemènidi di Persepoli. La
terrazza, nella sua concezione fondamentale, si rivela un prestito
dell'architettura urartea che i Persiani avevano avuto modo di conoscere
durante il loro lungo soggiorno nelle lande ad ovest del lago Urmia.
L'impero achemènide trasse dalle arti sumera, babilonese, assira,
neo-babilonese, gran parte del proprio repertorio iconografico (animali
affrontati; processioni di uomini e donne che reggono un fiore in mano;
sfilate militari; tori guardiani, ecc.) insieme con alcune particolari
antichissime stilizzazioni, come, ad esempio, quella del cipresso, che
ritroviamo identica tanto sulla scalinata dell'apadāna, quanto
sulla stele di Ur-Nammu di Ur. Dal mondo della pianura derivano anche le
rampe d'ingresso. Artisti ed artigiani ionici collaborarono sicuramente
all'edificazione del complesso. Essi portarono nei rilievi persepolitani
un maggior senso plastico ed una visione più tondeggiante dei volumi,
insieme con alcuni motivi iconografici e qualche particolare convenzione
figurativa meno facilmente definibili. A loro spetta anche il merito di
aver introdotto nell'Iran la colonna scanalata.
Più
superficiali ed esteriori sono gli influssi egiziani, visibili nelle
sale ipostile, nelle cornici a cavetto, nelle basi delle colonne, nelle
decorazioni floreali che ornano alcuni capitelli, nelle porte e finestre
monolitiche. Infine dal mondo hittita proviene l'iconografia del leone
ruggente.
E
tuttavia l'arte persepolitana non può esser considerata come la somma
pura e semplice degli influssi che a lei giunsero dalle grandi arti
medio-orientali e mediterranee.
 Fu
grande merito degli Achemènidi quello di aver saputo fondere le
esperienze di maestranze raccolte da ogni parte del loro impero vasto ed
eterogeneo, per dar vita ad un'arte nuova, la quale, pur restando
saldamente ancorata al mondo iranico, usciva finalmente dai limiti
provinciali dell'altopiano e si poneva come punto d'incontro e d'arrivo
di tutte le grandi arti arcaiche dell'Oriente Medio e Vicino.
Fu
grande merito degli Achemènidi quello di aver saputo fondere le
esperienze di maestranze raccolte da ogni parte del loro impero vasto ed
eterogeneo, per dar vita ad un'arte nuova, la quale, pur restando
saldamente ancorata al mondo iranico, usciva finalmente dai limiti
provinciali dell'altopiano e si poneva come punto d'incontro e d'arrivo
di tutte le grandi arti arcaiche dell'Oriente Medio e Vicino.
Ciò
accadde soprattutto perché a Persepoli l'arte achemènide seppe sentire
con coerenza una nuova, fondamentale esigenza: vale a dire il bisogno di
inquadrare ed armonizzare ogni dettaglio del complesso monumentale entro
gli schemi di un ideale canonico unitario.
Tale
ideale fu, nello stesso tempo, estetico, civile e religioso. L'atavica
sensibilità iranica per il ritmo e la linea continua fu intesa come il
mezzo più idoneo per esprimere quel clima di fiduciosa e serena
magnificenza regale che i sovrani achemènidi avevano voluto assumere
quale simbolo del proprio impero. Ne derivò un'architettura chiara ed
elegante, anche se esclusivamente scenografica ed una scultura luminosa,
eminentemente decorativa, vivificata da una nettissima ed armonica linea
di contorno. Le processioni che si snodano lungo le pareti e le
scalinate mostrano sempre un carattere religioso, sereno, cerimoniale,
ben lontano dall'intenzione esclusivamente militare propria delle
sfilate assire. Dignitarî, vassalli, soldati persiani sono forse privi
della vivacità drammatica e dell'impeto proprî dei loro modelli
mesopotamici; essi però rivelano in compenso una semplicità, una
precisione di segno, un senso ritmico, del tutto sconosciuti in epoche
precedenti.
La
tecnica impiegata nei rilievi riflette i medesimi ideali. Essa si mostra
dipendente in qualche modo da modelli in metallo, sia per gli acuti
contorni, la scarsa profondità, la compattezza delle superfici, sia per
alcuni particolari, come le sopracciglia e le chiome, che paiono
trattate con il bulino.
La
preferenza dell'arte persiana per i motivi animali emerge con
indiscutibile chiarezza nei vivaci capitelli ad animali addorsati, siano
essi tori, liocorni, grifoni o tori androcefali. Questo motivo
iconografico che troviamo anche a Susa, sembra essere di antichissima
origine iranica e verosimilmente discese ai Persiani attraverso gli
Elamiti, i Cassiti, i montanari del Luristan.
Per
concludere gioverà accennare brevemente all'intimo significato
simbolico di Persepoli. Persepoli non fu ideata certamente come la
capitale, o come una delle capitali dell'impero persiano, in senso
residenziale-amministrativo. I documenti rinvenuti tra le rovine non
hanno, nella maggior parte dei casi, un carattere politico, né vi sono
trattati, cronache o annali, lettere ed editti. Anche la posizione del
complesso, isolata ed eccentrica, pare poco favorevole ad una simile
destinazione. Sappiamo inoltre che i sovrani achemènidi dividevano di
abitudine il loro tempo tra Susa, Ecbàtana
e Babilonia. Essi soggiornarono dunque solo saltuariamente a Persepoli;
troppo raramente per giustificare, da questo punto di vista, la spesa
per la costruzione ed i successivi, continui ingrandimenti.
Il
complesso monumentale edificato sulla terrazza doveva piuttosto
rappresentare per tutto il popolo iranico l'ombelico dell'impero; il
simbolo, non solo della potenza e della gloria dinastica degli
imperatori, ma anche ed insieme di una idea più profonda e vitale per
l'esistenza dello Stato. Non bisogna dimenticare che l'Oriente antico
non accettò mai l'idea di una frattura tra il potere civile e quello
religioso, o tra il mondo fenomenico in cui operano i re ed il mondo
soprasensibile su cui regnano gli dèi.
 Gli
abitanti dell'Asia Anteriore e dell'Iran, come gran parte delle
popolazioni agrarie primitive, nutrivano la convinzione che ogni
avvenimento naturale, anche ciclico (benefiche inondazioni periodiche,
giro delle stagioni, alternarsi del giorno e della notte, ecc.) non si
ripetesse per merito di una legge meccanica ed immutabile, ma fosse ogni
volta continuamente rimesso in gioco; dipendesse insomma da un atto
gratuito della divinità.
Gli
abitanti dell'Asia Anteriore e dell'Iran, come gran parte delle
popolazioni agrarie primitive, nutrivano la convinzione che ogni
avvenimento naturale, anche ciclico (benefiche inondazioni periodiche,
giro delle stagioni, alternarsi del giorno e della notte, ecc.) non si
ripetesse per merito di una legge meccanica ed immutabile, ma fosse ogni
volta continuamente rimesso in gioco; dipendesse insomma da un atto
gratuito della divinità.
Da qui
nacque la necessità vitale ed urgente di garantirsi l'appoggio del
mondo soprannaturale attraverso preghiere ed atti magici il più
possibile potenti ed efficaci. Accadde così che il re, agli occhi dei
suoi sudditi iranici, fu anche e soprattutto il pontefice, il mediatore,
colui che era in grado di piegare la volontà di Ahura Mazdāh
costringendolo, come si legge in un'iscrizione "a proteggere questa
terra dalla carestia".
Per
tale motivo Persepoli fu ideata, insieme, come il sacrario dinastico
degli Achemènidi e come la città rituale per eccellenza: il punto
focale in cui cielo e terra si toccavano; e che, attraverso la
magnificenza dei suoi edifici ed il carattere simbolico-magico delle sue
strutture e dei suoi rilievi, contribuiva a rendere irresistibili e
perenni le richieste fatte dal re (inteso come mediatore e pontefice)
agli dèi, in occasione della festa del Nuovo Anno.
Tutto
ciò basta a fare comprendere come la religione che si riflette a
Persepoli non fosse in realtà lo zoroastrismo favorito dagli ambienti
di corte, ma l'antico politeismo naturalistico degli iranici, basato
sull'adorazione della montagna, sul toro, sui riti della fertilità.
Solo
attraverso la conoscenza di questi culti popolari e della loro
simbologia si può afferrare il significato più vero di molti elementi
scultorei ed architettonici persepolitani. Ad esempio: i merli a
scalini, diffusi lungo un vasto arco di secoli in tutto l'Oriente, non
hanno nessun reale scopo difensivo, essi simboleggiano la Montagna
Sacra, sorgente della fertilità, stilizzata nella forma di una ziqqurat
in miniatura; le
colonne del tripylon furono intese come palme sacre, mentre quelle
fittissime della Sala delle cento colonne altro non rappresentano se non
un bosco sacro; nel tema ricorrente della grande processione per il
Nuovo Anno i doni che i popoli soggetti portano al sovrano rappresentano
non soltanto il dovuto tributo, ma anche il simbolo di quanto si
desiderava ottenere di nuovo dalla benevolenza degli dèi; le scene di
lotta tra il toro ed il leone o tra il re ed il leone od altri animali
fantastici, nascondono probabilmente un significato zodiacale, legato al
mutare delle stagioni; infine le rosette che ornano a centinaia i
rilievi e gli edifici, non hanno un valore esclusivamente decorativo; il
loro significato magico è dimostrato dal fatto che se ne sono trovate
non poche scolpite sotto ai cardini di pietra delle porte, rivolte verso
terra e perciò nascoste alla vista.

LA SCRITTURA CUNEIFORME
- Sotto i detriti del palazzo,
chiamato Tesoro, sono state scoperte centinaia di tavolette d'argilla,
supporto delle iscrizioni in caratteri cuneiformi. Le impressioni
nell'argilla fresca a forma di cuneo, da cui il nome, avevano diverse
combinazioni che formavano sillabe e quindi parole; dopo l'essiccazione
al calore del sole venivano stipate nell'archivio reale, dove sono
giunte fino a noi grazie all'incendio che distrusse la città.
Furono
scritte in antico persiano, derivato dal ceppo delle lingue indoeuropee,
e in alcuni casi in lingua elamita e babilonese. Sono di grande
importanza perché proprio grazie alla loro traduzione da parte dei
linguisti si è riusciti a ricostruire la vita della città imperiale e
di conseguenza la cultura, la società e l'economia del popolo persiano.










Da esse
sappiamo che Persepoli era abitata da genti provenienti da ogni parte
dell'impero, scultori dall'Egitto, orafi dalla Caria, decoratori da
Susa. Alcune menzionano il mese e l'anno di regno di Dario o Serse in
cui fu edificata una certa struttura, il numero degli operai e il loro
compenso.
Abbiamo
la registrazione dei tributi, la loro quantità e la loro natura, dati
da ogni satrapia al re, la corrispondenza dei governatori con il re
relativi a problemi di ordine politico e amministrativo. Altre
conservano le istruzioni per compiere determinati riti o cerimonie in
onore degli dei o dei sovrani.