|
La
Moschea del Venerdì è probabilmente l'espressione architettonica più
importante della dominazione selgiuchide in Persia (1038-1118).
Nel 1051
Esfahan divenne la capitale dei selgiuchidi, giunti nel Khwarezm e nella
Transoxiana dall'Asia centrale nell'XI secolo. Di fede sunnita, essi
miravano alla restaurazione del califfato abbaside. La conquista di
Isfahan da parte di Toghrul Beg elevò il prestigio della città, il cui
nuovo status venne espresso attraverso un elaborato piano architettonico.
La potenza dell'Impero selgiuchide trovò concreta manifestazione in una
serie di edifici, dei quali il più importante era la moschea.
 I
Selgiuchidi progettarono il centro città e la piazza in prossimità della
preesistente moschea del Venerdì, il cui lato nord confinava con questi
spazi. In età successive, il sovrano safavide Shah Abbas avrebbe
rimpiazzato il centro originario con la sua nuova maydan (piazza),
completata nel 1602, spostando il nucleo della città più a sud. I
Selgiuchidi progettarono il centro città e la piazza in prossimità della
preesistente moschea del Venerdì, il cui lato nord confinava con questi
spazi. In età successive, il sovrano safavide Shah Abbas avrebbe
rimpiazzato il centro originario con la sua nuova maydan (piazza),
completata nel 1602, spostando il nucleo della città più a sud.
Numerosi
storici dell'architettura considerano la moschea del Venerdì l'epitome
del periodo selgiuchide-safavide e il cuore della città pre-abbaside. Le
testimonianze storiche danno informazioni contrastanti circa le condizioni
della moschea durante il periodo selgiuchide. Il rinomato geografo e
storico Yaqut al-Hamawi afferma che la popolazione di Esfahan fu costretta
a demolire il tempio "per mancanza di legno" nel 1051, quando la
città fu conquistata da Toghrul Beg. Il resoconto di Naser-e Khosrow
scrive in vece che la moschea era "grande e magnificente"
intorno al 1052.
Quel che
è certo, al di là delle discordanti versioni, è che prima della
conquista selgiuchida di Esfahan esisteva già una moschea del Venerdì a
pianta ipostila risalente al X secolo, edificata nel periodo Buyide. La
cattura della città e i successivi tumulti, le dispute religiose (tra le
correnti Hanafite e Shafi'ite) sotto Malik Shah, e incendi provocarono
diversi danni alla moschea. Tale situazione comportò la necessità di
ricostruire parzialmente il tempio, introducendovi nuovi elementi
architettonici.
La pianta
della moschea si evolse da quella originaria ipostila, che prevedeva un
cortile interno di forma regolare (65 per 55 metri) circondato da sale di
preghiera provviste di colonne a sezione circolare che sostenevano il
soffitto in legno (avente 7 campate nell'ala di sud-ovest, 3 a sud-est e a
nord-ovest, 5 a nord-est). Il nuovo progetto prevedeva una pianta con
quattro iwan, attuata nel XII secolo con l'edificazione/aggiunta degli
iwan, della sala con cupola sud-occidentale affiancata da due minareti,
della sala settentrionale con cupola. Tra tutte le aggiunte e
ricostruzioni successive vi è la serie di archi su due livelli intorno
alla corte (datati 1447), che hanno rimpiazzato la precedente serie
unificando gli elementi del cortile in un unico spazio.
Ciò che
distingue in maniera immediata la moschea è la sua integrazione con il
tessuto urbano attraverso i numerosi accessi che la collegano con le
attività della città, sfumando i confini tra spazi cittadini e spazi
religiosi. Questo risultato è anche l'esito finale del processo
costruttivo e ricostruttivo verificatosi nel tempo.
Gli
ingressi - La moschea è, come si è già detto in precedenza,
strettamente collegata con il tessuto urbano, con due torri fiancheggianti
l'iwan meridionale e le grandi cupole (meridionale e settentrionale) che
si stagliano nettamente sul profilo cittadino, costituendo un elemento
panoramico inconfondibile. L'integrazione della moschea nella città è
data dai numerosi accessi che si aprono lungo le mura che la delimitano,
comuni peraltro a molti edifici estranei ad essa. Il cancello di ingresso
alla moschea (la cui data di costruzione è incerta) è collocato sul lato
sud-orientale. Esso venne restaurato nel 1804.
Un'iscrizione
posta negli spazi che conducono alla madrasa, nella parte sud-orientale
del complesso menziona il sultano Muzaffaride Mahmud (che regnò ad
Esfahan tra il 1358 e il 1374). Molti storici sostengono che questa era la
porta principale durante il XIV secolo, in sostituzione di un ingresso non
più esistente. La porta introduce alla parte superiore del muro
orientale, nei pressi dell'angolo di sud-est.
Dalla
parte opposta, a sud-ovest, un'altra porta, ancora utilizzata, datata
1590-1, risalente al periodo dello Shah Abbas's. Essa collega l'angolo
sud-occidentale e i muri dell'arcata di nord-ovest con le adiacenti aree
cittadine, facilitando i trasporti tra zone della città altrimenti non
collegate a causa della presenza della moschea. Una grande porta
monumentale, non più utilizzata al giorno d'oggi, è situata a nord,
aprendosi nel muro nord-orientale della cupola settentrionale. Essa risale
al 1366 e reca iscrizioni dalla Surah 76 del Corano, descrivente la vita
eterna. È allineata con l'asse est-ovest, a differenza di altri elementi
architettonici della moschea. La quarta porta, nel segmento
nord-orientale, anch'essa non più in uso, è decorata con mattoncini
invece che con piastrelle, come lo sono le altre tre porte. Un'iscrizione
coranica sulla porta, descrivente le modalità di sconsacrazione di una
moschea, reca anche l'informazione che l'edificio fu restaurato dopo un
incendio nel 1121-2.
Il bazar
coperto con la sua intensa attività commerciale collega il nuovo centro
safavide rappresentato dalla maydan alla moschea del Venerdì. Il traffico
pedonale scorre attraverso il portale settentrionale.

Il
cortile - Come si è detto in precedenza il cortile è racchiuso da
un'arcata su due livelli, sorta di fondale bidimensionale, decorata con
piastrelle smaltate che formano disegni floreali e geometrici in diverse
tonalità di blu, in bianco e in giallo. Gli archi sono disposti
simmetricamente attorno ai quattro iwan posti al centro di ciascuno dei
muri e si uniformano alla loro altezze, con l'eccezione delle campate che
fiancheggiano l'iwan orientale, più alte.
Un'ulteriore
differenza è data dalla presenza di un ingresso monumentale, alto quanto
due piani, che si apre nella sezione settentrionale dell'arcata
occidentale, delimitando l'area della moschea invernale. Nonostante le
ingenti modifiche apportate alla struttura nel corso dei secoli, essa
conserva un'unità strutturale, decorativa, cromatica e di materiali. I
quattro rialzi del cortile non sono solamente degli schermi, ma
comprendono anche vie di transito tra le diverse aree sacre dell'edificio
e degli spazi cittadini.
La
cupola originaria meridionale (maqsura) - Come parte del
processo di ricostruzione della moschea danneggiata, Nizam al-Mulk, visir
di Abu al-Fath Malik Shah ordinò nel 1086 la costruzione di una sala con
cupola (avente lati di 15 metri e un'elevazione di di 30 metri) nell'ala
di sud-ovest. Tale ambiente fu progettato dall'architetto Abul Fath, a cui
alcuni storici attribuiscono entrambe le cupole presenti nella moschea.
Due
iscrizioni, poste sul tamburo della cupola, menzionano Abu Malik Shah e
Nizam al-Mulk. La cupola, rinforzata da nervature, poggia su delle
muqarnas, a loro volta sostenute da un muro portante e da otto pilastri,
appartenenti alla vecchia moschea. Gli storici hanno dibattuto, a
proposito di questa sala, circa la possibilità che essa fosse stata
eretta su una preesistente area ipostila (basando queste affermazioni su
ricerche archeologiche condotte in loco). Questa maqsura divenne il
prototipo di diverse moschee successive, come quelle di Ardestan, Qazvin e
Zavareh.

La
cupola nord-orientale -
Commissionata da Taj al-Mulk (successore di Nizam e principale
consigliere della madre di Malik Shah), la cupola di nord-est fu costruita
nel 1088-9 per conto di Terken Khatun (moglie di Malik Shah e figlia del
sultano Tamghach Khan). A causa della posizione distaccata della struttura
dal resto del complesso è stato ipotizzato che l'area venisse utilizzata
come spazio privato di preghiera, zona riservata alle donne o anche come
biblioteca. Di dimensioni più contenute e collocata sullo stesso asse
longitudinale della cupola di sud-ovest, la cupola di nord-est poggia su
piloni disposti a formare uno spazio quadrato, con una zona ottagonale di
transizione sormontata da quattro volte.
Al di
sopra delle volte troviamo sedici archi (quattro per lato) che sostengono
il tamburo della cupola. Quest'ultimo presenta alla base iscrizioni
religiose. Dieci doppie nervature ascendono dal tamburo della cupola
inscrivendo un pentagono. Questa componente architettonica è considerata
dagli storici dell'architettura un tentativo di Taj al-Mulk di costruire
una cupola più alta di quella del suo rivale Nizam al-Mulk, quella
meridionale. La cupola presenta ingressi sul lato sud e ovest.
Nell'interno della cupola vi sono versetti coranici, composti disponendo
piastrelle colorate.
Gli
storici dell'architettura hanno tratteggiato paragoni, relativamente alla
struttura e alla decorazione, tra la cupola di sud-ovest, opera di Nizam
al-Mulk, e la successiva cupola di nord-est, chiamata anche Gunbad-e
Khaki, costruita da Taj al-Mulk. La cupola settentrionale è
un'epitome di perfezione matematica, resa evidente dall'armonia delle sue
suddivisioni orizzontali e verticali e raggiunta attraverso una precisa
gerarchia nella disposizione delle sue componenti, basata sulla sezione
aurea. Molti storici dell'architettura trovano parallelismi tra questa
architettura e quella Alto-gotica francese.
Le due
cupole hanno diverse tipologie di decorazioni. In quella di sud-ovest sono
rintracciabili ancora tracce di ornamenti in stucco, mentre la cupola di
nord-est è prevalentemente decorata da disegni integrati nella struttura,
costituiti da mattoncini. I loro diversi gradi di rilievo e le
disposizioni creano una vasta gamma di disegni. Questo linguaggio
decorativo manca nella cupola meridionale, costruita su una struttura
preesistente, rendendo impossibile l'unificazione dei principi decorativi.
L'incongruenza tra vecchio e nuovo è evidente anche a livello
strutturale, confrontando la massiccia struttura originaria, con pilastri
doppi e archi a curvature diverse con la nuova concezione costruttiva,
decisamente più leggera. Una sorprendente descrizione letteraria di
questo contrasto ci è stata lasciata dal viaggiatore e scrittore Robert
Byron (1905-1941) con il suo libro del 1937 "La via per
l'Oxiana".
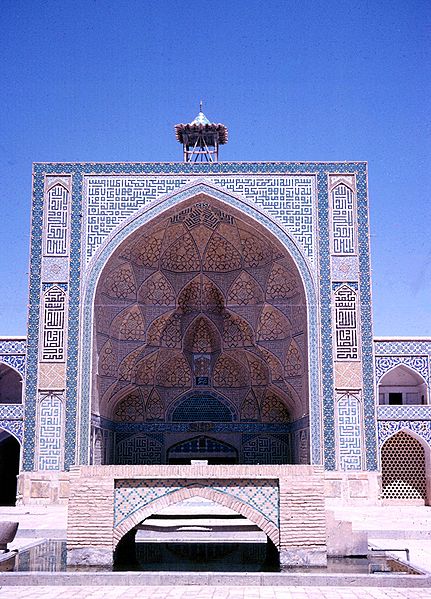 Gli
iwan -
I quattro iwan non sono tutti di uguale importanza e tale fatto è
reso evidente dalle loro diverse dimensioni, strutture e decorazioni.
L'iwan di sud-ovest, che precede la sala con cupola con una mirai è
indubbiamente il più importante dei quattro. È fiancheggiato da due
torri e viene utilizzato visivamente per enfatizzare la vastità degli
spazi vuoti del santuario, contrapponendosi alla maqsura. Colloquialmente
viene chiamato sofe-e saheb ovvero "il luogo superiore del
signore". Gli
iwan -
I quattro iwan non sono tutti di uguale importanza e tale fatto è
reso evidente dalle loro diverse dimensioni, strutture e decorazioni.
L'iwan di sud-ovest, che precede la sala con cupola con una mirai è
indubbiamente il più importante dei quattro. È fiancheggiato da due
torri e viene utilizzato visivamente per enfatizzare la vastità degli
spazi vuoti del santuario, contrapponendosi alla maqsura. Colloquialmente
viene chiamato sofe-e saheb ovvero "il luogo superiore del
signore".
Le
iscrizioni poste sulla mihrab risalgono principalemte al periodo dello
Shah Tahmasp I e dello Shah Abbas II. Vi è anche una menzione a Uzun
Hassan, capo della dinastia Ak Koyunlu, risalente al 1475-76. Le
iscrizioni sono accomunate da concetti ricorrenti: ta'mir
(restaurare) e taz'yin (decorare) e mostrano come l'edificio sia
stato oggetto di numerose trasformazioni nel tempo. Altre scritte, del
XVII e XVIII secolo, sono estratti dal Corano. Il soffitto dell'iwan
risale al XV secolo, mentre le sue mura sono state restaurate in età
safavide. Al di sotto dell'iwan sono state trovate colonne e basamenti
della moschea originaria.
Gli iwan
di sud-est e di nord-ovest, costruiti con tecniche analoghe e nello stesso
periodo, presentano elementi architettonici tardo-safavidi. Essi hanno
nomi che testimoniano la loro funzione. L'iwan di nord-ovest è chiamato
"seggio del maestro" (ustadh), quello di sud-est seggio
dell'allievo (shagird). L'iwan di nord-ovest venne completamente
restaurato tra il 1940 e il 1950.
Esso
comprende una serie di muqarnas fatte di mattoncini, orlate da linee
smaltate blu scuro. Ciascun blocco di muqarnas elevandosi termina con un
elemento in forma di stella, che inscrive al suo interno arabeschi
geometrici in blu scuro. Orizzontalmente ai tre muri dell'iwan corre una
banda di mattonelle smaltate di colore giallo e bianco con fondali in blu
scuro che reca iscrizioni.
L'iwan di
sud-est presenta motivi geometrici realizzati con piastrelle di epoca
safavide. Ciascuna faccia delle unità del muqarnas è decorata con pezzi
molto piccoli di piastrelle smaltate con punti e linee in blu scuro, che
formano un arabesco geometrico di maggiori dimensioni che inscrive un
elemento epigrafico di colore blu più tenue.
Le
aree di preghiera -
Le aree coperte che si estendono tra i quattro iwan sono sale
ipostile comprendenti una serie di piccole cupole, costruite verso il XII
secolo. I piloni di sostegno di queste sale differiscono tra di loro in
forma e grandezza, dal momento che furono aggiunti in periodi diversi.
Troviamo anche una serie di volte aperte e chiuse di varie forme e
disposizioni. Le volte aperte determinano spazi illuminati, in contrasto
con quelli bui. Le volte chiuse in laterizi presentano una sostanziale
innovazione strutturale e in molti casi includono volte a vela simili a
quelle della Grande Moschea di Cordova. La diversa disposizione dei motivi
geometrici dei laterizi, alcuni esagonali, alcuni ottagonali o decagonali
non è solo frutto di una scelta derivante da motivazioni meramente
strutturali, ma presenta un significato religioso, correlato al misticismo
Sufi, come suggerito da alcuni storici (es. Sayed Husein Nasr).
Ci sono
tre aggiunte al perimetro originale rettangolare della moschea che sono
incorporate al suo interno: la madrasa muzaffaride a sud-est (22 m per 26
m), la sala di preghiera timuride (masjid) a sud-ovest (32 m per 32 m),
l'ampia sala safavide ad ovest (32 m per 48 m), caratterizzate da un
sistema di volte a botte che si eleva dal livello del suolo con una base
avente forma simile ad un piedistallo.
Di
particolare interesse è la mihrab di Oljaytu, che fu edificata nel 1310
dal sovrano Ilkhanide Oljaytu. Essa si trova nella parte nord-occidentale
della moschea, lungo il muro esterno dell'iwan. La costruzione presenta
una complessa composizione in stucco costituita da iscrizioni
tridimensionali che si fondono con intagli floreali e geometrici. L'intera
mihrab si configura come un elemento estruso dal muro originale della
moschea. La mihrab è costituita da un arco esterno all'interno del quale
è inscritto un arco più piccolo, la cui altezza e profondità sono pari
alla metà del primo. Questi archi, incluse le loro intelaiature e
colonne, prive di funzioni strutturali, sono decorate con intagli e
disegni geometrici. L'intelaiatura più esterna presenta le decorazioni più
raffinate. La fascia delle iscrizioni, incassandosi nel muro, si incurva
nello spazio come se fossero tracciate su una superficie convessa; il
fondale decorato con motivi floreali e sottilmente traforato dà
l'impressione che esse galleggino nell'aria.
La
madrasa muzaffaride, conosciuta localmente come iwan di Umar (Suffeh-i
Umar), fu eretta nel lato di sud-est della moschea nel XIV secolo ed è
particolarmente interessante sotto il profilo artistico per i suoi superbi
mosaici di maiolica con disegni geometrici e floreali, paragonati dagli
storici ai lavori analoghi eseguiti presso la corte timuride.
Un'iscrizione sull'intradosso dell'iwan della madrasa reca il nome del
sultano muzaffaride Mahmud (reg. 1358-1374), probabile patrocinatore della
costruzione di questa parte della moschea. La campata centrale della qibla
è sovrastata da un tiburio e comprende una mihrab ricoperto di mosaici
con muqarnas. Mentre le piastrelle dell'hazarbaf, che presentano disegni
geometrici ravvivano il tiburio dell'iwan, le muqarnas al di sopra della
mihrab sono rivestite con maioliche in blu chiaro e scuro, bianco e nero,
così come da piastrelle non smaltate.

Gli
storici dell'architettura considerano la moschea del Venerdì di Isfahan
un capolavoro della costruzione in laterizi. Simile in grandezza alle
moschee della Siria e di Cordova, presenta nuovi elementi, molto
apprezzabili per la loro originalità e complessità. L'amalgama delle
composizioni decorative prodotto dalla varietà dei disegni dei laterizi,
il lavoro meticoloso di intagliatura dello stucco, i pannelli colorati
recanti motivi geometrici, floreali ed epigrafici, contribuiscono a
rendere quest'edificio il rappresentante di punta dell'architettura
selgiuchide.
|