|
Circa
3000 anni fa i Persiani hanno appreso come scavare acquedotti sotterranei
per trasportare le acque del sottosuolo dalle montagne alle pianure;
questo sistema fornisce ancor oggi il 75% dell'acqua.
Un
viaggiatore che sorvolasse l'Iran potrebbe vedere chiaramente che il paese
ha un clima arido, L'altipiano iraniano è desertico e gran parte
dell'Iran (eccettuate le aree nelle province dei nord-ovest e lungo le
coste a sud del Mar Caspio, riceve solo da 15 a 15 centimetri di pioggia
l'anno. Mentre altre regioni del mondo con precipitazione così limitata
(per esempio il centro arido dell'Australia) sono improduttive per
l'agricoltura, l'Iran è un paese agricolo il quale non solo produce
quanto basta alla sua popolazione, ma trova anche il modo di esportare
alcuni prodotti agricoli come cotone, frutta secca, semi
oleosi, ecc. Questo importante successo e stato raggiunto
sviluppando un ingegnoso sistema per attingere l'acqua sotterranea. Il
sistema, chiamato qanat (dalla parola semitica «scavare), fu inventato
nell'Iran migliaia di anni fa e è cosi semplice ed efficace da essere
adottato in molte altre regioni aride dei Medio Oriente e de!
Mediterraneo.
Il
sistema Qanat è costituito da canali sotterranei che per gravità portano
l'acqua dalle falde acquifere degli altipiani ad affiorare alla superficie
dei bassipiani. I qanat dell'Iran furono costruiti su una scala tale da
rivaleggiare con ì grandi acquedotti dell'impero Romano, ma mentre gli
acquedotti romani rappresentano oggi solamente una curiosità storica, il
sistema iraniano è ancora in uso dopo 3000 anni e si è continuamente
ampliato. Nell'Iran vi sono circa 22.000 qanat che comprendono più di
300.000 chilometri di canali sotterranei. Il sistema fornisce il 75 per
cento di tutta l'acqua usata nel paese, non solo per l'irrigazione ma
anche per gli usi domestici. Fino a poco tempo fa (prima della costruzione
della diga del Karaj) i due milioni di abitanti della città dì Teheran
dipendevano per il loro intero rifornimento di acqua da un sistema qanat
che provvedeva ad attingere l'acqua dalle colline ai piedi dei monti
Elbrus.
La
scoperta di condutture sotterranee in certe antiche zone romane ha indotto
alcuni archeologi a supporre che il sistema qanat sia stato inventato dai
Romani. Iscrizioni e scavi recenti non lasciano però alcun dubbio che
l'antico Iran (Persia) sia stato il suo luogo di nascita. All'inizio del
VII secolo a.C., il re assiro Sargon II riferiva che durante una campagna
in Persia aveva trovato in funzione vicino al lago Urmia un sistema
sotterraneo per attingere l'acqua. Suo figlio, il re Sennacherib, applicò
il "segreto" di usare canalizzazioni sotterranee nella
costruzione di un sistema dì irrigazione intorno a Ninive e costruì un
qanai sul modello persiano per rifornire d'acqua la città di Arbela. Le
iscrizioni egizie rivelano che i Persiani suggerirono l'idea all'Egitto
dopo la conquista di quel paese, nel 518 a.C., da parte di Dario I.
Scylax, un capitano della flotta di Darlo, costruì un qanat che portava
sull'oasi di Karg l'acqua di una falda sotterranea del fiume Nilo distante
centottanta chilometri; resti del qanat sono ancora in funzione. Questo
contributo fu forse, la ragione della benevolenza degli Egiziani verso i
loro conquistatori e del conferimento del titolo di faraone a Dario.
Riferimenti
ai sistemi qanat, conosciuti sotto vari nomi, sono abbastanza comuni nella
letteratura dei tempi antichi e medievali. Lo storico greco Polibio, nel
II secolo a.C., descriveva un qanat costruito in un deserto iraniano
durante l'influenza persiana.

Sono
stati trovati qanat in tutte le regioni che caddero entro la sfera
culturale dell'antica Persia: nel Pakistan, negli insediamenti cinesi
nelle oasi del Turkestan, nelle zone meridionali della Russia, nell'Iraq,
in Siria, in Arabia e nello Yemen. Durante i periodi delle dominazioni
romana e araba, il sistema si estese verso occidente. Nell'Africa del
nord, in Spagna e in Sicilia. Nella regione del Sahara un certo numero di
oasi vengono irrigate con il metodo qanat e qualcuno chiama ancora le
canalizzazioni sotterranee "lavori persiani". Nel Medio Oriente
sono stati portati
alla luce numerosi qanat particolarmente interessanti costruiti
dagli arabi durante il
primo medioevo. Nell'anno 728 d.C. il califfo Mutawakkil costruì un
piccolo qanat per fornire d'acqua un suo palazzo di campagna, Un secolo più
tardi, il califfo Mutawakkil costruì
nell'Iraq un altro
sistema qanat, presumibilmente con l'aiuto di ingegneri persiani,
che porta l'acqua dal
fiume Tigri superiore alla sua residenza di Samarra distante circa 500
chilometri.
Grazie
alle descrizioni particolareggiate di numerosi scrittori dei tempi
antichi, abbiamo una buona idea delle tecniche usate dagli originari
costruttori di qanat. Vitruvio, il primo storico della tecnologia, ci ha
dato un resoconto tecnico dettagliato del sistema qanat nel suo famoso De
Architectura (80 a.C. circa). Nel IX secolo d.C., su richiesta di un
governatore provinciale persiano, Ahdullah ihn-Tahir, un gruppo di
scrittori compilò un trattato sull'argomento intitolato Kitab-c Quniy.
Verso l'anno 100 d.C. Husan al-Husib, un'autorità araba nel campo
dell'ingegneria, scrisse un'opera di carattere tecnico che fortunatamente
è ancora disponibile e ha ottimi dettagli sulla costruzione e sulla
manutenzione degli antichi qanat.
I
metodi usasi oggi nell'Iran non si differenziano molto dal sistema
escogitato migliaia di unni fa che qui verrà descritto. Il progetto
inizia con un'accurata ispezione del terreno da parte di un esperto
assunto dagli organizzatori. Un sistema qanal è di solito scavato nel
pendio di una montagna o nella parte collinosa dove il materiale
trascinato lungo il pendio forma un deposito alluvionale. L'incaricato
dell'esplorazione esamina attentamente queste formazioni alluvionali,
generalmente durante l'autunno, cercando tracce di infiltrazioni in
superficie o di leggere variazioni nella vegetazione che potrebbero
suggerire la presenza di fonti d'acqua celate nella parte collinosa.
Localizzato un punto promettente, organizza lo scavo di un pozzo per il
sondaggio.
Due
scavatori, chiamati "muqanni", danno poi inizio all'opera:
fissano un verricello alla superficie per sollevare il materiale di scavo
mediante secchie di cuoio e procedono a scavare un pozzo verticale dì
circa un metro di diametro; un uomo lavora con una zappa, e l'altro con
una vanga dal manico corto. Non appena hanno scaricato il materiale nelle
secchie, due operai alla superficie lo sollevano con il verricello e lo
ammucchiano intorno all'imboccatura del pozzo. Se sono fortunati, gli
scavatori possono imbattersi in una falda dacqua alla profondità di 15 m
o anche meno. Alle volte, tuttavia, essi scavano fino alla profondità di
60 o 90 m prima di arrivare all'acqua e in questo caso è necessario
istallare sul percorso una serie di verricelli distanti 30 m l'uno
dall'altro.
Quando
arrivano allo strato umido - una potenziale falda d'acqua - gli operai
scavano una buca nel fondo argilloso impermeabile e nei giorni successivi
vengono immerse periodicamente in essa delle secchie di cuoio per misurare
la velocità di accumulo dell'acqua. Se nella cavità scorre più di un
filo d'acqua, l'esperto può dedurre di avere forato una vera falda
acquifera e quindi decidere di scavare più pozzi nella zona circostante
per determinare l'area della falda e la sua resa.
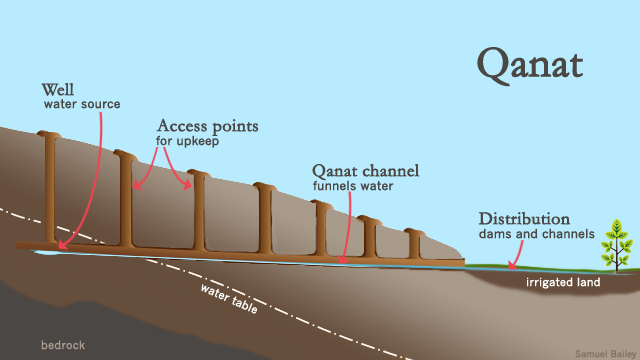
L'esperto
procede poi a disegnare la pianta del percorso della canalizzazione
sotterranea attraverso la quale l'acqua possa fluire dal pozzo principale
o dal gruppo di pozzi alla superficie del terreno in qualche punto più
basso del versante. Per l'inclinazione verso il basso della
canalizzazione, viene scelto un gradiente compreso tra 1:500 e 1:1500
circa; il gradiente deve essere lieve affinché l'acqua fluisca lentamente
e non asporti materiale dal fondo della canalizzazione né la danneggi in
qualche altro modo. Per queste misure, l'esperto usa strumenti molto
semplici: una lunga corda e una livella. Il perito fa calure nel pozzo una
corda fino al livello dell'acqua e segna la corda stessa alla superficie
per misurare la profondità. Ciò gli sarà di guida per costruire la
bocca della canalizzazione che, ovviamente, dovrà essere in un punto un
po' più basso del livello dell'acqua indicala dalla corda. Occorrerà
praticare una serie di pozzi verticali di ventilazione dalla superficie
fino alla canalizzazione a determinati intervalli misurati (circa 50
metri) lungo il suo percorso. Conseguentemente, l'esperto dovrà stabilire
la profondità dalla superficie di ciascuno di questi pozzi. Egli usa una
livella per trovare l'aumento della pendenza del terreno da ciascun pozzo
al successivo e segna sulla corda l'entità della riduzione. In questo
modo sa a quale profondità dalla superficie dovrebbe essere scavato ogni
pozzo se la canalizzazione fosse perfettamente livellala. Egli calcola
quindi in profondità addizionale alla quale dovrà essere scavato ciascun
pozzo (a causa della prevista inclinazione della canalizzazione) dividendo
l'abbassamento totale del canale dal livello dell'acqua del pozzo alla
bocca in base al numero di pozzi di ventilazione.
Per
procurare agli scavatori le informazioni relative al percorso e
all'inclinazione della canalizzazione, vengono scavati pozzi guida alle
profondità indicate a intervalli di circa 300 metri, mentre i muqanni
procedono allo scavo della canalizzazione vera e propria, iniziando lo
scavo all'estremità della bocca del terreno alluvionale. Per proteggere
la bocca dai danni provocati dai temporali i primi 3-5 metri del tunnel
vengono rivestiti con pietre di rinforzo. Il cunicolo è largo circa 1
metro e alto un metro e mezzo. Man mano che gli scavatori avanzano, si
assicurano di seguire un percorro rettilineo con l'ausilio di due lampade
a olio. Il materiale scavato viene depositato nelle secchie ai piedi del
pozzo di ventilazione più vicino e issato alla superficie dai compagni di
squadra. Il tunnel non richiede nessun rinforzo se è scavato nell'argilla
dura o in un conglomerato ben compatto. Quando i muqanni incontrano un
masso di roccia o qualche altro ostacolo insormontabile praticano un
passaggio intorno a esso e devono poi ritrovare la giusta direzione verso
il prossimo pozzo di ventilazione. Essi dimostrano una grande perizia in
questo lavoro, sia contando sul loro senso di orientamento sia ascoltando
i rumori degli scavatori che lavorano nel pozzo verticale più avanti. Il
pericolo maggiore che si può incontrare è un suolo sabbioso, soffice,
friabile o comunque mobile che può provocare il crollo della volta.
In
questi tratti gli scavatori rivestono le pareti con anelli in terracotta
non appena hanno tagliato lo strato frontale della galleria. Pericolosi
sono anche i gas e l'aria povera di ossigeno; gli scavatori sorvegliano
attentamente le loro lampade a olio che rappresentano un allarme per una
possibile atmosfera asfissiante. Non appena i muqanni si avvicinano alla
falda acquifera si devono guardare da un altro pericolo: il possibile
allagamento del tunnel da parte di una improvvisa irruzione d'acqua.
Questo pericolo è particolarmente grande nel momento dello sfondamento
del pozzo principale; il pozzo deve essere svuotato accuratamente se non
si vuole che gli uomini vengano spazzati via dall'irruzione dell'acqua. A
causa di tutti questi pericoli i muqanni, che chiamano il qanat
"l'assassino", recitano sempre una preghiera prima di entrarvi e
non vanno mai al lavoro in un giorno infausto.
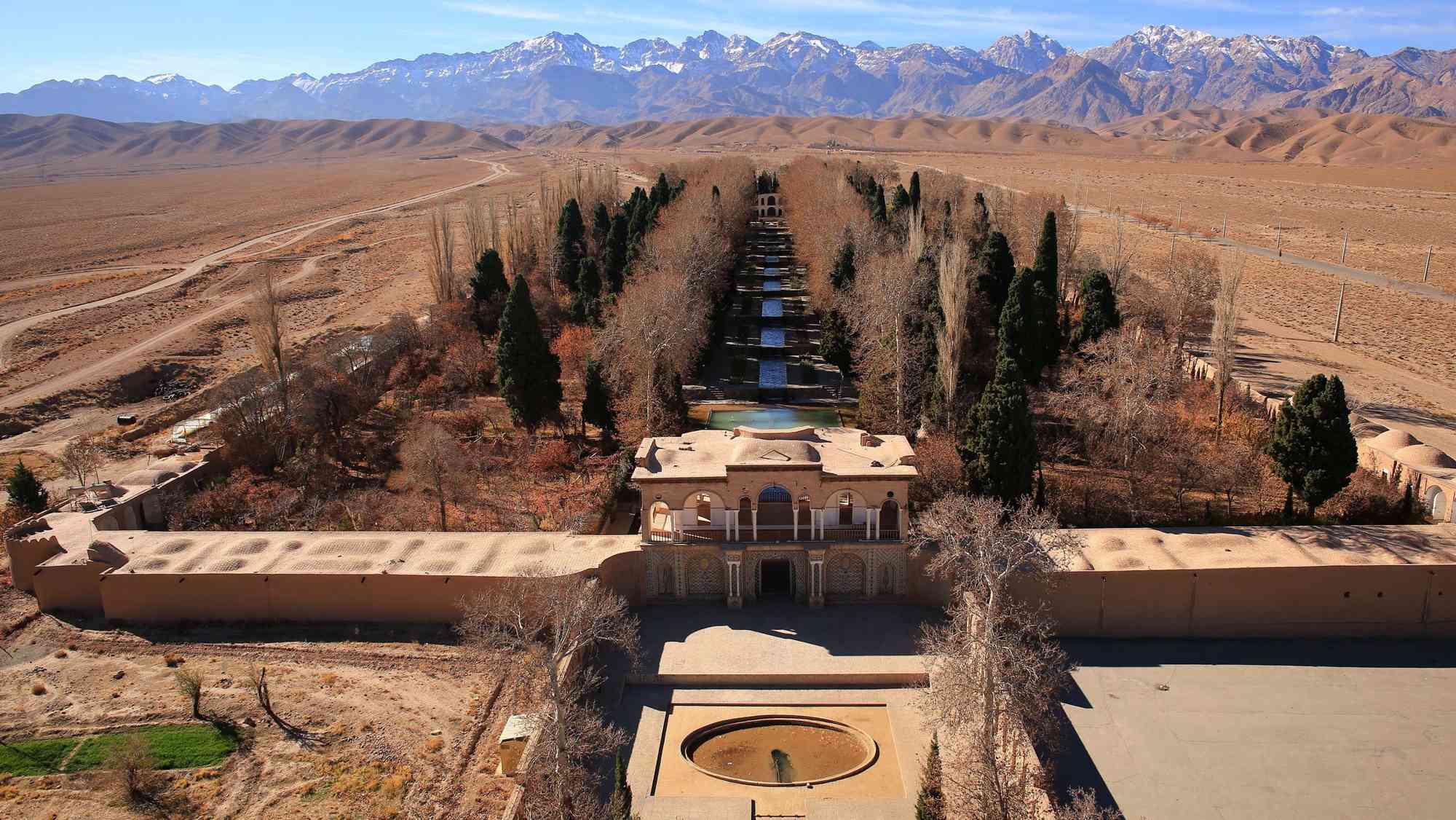
I
qanat variano molto in lunghezza secondo la profondità della falda e
l'inclinazione del terreno: in alcuni la canalizzazione dal pozzo
principale allo sbocco dell'acqua è lunga dai 2 ai 4 chilometri, ma in un
qanat dell'Iran del sud è invece lungo più di 32 chilometri. Normalmente
la lunghezza varia da 10 a 18 chilometri. Anche la quantità d'acqua
ottenibile dai singoli qanat è molto variabile. Per esempio, di circa 200
qanat esistenti nella pianura di Varamin a sud-est di Teheran il più
grande emette oltre 300 litri al secondo e il più piccolo solo un litro.
Finché
il qanat non è stato completato e non è in azione non è possibile per
un certo periodo di tempo stabilire se esso sarà una fonte continua
oppure una fonte stagionale che fornisce l'acqua solo in primavera o dopo
abbondanti piogge. Poiché l'investimento iniziale nella costruzione di un
qanat è considerevole, il proprietario e i costruttori ricorrono spesso
al sondaggio e ad apparecchiature complicate per aumentare la sua resa.
Per esempio, possono ricorrere a diramazioni della canalizzazione
principale per raggiungere altre falde acquifere oppure scavare il suolo
della canalizzazione esistente per abbassarla e attingere l'acqua a un
livello più profondo. Una grande cura viene anche dedicata alla
manutenzione del qanat. La buca dei pozzi di ventilazione è difesa con
muri simili a crateri costruiti con il materiale di scavo e alle volte con
un coperchio per impedire eventuali danni provocati dall'afflusso d'acqua
durante i temporali. E' necessario togliere la melma trasportata nei
cunicoli dalla falda, pulire la volta della cavità ed eseguire continue
riparazioni.
Com'è
naturale in un sistema che esiste da migliaia di anni e così importante
per in vita del paese, la costruzione dei qanat e la distribuzione
dell'acqua sono regolati sia da leggi e sia dal senso comune consacrato
dalla tradizione. I costruttori dì un qanut devono ottenere il consenso
dei proprietari del terreno che attraverserà, ma l'autorizzazione non può
essere rifiutata arbitrariamente; deve essere concessa se il nuovo qanat
non interferisce con il rendimento di altri qanat esistenti, il che di
solito significa che la distanza fra due sistemi qanat deve essere di
parecchie centinaia di metri, secondo le formazioni geologiche
interessate. Quando le due parti non raggiungono un accordo, la questione
viene decisa dalla magistratura che normalmente nomina un esperio
indipendente per risolvere i problemi tecnici in contestazione.
Vi
sono pure sistemi tradizionali per l'equa distribuzione dell'acqua di un
qanst agli utenti. Se il qanal appartiene a un proprietario terriero che
ha dei fittavoli questi di solito nomina un intendente dell'acqua che
sovraintenda alla distribuzione dell'acqua ai singoli fittavoli secondo la
vastità della fattoria e la natura dei prodotti che vi crescono. Quando
gli stessi contadini sono i proprietari del
qanat, il che accade sempre più spesso con la nuova riforma
fondiari dell'Iran, eleggono un sovraintendente dell'acqua con l'incarico
di vegliare che ogni contadino riceva la sua giusta parte di acqua e al
tempo giusto: il sovraintendente ne riceverà una parte a ricompensa dei
suoi servizi. Il sovraintendente si regola secondo un sistema di
distribuzione che è rimasto fisso da centinaia di anni. Per esempio, tre
borghi nella regione di Sehdeh nell'Iran occidentale ricevono ancora le
stesse porzioni che furono loro attribuite nel XVII secolo durante il
regno di Shab Abbas il Grande. I borghi di Dastgerd e Parvar hanno diritto
a 8 parti ciascuno e Karton a 9 e le assegnazioni vengono fatte agli
sbocchi del bacino di distribuzione; gli sbocchi di Dastgerd e di Parvar
sono larghi 8 spanne, 9 quello di Karton.
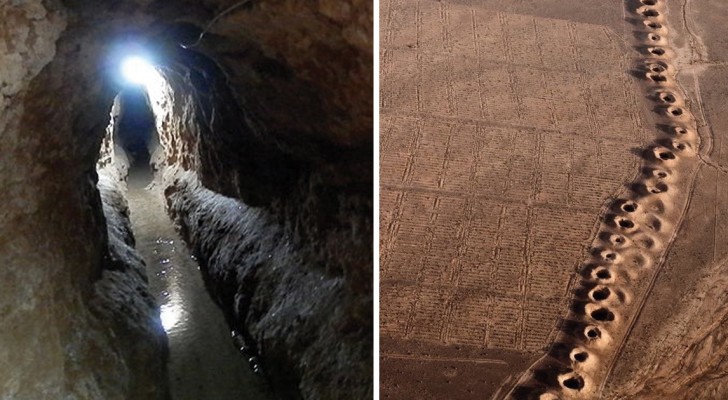
La
produzione agricola resa possibile dai qanat ripaga ampiamente gli
investimeni fatti nella loro costruzione e nella loro manutenzione. Una
recente inchiesta ha dimostrato che il profitto di questi investimenti in
valore di prodotti agricoli e di vendita di acqua si aggira dal 10 al 25%.
La costruzione di un qanat lungo circa 10 km costa dagli 8 ai 20 milioni
di lire secondo la natura del terreno: per un qanat lungo da 18 a 27 km il
costo si aggira sui 54 milioni.
Il
costo di costruzione è aumentato negli anni recenti in quanto anche il
costo della mano d'opera è aumentato. Inoltre, la divisione di grandi
latifondi in piccole proprietà con la nuova politica di distribuzione
fondiaria, come pure l'uso di macchinario agricolo moderno, hanno reso
difficile ai singoli proprietari terrieri di poter sostenere la spesa per
nuove costruzioni di qanat o per la manutenzione di quelli esistenti.
Molti agricoltori ora forano pozzi e usano motopompe per portare l'acqua
alla superficie. Conseguentemente, la costruzione di nuovi qanat cesserà
a meno che le cooperative di contadini dì nuova formazione non la trovino
vantaggiosa e possano reperire i capitali necessari per realizzarla.
Qualunque
sia il futuro del sistema iraniano dei qanat, esso rimane oggi un esempio
impressionante delle fatiche di un popolo che lavora sodo. I 22.000 qanat
dell'Iran con i loro 300.000 chilometri di canalizzazioni sotterranee
tutte costruite con il lavoro manuale, distribuiscono ben 585 metri cubi
d'acqua al secondo - una quantità equivalente al 75 per cento della
portata del fiume Eufrate nella pianura della Mesopotamia. Questo volume
d'acqua sarebbe sufficiente a irrigare oltre un milione di ettari di terra
arida se fosse usato interamente per l'agricoltura. Si è fatto un
giardino di ciò che altrimenti sarebbe diventato un deserto inabitabile.
Si dice che nei tempi antichi il paese avesse una vegetazione fiorente che
gradualmente andò inaridendo a causa de! disboscamento e della perdita
del terreno fertile per le erosioni. Il popolo persiano ha risposto al
disastro potenziale con una soluzione ingegnosa e lungimirante che
rappresenta un tributo classico alle risorse umane.
|