Xanthos fu
una città dell'antica Licia, luogo dell'attuale Kınık, nella
provincia turca di Antalya, e del fiume sul quale la città è stata
costruita. Nelle antiche fonti il termine "Xanthos" viene
usato come sinonimo di "Licia".
Xanthos
viene citata da numerosi scrittori greci e romani. Strabone afferma che
sia la più grande città Licia. Sia Erodoto che Appiano ne descrivono
la conquista fatta da Harpagus per conto dei persiani
approssimativamente nel 540 a.C. Secondo gli scritti di Erodoto, i
persiani sconfissero un esiguo esercito licio nelle pianure a nord della
città. Dopo lo scontro, i liciani si ritirarono all'interno della città
che venne assediata. I liciani distrussero la propria acropoli, uccisero
le proprie mogli, i figli, e gli schiavi, dopodiché iniziarono un
attacco suicida contro le truppe persiane. Morì l'intera popolazione ad
eccezione di 80 famiglie che non si trovavano in città durante la
battaglia.
Durante
l'occupazione persiana, venne insediato un capo locale a Xanthos, e nel
520 a.C. era già in uso il conio delle monete. Dopo il 516 a.C. Xanthos
venne inclusa tra i primi nomos nella lista tributaria di Dario I di
Persia. Le fortune di Xanthos furono legate a quelle della Licia, anche
quando questa cambiò alleanza durante la guerra greco-persiana. Gli
scavi archeologici ne dimostrano la distruzione attorno al 475 a.C. -
470 a.C., o per mano dell'ateniese Cimone o dei persiani, questo punto
è ancora dibattuto. Dal momento che non esistono racconti della sua
distruzione, né negli scritti greci né in quelli persiani, alcune
correnti di pensiero ne legano la fine a cause naturali o accidentali.
Nella seconda metà del quinto
secolo a.C., Xanthos conquistò la vicina Telmessos incorporandola nella
Licia.
I resoconti sulla resa della città ad Alessandro Magno sono discordi:
quelli di Arriano parlando di una cosa pacifica, ma subito dopo accenna
ad un saccheggio. Dopo la morte di Alessandro la città passò sotto il
controllo degli eredi; Diodoro Siculo ne narra la cattura da parte di
Tolomeo I di Antigone. Appiano, Cassio Dione e Plutarco dicono che venne
distrutta durante le guerre civili romane attorno al 42 a.C., da Bruto,
ma Appiano parla anche di una ricostruzione effettuata da Marco Antonio.
I resti di un anfiteatro romano sono ancora visibili. I racconti di
Marino dicono che Xanthos ospitava anche una scuola di grammatica.
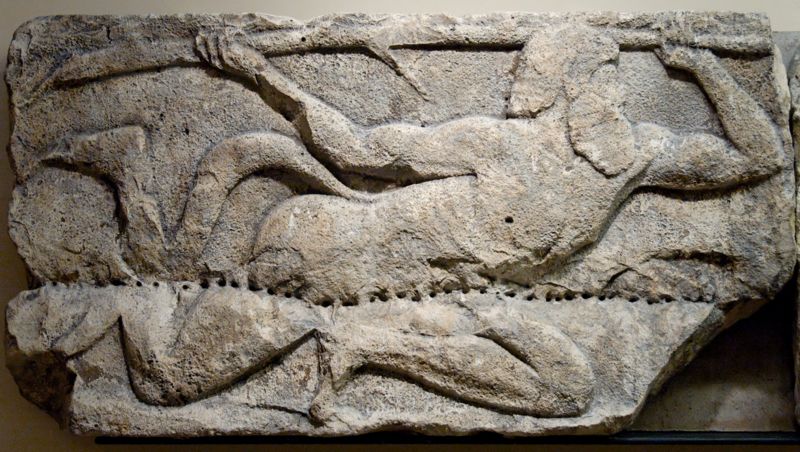
Il sito di
Xanthos fu riscoperto il 20 aprile 1838 dall'inglese Ch. Fellows che vi
ritornò tre volte (aprile 1840; dicembre 1841 - febbraio 1842; ottobre
1843-marzo 1844). I due ultimi viaggi furono vere spedizioni che
fruttarono al British Museum una collezione di documenti di
incomparabile ricchezza.
Le spedizioni
austriache dirette da O. Benndorf raccolsero le iscrizioni, permettendo
così, lo studio dei monumenti di Xanthos e in particolare del Monumento
delle Nereidi.
Una missione
archeologica francese diretta da P. Demargne, P. Devambez e H. Metzger
ha eseguito scavi a Xanthos dal 1950 al 1962. Essa si è dedicata
all'acropoli bassa, detta licia, ai monumenti funerarî, compreso il
Monumento delle Nereidi, così come al teatro romano e alle basiliche
bizantine comprese nei limiti di questi scavi. I principali ritrovamenti
sono stati trasportati ai musei di Antalya e di Istanbul; altro
materiale è riunito in un magazzino a Xanthos stessa.
L'acropoli licia
in forma di pianoro (altezza massima m 85), è difesa da una cinta di
mura del V sec. a.C. e domina direttamente il fiume; immediatamente a
Nord, dal basso in alto, una piccola spianata ha accolto i monumenti
funerarî di epoca arcaica e classica. Altri sono stati disposti sul
pendio di una collina più elevata che diventerà l'acropoli ellenistica
e romana. Il Monumento delle Nereidi occupa una terrazza vicina
all'acropoli licia, dalla quale un precipizio la separa.
La città si
estese in maniera eccezionale probabilmente nel III sec. a.C.; la nuova
cinta di mura inglobò un'acropoli alta (altezza m 148) e una serie di
terrazze inclinate ai piedi di questa, da nord a sud. Questa cinta di
cui alcune sezioni appartengono ancora alla costruzione ellenistica, non
cessò di essere rimaneggiata fino alla piena epoca bizantina. Sembra
che infine (forse dopo l'attacco arabo), la città bizantina si sia
raccolta sull'acropoli primitiva, il cui muro nord a speroni, senza
dubbio non è anteriore all'XI sec. della nostra era.
Necropoli di età
diverse, principalmente romane, si distribuiscono a nord della località
in una specie di "valle delle tombe" e sulle colline
circostanti.
Il problema più
importante che i monumenti di Xanthos propongono è quello della
influenza ellenica che agisce e si innesta su di una tradizione indigena
imparentata alle civiltà orientali.

Arcaismo - Nessun
documento dell'Età del Bronzo né della prima Età del Ferro è stato
messo in luce. Il livello più antico dell'acropoli licia, nella sua
parte sud-est, è rappresentato da un primo palazzo che dimostra una
parentela forse con gli edifici neohittiti della Siria del nord
(Zincirli); questo livello ha dato ceramiche locali a motivi geometrici
semplici "nero su rosso" e materiale di importazione greca,
risalente alla fine dell'VIII sec. I ritrovamenti più antichi si
collegano a quelli di al Mina, Tarso, Lindos e suggeriscono l'ipotesi
che queste prime influenze greche siano giunte attraverso i Rodî. Oltre
il palazzo dovette esistere un luogo di culto in questo periodo nella
parte centrale dell'acropoli.
La conquista
persiana e l'incendio della città verso il 545-540, apre una nuova
epoca che si conclude con un altro incendio verso il 470, in relazione,
forse, con la spedizione ateniese di Cimone.
Sull'acropoli,
forse proprio da allora circondata da una fortificazione, si trovano un
secondo palazzo ed un tempio a tre celle (paragonabile ad alcuni esempî
ciprioti e palestinesi). La ceramica attica a figure nere vi abbonda; vi
si trovano insieme ceramica di Fikellura e numerose figurine ioniche; è
stata rinvenuta anche una testa di koùros di tipo milesio. È
proprio in questo periodo che, a una certa distanza, viene innalzato il
primo pilastro funerario, quello detto "del leone" (verso il
540), tipo "barbarico" di cui noi ignoriamo ancora l'origine;
l'influenza greca è evidente nella decorazione delle lastre di pietra
che chiudono la camera funeraria sopra il pilastro monolitico,
nonostante i temi iconografici siano dinastici e orientali: leone che
atterra un toro; leonessa e i figli; combattimento di un uomo col leone;
personaggio seduto (il dinasta?) in una scena scomparsa; scena guerresca
parzialmente conservata.
Ai piedi
dell'acropoli altri pilastri si eleveranno in seguito: di uno (verso il
525) non rimane che una lastra isolata, reimpiegata in una sepoltura
posteriore, con lottatori, suonatore di lyra finemente cesellato,
suonatore di flauto. Questa rappresentazione è analoga a quella che
decora una delle facce del pilastro di Isinda-Belenkli: essa è dovuta
senza dubbio a Greci di Rodi; le forme sono abilmente alternate, a volte
di una eleganza raffinata, a volte di una solidità massiccia, secondo
la tradizione orientale.
Una generazione
più tardi (tra il 500 e il 470) il Monumento detto delle Arpie è uno
dei pilastri funerari più caratteristici, ma anche il più tozzo: su di
una base massiccia il pilastro monolitico è alto m 5,43; la camera
funeraria è chiusa da lastre di marmo (alte m 1,02); la
lastra-coperchio è di m 0,44, un blocco di coronamento di m 0,53. La
decorazione delle lastre di marmo deve essere attribuita a dei Milesî
che la trattano con una pesantezza ereditata dal VI sec. e dai
Branchidi, ma addolcendo le forme con i piacevoli e sovrabbondanti
particolari delle vesti: si ha in questo monumento senza dubbio una
testimonianza dello stile milesio del primo venticinquennio del V
secolo. I membri della famiglia dinastica siedono sulle quattro facce.
Vengono fatte diverse offerte; su due facce alcune Sirene (e non Arpie)
guidano le anime. L'iconografia dinastica si arricchisce della
iconografia greca relativa all'Aldilà.

L'epoca
classica - Quella tra il 470 e il 330 circa è una grande
epoca per l'arte di Xanthos. Vi si pone il problema dell'accoglienza
fatta alle forme successive dell'arte classica greca. Sull'acropoli, la
cui cinta risale in parte al V sec. a.C., furono fatti grandi lavori che
le diedero l'aspetto che essa conservò senza dubbio fino alla fine
dell'antichità; un secondo tempio viene costruito sulla sommità
dell'acropoli, più in alto del tempio a tre celle. Il palazzo di questa
epoca è scomparso ma si sono potuti ricostruire tre monumenti funerarî
o Heròa concepiti nella pura tradizione licia della
costruzione in legno trasferita in pietra. P. Coupel e H. Metzger hanno
restaurato due edifici col tetto a doppio spiovente e un terzo col tetto
a terrazza. Vi sono stati ricollocati gli elementi dei frontoni e dei
fregi portati a Londra da Fellows: sono documenti che appartengono tutti
senza dubbio all'epoca dello stile severo (470-450). Ma vi si uniscono
tendenze diverse le quali, altrove che non in queste zone periferiche,
implicherebbero uno scaglionamento cronologico ben più prolungato. Così
alcuni rilievi secondarî, forse appartenenti alla base di questo
monumento (fregi di galli e uccelli, di satiri, centauri, ecc.) hanno
ancora molto della tradizione arcaica del VI sec.: uno dei frontoni
evoca lo stile milesio delle Arpie, l'altro con le sue sfingi eleganti
appartiene ad uno stile subarcaico che sembra essere stato molto
apprezzato in Licia ed essere durato fino alla metà del secolo: si
constaterà un fenomeno analogo nell'ellenizzazione occidentale. È a
questo stesso stile che si potrà riportare un rilievo con due
personaggi, appartenente ad una scena di banchetto funerario, come anche
la processione del dinasta in carro. I temi più particolarmente
dinastici trovano in questo caso il mezzo espressivo che gli è
familiare. Di questa processione fanno parte tuttavia personaggi
drappeggiati che portano la lancia, che imitano molto maldestramente lo
stile proprio della Grecia; ancora più chiaramente le peplophòroi che
apparterrebbero anch'esse ad uno di questi Heròa, sono
trasposizioni ioniche di modelli peloponnesiaci o attici. Con lo stesso
spirito è trattato un bellissimo rilievo inedito, reimpiegato nel
teatro, con una rappresentazione di Nike.
Due monumenti
funerarî importanti vanno inquadrati in questo periodo. Il primo
databile probabilmente tra il 450 e il 400 è il più antico dei
sarcofagi lici a decorazione figurata. Si è per lungo tempo fatto
risalire all'arcaismo il motivo tradizionale dei leoni che assalgono un
toro, che decora il basamento. Ma i resti molto poveri che permettono
ora di ricostruire il coperchio, ci obbligano a modificare questo punto
di vista: sulle ogive dei lati brevi le sfingi guardiane sono proprio
nella tradizione subarcaica di quelle dell'acropoli; sui lati lunghi una
caccia al cinghiale (molto parzialmente conservata), un banchetto
funerario, accolgono le influenze del nuovo classicismo attico. I
personaggi che stanno a capo del letto o sfilano dinnanzi ad esso
potrebbero derivare il loro archetipo da vasi o stele. Il dinasta seduto
sul letto è trattato in scala più grande e quasi di faccia. Questi
sono i procedimenti escogitati dall'arte greca per esprimere la maestà
del personaggio orientale.
Il pilastro
iscritto, uno dei monumenti più considerevoli di Xanthos ci è
particolarmente prezioso perché ben datato (430-410). Il tipo
tradizionale del pilastro rimane, ma più slanciato nelle sue
proporzioni (altezza del pilastro e del fregio m 5,58 con una larghezza,
alla base, di m 1,71 per 1,50). Il fregio che illustra queste vittorie
si trova agli angoli su degli avancorpi di tori inginocchiati, alla
maniera dei capitelli achemènidi: il dinasta, forse il Kherei delle
monete, percorre da vincitore il campo di battaglia, abbattendo i suoi
nemici, uno dopo l'altro. Gli scudi che egli ha loro preso, formano un
fregio al di sopra della scena, mentre alla sommità del pilastro egli
era seduto su un trono con leoni, secondo l'iconografia della maestà
(la statua è scomparsa, le tracce dei piedi restano sullo zoccolo). Si
ritrova qui l'iconografia indigena e orientale della vittoria, che
ricorre a certi procedimenti arcaici (la sfilata di guerrieri uno dietro
l'altro) ma conosce anche la distribuzione dei combattimenti secondo lo
schema delle gigantomachie e amazzonomachie dell' epoca di Fidia.

Il Monumento
delle Nereidi non è di molto posteriore (verso il
410-400): gli scavi fatti dopo il 1950, permettono di ricostruirne
esattamente l'architettura: esso è un vero documento della completa
ellenizzazione. Sullo zoccolo tradizionale dei pilastri (tre assise di
marmo al di sopra di una base in calcare) sorge per la prima volta una
architettura ionica, quella di un piccolo tempio periptero con quattro
colonne per sei, coronato da un frontone. I muri della cella hanno
potuto essere ricostruiti, così come le ante. Della porta E sono stati
trovati tutti gli elementi: soglia, piedritti, fregio a tre serie di
ovoli, cornice; le proporzioni di questa porta, la pesantezza del suo
coronamento, sono in una tradizione ionico-arcaica. La cella accoglieva
quattro letti funebri in calcare di cui si sono trovati resti: ne appare
ancora la traccia sugli ortostati dei muri. Nelle colonne del
peristilio, ioniche a base asiatica, si aggiunge ai capitelli un toro
decorato con una treccia, ad imitazione dell'Eretteo: semplice
particolare attico in un monumento di carattere asiatico. È stato
ritrovato anche un capitello d'angolo, il primo che noi conosciamo a
quattro volute.
Se
l'architettura greca fa la sua apparizione a Xanthos nel Monumento delle
Nereidi, la decorazione era da molto tempo ellenizzata. Tuttavia essa si
dispiega qui con una ricchezza sovrabbondante. Fra l'assise di marmo
semplice della base e la cornice a due serie di ovoli, si trovano due
fregi dello zoccolo sovrapposti, tutti e due illustranti le vittorie del
dinasta: l'uno, il più alto (m 1,1) è posto sul secondo (m 0,63). Il
primo trasforma le battaglie in combattimenti mitologici alla maniera
greca delle amazzonomachie (anche se qui i combattenti dei due campi
sono uomini); vi si distinguerebbe volentieri la mano di uno scultore
greco della Ionia che conosceva i modelli attici ma gli dava proporzioni
più pesanti, e quella di un imitatore indigeno. Il secondo fregio
celebra gli stessi vincitori, con la stessa arte ma con tutt'altro
spirito, quello del realismo indigeno e dinastico: il dinasta seduto
sotto il suo parasole accoglie gli inviati nemici. Lo scultore ricorre a
procedimenti artistici tutti diversi: sfilate di persone una dietro
l'altra, rappresentazione dei muri della città assediata con i suoi
difensori sugli spalti, rappresentazione che sarebbe straordinaria nella
Grecia propriamente detta, ma che è familiare ai Lici e sembra
risalire, attraverso tappe che noi ignoriamo, all'eredità della
tradizione narrativa orientale, quella assira per esempio.
Gli altri due
fregi, l'uno sull'architrave, l'altro sul muro della cella, hanno
rilievi assai schematici. Sono consacrati a temi indigeni e orientali e
usano volentieri l'artificio della ripetizione, per esempio per la
sfilata dei servitori. Il fregio dell'architrave ha per tema principale
la caccia e la consegna di offerte; l'altro il sacrificio e i banchetti
funerarî.
I frontoni, come
ci si poteva aspettare, sono riservati ancora a due scene di
glorificazione del sovrano: una scena di battaglia, in cui egli doveva
figurare a cavallo, e un'altra in cui egli siede al fianco della moglie,
fra i dignitari della corte: quest'ultima scena è trattata con una
pesantezza ed una mancanza di eleganza che stupisce in questa età; vi
si sente l'influenza delle statue in maestà che coronavano i pilastri;
notiamo una volta di più che le rappresentazioni più legate alle
tradizioni indigene ritrovano naturalmente i procedimenti dell'arcaismo.

Al simbolismo
greco dell'Oltretomba appartengono al contrario le famose Nereidi degli
intercolumnî e le figure degli acroterî principali (due scene di
rapimento). Le Nereidi sono tra le più belle figure che ci siano
pervenute di un'arte classica ionica ispirata all'arte attica.
Il passaggio dal
V al IV sec. a.C. ha una grande importanza, come in ogni altra zona
periferica. Il fenomeno di ellenizzazione prosegue e si accentua ed
anche si stabilizza. Certe incoerenze scompaiono e nasce un nuovo stile
che sembra essere stato particolarmente brillante a Xanthos nella prima
metà del IV secolo. Una necropoli di quest'epoca, sul pendio sud-est
dell'acropoli alta, riunisce un certo numero di innovazioni originali.
Un pilastro funerario, l'ultimo (con un altro che si rizza sopra il
teatro), ha singolarmente ellenizzato la sua forma e le sue proporzioni;
non si erige più su di uno zoccolo massiccio, ma su tre gradini alla
moda greca. La lastra coperchio è divenuta molto più modesta, il
fregio è di marmo, ma non decorato. Nelle vicinanze si allineano alcune
facciate di tombe rupestri trattate secondo la moda tradizionale, mentre
proprio accanto, una di esse è trattata per la prima volta alla greca,
con un piccolo portico e due colonne tra le ante, con una porta centrale
circondata di modanature.
Non lontano il sarcofago
di Payava è un chiaro documento dell'arte nuova: fedele
alla tradizione licia del sarcofago di pietra imitante quello in legno,
si sviluppa in altezza con una eleganza maestosa (una tomba inferiore,
uno zoccolo massiccio, il sarcofago propriamente detto col suo
coperchio); le zone decorate, come nel Monumento delle Nereidi,
manifestano una esuberante ricchezza, i temi dinastici tradizionali sono
conservati, ma trattati con gusto straordinario dell'effetto: si
paragoni alle scene schematiche del pilastro iscritto e anche alle scene
tradizionali del Monumento delle Nereidi, la vivace battaglia
raffigurata sullo zoccolo intermedio: si tratta di Payava senza dubbio,
che sta a cavallo trionfando dei suoi nemici nascosti tra le rocce; il
suo corpo di guardia di cavalieri lo segue, giungendo dal fondo, con un
senso molto nuovo della profondità; l'altra grande scena dello zoccolo
è una udienza del satrapo che accoglie personaggi vestiti alla greca,
mentre lui stesso e i suoi due ufficiali sono vestiti alla persiana,
rappresentati con una straordinaria fedeltà nel costume e negli
atteggiamenti.
Le monete dello
stesso periodo, il secondo venticinquennio del IV sec. circa, in
particolare i magnifici esemplari col nome di Mithrapata e di Pericle,
ci offrono effetti analoghi; è nato uno stile greco d'Asia che usa
tutte le risorse della seconda età classica per illustrare la vita di
queste corti dinastiche. Sul coperchio del sarcofago di Payava appaiono
delle immagini simboliche (la quadriga che porta il dinasta nell'Aldilà),
ma anche scene di vita reale. Gli antichi animali guardiani perdono la
loro importanza: le sfingi non occupano più che una piccola parte
dell'ogiva; i leoni si riducono alle protomi sporgenti del coperchio.
Insieme a quello di Merehi, trattato con lo stesso spirito, il sarcofago
di Payava è il solo a rappresentare a Xanthos questa grandissima epoca
della scultura licia testimoniata dai monumenti funerarî di altre città.
È molto
sorprendente che questo impulso creativo duri poco; l'ultimo sarcofago
di epoca classica di Xanthos, quello detto delle danzatrici, databile
all'epoca di Alessandro con ogni probabilità, ritorna a scene molto più
schematiche e alla tradizionale iconografia indigena; quella della
caccia e della guerra (si ritrova nella scena di guerra, il vincitore
fuori dell'azione, che tocca, secondo il vecchio gesto magico, lo scudo
preso al vinto, mentre i suoi nemici fuggono sui loro cavalli). Il
simbolismo alla greca e la testimonianza di un'arte più colta non
appaiono che nelle figure delicate delle danzatrici col kàlathos,
raffigurate nelle ogive, al posto delle sfingi guardiane.

L'età
ellenistico-romana; la prima età bizantina - Si sa che la
città di Xanthos si ingrandì singolarmente nel III sec. a.C.,
all'epoca dei Lagidi, che fu per Xanthos un'epoca di prosperità. Alcuni
settori delle mura della città si sono conservati nel loro aspetto
ellenistico, in particolare in vicinanza della porta sud (la quale
presenta una iscrizione di Antioco il Grande con la dedica della città
alla triade apollinea). La città ellenistica non è stata ancora
sistematicamente esplorata: vi si indovina una urbanistica nuova nella
zona delle terrazze sovrapposte, dietro il Monumento delle Nereidi. Solo
alcune zone sono conosciute: un cimitero ellenistico fu accertato ai
piedi del Monumento delle Arpie ed ha fornito qualche oggetto di arte
alessandrina: una tazza di vetro, una oinochòe di faïence
col ritratto della regina Berenice. L'epoca romana che si prolunga
senza interruzione nella prima età bizantina, ha lasciato tracce
profonde a Xanthos la cui importanza continuò, senza però riuscire ad
eclissare quella delle città della costa come Platea e Myra. I soli
monumenti scavati finora sono il teatro romano, posto sul pendio nord
dell'antica acropoli; una grande agorà è stata riconosciuta nelle
vicinanze del teatro e fu senza dubbio uno dei centri della vita
pubblica in età romana: una iscrizione datata all'età di Domiziano,
ricorda nelle vicinanze un bouleutèrion. L'acropoli nuova
doveva essere coronata da un grande tempio di cui molti blocchi sono
ancora visibili.
Nel III e IV
sec. della nostra èra devono essere sorte ancora grandi costruzioni
nella città, a giudicare dal numero dei resti architettonici di questa
epoca; si aggiunga che le monete di questi stessi secoli sono molto
numerose. L'acropoli antica, di nuovo fortificata nella tarda antichità,
accolse numerosi monumenti nella prima età bizantina, principalmente
una residenza dell'epoca costantiniana, i cui mosaici pavimentali sono
tuttavia trattati in uno stile particolarmente barbaro (Meleagro e
Atalanta; Teti e Achille allo Stige; medaglioni di Eirene ed Eupripeia).
Le basiliche
cristiane si moltiplicarono a Xanthos. Una è stata esplorata
sull'acropoli antica, un'altra nella parte sud-ovest della grande agorà
romana; una terza di grandi dimensioni è stata solo riconosciuta nella
parte E della città. Un grande monastero sostituì il tempio romano
sull'acropoli alta, in data senza dubbio assai tarda. Nelle mura della
città sono inglobati numerosi blocchi appartenenti a monumenti romani;
le mura dovettero essere difese fino agli attacchi arabi, dopo i quali
l'acropoli antica dovette ancora servire da recinto. Il suo muro N a
speroni non deve essere anteriore alla seconda età bizantina.
Dobbiamo
ricordare infine, fuori della cinta, numerosi complessi funerarî di
epoca romana: un mausoleo, già scavato da Ch. Fellows, nella pianura a
S della città; una serie di tombe a nord, facenti capo ad un heròon
su di una collina ad est Mausoleo ed heròon hanno fornito
sarcofagi attici e altri del II e III sec. della nostra era.