- Belvedere,
di nome e di fatto
Fra
i più
straordinari complessi
barocchi d'Europa, il
Belvedere di Vienna gode di un
fascino che nasce non solo
dalla grandiosità, ma
soprattutto dall'armonia
dell'insieme, con i due
palazzi, l'Oberes (Superiore)
e l'Unteres (Inferiore), che
si fronteggiano a livelli
diversi, uniti da un elegante
giardino, formato da terrazze,
parterres fioriti, cascate,
bacini e sculture. Diventato nel
1903 un museo, ora sede della
più
importante collezione d'arte
austriaca, il Belvedere, con i
suoi fastosi interni, rimane
indissolubilmente legato alla
figura del primo proprietario,
il Principe Eugenio di Savoia
(1663-1736), che lo volle come
residenza estiva.
Definito
"nobile cavaliere"
in una popolare canzone
dell'epoca, questo uomo
d'armi, filosofo, amante
dell'arte, nato a Parigi,
figlio di un Savoia-Carignano
e di Olimpia Mancini, nipote
del Cardinale Mazarino (e,
pare, amante di Luigi XIV), fu
una figura di eccezionale
rilievo anche per doti
politiche e diplomatiche. Il
Trionfo marmoreo di Balthasar
Permoser (realizzato nel
1718-21), esposto al Belvedere
Inferiore nella Goldenes
Zimmer (Camera dorata) - i cui
pannelli a grottesche di Jonas
Drentwett erano in origine nel
palazzo di città del principe
-, lo ritrae con l'armatura e
le insegne di cavaliere del
Toson d'Oro, conferendogli una
dimensione mitologica grazie
agli attributi di Èrcole e al
personaggio della Fama, che
gli sta accanto. Sotto i suoi
piedi, la figura di un vecchio
Turco ne simboleggia le
imprese militari.
Eugenio,
che Napoleone Bonaparte
collocava fra i sette più
grandi condottieri della
storia, respinto dall'esercito
francese, offre i suoi servigi
all'imperatore Leopoldo I
d'Austria. Il momento non può
essere più opportuno perché
Vienna, nel 1683, stava
subendo la minaccia
dell'esercito ottomano: la
vittoriosa battaglia di
Kahlenberg è l'inizio della
brillante carriera del
giovane Savoia, che lo porta
al vertice dell'esercito
imperiale.

Fra
le tappe fondamentali della
fulminea ascesa troviamo, nel
1697, il successo nella
battaglia di Zenta ancora
contro i Turchi, a cui segue
la pace di Carlowitz (1699),
che sancisce la fine
dell'espansionismo ottomano.
Comandante supremo, nel 1703,
delle truppe austriache in
Italia durante la guerra di
Successione Spagnola, tre anni
dopo Eugenio
aiuta il cugino
Vittorio Amedeo II di Savoia a
sconfiggere i Francesi nella
battaglia di Superga,
assicurando agli Asburgo
la Lombardia, di cui egli
diviene primo governatore
austriaco.
Il
principe partecipa ai
negoziati per la Pace di
Rastatt (1714), fra Luigi XIV
e Carlo VI d'Asburgo, e
diventa poi governatore dei
Paesi Bassi austriaci, fra le
cariche meglio remunerate
della monarchia; due anni dopo
consegue, a Petervaradino, la
grande vittoria contro i
Turchi, evocata nella
decorazione della Marmorsaal
nel Belvedere Inferiore; nel
1717 conquista Belgrado e,
l'anno successivo, costringe
Ottomani e Veneziani alla pace
di Passarowitz.
Ormai
anziano, Eugenio di Savoia si
occupa del riordinamento
amministrativo e militare
negli ex territori turchi,
prima di morire a Vienna nel
1736, nella sua sontuosa
residenza di città, sulla
Hillelpfortgasse, oggi sede
del Ministero delle Finanze.
Voltaire, nel lodare il
condottiero "che scosse
la grandezza di Luigi XIV e
della potenza ottomana",
lo descriveva come sdegnoso
"delle tentazioni sia del
fasto sia della
ricchezza", ma in realtà
questo personaggio - detto
anche l'"abatino",
perché spesso indossava una
semplice tunica scura
(nei ritratti ufficiali
compare, però,
in sfarzosa uniforme) - amava
circondarsi di oggetti d'arte
e, vista la sua posizione,
aveva bisogno di adeguate
residenze in tutto l'impero.
 Costruire
e arredare palazzi era anche
una sorta d'investimento e
dava la possibilità di
ricevere ospiti di alto rango.
Così nel 1697 egli acquista
un terreno a sudest della città,
occupato da un ampio vigneto
che, essendo su vari livelli,
risultava ideale per un
palazzo nobiliare "fuori
porta". Costruire
e arredare palazzi era anche
una sorta d'investimento e
dava la possibilità di
ricevere ospiti di alto rango.
Così nel 1697 egli acquista
un terreno a sudest della città,
occupato da un ampio vigneto
che, essendo su vari livelli,
risultava ideale per un
palazzo nobiliare "fuori
porta".
Dall'alto,
si godeva una magnifica vista
su Vienna e sul Wienerwald
(Bosco Viennese), mentre a
valle l'accesso avveniva dal
Rennweg,
sin dall'epoca dei
Romani arteria principale
verso l'Ungheria.
A
progettare la residenza
estiva, chiamata Belvedere
solo nel 1752, quando
l'imperatrice Maria Teresa
l'acquistò
dall'unica erede di Eugenio,
la nipote Vittoria di Savoia,
il principe vuole il giovane,
ma già affermato Johann Lucas
von Hildebrandt (1668-1745). I
lavori di costruzione durano
oltre 25 anni: l'architetto
comincia dal terrazzamento del
giardino e, nel 1714, si
accinge alla costruzione del
Belvedere Inferiore.
L’insieme generale del palazzo,
molto lungo ma a un solo
piano, è alleggerito da alte
finestre incorniciate da
colonne, che contribuiscono a
dare slancio alla facciata. Un
ingresso centrale, aggettante
e su due piani, conferisce
rigore alla struttura.
Il tetto è diviso in tre
parti, cosa che enfatizza la
zona centrale mettendo in
risalto la balaustra adorna di
statue, che funge da elegante
collegamento tra le diverse
aree. La sobrietà
dell’esterno, in forte
contrasto con la magnificenza
dell’interno, prelude allo
stile del Belvedere Superiore.
I 500 metri di giardino che
separano il Belvedere
Inferiore da quello Alto
aumentano questa sensazione.
Il paesaggista francese
Dominique Girard,
l’architetto che realizzò
le vaste aree verdi di
Versailles, creò un parco
barocco con specchi d’acqua,
scalinate, cascate
artificiali, sculture di putti
e personaggi mitologici –
figure molto amate dal
principe, come si evince anche
dai fregi e dalle decorazioni
dei due edifici.
Sfortunatamente solo parte di
questo progetto è
sopravvissuto sino ad oggi.
Tuttavia, almeno la
prospettiva, creata dalla
salita attraverso il giardino
in direzione del Belvedere
Superiore, continua a
esercitare tutto il suo
fascino: la gradualità degli
scalini e delle cascate
sottolinea l’effetto
ascensionale e, alla sommità
dell’altura, il palazzo –
che si specchia nella piscina
di fronte – è il suggello
di tanta magnificenza. Da qui,
la vista sulla città è
straordinaria.

Intanto
il principe Eugenio aveva
deciso di costruire sulla
cresta della collina un altro
palazzo, più adatto al
cerimoniale di corte. I lavori
del Belvedere Superiore
iniziano nel 1721 e il nuovo
edificio si rivela ben più
grandioso del primo,
sottraendogli il ruolo
ufficiale di Residenza di
Stato e di cornice per i
ricevimenti.
L'abilità
di Hildebrandt di combinare
armoniosamente spazio e
proporzioni
appare nella magnifica
facciata dove, specularmente
al Belvedere Inferiore, il
padiglione centrale ha una
struttura articolata ed è
ornato di statue. Due altri
padiglioni e due ali più
basse lo collegano con le
torri d'angolo ottagonali. Dal
lato sud dove, in origine, era
posto l'accesso, il palazzo si
riflette nello stagno, secondo
il modello di Versailles: nel
grande specchio d'acqua del
cortile d'onore le passeggiate
in gondola creavano un'atmosfera
magica ed esotica durante le
sontuose feste del principe.
L’interno è ricco di affreschi a soggetto
mitologico. Carlo Carlone
dipinse le pareti e il
soffitto della Camera del
Giardino, al piano terra, con
scene della vicenda di Apollo
ed Aurora. Il Gabinetto
Dorato, nel padiglione a
nord-ovest, risplende di
bianco e oro ed è arricchito
da una statua equestre del
principe Eugenio, datata 1862
e opera di Antonio Dominik
Fernkorn.
A
proposito di ricevimenti, dopo
la scomparsa di Eugenio di
Savoia e la vendita dei
palazzi agli Asburgo, il
Belvedere sembra rivivere una
nuova, grande stagione nel
1770, grazie alla festa in
maschera con 16.000 invitati,
data in occasione delle nozze
per procura di Maria
Antonietta con il delfino di
Francia: il futuro Luigi XVI.

Le
sale del Belvedere Inferiore
ospitano attualmente il Museo
del Barocco Austriaco,
dove sono raccolte
significative opere del
Seicento e del Settecento, che
trovano il giusto risalto in
un ambiente ad esse
congeniale.
Di
particolare rilievo la Sala
dei Marmi (Marmorsaal),
con il pesante rivestimento in
marmo rosso scandito da
stucchi e affreschi
prospettici di Gaetano Fanti,
e sul cui soffitto Martino
Altomonte realizzò nel 1716
una delle tre Apoteosi del
Principe Eugenio presenti nel
Belvedere. Nell'affresco il
condottiero, vittorioso dopo
la battaglia di Petervaradino
(1714), è rappresentato nelle
vesti di Apollo che guida il
carro del Sole. In questa sala
sono stati sistemati gli
originali in piombo delle
statue che formavano la
Providentia-Brunnen (Fontana
della Provvidenza) in Neuer
Markt, realizzate da Georg
Raphael Donner nel 1737-1739.
Altro
ambiente di grande interesse
è la Camera da letto del
principe (attigua alla
Marmorsaal), che ha conservato
la tappezzeria originale, e
dove possiamo ammirare altre
due pregevoli opere in marmo
del Donner: un rilievo che
raffigura Agar nel deserto, il
grande gruppo dell'Apoteosi
dell'Imperatore Carlo VI,
nonché i rilievi in bronzo
con il Giudizio di Paride e
Venere nella fucina di
Vulcano.
Nella
Sala delle Grottesche,
così chiamata dai motivi
della decorazione a fresco
realizzata dal pittore Jonas
Drentwett, sono conservate
alcune delle famose Teste di
carattere di Franz Xavier
Messerschmidt (1736-1783). Lo
scultore ha qui magistralmente
realizzato esasperate indagini
fisiognomiche ispirandosi agli
studi e alle teorie dello
svizzero Johann Kaspar
Lavater, che mettevano in
relazione il carattere
dell'uomo con i tratti del suo
volto.
La
contigua Galleria dei Marmi
(Marmorgalerie), dove il rosso
materiale è stato usato come
tratto disegnativivo per
racchiudere e separare le
bianche zone degli stucchi e
le masse delle statue, ospita
altre due opere del
Messerschmidt: le figure in
piombo dell'imperatrice Maria
Teresa e del consorte
Francesco Stefano.

Da
ammirare infine il Salone
degli specchi, o Salone
dorato (per la preziosa
boiserie che ne riveste le
pareti, rimaneggiamento in
stile rococò effettuato sotto
Maria Teresa), dove è esposta
un'altra Apoteosi del Principe
Eugenio: quella realizzata in
marmo da Balthasar Permoser
fra il 1718 e il 1721,
considerata da tutti come il
culmine del barocco austriaco.
In questa scultura l'autore si
è raffigurato nel turco
soggiogato dal principe.
Anche
il Belvedere Superiore fu
sontuosamente decorato
all'interno: Gaetano Fanti,
Carlo Carlone, Martino
Altomonte e Giacomo del Po ne
affrescarono le pareti, mentre
Santino Bussi realizzò
ricercati stucchi purtroppo
modificati nel XIX secolo.
Bellissima è la cosiddetta Sala
Terrena adornata da
quattro potenti Atlanti che,
come pilastri, sorreggono la
volta. Questa soluzione
architettonica, che
Hildebrandt mutuò dallo
scalone del palazzo di città
del principe Eugenio, dove J.
B. Fischer von Erlach aveva
realizzato pilastri del tutto
simili, risale alla fine del
1732, quando si rese
necessario sostituire il
debole soffitto a tavole di
quercia che, marcito,
minacciava di crollare. È una
testimonianza indiretta della
relativa fretta con cui lo
Hildebrandt fu costretto a
lavorare.
Altro
ambiente di grande interesse
è la grande Sala dei Marmi
al primo piano - anch'essa
denominata Marmorsaal - sul
cui soffitto Carlo Carlone
affrescò l'ennesima Apoteosi
del Principe, il che ci
conferma che il primo compito
degli artisti del tempo era la
glorificazione del
committente, al di là di ogni
ragionevole limite.
 In
questa sala, il 15 maggio
1955, venne firmato l'"Ùsterreichische
Staatsvertrag" (Trattato
di Stato), che metteva fine
alla ormai decennale
occupazione dell'Austria da
parte degli alleati russi,
francesi, inglesi e americani. In
questa sala, il 15 maggio
1955, venne firmato l'"Ùsterreichische
Staatsvertrag" (Trattato
di Stato), che metteva fine
alla ormai decennale
occupazione dell'Austria da
parte degli alleati russi,
francesi, inglesi e americani.
Per
il giardino retrostante, su
cui prospetta la facciata
orientale, l'Hildebrandt studiò
una soluzione particolare
costruendo un'enorme vasca, in
modo che la prospettiva del
palazzo, da questo lato,
risultasse più bassa e
slanciata. Alla morte del
principe Eugenio, il Belvedere
fu ereditato da Vittoria di
Savoia, che vendette la
proprietà alla corte
asburgica. Nel 1777
l'imperatore Giuseppe II vi
fece collocare la quadreria
imperiale, che confluirà nel
1890 nel Kunsthistorisches
Museum. Vi abitò poi l'erede
al trono, l'arciduca Francesco
Ferdinando, che morirà
assassinato a Sarajevo.
Oggi
le belle sale del Belvedere
Superiore ospitano la Galleria
Austriaca del XIX e XX
secolo, che raccoglie esempi
di arte austriaca dalle prime
opere neoclassiche fino alle
espressioni artistiche dei
nostri giorni. L'esposizione
documenta la pittura del
periodo Biedermeier e della
Secessione austriaca.
L'epoca
Biedermeier è ottimamente
rappresentata da Ferdinand
Georg Waldmuller (1793-1865),
Jakob von Alt (1789-1872),
Rudolf von Alt (1812-1905),
Friedrich von Amerling
(1803-1887), Friedrich
Gauermann (1807-1862), Moritz
Michael Daffinger (1790-1849).
Si prosegue con un gruppo di
opere che documentano la
pittura "storica
idealizzante", il cui
massimo esponente, Hans Makart
(1840-1884), interpreta
perfettamente la tendenza al
fastoso e al monumentale
propria del ceto borghese in
ascesa al tempo della
Ringstrasse.
Contemporaneo
di Makart, ma completamente
avulso dallo stile ufficiale,
Anton Romako (1832-1889),
evidenziando con particolare
abilità i ritratti
psicologici dei suoi
personaggi, si fa precursore
del rinnovamento che verrà
introdotto dalla Secessione.
Degli artisti di questo
movimento la Galleria possiede
una ricca raccolta in cui
primeggiano le opere di Klimt
(1862-1918). La sezione
dedicata alla pittura
contemporanea vanta opere di
Egon Schiele (1890-1918), di
Oskar Kokoschka (1886-1980) e
di Herbert Boeckl (1894-1966).
Il
Bacio di Gustav Klimt è
per il Belvedere quello che la
Gioconda rappresenta per il
Louvre. Klimt ha dato il via
alla Secessione Viennese, un
movimento artistico che ruppe
con le rigide tradizioni
artistiche avendo una vasta
eco soprattutto nelle classi
borghesi. Erano i primi anni
del 1900 e Klimt dipinse opere
destinate ad entrare
nell'immaginario collettivo:
Il Bacio è una di queste.
L'abbandono dell'amante tra le
braccia dell'uomo, il suo
volto estasiato, il senso di
protezione e tenerezza che
trasmettono la figura e le
mani dell'uomo, conferiscono
al quadro un'atmosfera di
grande dolcezza e sensualità.
La bellezza di questo quadro
sta nella forza ipnotica dei
visi dei due amanti; né il
prato fiorito con la sua
vivace policromia, né le
sontuose vesti degli amanti,
riescono a catturare lo
sguardo come i due visi. Il
Bacio rappresenta una sorta di
eccezione nella visione
femminile di Klimt; la donna
del Bacio è abbandonata,
quasi succube, anche se con
voluttà, dell'uomo. La donna
di Klimt, invece, è quasi
sempre Femme Fatale
come in Giuditta I, esposto
poco distante dal Bacio.
Racchiusa in una cornice di
rame realizzata dal fratello
di Klimt, l'eroina biblica è
da sempre il segno del potere
seduttivo delle donne, in
grado di vincere, con i sensi,
anche la forza bruta di
Oloferne. Il volto
sensualissimo della Giuditta
di Klimt è quelle di Adele
Bloch-Bauer, esponente
dell'alta società viennese.
La testa di Oloferne è
secondaria, appena visibile
nell'angolo.
Anche
nell'antica Orangerie del
Belvedere è stato sistemato
un museo, il Museo d'Arte
Medioevale, che raccoglie
opere di pittura e scultura
soprattutto quattrocentesche.
Si possono ammirare, tra
l'altro, opere di Roland
Frueauf il Vecchio, di Michael
Pacher, del Maestro
dell'altare di Albrecht e
dell'altare della Creazione di
Vienna.

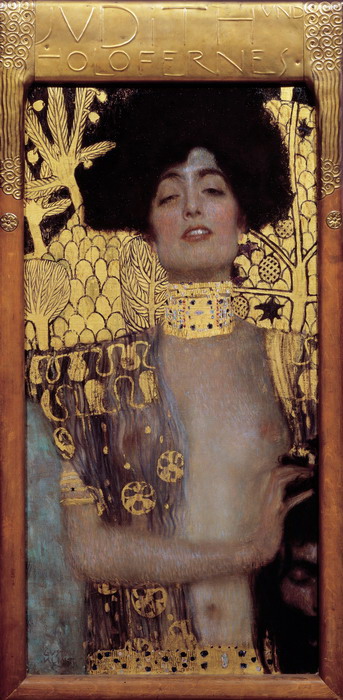
31
Maggio 2015
Pag.
5 
 Pag.
7
Pag.
7
|