|
Caposaldo
strategicamente importante per
l'accesso alla piana di Sofia,
Bojana viene citata per la
prima volta nel 1048, ma la
sua storia è anteriore: già
alla metà del X secolo era
stata infatti probabilmente
costruita la prima chiesa
del borgo, un piccolo edificio
di pianta quadrangolare
con abside semicircolare,
bracci trasversali ridotti e
inscritti in spessore di muro,
con cupola senza sostegni e
tamburo cilindrico su
pennacchi.
Le
facciate settentrionale e
meridionale sono scandite da
tre arcate cieche, aperte al
centro da finestre molto
strette; nell'abside si apriva
una trifora, oggi parzialmente
murata. L'edificio, forse
parzialmente distrutto insieme
alla fortezza dopo la rivolta
del 1040 contro l'occupazione
bizantina, fu ricostruito poco
prima del 1253 e coperto con
una nuova cupola; fu dedicato
ai santi Pantaleone e Nicola.
 Contemporaneamente,
sul lato occidentale venne
addossato un edificio a due
piani, il cui piano terreno è
costituito da un ambiente
rettangolare, coperto a volta,
con due arcosoli lungo le
pareti laterali, mentre quello
superiore ricorda
nell'impianto la chiesa più
antica. Contemporaneamente,
sul lato occidentale venne
addossato un edificio a due
piani, il cui piano terreno è
costituito da un ambiente
rettangolare, coperto a volta,
con due arcosoli lungo le
pareti laterali, mentre quello
superiore ricorda
nell'impianto la chiesa più
antica.
Al
piano superiore si accedeva
attraverso scale esterne,
rimosse durante l'ultima fase
di costruzione (1845-1882),
quando, sul lato occidentale,
venne addossato un ulteriore
edificio quadrato a due piani.
Il modello della chiesa
offerta dal sebastocratore
Kalojan - la scena è dipinta
nell'atrio al piano terreno -
documenta la struttura
originaria della cupola
(ricostruita nel XIX secolo),
del tetto e della facciata
occidentale, anch'essa
distrutta.
Con
grande senso artistico e amore
per il bello nel XVII secolo
gli affreschi vennero
interamente ricoperti (cosa
che in realtà ne ha
involontariamente aiutato la
conservazione). All'inizio
del XIX secolo la chiesa venne
nuovamente ampliata, con
l'aggiunta della parte che
adesso funge da ingresso, dopo
un altro secolo, agli albori
del XX, era completamente
decaduta: piccola, buia,
malridotta da aperture nel
soffitto, praticamente in
disuso.
Gli
abitanti del luogo non ne
erano affatto contenti, ed
ignorando completamente il suo
valore artistico decisero di
demolirla per costruirne
un'altra nuova e più bella
sullo stesso posto. Per puro
caso, e direi per la fortuna
degli attuali discendenti di
quei lungimiranti amanti
dell'arte e delle vecchie
chiese, venne a conoscenza
della storia la zarina Eleonora
di Reuss-Köstritz , che
convinse il marito Ferdinando
I di Bulgaria a bloccare
l'intento distruttore dei
villici concedendogli una
nuova chiesa nelle vicinanze.
Era il 1912, la zarina morì
cinque anni dopo, ed espresse
il desiderio di essere sepolta
nella piccola chiesa che aveva
salvato. Lo zar Ferdinando
fece allora piantare attorno
alla chiesa il bosco di
sequoie che le fa ombra
tutt'oggi.
La
zarina, oltre che protettrice
del patrimonio artistico, fu
una santa donna dedita ad
opere di carità, in
particolare formazione delle
infermiere e assistenza
ospedaliera durante le guerre
balcaniche del 1912-13 e la
prima guerra mondiale, e fu
tanto amata che per molti anni
continuarono i pellegrinaggi
alla sua tomba da parte di
infermiere e soldati. Dal 1944
arrivò il comunismo e cancellò
definitivamente la pia usanza.
Nel 1960 la tomba venne
addirittura profanata e le
pietre tombali intarsiate
vennero rimosse. Dopo il 1989
la tomba venne ripristinata,
ma ancor oggi è abbandonata e
nessuno ricorda più
l'intervento provvidenziale
della zarina Eleonora, né la
tanto loquace guida locale né
il sito internet ufficiale.
Sulla
chiesa ai primi lavori di
restauro del 1912 seguirono
quelli del 1934, poi ancora
nel 1944, e nel 1977-1979,
dopo i quali la chiesa entrò
nella lista dei siti Unesco
patrimonio dell'umanità.
Gli
scarsi frammenti degli
affreschi che decoravano la
prima fase costruttiva
dell'edificio non danno validi
elementi per una datazione
sicura. Tuttavia alcuni
arcaismi nello stile, nonché
l'iconografia e il programma
figurativo possono portare a
una datazione intorno alla metà
del X secolo e a un sicuro
accostamento alla tradizione
preiconoclasta dei Balcani
occidentali.
Un
secondo ciclo di pitture, la
cui datazione è accertata al
1259 da un'iscrizione che
ricorda il fondatore, decora
la chiesa più antica e
l'atrio; eseguito con la
tecnica del buon fresco, si è
in gran parte conservato. Il
ciclo delle Feste occupa la
parte alta delle pareti e
degli archi portanti al di
sotto della cupola, dove la
scena centrale con il
Pantocratore circondato da
angeli domina tutto l'interno;
nei pennacchi sono poste le
raffigurazioni degli
evangelisti, tra i quali sono
dipinte le due immagini
acheropite, il mandilio e il
kerámion, nonché le
raffigurazioni dell'Emanuele e
dell'Antico dei giorni.
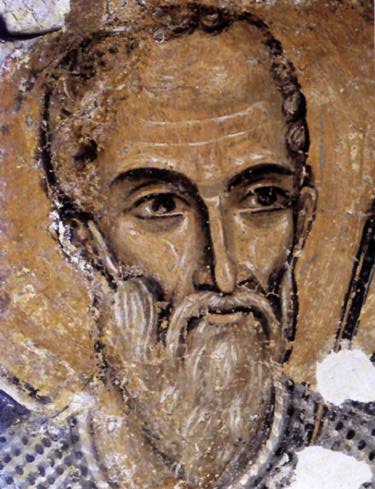

Nel
catino absidale è
rappresentata la Madonna in
trono tra gli arcangeli,
mentre al di sotto si trovano
le figure intere dei Padri
della Chiesa nell'atto di
celebrare.
Nella
parte bassa della chiesa sono
invece dipinte figure di santi
guerrieri e di martiri, simili
alle icone del Cristo Euerghétes
benedicente e di s. Nicola,
poste sui pilastri ai lati
dell'antica iconostasi.
Immagini di martiri ed eremiti
decorano anche l'atrio, dove
nei due arcosoli delle pareti
laterali sono raffigurate le
scene di Gesù tra i Dottori e
della Presentazione di Maria
al Tempio (XVI secolo). Ai
lati appaiono i ritratti dei
donatori, il sebastocratore
Kalojan, sua moglie Desislava
e la coppia regnante, lo zar
Costantino Asen (1257-1277) e
la zarina Irene; la parete
orientale del timpano reca
invece l'immagine della
Vergine Odighítria,
fiancheggiata da quelle di
Gioacchino e Anna. Le figure
del Cristo della Chalke e di
Cristo sacerdote nel Tempio
sono rappresentate ai lati
dell'arco, mentre nella fascia
superiore e sulla volta sono
distribuite diciotto scene
della Vita di s. Nicola.
Le
pitture del piano superiore,
conservatesi in modo molto
frammentario e non ancora
completamente portate alla
luce, sviluppano il tema della
morte e della risurrezione,
che trova espressione nella Déesis
(nel catino absidale),
nell'Anastasi e nel Concilio
degli arcangeli; completano
l'intero programma figurativo
l'Annunciazione sull'arco
trionfale e la Sepoltura del
patrono della chiesa
superiore, San Pantaleone,
nonché le raffigurazioni di
Padri della Chiesa, di
martiri, eremiti e di un
fondatore non identificato.
Così
come il programma
iconografico, anche i modelli
delle singole scene appaiono
fortemente legati alla
tradizione artistica della
Bulgaria occidentale, spesso
caratterizzata da elementi
arcaicizzanti dell'Oriente
cristiano e dalla persistenza
di modelli iconografici di
origine paleocristiana. Gli
affreschi di Bojana
testimoniano tuttavia di una
tendenza verso il naturalismo
e verso il realismo che è
propria dello stile di
transizione della
contemporanea arte dell'Europa
centrale e occidentale.
 I
TRACI I
TRACI
I
traci non hanno lasciato
nessun documento scritto, ma
la loro memoria ha
attraversato ugualmente i
secoli soprattutto grazie a
pregevoli oggetti di metallo
lavorato e affreschi scoperti
nelle tombe regali.
Sono
leggendari i ritrovamenti di
"tesori" come quelli
di Panagyurishte, e mostre
come L'oro dei traci
hanno fatto il giro del mondo,
destando la meraviglia di
decine di migliaia di
visitatori.
I
greci conoscevano i traci come
forti bevitori, musicanti,
appassionati d'armi e di
cavalli, lo storico Erodoto li
riteneva il popolo più
numeroso dopo gli indiani. I
miti di alcuni importanti dèi
greci - tra cui Orfeo, che con
il suono della sua lira
commuoveva le belve, e
Dionisio, il dio del vino e
dell'ebbrezza - sono
ambientati in Tracia.
Questo
popolo indoeuropeo comunque si
diffuse in tutta l'Europa
meridionale e in alcune
regioni dell'Asia Minore a
partire dal II millennio a.C.
Ne facevano parte anche i
daci, stanziati a nord del
basso Danubio, che i romeni di
oggi considerano propri
antenati.
Le
litigiose tribù tracie, che
non vivevano in città, bensì
in insediamenti fortificati,
raggiunsero l'unità politica
solo nel V secolo a.C.,
all'epoca in cui la cultura
tracia era già in piena
fioritura.
Orafi
e argentieri producevano
raffinatissimi oggetti di
lusso, e i traffici
commerciali fecero conoscere
in Tracia il modo di vivere
dei greci. I traci furono
successivamente sottomessi da
celti, macedoni e infine
romani, ma la loro cultura
scomparve solo con l'arrivo
degli slavi nel VI secolo d.C.
|