|
La
Città
del
Vaticano
si
estende
sulla
riva
destra
del
Tevere,
tra
le
estreme
pendici
del
monte
Mario
a
nord
e
del
Gianicolo
a
sud,
sull'area
dell'antico
"ager
Vaticanus".
Con
una
superficie
di
appena
0,44
kmq
è
il
più
piccolo
stato
esistente
al
mondo,
ma
in
quanto
sede
del
capo
della
chiesa
cattolica
e
perché
vi
sorge
il
maggiore
tempio
della
cristianità,
è
da
secoli
meta
di
pellegrinaggio.
Inoltre
la
concentrazione
di
capolavori
d'arte
e
d'antichità
ne
fanno
una
delle
maggiori
attrazioni
artistiche
e
culturali
di
Roma
e
dell'Italia.
L'Unesco
ha
dichiarato
tutto
il
territorio
vaticano
patrimonio
culturale
del
mondo
intero.
L'espressione
"Vaticano"
comunemente
utilizzata
significa
a
un
tempo
sia
"Santa
Sede"
che
l'entità
territoriale
sorta
nel
cuore
di
Roma.
Il
documento
che
è
all'origine
della
nascita
di
questo
minuscolo
stato,
il
Trattato
del
Luterano,
fu
firmato
fra
Santa
Sede
e
Italia
l'11
febbraio
1929,
ed
è
entrato
in
vigore
il
7
giugno
dello
stesso
anno.
Assieme
al
Trattato
fu
stipulato
anche
il
Concordato,
per
regolare
i
rapporti
fra
la
Santa
Sede
e
il
governo
italiano.
Questi
due
strumenti
diplomatici
hanno
preso
il
nome
di
Patti
Lateranensi,
poiché
essi
furono
firmati
nel
palazzo
del
Laterano,
dal
primo
ministro
italiano,
Benito
Mussolini,
e
dal
segretario
di
stato
vaticano,
il
cardinale
Pietro
Gasparri.
Mentre
il
Trattato
è
uno
strumento
unico
e
storicamente
importantissimo
che
ha
posto
fine
alla
"questione
romana",
nata
con
l'occupazione
di
Roma
da
parte
delle
truppe
italiane
nel
1870,
il
Concordato
è
un
accordo
che
la
Santa
Sede
ha
stretto,
oltre
che
con
l'Italia,
anche
numerose
altre
volte
con
diversi
paesi
del
mondo.
Non
sono
soltanto
i
tesori
che
vi
sono
racchiusi
a
fare
del
Vaticano
il
più
sensazionale
compendio
di
quanto
le
arti
hanno
prodotto
sul
suolo
italiano
dall'epoca
etrusca
ai
nostri
giorni.
Gli
stessi
contenitori
di
quelle
raccolte,
risultato
del
succedersi
ininterrotto
di
interventi
iniziati
con
il
periodo
imperiale,
riassumono
le
concezioni
architettoniche
degli
ultimi
cinque
secoli,
con
modelli
memorabili
dovuti
ad
artisti
come
Bramante,
Raffaello,
Michelangelo,
Gian
Lorenzo
Bernini.
Le
motivazioni
ideologiche
che,
insieme
a
quelle
funzionali,
sono
alla
base
delle
vicende
costruttive
di
questo
complesso,
dai
giardini,
metafora
del
paradiso,
alla
cinta
muraria
che
protegge
il
complesso,
testimoniano
la
volontà
di
realizzare
la
residenza
del
vicario
di
Cristo
come
cittadella
della
fede,
della
sapienza
e
della
bellezza,
quale
proiezione
della
"città
celeste".
 
La
basilica
di
San
Pietro,
con
gli
annessi
palazzi
apostolici
e
altri
edifici
minori,
copre
complessivamente
circa
un
terzo
dell'area
totale
della
Città
del
Vaticano,
ma
per
i
Patti
Lateranensi
fanno
parte
di
essa
anche
numerose
aree
ed
edifici
situati
in
territorio
italiano:
le
tre
basiliche
di
Santa
Maria
Maggiore,
di
San
Giovanni
in
Laterano
e
di
San
Paolo
fuori
le
Mura,
con
gli
annessi
edifici,
alcuni
palazzi
di
Roma
in
cui
hanno
sede
vari
uffici
pontifici,
la
villa
e
il
palazzo
di
Castel
Gandolfo,
sul
lago
di
Albano,
sede
di
uno
dei
più
antichi
osservatori
astronomici
d'Europa
(
la
Specola
Vaticana
)
e
abituale
residenza
estiva
del
papa.
Anche
a
prescindere
da
queste
peculiari
caratteristiche
territoriali,
lo
stato
della
Città
del
Vaticano
presenta
alcune
particolarità
che
lo
distinguono
da
qualsiasi
altro
soprattutto
in
conseguenza
della
sua
inscindibile
connessione
con
la
Santa
Sede
della
quale
è
deputato
a
preservare
l'indipendenza.
Esso
agisce
in
sostanza
sempre
ed
esclusivamente
attraverso
quest'ultima,
che
non
si
considera
ente
territoriale
e
che
esercita
la
sovranità
sullo
stato
stesso,
il
quale
quindi
viene
a
essere
non
un
ordinamento
giuridico
originario,
ma
derivato.
E
a
differenza
degli
altri
stati,
di
cui
sono
elementi
costitutivi
il
territorio,
la
popolazione
e
la
sovranità,
allo
stato
della
Città
del
Vaticano
manca
quest'ultima,
attribuita
invece
alla
Santa
Sede.
 Il
suo
ordinamento
è
inoltre
lo
stesso
della
chiesa
cattolica,
vale
a
dire
il
diritto
canonico;
suo
organo
supremo
è
il
capo
stesso
della
chiesa,
il
papa;
suoi
fini
istituzionali
non
sono,
come
in
tutti
gli
stati,
la
regolamentazione
della
vita
associata
dei
propri
cittadini,
bensì
la
garanzia
di
indipendenza
della
Santa
Sede
e
di
non
ingerenza
esterna.
Nonostante
tutto
questo,
all'esterno
lo
stato
del
Vaticano
si
presenta
organizzato
come
qualsiasi
altro
stato
in
forma
di
monarchia
elettiva,
il
cui
capo
-
il
papa
-
ha
la
pienezza
dei
poteri
esecutivo,
legislativo
e
giudiziario. Il
suo
ordinamento
è
inoltre
lo
stesso
della
chiesa
cattolica,
vale
a
dire
il
diritto
canonico;
suo
organo
supremo
è
il
capo
stesso
della
chiesa,
il
papa;
suoi
fini
istituzionali
non
sono,
come
in
tutti
gli
stati,
la
regolamentazione
della
vita
associata
dei
propri
cittadini,
bensì
la
garanzia
di
indipendenza
della
Santa
Sede
e
di
non
ingerenza
esterna.
Nonostante
tutto
questo,
all'esterno
lo
stato
del
Vaticano
si
presenta
organizzato
come
qualsiasi
altro
stato
in
forma
di
monarchia
elettiva,
il
cui
capo
-
il
papa
-
ha
la
pienezza
dei
poteri
esecutivo,
legislativo
e
giudiziario.
Con
il
termine
generico
di
Musei
Vaticani
si
intende
un
complesso
di
istituti
situati
in
parte
nel
Vaticano
e
in
parte
in
Laterano
(questi
ultimi
sono
detti
anche
Musei
del
Laterano).
Tra
le
istituzioni
più
importanti
vi
sono
il
Museo
Pio-Clementino,
il
Museo
Chiaramonti,
il
Museo
gregoriano
egizio,
il
Museo
gregoriano
etrusco,
il
Museo
cristiano,
il
Museo
profano
e
la
Pinacoteca.
Per
quanto,
nella
loro
forma
attuale,
queste
istituzioni
siano
state
ordinate
tra
il
XVIII
e
il
XX
secolo,
le
loro
origini
affondano
nell'età
umanistica.
Nel
1471
Sisto
IV
offriva
al
popolo
romano
la
più
antica
raccolta
di
opere
d'arte
tuttora
esistente:
il
Museo
capitolino.
Consacrato
pontefice,
Giulio
II
Della
Rovere
(1503-13)
fece
trasportare
in
Vaticano
dalla
propria
sede
cardinalizia
di
San
Pietro
in
Vincoli
la
celebre
statua
di
Apollo
che,
dal
cortile
ove
fu
collocata,
si
chiamò
poi
Apollo
del
Belvedere.
Rapidamente
numerosi
e
straordinari
pezzi
si
aggiunsero
a
quella
prima
scultura,
tanto
da
giustificare
il
nuovo
appellativo
dato
al
cortile
in
cui
le
opere
furono
raccolte,
"Antiquario
delle
statue",
e
da
costringere
i
pontefici
di
lì
a
breve
a
organizzare
nuovi
spazi
espositivi.
Una
battuta
d'arresto
si
verificò
con
Pio
V
(1566-72),
severo
interprete
dello
spirito
della
Controriforma
,
il
quale
non
soltanto
chiuse
l'Antiquario,
ma
bandì
dal
Vaticano
anche
gran
parte
delle
collezioni
donando
statue
al
Museo
capitolino
e
persino
a
privati
come
Massimiliano
II
e
Francesco
de'
Medici.
La
spinta
al
collezionismo
fu
ciononostante
inarrestabile,
anche
in
virtù
dei
nuovi
reperti
archeologici
che
continuamente
affioravano
a
Roma
e
nei
domini
della
chiesa,
troppo
importanti
perché
i
pontefici
potessero
disinteressarsene.
La
stessa
Biblioteca
Vaticana,
a
illustrazione
e
commento
delle
proprie
opere,
aveva
accumulato
nel
corso
dei
secoli
un
ricco
e
importante
materiale
minore
(monete,
vasi,
iscrizioni,
avori,
bronzi
ecc.)
che
si
dovette
necessariamente
catalogare
e
ordinare.
Sorse
così,
nel
1756
sotto
Benedetto
XIV
(1740-58),
il
primo
nucleo
dei
Musei
Vaticani,
il
Museo
di
antichità
cristiana,
cui
si
aggiunse
-
per
volontà
del
medesimo
pontefice
-
la
Galleria
lapidaria.
Dieci
anni
più
tardi,
nel
1767,
Clemente
XIII
(1758-69),
con
la
collaborazione
del
cardinale
Albani,
dava
vita
al
Museo
profano,
una
raccolta
numismatica
comprendente
monete
e
medaglie
di
grande
interesse.
 
L'intensificarsi
delle
ricerche
e
degli
scavi
archeologici
portò
in
Vaticano
un
gran
numero
di
opere
d'arte
-
egizie,
greche,
etrusche
e
romane
-
così
che
Clemente
XIV
(1769-74),
nel
1771,
e
il
suo
successore,
Pio
VI
(1775-99),
poterono
fondare
un
eccezionale
museo
di
sculture
che,
dai
due
papi,
prese
il
nome
di
Pio-Clementino,
alloggiato
in
gran
parte
in
edifici
appositamente
costruiti.
Dopo
la
migrazione
in
Francia
di
un
gran
numero
di
opere
d'arte
causata
dalle
campagne
napoleoniche,
e
la
loro
conseguente,
anche
se
parziale,
restituzione,
Pio
VII
(1800-23)
riuscì
a
dar
vita
a
un
nuovo
museo
che
da
lui
prese
il
nome
di
Chiaramonti.
Insieme
al
Pio-Clementino
esso
costituisce
il
più
grandioso
e
fondamentale
complesso
di
sculture
che
esista
al
mondo.
Pio
VII
diede
inizio
inoltre
alla
Pinacoteca
e
al
Medagliere
Vaticano.
L'attuale
splendore
dei
Musei
fu
raggiunto
con
Gregorio
XVI
(1831-46):
nel
1836
egli
costituì
la
Galleria
degli
arazzi,
che
si
aggiunse
a
quella
dei
Candelabri;
nel
1837
aprì
il
Museo
etrusco,
nel
1839
quello
egizio,
nel
1844
il
Museo
profano
lateranense,
dedicato
all'arte
paleocristiana.
Infine
a
Pio
XI
(1922-39),
oltre
a
notevoli
aggiunte
ai
musei
etrusco
ed
egizio,
si
deve
l'apertura
del
Museo
missionario.
Il
nucleo
originario
della
Biblioteca
Apostolica
Vaticana
è
costituito
dai
codici
di
opere
greche
e
latine
radunati
da
Niccolò
V,
che
fece
sistemare
la
biblioteca
al
piano
terreno
del
proprio
palazzo
in
Vaticano,
con
ingresso
dal
cortile
del
Pappagallo
e
prospettiva
sul
cortile
del
Belvedere.
Ben
presto
il
numero
dei
codici
accrebbe
sino
a
oltre
duemila
opere
e
Sisto
IV
ne
fece
allestire
una
nuova
sede,
decorata
con
affreschi
di
Melozzo
da
Forlì,
Antoniazzo
Romano,
Domenico
e
Davide
Ghirlandaio.
Il
progressivo
e
inarrestabile
incremento
dei
codici
nel
corso
del
XVI
secolo
spinse
Sisto
V
a
far
erigere
da
Domenico
Fontana,
negli
anni
1587
-
89,
l
'edificio
che
ancora
oggi
accoglie
l'istituzione.
La
biblioteca
fu
innalzata
in
luogo
delle
scalinate
divisorie
del
cortile
del
Belvedere,
progettato
da
Bramante,
e
lo
interrompe
trasversalmente.
La
Biblioteca
Apostolica
è
a
buona
ragione
considerata
la
più
importante
biblioteca
del
mondo
quanto
alla
preziosità
delle
sue
collezioni,
che
nel
corso
del
tempo
hanno
visto
incrementare
sensibilmente
il
proprio
patrimonio
grazie
non
solo
agli
acquisti,
ma
anche
alle
donazioni
delle
biblioteche
di
famiglie
patrizie
romane,
di
principi
e
prelati.

Tra
i
manoscritti
(più
di
60.000),
si
annoverano
i
frammenti
dei
codici
virgiliani
dei
secoli
III
e
IV,
l'autografo
del
Canzoniere
petrarchesco,
codici
miniati
dei
più
illustri
miniatori
rinascimentali
e
codici
biblici
del
IV
e
V
secolo.
La
parte
propriamente
documentaria
delle
collezioni
fu
distaccata
sotto
il
pontificato
di
Paolo
V
e
diede
origine
all'Archivio
segreto
vaticano.
All'interno
della
Città
del
Vaticano,
oltre
agli
edifici
e
alle
istituzioni
museali
o
religiose
abitualmente
comprese
nel
circuito
di
visita,
ve
ne
sono
altri
ugualmente
importanti
ma,
poiché
difficilmente
accessibili,
meno
noti.
Tra
essi
il
Collegio
e
il
Camposanto
teutonico,
a
ovest
di
San
Pietro,
due
istituzioni
fondate
nel
799,
di
cui
la
prima
è
sede
dell'Istituto
di
studi
archeologico-storici
e
comprende
un
piccolo
museo
e
una
biblioteca
archeologica
e
di
storia
ecclesiastica
ricca
di
circa
45.000
volumi.
Prospiciente
l'abside
della
basilica
vaticana
è
la
chiesetta
di
Santo
Stefano
degli
Abissini,
eretta
da
Leone
III
col
titolo
di
Santo
Stefano
Maggiore
e
concessa
nel
1479
da
Sisto
IV
a
monaci
copti,
poi
quasi
del
tutto
rifatta
nel
XVIII
secolo
da
Clemente
XI.
A
destra
della
chiesa
una
vasta
scalinata
conduce
al
palazzo
del
Governatorato
(1931),
ove
hanno
sede
i
vari
servizi
civili,
mentre
nell'area
a
sinistra
vi
è
lo
Studio
del
mosaico,
fondato
per
provvedere
alla
decorazione
musiva
di
San
Pietro,
e
una
piccola
stazione
ferroviaria,
collegata
da
un
breve
raccordo
alla
linea
Roma-Viterbo.
Dietro
il
palazzo
del
Governatorato
si
estende
alle
falde
del
monte
Vaticano
un'ampia
area
verde
caratterizzata,
come
altri
giardini
italiani
del
XVI
secolo,
dall'alternarsi
di
prati
e
boschetti,
grotte
artificiali
e
fontane.
Nell'avvallamento
a
nord-est,
i
cui
contorni
sono
segnati
dall'edificio
della
Pinacoteca
Vaticana
e
dal
muro
laterizio
del
cortile
del
Belvedere,
vi
è
la
palazzina
fatta
erigere
da
Pio
XI
per
ospitare
la
Pontificia
accademia
delle
scienze,
collocata
a
ridosso
della
cosiddetta
Casina
di
Pio
IV,
indubbiamente
il
complesso
architettonico
più
suggestivo
dei
giardini.
Il
fabbricato
fu
in
realtà
iniziato
da
Paolo
IV,
il
quale
ne
affidò
la
costruzione
(1558)
a
Pirro
Ligorio,
che
ultimò
l'opera,
con
aiuti,
nel
1561.
Esso
si
compone
di
due
distinti
edifici
e
di
due
padiglioni
laterali.
L'edificio
minore,
circondato
da
una
fontana,
ha
un
basamento
ornato
da
mosaici
ed
è
aperto
superiormente
da
una
loggia
dorica;
il
maggiore
invece
ha
una
fronte
decorata
di
stucchi
ornamentali
e
figurati,
e
conserva
all'interno
affreschi
di
Federico
Barocci,
Santi
di
Tito
e
Federico
Zuccari.
Vi
è
infine
la
chiesa
di
Sant'Anna
dei
Palafrenieri,
parrocchiale
della
Città
del
Vaticano
che,
iniziata
nel
1572
da
Vignola
per
la
confraternita
dei
Palafrenieri
della
Corte
papale,
fu
ultimata
alla
morte
dell'architetto
dal
figlio
Giacinto
Barozzi.
Essa
presenta
una
facciata
posteriore
di
gusto
barocco
e
deve
la
sua
importanza
al
fatto
che
il
suo
interno
è
tra
i
primi,
a
Roma,
a
pianta
ellittica.

La
Basilica
di
San
Pietro
E'
la
più
grande
chiesa
del
mondo:
ha
una
lunghezza
di
218
metri
(187
metri
la
navata
interna),
la
cima
della
cupola
è
alta
oltre
130
metri
e
la
superficie
totale
supera
i
15.000
metri
quadrati.
L’edificio
può
contenere,
si
calcola,
80.000
persone.
Le
13
statue
della
facciata,
alte
5,70
metri,
rappresentano
Gesù,
Giovanni
Battista
e
gli
apostoli,
escluso
San
Pietro.
I
due
orologi
laterali
li
ha
costruiti
nel
1795
Giuseppe
Valadier.
Nell'interno
148
colonne
sostengono
i
soffitti
alti
44
metri.
Le
statue
inserite
nei
quattro
pilastri
centrali
sono
enormi:
5
metri
ciascuna
mentre
i
putti
che
sostengono
le
acquasantiere
sono
di
2
metri.
Nella
chiesa,
oltre
il
baldacchino
del
Bernini,
che
è
alto
come
Palazzo
Farnese,
ci
sono
29
altari
e
le
tombe
di
147
Papi.
Alle
pareti
non
ci
sono
pitture,
ma
mosaici,
oltre
naturalmente
a
marmi
ed
ori.
Centro
della
Cristianità,
fulcro
della
spiritualità
occidentale
e
caposaldo
della
religione
cattolica,
da
sempre
espressione
della
gloria
della
Chiesa
Trionfante,
il
Vaticano
sorge
su
quello
che
in
antichità
era
l'Ager
Vaticanus,
il
cui
nome,
derivante
da
"vaticinio",
segnò
in
qualche
modo
fin
dall'era
pagana
il
suo
destino
di
luogo
sacro.
Qui
sorgeva
il
Circo
di
Nerone,
in
realtà
iniziato
da
Caligola
e
solo
ultimato
dal
tristemente
famoso
imperatore,
sotto
il
cui
regno
fu
appunto
martirizzato
san
Pietro,
primo
pastore
della
Chiesa
e
figura
centrale
della
sua
storia.
La
tomba
dell'apostolo,
che
venne
sepolto
in
corrispondenza
del
punto
preciso
dove
si
era
compiuto
il
suo
martirio,
divenne
ben
presto
frequentatissimo
luogo
di
devozione,
tanto
che,
dopo
il
riconoscimento
della
professione
del
Cristianesimo
a
seguito
dell'Editto
di
Milano
del
313,
l'imperatore
Costantino
sentì
il
bisogno
di
fondarvi
un'imponente
basilica,
i
cui
lavori
iniziarono
qualche
anno
dopo.
ANTICA
BASILICA
DI
SAN
PIETRO
IN
VATICANO
-
La
cronologia
esatta
della
costruzione
della
basilica
non
è
conosciuta,
anche
se
il
Liber
Pontificalis
riporta
che
fu
eretta
da
Costantino
durante
il
pontificato
di
papa
Silvestro
I
(314-335),
anche
se
è
probabile
che
alcuni
lavori
si
siano
protratti
dopo
la
morte
del
papa
e
dell'imperatore
(337).
I
lavori
ebbero
inizio
presumibilmente
tra
il
319
ed
il
326
e
si
conclusero
sostanzialmente
entro
il
333.
La
Basilica
di
San
Pietro
sorse
così
in
tutta
la
sua
magnificenza
divenendo
in
breve
punto
chiave
della
religione
cristiana.
Per
costruire
l'imponente
basilica
(circa
110
x
65 m,
30 di
altezza),
l'imperatore
Costantino,
forte
anche
della
propria
carica
di
"Pontefice
Massimo"
e
coadiuvato
probabilmente
da
papa
Silvestro,
fece
spianare
quasi
tutti
i
mausolei
della
necropoli
demolendo
le
volte
che
fuoriuscivano
dalla
quota
prevista,
interrò
con
materiale
di
riporto
le
camere
funerarie
e
livellò
l'intera
zona
creando
una
spianata
detta
platea
Sancti
Petri
dove
venne
fondato
l'edificio
(con
presumibili
difficoltà
tecniche,
visto
l'apporto
di
terreno
di
riporto
tratto
dal
colle
sui
lati
Nord
ed
Ovest
della
basilica).
L'atto
di
spianare
un'area
cimiteriale
ancora
in
uso,
inconsueto
anche
sotto
il
profilo
religioso
e
giuridico
ed
effettuato
con
grandi
spese,
si
giustifica
con
la
grande
importanza
attribuita
alla
sepoltura
dell'apostolo,
riconosciuta
come
autentica.
Infatti
il
sito,
da
tradizione
antichissima,
è
riconosciuto
come
luogo
della
sepoltura
dell'apostolo
Pietro,
il
quale
dovrebbe
aver
subito
il
martirio
proprio
nei
vicini
Horti
neroniani.
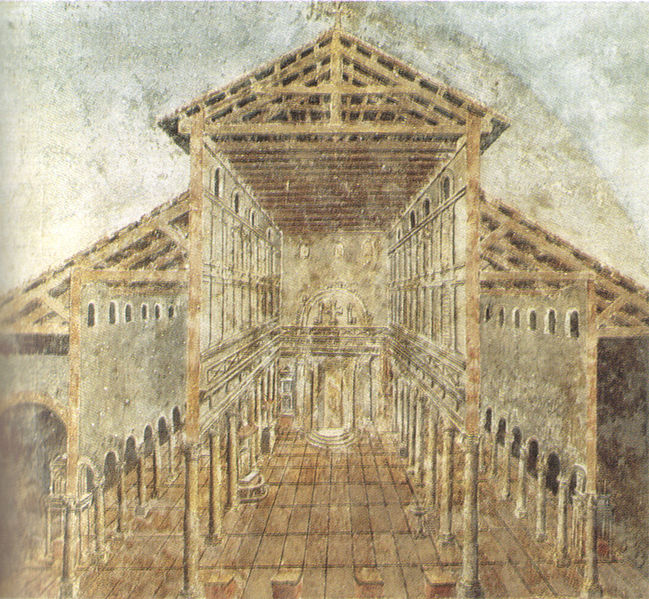 La
costruzione
del
grande
quadriportico
antistante
la
basilica,
documentato
dal
397,
fu
probabilmente
prevista
contestualmente
al
cantiere
della
basilica
e
realizzata
poco
dopo,
essendo
localizzato
anch'esso
sulla
platea
della
basilica,
raccordata
al
livello
del
piano
originario
con
una
grande
scalinata. La
costruzione
del
grande
quadriportico
antistante
la
basilica,
documentato
dal
397,
fu
probabilmente
prevista
contestualmente
al
cantiere
della
basilica
e
realizzata
poco
dopo,
essendo
localizzato
anch'esso
sulla
platea
della
basilica,
raccordata
al
livello
del
piano
originario
con
una
grande
scalinata.
Quando
il
re
degli
Ostrogoti
Totila
conquistò
Roma
il
17
dicembre
546,
molti
senatori
e
patrizi
romani
(tra
cui
Flavio
Anicio
Olibrio,
Rufio
Gennadio
Probo
Oreste
e
Flavio
Anicio
Massimo)
si
rifugiarono
qui.
Dopo
l'incoronazione
a
imperatore
di
Carlo
Magno
il
giorno
di
Natale
dell'800,
avvenuta
al
suo
interno,
il
Vaticano
assunse
una
connotazione
oltre
che
spirituale
anche
politica.
Cinta
dalle
cosiddette
Mura
Leonine,
sorte
sotto
il
pontificato
di
Leone
IV,
la
zona,
che
sino
ad
allora
si
trovava
al
di
fuori
del
pomerio
cittadino,
entrò
a
far
parte
integrante
del
tessuto
urbano
di
Roma.
Tuttavia
per
altri
cinque
secoli
i
pontefici
continuarono
a
preferirle
il
Laterano,
che
seguitò
ad
ospitare
le
massime
cariche
ecclesiastiche
e
a
svolgere
il
ruolo
di
centro
del
potere
papale.
Nel
corso
del
Duecento
un'intensa
attività
edilizia
segnò
lo
spazio
intorno
alla
basilica,
che
si
arricchì
di
edifici
destinati
ad
ospitare
alcune
cariche
istituzionali
della
Curia
romana.
Sotto
Nicolo
III,
Sisto
e
Ristoro,
due
frati
domenicani
architetti,
procedettero
all'ampliamento
del
primitivo
palazzo
pontificio
da
cui
poi
avrebbe
tratto
origine
il
complesso
dei
Palazzi
Vaticani
in
seguito
adattati
ad
ospitare
anche
le
collezioni
dei
Musei
Vaticani,
costruendo
fra
l'altro
la
Cappella
Palatina,
su
cui
sarebbe
sorta
la
Cappella
Sistina,
e
un
giardino
recintato,
su
cui
sarebbe
stato
eretto
il
Palazzetto
del
Belvedere.
Dopo
un
periodo
di
abbandono
dovuto
alla
cosiddetta
cattività
avignonese,
alla
fine
del
XIV
secolo
la
basilica,
insieme
al
complesso
vaticano
divenuto
la
residenza
dei
papi,
fu
al
centro
dell'interesse
papale
e
si
arricchì
di
molte
opere
d'arte.
Iniziarono
così
una
serie
di
lavori
di
costruzione
che
videro
impegnate
per
secoli
intere
schiere
di
architetti
e
di
artisti.
Durante
il
pontificato
di
Martino
V
e
Eugenio
IV
si
cominciò
a
pensare
ad
interventi
di
consolidamento.
Nel
XV
secolo
papa
Niccolò
V
decise
un
profondo
rinnovamento
del
complesso
edilizio
ed
in
particolare
della
vetusta
costruzione
che
lamentava
uno
stato
di
degrado,
soprattutto
alle
strutture
di
copertura
ed
al
muro
laterale
posto
a
nord
che
si
era
inclinato.
Consultato
Leon
Battista
Alberti,
il
progetto
fu
affidato
a
Rossellino
ma
i
lavori,
localizzati
alla
parte
absidale,
rimasero
a
lungo
interrotti.
All'inizio
del
XVI
secolo
si
decise
per
la
sua
totale
ricostruzione
e
quindi
fu
lentamente
demolita,
a
partire
dal
presbiterio,
per
far
spazio
alla
nuova,
grandiosa
basilica.
Tuttavia
una
parte
della
navata
del
tempio
costantiniano,
divisa
al
tempo
di
Paolo
III
da
un
muro
(detto
muro
"farnesiano")
dalla
nuova
crociera
in
costruzione,
sopravvisse
e
fu
utilizzata
per
quasi
tutta
la
durata
del
cantiere,
fino
a
quando,
nel
1609,
non
fu
definitivamente
abbattuta
per
volontà
di
papa
Paolo
V,
superando
le
ultime
perplessità.
Infatti
anche
in
tale
fase
non
mancò
chi
si
opponeva
a
questa
ulteriore
demolizione
e
quindi
al
compimento
del
progetto
di
Michelangelo.
Tale
devozione
verso
l'antica
basilica
portò
vari
studiosi
a
lasciare
descrizioni
minuziose
che
ne
tramandassero
ai
posteri
la
memoria:
Tiberio
Alfarano
(De
basilicae
Vaticanae
antiquissima
et
nova
structura
del
1582),
Giacomo
Grimaldi,
Onofrio
Panvinio
(De
rebus
antiquis
memorabilibus
et
praestantia
basilicae
S.
Petri
Apostolorum
libri
septem).
La
nuova
basilica
fu
consacrata
nel
1626.







L'antica
basilica
ci
è
nota
da
fonti
iconografiche
(disegni,
affreschi),
letterarie
e
risultanze
archeologiche.
La
basilica
era
a
cinque
navate
(87x64
metri),
con
la
centrale
rialzata
e
più
larga,
e
coperta
da
capriate.
Le
navate
erano
divise
da
quattro
colonnati
di
ventidue
colonne
ciascuno,
coperti
da
architravi
nella
navata
centrale
e
da
archi
in
quelle
laterali.
L'illuminazione
interna
era
garantita
dalle
finestre
che
numerose
si
aprivano
nella
parte
che
si
elevava
della
navata
maggiore
(in
rapporto
3:1),
il
cleristorio.
La
copertura
era
in
capriate
lignee.
La
facciata
aveva
degli
spioventi
digradanti,
ma
a
differenza
di
San
Giovanni
in
Laterano
non
vi
era
uno
spiovente
per
navata,
ma
le
navate
minori
erano
coperte
da
un'unica
travatura
digradante.
Un'altra
peculiarità
di
San
Pietro
era
l'uso
del
transetto[9]
(trans
saepta,
"oltre
i
cancelli"),
il
primo
ad
essere
concepito
come
navata
trasversale
indipendente,
alto
come
la
navata
centrale
(ma
meno
ampio)
e
dotato
di
una
propria
copertura.
Sul
transetto
si
apriva
l'abside
e
in
fondo
ai
bracci
si
trovavano
due
nicchie
rettangolari
che
sporgevano
esternamente
oltre
il
profilo
delle
navate.
In
corrispondenza
della
navata
centrale
si
apriva
sul
transetto
l'arcone
("arco
di
trionfo")
tipico
della
basiliche
paleocristiane,
sia
cristiane
che
civili
(come
nella
basilica
di
Costantino
a
Treviri).
Le
navatelle
terminavano
invece
con
trifore
colonnate,
simili
a
quelle
che
sia
aprivano
nelle
nicchie
laterali
del
transetto.
L'abside
era
decorata
da
mosaici
offerti
da
un
figlio
di
Costantino
(probabilmente
Costanzo
II)
che
rappresentavano
Cristo
tra
san
Pietro
e
san
Paolo
secondo
un
modello
iconografico
definito
traditio
legis,
in
sostituzione
forse
di
un
originario
mosaico
color
d'oro
senza
immagini[10].
Nell'abside
si
trovava
anche,
dove
si
troverebbe
di
solito
l'altare,
la
memoria
dell'Apostolo,
che
altro
non
era
che
l'edicoletta
del
II
secolo
detta
anche
"trofeo".
Quest'ultima
sporgeva
dal
pavimento
della
basilica
(qui
a
solo
30 cm
dal
livello
originario
della
necropoli)
ed
era
inserita
in
una
dado
marmoreo
con
lesene
in
porfido
e
recintato
da
una
pergula
con
colonne
tortili
e
amorini
vendemmianti,
che
fece
da
ispirazione
per
il
baldacchino
seicentesco.
Le
colonne
originarie
della
pergula
vennero
riutilizzate
negli
altari
incassati
nei
piloni
della
basilica
attuale
e
ce
ne
resta
traccia
in
varie
opere
d'arte
come
una
copia
fedele
nella
cassetta
eburnea
di
Pola
del
V
secolo.
 La
facciata
ed
il
quadriportico[modifica
|
modifica
sorgente] La
facciata
ed
il
quadriportico[modifica
|
modifica
sorgente]
La
facciata
presentava
finestroni
ad
arco
su
due
ordini.
Il
frontone
aveva
solo
un
piccolo
rosone,
mentre
la
parte
corrispondente
alla
navata
centrale
era
decorata
con
mosaici
che
nella
parte
più
alta
erano
leggermente
incurvati
verso
il
basso
per
una
migliore
visione.
I
mosaici
risalivano
al
V
secolo,
anche
se
furono
restaurati,
rimaneggiati
e
reintegrati
varie
volte,soprattutto
nel
XIII
secolo.
Erano
organizzati
su
tre
ordini:
in
alto
Cristo
tra
san
Pietro,
la
Vergine
ed
i
simboli
del
tetramorfo;
in
mezzo
quattro
figure
disposte
tra
i
finestroni
ed
identificati
con
gli
evangelisti
o
santi;
in
basso,
sotto
un'iscrizione,
altre
figure
identificate
negli
Anziani
dell'Apocalisse;
sui
frontoni
triangolari
delle
navate
laterali
immagini
di
Gerusalemme
e
Betlemme[11].
La
facciata
a
spioventi
della
basilica
era
preceduta
ad
est
da
un
quadriportico,
descritto
per
primo
da
Eusebio
di
Tiro,
dove
sostavano
anticamente
i
catecumeni
durante
la
celebrazione
dell'Eucarestia.
Il
quadriportico
aveva
anche
una
funzione
cimiteriale.
L'area
interna
del
quadriportico
era
originariamente
un
giardino
(da
cui
forse
la
denominazione
Paradisus)
con
all'interno
un
fontana
per
abluzioni
purificatrici[12].
Con
l'aumento
del
numero
dei
pellegrini
l'area
fu
pavimentata
nel
VII
secolo
e
vi
fu
posta
al
centro
il
Pignone,
una
scultura
in
bronzo
di
epoca
romana,
oggi
nel
cortile
della
Pigna
nei
Musei
Vaticani.
Non
sappiamo
se
Dante
Alighieri
vide
il
Pignone
in
questa
posizione
durante
l'ipotetico
pellegrinaggio
per
il
Giubileo
del
1300,
ma
comunque
lo
citò
in
un
passo
della
Divina
Commedia
(Inf.
XXXI,
59).
Edifici
annessi[modifica
|
modifica
sorgente]
Accanto
alla
basilica
esistevano
numerosi
altri
edifici
tra
cui
un
campanile
medievale
e
due
edifici
a
pianta
circolare,
antichi
mausolei
romani
usati
forse
come
martyrion.
Uno
di
essi,
noto
come
cappella
di
Santa
Petronilla,
era
il
mausoleo
imperiale
onoriano,
in
cui
furono
sepolti
l'imperatore
romano
Onorio
con
le
mogli
Maria
e
Termanzia,
oltre
a,
probabilmente,
sua
sorella
Galla
Placidia
col
figlio
primogenito
Teodosio.
L'altro
era
un
mausoleo
databile
all'epoca
di
Caracalla
e
poi
utilizzato
come
Cappella
di
Sant'Andrea
(nota
anche
come
chiesa
di
Santa
Maria
della
Febbre)[13].
La
rotonda
di
Santa
Petronilla
fu
demolita
nel
corso
del
XVI
secolo,
con
la
costruzione
del
transetto
sud
della
nuova
basilica;
quella
di
Sant'Andrea
fu
abbattuta
alla
fine
del
Settecento
per
far
posto
alla
nuova
Sagrestia
di
Carlo
Marchionni.
Sul
lato
sud,
poco
discosto
dalla
basilica
e
dai
suddetti
mausolei,
si
trovava
un
obelisco,
resto
del
Circo
di
Nerone,
che,
rimasto
ancora
in
piedi,
fu
spostato
nel
1586
al
centro
della
nuova
Piazza
San
Pietro.
Le
opere
d'arte[modifica
|
modifica
sorgente]
Tra
le
tante
opere
d'arte
che
nei
secoli
abbellirono
la
basilica,
in
parte
andati
perduti,
in
parte
ancora
conservate
in
Vaticano
o
riutilizzati
nella
nuova
basilica
o
in
altre
chiese.
Mosaici
la
adornavano
internamente
ed
esternamente.
Un
mosaico
raffigurante
la
Navicella
degli
Apostoli,
realizzato
su
cartone
di
Giotto,
era
posto
nel
quadriportico,
sulla
parete
interna
dell'atrio
d'ingresso,
contrapposta
alla
facciata
della
basilica[14].
Dopo
la
demolizione
della
basilica
costantiniana,
alcuni
dei
suoi
frammenti,
dopo
pesanti
rifacimenti,
furono
rimessi
in
opera
nell'atrio
della
nuova
basilica
in
forma
di
lunetta.
Nel
portico
si
trovavano
poi
delle
Storie
si
san
Pietro
della
seconda
metà
del
Duecento,
forse
disegnate
da
Cimabue
o
da
Pietro
Cavallini
e
oggi
note
solo
da
copie
seicentesche.
Lo
stesso
Giotto
aveva
eseguito
nel
1320
circa
la
pala
dell'altare
principale,
il
Polittico
Stefaneschi
ora
nei
Musei
Vaticani
ed
alcuni
affreschi,
perduti,
nella
tribuna.[15].
Nell'abside
si
trovavano
affreschi
con
Storie
di
Cristo
di
alcuni
suoi
alloievi,
tra
cui
Stefano
Fiorentino.
Nel
1377
il
complesso
vaticano
divenne
la
residenza
dei
papi
dopo
la
cattività
avignonese.
La
basilica,
al
pari
delle
altre
grandi
chiese
romane,
fu
partecipe
delle
opere
di
ripristino
e
rinnovamento
promossi
da
Martino
V,
Eugenio
IV
e
da
Niccolò
V
per
riparare
al
disastroso
abbandono
in
cui
versava
tutta
la
città.
In
quel
periodo
San
Pietro
venne
abbellita
anche
con
affreschi
come
le
Storie
di
Cristo
di
Beato
Angelico,
perduti
a
parte
alcuni
frammenti
di
controversa
attribuzione,
o
da
quelli
eseguiti
nella
Cappella
della
Concezione
da
Pietro
Perugino
(1478-1479).
Di
Pinturicchio
era
una
perduta
tavola
nella
Cappella
Lancia,
raffigurante
la
Madonna
col
Bambino,
santi
e
papa
Innocenzo
VIII.
Tra
il
1467
e
il
1470
fu
realizzato
un
grande
ciborio
marmoreo
per
l'altare
principale
scolpito
da
Paolo
Romano,
di
cui
rimangono
alcuni
bassorilievi
ricomposti
all'interno
della
Biblioteca
Vaticana.
Vi
erano
inoltre
monumenti
di
Andrea
Sansovino
e
Andrea
Bregno,
alcuni
dei
quali
furono
portati
da
monsignor
Simoncelli,
segretario
di
Paolo
V,
nella
sua
terra
d'origine
a
Boville
Ernica
(provincia
di
Frosinone),
nella
chiesa
di
San
Pietro
Ispano
dove
si
trova
anche
un
Angelo
proveniente
dalla
cornice
del
mosaico
della
Navicella
di
Giotto.
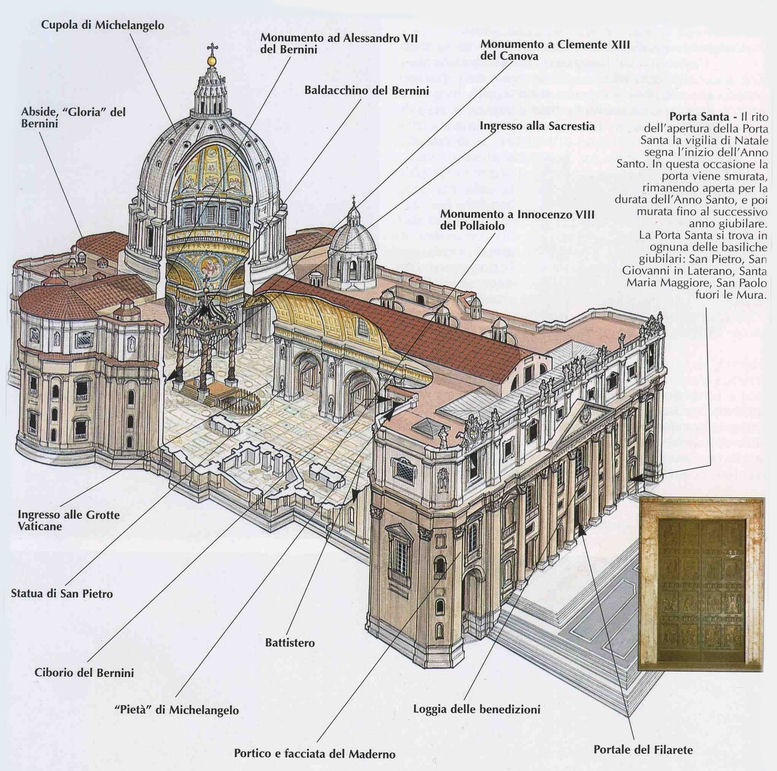
Dopo
circa
un
millennio,
la
basilica
fu
oggetto
di
un
lungo
rifacimento
che,
affidato
nel
1452
da
papa
Niccolo
V
a
Bernardo
Rossellino,
nell'arco
di
due
secoli
portò
a
un
totale
stravolgimento.
All'interno
del
progetto
culturale
cinquecentesco
di
renovatio
imperi,
atto
a
far
risorgere
la
grandezza
di
Roma
antica,
papa
Giulio
II,
già
cardinale
di
San
Pietro,
eletto
al
soglio
pontificio
nel
1503,
inaugurò
un
poderoso
progetto
artistico
che
prevedeva
appunto
la
rifondazione
dell'intera
basilica,
unita
alla
decorazione
delle
stanze
vaticane
e
della
cappella
Sistina
e
alla
costruzione,
affidata
a
Michelangelo,
del
proprio
sepolcro.
I
lavori
furono
affidati
a
Bramante
che,
partendo
dall'area
di
cupola
e
mantenendo
i
muraglioni
qui
realizzati
dal
Rossellino
cinquant'anni
prima,
procedette
nel
1506
alla
demolizione
di
buona
parte
dell'edificio
a
settentrione,
secondo
un
progetto
a
pianta
centrale
che,
nella
sua
perfezione
formale,
rispondeva
pienamente
a
una
visione
del
mondo
rinascimentale.
La
tipologia
planimetrica,
di
ascendenza
orientale-bizantina,
progettata
da
Bramante
per
San
Pietro
(croce
greca;
cupola
centrale
al
centro
dell'incrocio
dei
bracci
e
cupole
minori
sulle
diagonali
dello
spazio
di
cupola;
quattro
campanili
angolari)
risultò
ottimale
da
un
punto
di
vista
funzionale
e
statico,
in
quanto
permise
di
realizzare
una
struttura
colossale
e
allo
stesso
tempo
leggera,
grazie
anche
ai
particolari
piloni
di
cupola,
dalla
forma
smussata
verso
l'interno
e
quindi
meno
pesanti.

Nel
1515
la
direzione
dei
lavori
passò,
sotto
il
pontificato
di
Leone
X,
a
Raffaello,
affiancato
da
fra
Giocondo
e
Giuliano
da
Sangallo,
questi
ultimi
presto
sostituiti
da
Antonio
da
Sangallo
il
Giovane.
Raffaello
elaborò
un
maestoso
progetto
a
croce
latina,
portato
avanti
anche
dal
suo
successore
(il
modello
del
progetto
di
Antonio
da
Sangallo
il
Giovane
è
conservato
ai
Musei
Vaticani).
Successivamente
Michelangelo,
incaricato
da
papa
Paolo
III,
ritornò
al
progetto
a
croce
greca
bramantesco
e
studiò
nuove
soluzioni
per
la
cupola
il
cui
valore
simbolico,
sovrastando
essa
la
tomba
di
San
Pietro,
appariva
fondamentale
già
nei
primi
progetti
quattrocenteschi
di
ristrutturazione
della
basilica.
Michelangelo
tuttavia
realizzò
solo
il
tamburo,
la
cui
alta
fascia
orizzontale
ritmata
dalle
colonne
binate
e
dalle
finestre
con
frontoni
alternativamente
curvi
e
rettilinei,
funge
da
raccordo
tra
la
grande
mole
della
basilica
e
la
cupola.
La
cupola
fu
portata
a
termine,
insieme
al
lanternino,
da
Giacomo
della
Porta
e
da
Domenico
Fontana
tra
il
1588
e
l'anno
seguente.
Risultò
così
costituita
da
un
tamburo
sorretto
da
16
contrafforti
nascosti
da
colonne
binate,
tra
i
quali
si
aprono
le
grandi
finestre
dotate
di
timpano.
La
calotta
a
doppio
guscio
si
slancia
al
di
sopra
del
tamburo
suddivisa
in
spicchi
da
16
nervature
su
cui
si
aprono
tre
ordini
di
oculi.
 
A
fianco
sorgono
due
cupolette,
opere
del
Vignola
erette
a
scopo
unicamente
decorativo
e
senza
alcuna
corrispondenza
con
le
Cappelle
Clementina
e
Gregoriana
che
esse
sovrastano.
Alla
morte
del
maestro
toscano,
i
lavori
passarono
nuovamente
ad
una
schiera
di
altri
architetti
finché,
sotto
Paolo
V,
ritornata
in
auge
la
soluzione
a
croce
latina,
il
Maderno
non
aggiunse
tre
cappelle
per
lato,
facendo
avanzare
le
navate
sino
ad
innestarle
alla
facciata,
che
egli
terminò
nel
1614. 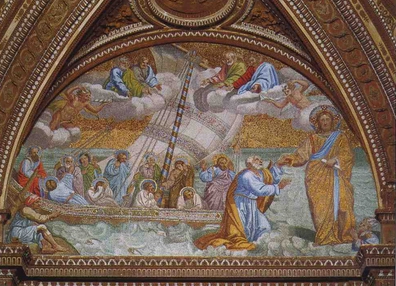
Il
18
novembre
1626,
nel
milletrecentesimo
anniversario
della
consacrazione
originaria,
Urbano
VIII
consacrò
finalmente
la
nuova
basilica.
Gli
interventi
del
Maderno
penalizzarono
in
un
certo
qual
modo
il
progetto
michelangiolesco
impedendo
la
visione
totale
della
cupola,
che
spunta
soltanto
in
parte
da
dietro
il
monumentale
prospetto
coronato
da
due
graziose
mostre
d'orologio
del
Valadier
e
preceduto
da
due
grandi
statue
neoclassiche
raffiguranti
San
Pietro
e
San
Paolo.
Dal
balcone
mediano
che
si
apre
sulla
facciata,
detto
loggia
delle
benedizioni,
oltre
le
benedizioni
solenni
viene
dato
anche
l'annuncio
dell'elezione
del
papa.
Il
portico,
di
una
vastità
proporzionale
alla
grandezza
dell'interno,
fu
decorato
con
fantasia
e
ricercatezza
da
statue,
fregi
e
stucchi.
Qui
è
conservato,
ancorché
quasi
totalmente
rifatto,
il
mosaico
della
Navicella,
disegnato
da
Giotto
per
la
basilica
originaria
e
raffigurante
Cristo
che
invita
Pietro
a
camminare
sulle
acque.
Sul
fondo
si
aprono
cinque
ingressi:
quello
mediano,
che
introduce
alla
basilica,
possiede
uno
stupendo
portale
opera
quattrocentesca
del
Filarete;
l'ultimo
a
destra
è
invece
la
famosa
Porta
Santa,
solennemente
aperta
dal
pontefice
per
inaugurare
l'anno
giubilare
e
che
al
termine
viene
richiusa
con
un'altrettanto
solenne
cerimonia.

L'interno
appare
in
tutta
la
sua
sconfinata
grandezza
quale
simbolo
della
Chiesa
Trionfante,
in
cui
la
ricchezza
e
la
sontuosità
degli
arredi
accentuano
il
senso
di
sublime
glorificazione
del
Cristianesimo.
Basterebbe
solo
il
colpo
d'occhio
della
navata
mediana
con
la
volta
riccamente
decorata
sotto
Pio
VI
nel
1780,
le
stelle
sul
pavimento
che
indicano
la
grandezza
delle
maggiori
chiese
del
mondo,
le
acquasantiere
sorrette
da
colossali
putti
di
marmo
e
la
veneratissima
statua
di
San
Pietro,
raffigurato
seduto
e
benedicente
presso
l'ultimo
pilastro
a
destra
-
probabilmente
di
Arnolfo
di
Cambio
-
a
dare
l'idea
di
tale
monumentalità.

Attrae
però
lo
sguardo,
appena
varcato
l'ingresso,
il
grande
baldacchino
di
bronzo
con
colonne
tortili,
frutto
di
una
felicissima
collaborazione
tra
il
Bernini,
il
Borromini
e
il
Duquesnoy,
che
vide
impegnati
i
tre
artisti
dal
1624
al
1633.
Sotto
il
tripudio
di
angeli
che
corona
l'ardita
struttura
di
quasi
30
metri
di
altezza,
per
la
costruzione
della
quale
Urbano
VIII
Barberini
fece
sacrificare
i
bronzi
del
Pantheon,
si
trova
l'altare
papale
riservato
al
pontefice,
che
solo
può
recitarvi
la
messa,
e
la
sottostante
confessione,
decorata
dal
Maderno
e
illuminata
da
95
lampade
eterne,
sorta
in
corrispondenza
della
tomba
di
san
Pietro.
Al
di
sopra
del
baldacchino
si
eleva
la
calotta
interna
della
cupola
michelangiolesca,
decorata
con
mosaici
disegnati
dal
Cavalier
d'Arpino.
Nello
spazio
retrostante,
in
corrispondenza
della
colossale
abside
o
tribuna,
si
trova
la
splendida
Gloria,
opera
della
tarda
maturità
del
Bernini,
che
seppe
profondervi
tutta
la
sua
abilità
di
scultore
e
decoratore
attraverso
un
complesso
intreccio
di
stucchi,
dorature,
sculture,
rilievi.
La
struttura,
realizzata
tra
il
1656
e
il
1665,
conserva
entro
la
cattedra
bronzea
sorretta
dalle
statue
dei
Dottori
della
Chiesa
la
cattedra
lignea
che
la
tradizione,
storicamente
infondata,
vuole
essere
appartenuta
a
san
Pietro.
Affiancano
la
monumentale
tribuna,
a
sinistra,
il
monumento
a
Paolo
III,
opera
di
Guglielmo
Della
Porta,
e,
a
destra,
il
monumento
a
Urbano
Vili
del
Bernini.
La
navata
destra,
decorata
dal
Bernini
in
maniera
da
mascherarne
il
restringimento
all'altezza
del
terzo
arcone,
laddove
alla
struttura
michelangiolesca
s'innesta
l'ampliamento
del
Maderno,
mostra
subito,
nella
prima
cappella,
la
celebre
Pietà
di
Michelangelo,
che
il
maestro
toscano
realizzò
tra
il
1498
e
il
1499
per
il
legato
di
Carlo
VIII
presso
la
Santa
Sede.
La
terza
è
la
Cappella
del
Santissimo
Sacramento,
dove
si
trova
il
ricco
ciborio
del
Bernini
ispirato
al
Tempietto
di
San
Pietro
in
Montorio
del
Bramante
fiancheggiato
da
due
angeli
in
ginocchio.
Oltrepassato
il
monumento
a
Gregorio
XIII,
riformatore
del
calendario
che
da
lui
prese
appunto
il
nome
di
gregoriano,
si
entra
nella
Cappella
Gregoriana,
compiuta
da
Giacomo
Della
Porta
nel
1583,
quindi
nel
transetto
destro,
dal
quale
si
accede
alla
Cappella
di
San
Michele,
cui
introduce
il
monumento
a
Clemente
XIII,
capolavoro
del
Canova
datato
intorno
al
1790.

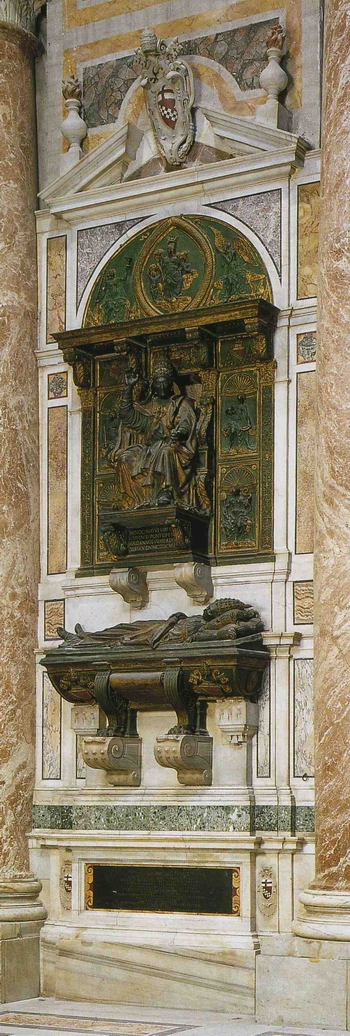 Attraversata
l'abside
e
raggiunto
il
fianco
sinistro
della
basilica
ci
si
trova
nella
corrispondente
Cappella
della
Colonna,
dove
sono
conservate
le
reliquie
di
san
Leone
Magno,
al
quale
allude
la
bella
pala
marmorea
dell'Algardi
raffigurante
l'Incontro
di
Leone
Magno
con
Attila.
Nell'attiguo
passaggio
il
tetro
scheletro
con
in
mano
la
clessidra
richiama
l'attenzione
sul
berniniano
monumento
a
papa
Alessandro
VII,
che
introduce
al
transetto
sinistro,
dal
quale,
attraversata
la
Cappella
Clementina,
realizzata
al
pari
della
corrispondente
destra
dal
Della
Porta,
si
giunge
alla
navata
sinistra.
Qui
si
apre
la
ricchissima
Cappella
del
Coro. Attraversata
l'abside
e
raggiunto
il
fianco
sinistro
della
basilica
ci
si
trova
nella
corrispondente
Cappella
della
Colonna,
dove
sono
conservate
le
reliquie
di
san
Leone
Magno,
al
quale
allude
la
bella
pala
marmorea
dell'Algardi
raffigurante
l'Incontro
di
Leone
Magno
con
Attila.
Nell'attiguo
passaggio
il
tetro
scheletro
con
in
mano
la
clessidra
richiama
l'attenzione
sul
berniniano
monumento
a
papa
Alessandro
VII,
che
introduce
al
transetto
sinistro,
dal
quale,
attraversata
la
Cappella
Clementina,
realizzata
al
pari
della
corrispondente
destra
dal
Della
Porta,
si
giunge
alla
navata
sinistra.
Qui
si
apre
la
ricchissima
Cappella
del
Coro.
Nel
passaggio
seguente
si
trova
il
monumento
a
Innocenzo
VIII,
realizzato
in
bronzo
dal
Pollaiolo
nel
1498.
All'altezza
della
prima
cappella
si
trova
invece
un
altro
capolavoro
del
Canova,
il
sepolcro
degli
ultimi
Stuart,
nel
quale
spicca
in
maniera
particolare
la
grazia
dei
due
geni
con
le
fiaccole
rovesciate.
Per
ultimo
si
apre
sulla
navata
il
battistero,
il
cui
fonte
battesimale
è
costituito
da
un
antico
sarcofago
romano.

Piazza
San
Pietro
Luogo sacro di grande suggestione e
di
profonda
connotazione
religiosa
e
simbolica,
piazza
San
Pietro
è
forse
la
piazza
più
famosa
del
mondo.
Sin
dal
Medioevo
essa
accolse
e
raccolse
folle
innumerevoli
di
pellegrini
in
visita
alla
Basilica
di
San
Pietro,
centro
della
Cristianità,
assolvendo
la
funzione
di
spazio
vitale
della
vita
religiosa
cittadina.
La piazza sorse su parte dell'antico Circo Vaticano o di
Nerone,
in
realtà
costruito
quasi
totalmente
sotto
Caligola,
a
testimonianza
del
quale
resta
l'Obelisco
Vaticano,
trasportato
nel
37
d.C.
da
Alessandria
d'Egitto,
dove
ornava
il
Foro
di
Cesare.
Esso,
detto
nel
Medioevo
aguglia,
rimase
per
lungo
tempo
a
lato
della
basilica,
sinché,
nel
1586,
Sisto
V
dette
incarico
a
Domenico
Fontana
di
spostarlo
nel
sito
attuale,
alla
destra
del
quale
Carlo
Maderno,
realizzò
nel
1613,
per
volere
di
Paolo
V, una fontana, cui, dopo oltre mezzo secolo, se ne
aggiunse
un'altra
ad
essa
simmetrica,
costruita
da
Carlo
Fontana.
Sempre
sotto
Sisto
V, l'originale globo bronzeo che ornava l'obelisco (oggi ai Musei
Capitolini)
e
che
era
ritenuto
conservare
le
ceneri
di
Cesare,
fu
sostituito
dal
suo
emblema
familiare,
i
monti
e
la
stella,
sormontato
da
un
crocifisso
in
cui
si
trova
custodito
un
frammento
della
Santa
Croce
di
Cristo.

A metà del XVII secolo
la
monumentale
opera
di
abbellimento
della
Basilica
di
San
Pietro
trovò
una
sua
ideale
prosecuzione
nella
fastosa
sistemazione
della
piazza
ad
essa
antistante,
che
Gian
Lorenzo
Bernini
realizzò
tra
il
1656
e
il
1667.
La
trionfante
spettacolarità
che
il
genio
dell'architetto
e
scultore
barocco
profuse
nell'esecuzione
di
questo
immenso
capolavoro
non
fu
tuttavia
dettata
da
un
semplice
gusto
estetico,
bensì
caricata
di
profondi
significati
simbolici,
tanto
che
la
piazza
stessa
può
essere
interpretata
come
una
monumentale
allegoria.
Lo spazio è suddiviso in due parti:
la
prima
a
forma
di
trapezio
rovescio
con
il
lato
maggiore
lungo
la
facciata,
la
seconda
di
forma
ellittica
con
l'imponente
colonnato
dorico
sormontato
da
una
robusta
architrave.
Nel
progetto
berniniano
compariva
uno
spicchio
centrale
("il
nobile
interrompimento")
in
prosecuzione
del
colonnato,
che,
se
realizzato,
avrebbe
nascosto
la
piazza
e
la
basilica
rispetto
alla
veduta
frontale.
In
questo
modo,
provenendo
da
Ponte
Sant'Angelo,
il
visitatore,
dopo
aver
percorso
le
vie
anguste
del
Borgo,
si
sarebbe
trovato
all'improvviso
in
uno
spazio
vasto
e
solenne
e
avrebbe
provato
stupore
e
meraviglia.
Va
considerato
a
questo
proposito
che
l'attuale
Via
della
Conciliazione
è
il
risultato
dell'opera
di
demolizione
(1936-1950)
di
un
isolato
lungo
e
stretto
(la
Spina
di
Borgo)
tra
le
strade
oggi
scomparse
di
Borgo
Vecchio
e
Borgo
Nuovo.

Piazza San Pietro
con
il
celebre
colonnato,
una
delle
trovate
più
geniali
di
Gian
Lorenzo
Bernini,
è
profonda
320
metri
con
un
ellissi
centrale
di
240
metri
ed
è
circondata
da
4
file
di
284
colonne
e
88
pilastri.
La
balaustra
sopra
le
colonne
è
decorata
da
140
statue
di
Santi.
In
basso,
un‘enorme
scalinata
a
tre
ripiani
con
ai
lati
le
statue
di
S.
Pietro
e
S.
Paolo.
In
mezzo
alla
piazza
due
grandi
fontane
e
l’obelisco.
 Pag.
2 Pag.
2
|