|
Fu
un segmento relativamente
breve della lunga storia
parentina a mutare
definitivamente il destino di
questa città. Il piccolo
centro della provincia,
collocato ai margini del
morente Impero Romano, nel VI
sec. subì una prodigiosa
metamorfosi. Nell'intento di
riunire un impero ormai
disgregato, l'imperatore
Giustiniano ristabilì
un'effimera sembianza di unità
e non soltanto territoriale e
politica, poiché egli cercò
di riportare anche l'arte al
suo antico splendore.
All'apice della riconquista
giustiniana il vescovo
parentino Eufrasius eresse,
sul sito dell'antica basilica
cittadina, la sua cattedrale
inserendola in un insieme di
edifici che formarono uno dei
maggiori complessi
architettonici di quell'epoca.
Qui, sul lato settentrionale
della penisola, dove alcuni
secoli prima era sorta
Parentium, un modello di città
romana, il gusto, lo splendore
e l'opulenza stilistica
dell'Oriente entrarono a far
parte del nuovo complesso,
destinato a dare un'impronta
caratteristica a quell'epoca.
 Il
gusto del vescovo Eufrasio,
avvezzo alla sontuosità
dell'Oriente, non poteva
soddisfarsi in alcun modo del
letargo provinciale che
caratterizzava Parenzo,
l'Istria e la maggior parte
del corroso Impero Romano. Le
grandi opere urbanistiche da
egli intraprese non recepirono
che in parte il preesistente
sostrato antico e introdussero
delle innovazioni
architettoniche e, più in
generale, artistiche che sino
ad allora l'Occidente non
aveva mai conosciuto. Il
gusto del vescovo Eufrasio,
avvezzo alla sontuosità
dell'Oriente, non poteva
soddisfarsi in alcun modo del
letargo provinciale che
caratterizzava Parenzo,
l'Istria e la maggior parte
del corroso Impero Romano. Le
grandi opere urbanistiche da
egli intraprese non recepirono
che in parte il preesistente
sostrato antico e introdussero
delle innovazioni
architettoniche e, più in
generale, artistiche che sino
ad allora l'Occidente non
aveva mai conosciuto.
Esse
riguardarono tanto
l'organizzazione dello spazio
all'interno della basilica, in
particolar modo dell'ala est,
quanto la parte iconografica
che il vescovo, grazie agli
artisti di spicco giunti al
suo seguito, fece nei mosaici
parietali all'interno
dell'edificio votivo.
Il
grande vescovo parentino
subordinò totalmente la
chiesa a sé stesso: fece
iscrivere le proprie iniziali
in vari punti strategici,
mentre nei mosaici dell'abside
si fece raffigurare nello
spazio dedicato esclusivamente
ai santi e ai martiri, alla
Madonna e al Cristo, palesando
in modo inequivocabile la
posizione in cui egli stesso
si collocava. In tali gesti,
autoritari prima ancora che
narcisistici, si celano
numerosi significati,
riconducibili anche al
rapporto del presule con il
papa, che lo esecro e lo
dichiaro apostata.
Giungendo
a Parenzo alla meta del VI
sec., Eufrasio trovò una città
con un lungo passato. Il suo
strato visibile rispondeva
appieno ai caratteri della
tipica città provinciale
tardo antica, logorata dalle
avversità del tempo o, più
propriamente, dalle orde dei
Barbari che proprio in
quell'epoca posero fine ad una
ricca tradizione. L'agonia di
Roma avvenne in quest'area con
dei ritmi più dilatati.



Assumendo
la guida della diocesi,
Eufrasio si mise a capo di una
comunità cristiana ben
organizzata, che nel corso
della sua lunga storia diede
alla Chiesa alcuni santi e
martiri, tra i quali San
Eleuterio e San Mauro
(Maurus). Figura eminente,
quest'ultimo fu vittima a
Parenzo delle grandi
persecuzioni assieme a tutto
il clero e a numerosi laici.
Il
periodo compreso tra le ultime
persecuzioni dei cristiani,
all'inizio del IV sec., e la
metà del VI sec., fu l'epoca
in cui Parenzo, con il vescovo
Eufrasio, raggiunse l'apogeo
del suo sviluppo,
caratterizzata dal continuo
consolidamento del potere
ecclesiastico. Testimoni dello
status della chiesa furono i
numerosi edifici sacrali che
sorsero in tutta l'Istria, tra
i quali le basiliche parentine
assunsero una particolare
rilevanza. La seconda meta del
V sec. fu segnata dalle orde
dei Barbari, che attaccarono
perfino Roma e altri punti
strategici dell'Impero. Le
impetuose trasformazioni
portate dall'esterno da
personaggi come Alarico,
Attila re degli Unni e
Odoacre, che - nel 476 -
divenne re d'Italia (il cui
posto verrà preso nel da 493
Teodorico), non interessano
l'Istria che marginalmente.
Alla fine del V sec. la
regione e parte dello stato
ostrogoto; nel 539, con
Giustiniano, essa entra a far
parte dell'Impero Romano
d'Oriente, ovvero di Bisanzio.
ATTRAVERSO
I SECOLI
Mantenere
una cattedrale così grande e
di così elevato valore
artistico non fu certo facile.
La basilica e gli edifici
nelle sue immediate vicinanze
hanno naturalmente subito dei
danni, dovuti sia all'usura
del tempo, sia ad altri
fattori. Tuttavia, se
consideriamo la storia
dell'Eufrasiana possiamo
distinguere agevolmente un
filo conduttore costituito
dalla serie ininterrotta di
restauri e di adeguamenti ai
gusti e alle esigenze di
ciascuna epoca. I documenti
riportano i dati sulla
riparazione del tetto della
basilica, avvenuto nel '300 e
sugli interventi edili di più
ampie proporzioni compiuti a
seguito del terremoto che colpì
la città nel '400. Nel corso
dello stesso secolo fu eretto
il nuovo edificio della
sacrestia, furono murate le
ultime tre campate al fine di
collocarvi i sedili del coro e
vennero aperte le finestre
delle absidi laterali,
danneggiandone cosi i mosaici.
L'atrio
e il battistero subirono
pesanti lesioni nel '500
quando, durante la pestilenza,
l'atrio fu adibito a cimitero.
Nel '600, il vescovo Tommasini
descrive le parti del
complesso eufrasiano come dei
ruderi, con il tetto della
cattedrale seriamente
danneggiato, mentre all'inizio
del '700 quest’ultima rischiò
di crollare. Tuttavia, i
documenti narrano anche
dell'impegno dei cittadini
volto alla preservazione del
più prezioso retaggio dei
loro antenati. La chiesa
fu restaurata nel 1711 e dopo
un certo periodo in essa si
poterono di nuovo celebrare le
funzioni religiose. La
ristrutturazione del tetto del
XVIII sec. ebbe gravi
conseguenze sul mosaico
dell'arco trionfale; vennero
murate le finestre della
navata centrale e ne furono
aperte delle nuove secondo il
gusto barocco. Nel XIX sec. si
iniziò a correggere alcuni
errori di costruzione commessi
nei periodi precedenti e ad
eseguire gli interventi di
restauro continuati nel corso
di questo secolo. Tali
restauri e gli interventi sui
mosaici, spesso eccessivi,
mutarono profondamente
l'aspetto originario della
chiesa.

L'ERA
PRE-EUFRASIANA
Quando
il vescovo Eufrasio inizio a
mettere in atto i suoi grandi
interventi, non soltanto di
natura costruttiva, non parti
da nulla. Sul terreno su cui
sorse la sua maestosa basilica
e una serie di edifici
annessi, esistevano gia altre
costruzioni sacrali databili
al IV sec., probabilmente agli
anni immediatamente successivi
al 313. Le prime comunità
cristiane, finché questa
religione non fu ancora
riconosciuta, adattarono anche
qui qualche edificio
preesistente per il culto. Il
pavimento del primo oratorio,
i cui resti furono rinvenuti
nelle immediate adiacenze
della stessa Eufrasiana, fu
ricoperto da mosaici in cui
figurano i motivi del
viticcio, del meandro e delle
figure di pesci
dall'inequivocabile
significato simbolico.
Nella
parte superiore del mosaico
quadrato con il cantaro si
trovano le iscrizioni con i
nomi dei donatori, che
commissionarono questo
meraviglioso pavimento musivo,
e le sue dimensioni espresse
in piedi. Negli scavi nella
navata settentrionale
dell'Eufrasiana vennero alla
luce numerosi esempi di
mosaici analoghi recanti i
nomi dei donatori e proprio
grazie a questi mosaici e le
iscrizioni conservatesi si
possono interpretare con
precisione le fasi della
costruzione, le
ristrutturazioni, le
ricostruzioni: in altre
parole, la dinamica
dell'esistenza della comunità
cristiana a Parenzo dell'epoca
pre-eufrasiana.
Dall'iscrizione di una lapide
apprendiamo della traslazione
delle spoglie del vescovo
Mauro, santo e martire
parentino, dal cimitero
situato al di fuori della città
in luogo "dove egli fu
vescovo". Tale luogo fu
una nuova sala costruita a
fianco del precedente oratorio
e ad esso identica, che formo
cosi una basilica gemella,
detta basilicae geminae.

LE
CONDIZIONI TROVATE
La
nuova basilica di vaste
dimensioni, costruita nel V
sec., si inserì nelle
preesistenti costruzioni
sacrali. Si trattò di una
sala a tre navate di pianta
rettangolare regolare priva di
abside, con un muretto
semicircolare adibito a
subsellia. La basilica,
analogamente ad altre chiese
istriane del V sec., sorse
sotto l'influsso
dell'architettura
caratteristica della costa
adriatica orientale e di
quella del Vicino Oriente. I
costruttori locali inserirono
tali elementi nel loro
patrimonio, retaggio
dell'architettura
paleocristiana e di quella
romana profana. I muri vennero
costruiti con pietre di cava
sbozzate che richiesero spessi
strati di intonaco e vennero
rinforzati da lesene. Questo
fu l'inventario elementare che
Eufrasio trovò quando giunse
nella sua nuova diocesi alla
meta del VI sec.
Nell'abside
della sua basilica, al di
sotto della scena centrale
dominata dalla figura della
Madonna con Cristo attorniata
dalle figure del vescovo
Eufrasio, dell'arcidiacono
Claudio, del martire Mauro ed
alcuni altri personaggi, si
trova l'iscrizione latina con
cui il vescovo spiega il
motivo che lo spinse ad
intraprendere questa opera
imponente. Il testo tradotto
recita: All'inizio questo fu
un tempio vacillante e cadente
in pericolo di crollo e non fu
consolidato con forza sicura,
angusto e non fu decorato con
oro, mentre il tetto logoro
resisteva per pura
grazia.
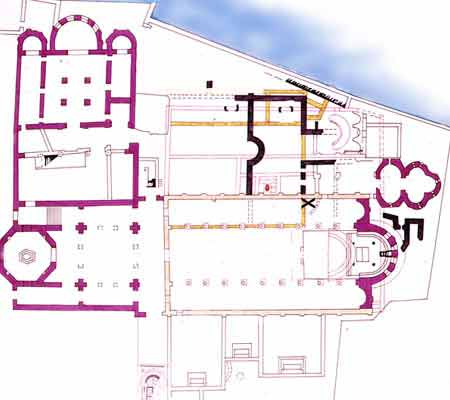 Quando
premuroso e alla fede devoto
sacerdote Eufrasio vide che la
sua sede fu minacciata dal
pericolo di crollo sotto il
peso con sacro proposito
prevenne il cedimento e per
consolidare meglio l'edificio
cadente lo smantellò, costruì
le fondamenta ed eresse il
comignolo del tempio. Questo
che tu testé vedi splendere
in oro (egli) abbellì
terminando l'opera iniziata e
regalò grandi doni, evocando
il nome di Cristo consacrò la
chiesa rallegrandosi
dell'opera. Quando
premuroso e alla fede devoto
sacerdote Eufrasio vide che la
sua sede fu minacciata dal
pericolo di crollo sotto il
peso con sacro proposito
prevenne il cedimento e per
consolidare meglio l'edificio
cadente lo smantellò, costruì
le fondamenta ed eresse il
comignolo del tempio. Questo
che tu testé vedi splendere
in oro (egli) abbellì
terminando l'opera iniziata e
regalò grandi doni, evocando
il nome di Cristo consacrò la
chiesa rallegrandosi
dell'opera.
Questa
dichiarazione del vescovo non
corrisponde del tutto alla
realtà, in quanto la basilica
che Eufrasio trovò non fu
affatto cadente e ornata con
decorazioni modeste. Parte dei
muri e le basi delle colonne
furono riutilizzate nella
costruzione della nuova chiesa
e per quanto concerne i
mosaici essi non mancavano
nemmeno nella basilica del V
sec. I motivi della
riedificazione vanno ricercati
innanzitutto nel gusto del
nuovo periodo e nell'ambiente
in cui Eufrasio visse prima di
recarsi a Parenzo.
Uno
di questi grandi elementi
innovativi è la porzione
orientale della basilica
Eufrasiana, che termina con
tre absidi: alla navata
centrale corrisponde l'abside
maggiore la cui parete esterna
è poligonale, mentre le
absidi delle due navate
laterali vennero ottenute
tramite due concavità
semicircolari ricavate nella
massa del muro che all'esterno
appare diritta.
Tale
intervento fece si che una
basilica a tre navate - la cui
parete posteriore si conclude
con tre absidi, vale a dire
con tre centri visuali e di
culto e con tre altari
separati - venisse concepita
per la prima volta in
Occidente in modo tale da
formare un'unica unita
spaziale.
II
EPISCOPATO
L'Eufrasiana
rappresenta soltanto la parte
centrale di un complesso più
ampio. L'episcopato, che
conservò soltanto in parte il
suo aspetto originale, è
situato a nordest rispetto
alla basilica ed è collegato
con il suo nartece attraverso
uno stretto corridoio. In
origine si trattò di una
costruzione ad un piano a
semplice pianta quadrangolare
e con un'unica grande abside.
Nella rappresentativa sala
centrale al primo piano,
salutatorium o segretarium,
davanti all'abside si trovava
il tribelon, di cui si sono
conservati solo dei frammenti:
la colonna con il capitello e
gli archi recanti resti di
stucco e di decorazioni
marmoree. In questa sala il
vescovo riceveva il clero e i
religiosi al di fuori della
liturgia.
GLI
SPAZI DELLA BASILICA
L'entrata
nella basilica è costituita
da un nartece, costruito sopra
una via preesistente, mentre
lo spazio antistante il
nartece appartiene ad un
armonioso atrio aperto a
pianta quadrata. Di fronte
all'entrata nella basilica è
situato il battistero
ottagonale, che risale
all'epoca pre-eufrasiana e
riprende la tradizione
dell'architettura tardo
antica, mentre la struttura
del muro e la costruzione
lignea del tetto sono opera di
costruttori locali.
In
prossimità dell'angolo nord
orientale della basilica fu
costruita la memoria, la cui
pianta si distingue da quelle
degli edifici nelle sue
dirette adiacenze. Davanti
all'entrata della cappella a
pianta trilobata, in cui
venivano custodite le
reliquie, si trova un
vestibolo ovale, mentre le tre
absidi al suo esterno hanno
forma poligonale. Nel XIX sec.
l'intero edificio fu
sottoposto ad un intervento di
restauro. Nell'atrio, nel
battistero e anche in una
parte dei muri furono
inglobate in buona parte delle
porzioni di costruzioni che
Eufrasio trovò all'inizio
della sua impresa. Le
ricostruzioni depongono a
favore di un concetto preciso
che Eufrasio utilizzò per
dare forma al suo grande
complesso; proprio tale
concetto esprime lo spirito
dei tempi nuovi e l'audacia
visionaria di Eufrasio.
  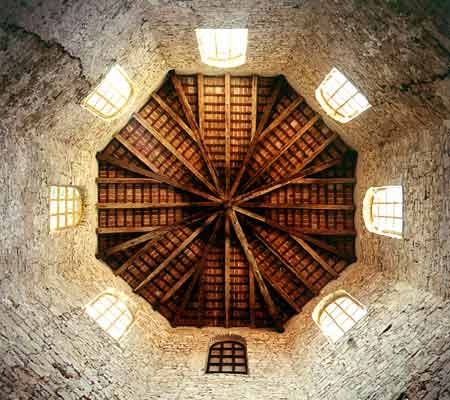
I
segni visibili delle presenza
di Eufrasio, ma anche dello
spirito d'Oriente, si possono
scorgere nella ricca
decorazione dell'interno della
basilica. Le navate sono
separate da due serie di nove
arcate che alla loro estremità
occidentale e quella orientale
si appoggiano ai pilastri
addossati al muro. Le arcate
sono formate da colonne di
marmo grigio che si ergono
sopra le basi abilmente
scolpite, mentre la loro parte
superiore termina con dei
capitelli sovrastati da
imposte con i medaglioni
circolari recanti il
monogramma inciso di Eufrasio.
I capitelli stanno ad indicare
in modo inequivocabile
l'origine dei principi
estetici del vescovo
costruttore. Da essi traspare
le raffinatezza dell'elevata
arte bizantina sia che i
capitelli corinzi compositi
vengano variati in modo
singolare, sia che le
superfici della piramide mozza
capovolta si aprano con ricche
perforazioni che formano degli
ornamenti simili all'intreccio
o alla vegetazione stilizzata.
All'inventario
scultoreo dell'Eufrasiana va
aggiunta anche una serie di
plutei marmorei decorati con
bassorilievi poco profondi
raffiguranti i simboli (croci,
monogrammi, uccelli, cervi,
cantaro, corna stilizzate).
Nelle arcate sul lato
settentrionale si sono
conservate le stuccature
originariamente dipinte. A
questo splendore visuale si
debbono aggiungere anche le
incrostazioni della porzione
inferiore dell'abside dove il
rivestimento di marmi
policromi e di madreperla
formano fantasiosi ornamenti.
Nell'abside sono collocati
sedili marmorei per i
sacerdoti che ai lati vengono
delimitati da lastre di marmo
con i bassorilievi
raffiguranti i delfini, mentre
al centro del semicerchio si
erge la cattedra episcopale.
I
MURI

Passando
dallo spazio alle superfici
dei muri dell'Eufrasiana, tra
lo splendore dei mosaici, si
scorgono altrettante opere
d'arte tra cui anche
un'innovazione iconografica
introdotta per la prima volta
in Occidente. A Parenzo,
infatti, la posizione centrale
nell'abside e occupata dalla
Madonna, che sino a quel
momento apparteneva
esclusivamente a Cristo.
La Madonna
e raffigurata seduta sul trono
con Gesù bambino sulle
ginocchia che indossa vesti
romane solenni e tiene la mano
destra innalzata nel gesto
della benedizione. Accanto
alla Madonna si trovano due
angeli, uno per parte, che
guidano gruppi di persone che
vengono a porgerle il saluto.
Da sinistra ad essa si
avvicinano tre martiri senza
nome con delle ghirlande in
mano e cinti da aureole;
anch'essi, come gli angeli,
indossano delle vesti romane
solenni.
Dall'altra
parte, dietro gli angeli,
incede San Mauro, raffigurato
allo stesso modo dei tre
martiri ma, a differenza di
questi ultimi, con
l’iscrizione del nome
accanto all'aureola. Questo
vescovo e santo parentino
guida un gruppo
particolarmente interessante,
composto da tre persone
vissute in quel periodo: il
vescovo Eufrasio, che nelle
mani tiene il modello della
sua basilica, l'arcidiacono
Claudio, fratello di Eufrasio.
Tra i due un bimbo che, stando
all’iscrizione, sarebbe
stato il figlio
dell'arcidiacono, chiamato
anch'egli con il nome di
Eufrasio. Era necessaria una
notevole audacia perché il
donatore e due suoi
contemporanei, per di più
parenti, invadessero lo spazio
riservato alle più alte
gerarchie celesti. Eufrasio
evidentemente non fu un
semplice mortale e sedizioso
che oso sovvertire le rigide
norme ecclesiastiche. Le facce
e i gesti degli angeli e dei
santi martiri del corteo che
circondano
la Madonna
sul trono, nonostante le belle
vesti romane, sono in un certo
qual modo tipizzati, mentre i
personaggi viventi di fronte
ad essi, che si avvicinano al
trono celeste, sono
raffigurati senza le aureole e
in modo individualizzato, come
se davvero si trattasse di
ritratti.
I
MOSAICI

La
Madonna
,
collocata nella parte
superiore dell'abside,
rappresenta il punto centrale
della basilica Eufrasiana e
nel suo grembo e seduto Gesù
bambino. Questi due personaggi
sono anche le figure centrali
del cristianesimo. Esiste
nell'iconografia cristiana un
episodio in cui
la Madonna
e il Cristo, figlio suo e di
Dio, si avvicinano
maggiormente quasi a
raggiungere una
compenetrazione completa. Si
tratta della scena
dell'Annunciazione, il momento
in cui Dio entra in un corpo
umano, in quello di Maria.
L'annunciazione
nell'iconografia compare in
base al Vangelo secondo Luca e
viene integrata dal
protovangelo apocrifo di
Giacomo, dallo pseudo-vangelo
apocrifo di Matteo, e più
tardi dai motivi presenti
nella letteratura predicatoria
e mistica. La scena
dell'annunciazione compare
molto presto nell'iconografia
e può essere trovata già nel
IV sec. nelle catacombe
romane, per svilupparsi poi a
partire dal V sec. in una
tipologia presente in modo
generalizzato con posizioni,
gesti, espressioni ecc. che
seguono delle norme ben
definite.
La
Madonna
viene raffigurata seduta sul
trono, generalmente con la
rocca e il filato nelle mani,
mentre l'angelo cammina
avvolto in splendenti vesti
antiche. La raffigurazione
della Madonna a Parenzo
corrisponde perfettamente a
questi canoni. Trattandosi
tuttavia dell'anno 540, del
periodo giustiniano e dello
spirito bizantino, essa
indossa vestiti di foggia
bizantina e la sua testa e
parzialmente coperta dal velo
chiamato maforion. Tale velo
ha un significato: esso
simboleggia la verginità e
proviene probabilmente
dall'arte siriana.
La Madonna
è seduta sul trono, le cui
colonne si fondono con quelle
vere della basilica.
Questa
rappresentazione trae le sue
origini dai commenti di S.
Ambrosio, che parlando
dell'Annunciazione nel Vangelo
secondo Luca ribadì il nesso
ovvero l'identificazione della
Madonna con
la Chiesa. Più
esattamente: come Maria,
nell'atto dell'annunciazione,
sia colma di Spirito Santo,
allo stesso modo della Chiesa.
L'Annunziata regge nella mano
sinistra il filato purpureo
poiché l'angelo l'ha colta al
lavoro e questo fattore di
sorpresa qui è rappresentato
dal gesto della mano destra,
che
la Madonna
avvicina alla propria testa
leggermente chinata. La
vistosa figura dell'angelo
posto di semiprofilo, la
posizione che in quell'epoca
fu una regola, saluta con la
mano destra mentre nella
sinistra tiene un lungo
bastone da messaggero. Egli
indossa delle splendenti vesti
antiche, le cui pieghe seguono
il rapido movimento del corpo,
che viene rappresentato dai
piedi divaricati, con il piede
destro che poggia a terra
soltanto con le dita.

Nell'abside
dell'Eufrasiana, di fronte
all'Annunciazione, è
raffigurata la scena della
Visitazione. Due corpi
femminili snelli, quello di
Maria, avvolto nelle vesti
purpuree, e quello di
Elisabetta, in vesti gialle,
mostrano evidenti segni di
gravidanza. Dietro
quest'ultima è raffigurata la
facciata dell'edificio, alla
cui porta si affaccia una
figura di ragazza con la mano
accostata alle labbra. Questo
gesto, colmo di graziosa
curiosità, conferisce ai due
personaggi principali un'aria
ancor più dignitosa e
solenne. Maria ed Elisabetta
appartengono ad un'altra
gerarchia di personaggi: esse
sono le elette che portano nei
loro grembi i grandi
protagonisti che avrebbero
mutato il destino del mondo e
del tempo.
Nella
parte centrale dell'abside,
tra queste due scene
principali tratte dalla vita
di Maria, in campi separati
delimitati da finestre, sono
collocate le figure di S.
Zaccaria, di un angelo e di S.
Giovanni Battista. Nella
porzione inferiore dell'arco
trionfale si trovano tredici
medaglioni di forma circolare;
in quello centrale è
raffigurato il Cristo come
Agnus Dei, mentre quelli
laterali, sei per lato, recano
le immagini delle sante con i
loro nomi. Nella parte
conclusiva del mosaico, sulla
parete frontale dell'abside,
è collocato un fregio
composto da immagini degli
apostoli, quasi identiche, con
al centro il Cristo
raffigurato come un giovane
sovrano che, seduto sul globo,
governa l'Universo. Gli
apostoli invece, con ritmo
monotono e in modo simmetrico,
ad entrambi i lati, circondano
la figura del sovrano divino.
Essi tengono nelle mani,
coperti dal manto, gli
attributi mentre tra le
aureole circolari compaiono le
scritte con i loro nomi.
 Nelle
zone superiori delle absidi
laterali si sono conservati i
frammenti del mosaico
raffigurante delle scene quasi
identiche: la grande immagine
di Cristo emerge dalle nuvole
stilizzate e cinge con
l'alloro le teste di due
martiri. I mosaici non
coprirono solo l'interno della
chiesa: li troviamo infatti
anche al suo esterno sulla
facciata sovrastante il
nartece. Dalle parti
conservate non è facile
risalire all'aspetto
originario, considerato che i
mosaici nella parte superiore
sono quasi completamente
scomparsi, mentre in quella
inferiore furono modificati
durante il restauro effettuato
nel XIX sec. I mosaici del
frontone, andati distrutti,
raffiguravano Cristo seduto
sul globo sotto il quale
scorrevano i quattro fiumi del
paradiso mentre sul lato
sinistro c'erano quattro
apostoli. Nella parte
inferiore, negli spazi
laterali, sono rappresentati
due apostoli e in quelli
centrali, separati da una
finestra, si trovano i sette
candelieri apocalittici. Nelle
zone superiori delle absidi
laterali si sono conservati i
frammenti del mosaico
raffigurante delle scene quasi
identiche: la grande immagine
di Cristo emerge dalle nuvole
stilizzate e cinge con
l'alloro le teste di due
martiri. I mosaici non
coprirono solo l'interno della
chiesa: li troviamo infatti
anche al suo esterno sulla
facciata sovrastante il
nartece. Dalle parti
conservate non è facile
risalire all'aspetto
originario, considerato che i
mosaici nella parte superiore
sono quasi completamente
scomparsi, mentre in quella
inferiore furono modificati
durante il restauro effettuato
nel XIX sec. I mosaici del
frontone, andati distrutti,
raffiguravano Cristo seduto
sul globo sotto il quale
scorrevano i quattro fiumi del
paradiso mentre sul lato
sinistro c'erano quattro
apostoli. Nella parte
inferiore, negli spazi
laterali, sono rappresentati
due apostoli e in quelli
centrali, separati da una
finestra, si trovano i sette
candelieri apocalittici.
IL
CIBORIO
Nel
XIII sec., la città di
Parenzo cominciò a
riprendersi dopo un lungo
periodo di crisi e di
stanchezza e ciò lasciò il
segno nella cattedrale. Sette
secoli dopo Eufrasio, nella
basilica da egli edificata,
venne collocato un nuovo
capolavoro. Nel 1277 fu
costruito infatti un imponente
ciborio marmoreo commissionato
dal vescovo Ottone. Il suo
alto baldacchino è sorretto
da quattro sottili colonne che
appartennero al ciborio
precedente e anche il nuovo
baldacchino e ricoperto da
mosaici.
Sul
lato frontale riporta la
stessa scena iconografica già
raffigurata sulla parete
dell'abside - l'Annunciazione.
I tempi diversi naturalmente,
comportarono una serie di
mutamenti. La collocazione
delle figure di Maria e
dell'Arcangelo Gabriele in
spazi diversi, ossia nei
segmenti triangolari sopra
l'arco, impose sicuramente
anche diversi processi di
composizione. Sul lato
sinistro si trova l'angelo con
le mani sollevate in segno di
saluto e il bastone da
messaggero sulla spalla. Il
suo passo adesso è più
vigoroso, come lo indicano
anche le numerose pieghe della
veste e le ali discostate.
Lo
spazio tra l'angelo e Maria,
su entrambi i lati, è
occupato da un albero curvato.
Maria adesso sta in piedi
davanti al trono dietro al
quale, anche in questa
raffigurazione, sono
presenti degli edifici. La sua
espressione, con il capo
completamente chinato in segno
di confusione, è accompagnata
dal gesto della mano: il palmo
interamente aperto è
sollevato verso l'alto. I
nuovi tempi cercarono di
rappresentare i stati d'animo
con molta più retorica. Il
vescovo Ottone, in qualche
modo, riuscì a ripercorrere
il processo che molto prima di
lui fu messo in atto dal suo
predecessore: un processo di
compenetrazione reciproca
delle tracce culturali. Anche
in quell'epoca, come nel IV
sec., vennero ripresi degli
elementi dei periodi
precedenti e inseriti nelle
nuove opere.
Le
colonne e i capitelli alto
bizantini sorreggono la
costruzione del nuovo
baldacchino gotico ricoperto
di mosaici che annunciano in
modo chiaro come una
tradizione sia terminata e le
subentri un'altra, in cui le
tracce di Bisanzio vanno
sempre più atrofizzandosi per
scomparire del tutto in tempi
piuttosto brevi.
I
mosaici e gli archi acuti
infatti, svelano la loro
origine veneziana. Questi
elementi, tuttavia, in un
certo senso furono molto più
innovativi dei gusti che in
quegli anni fecero da padroni
a Venezia. Essi furono più
progrediti poiché da essi
traspiravano anche delle
referenze caratteristiche del
rinnovamento paleologico della
pittura di Costantinopoli.
L'INFLUENZA
VATICANA
In
tal modo, nel presbiterio
della cattedrale parentina
l'Oriente e l'Occidente
entrarono nuovamente in
contatto, con la differenza
che la presenza di Venezia fu
più incisiva. Venezia e
Parenzo uscirono insieme
dall'area dominante bizantina
e si orientarono verso
l'Occidente. Questo
orientamento traspare anche
negli affreschi
quattrocenteschi alquanto
naif, che ci sono pervenuti
sotto forma di pochi
frammenti, e nell'acquisto del
polittico rinascimentale di
Antonio Vivarini, ma anche in
tutta una serie di altre opere
create a Parenzo o qui
importate permanentemente.

|