|
Traù
è considerata una delle città
veneziane più belle e meglio
conservate dell'intera
Dalmazia. Secondo l'autorevole
critico Bernard Berenson poche
città al mondo annoverano
tante opere d'arte in così
poco spazio.
La
città fu fondata dai greci
della stirpe ellenica dei Dori
di Siracusa col nome di
Tragurion. L'imperatore
Claudio vi installò i suoi
onorevoli veterani. Fu
sede vescovile dall'XI secolo.
Dopo vari secoli di alterne
vicende, comprendenti anche la
conquista da parte dei
saraceni e la distruzione
della città nel 1123, nel
1420 inizia un lungo periodo
di prosperità sotto il
controllo della Repubblica di
Venezia che ebbe termine solo
nel 1797.
Si
susseguirono quindi alcuni
passaggi di sovranità fra la
Francia napoleonica (dal 1806
al 1809 Traù fece parte del
napoleonico Regno d'Italia e
dal 1809 al 1813 delle
Provincie Illiriche) e
l'Impero d'Austria, poi la
città venne stabilmente
incorporata in quest'ultimo
assieme al resto della
Dalmazia. Nel 1828 la diocesi
di Traù fu soppressa. Questo
secondo periodo della storia
di Traù durò fino al termine
della prima guerra mondiale
nel 1918.
Durante
il periodo della dominazione
austroungarica, Traù divenne
uno dei teatri dello scontro
che opponeva gli autonomisti
dalmati agli unionisti, che
reclamavano l'unione della
Dalmazia alla Croazia. I primi
- fra i quali gli esponenti
delle famiglie cittadine
italiane e italofile -
governarono Traù fino al
1887, favoriti prima del 1850
dal fatto che la maggioranza
dei cittadini di Trau erano
italiani. Successivamente al
1860 il partito autonomista
dei Dalmati italiani rimase al
potere anche grazie ad un
meccanismo elettorale che
privilegiava la rappresentanza
delle classi più abbienti ed
istruite (in prevalenza
italiane) alla massa popolare
(diventata quasi totalmente
croata a seguito di notevoli
immigrazioni dalle campagne
circostanti nella seconda metà
del secolo XIX).
Secondo
i censimenti austriaci nel
1880 si contavano 1960
Italiani su 3129 abitanti, che
negli anni successivi
diminuirono bruscamente quando
il Podestà del "Partito
autonomista" italiano
della città fu sostituito da
quello "unionista"
croato (gli Italiani erano
solo 171 nel censimento del
1890 e 170 in quello del
1900).
Al
termine del primo conflitto
mondiale, Traù entrò a far
parte dello Regno dei Serbi,
Croati e Sloveni, divenuto
successivamente Regno di
Jugoslavia, fino alla seconda
guerra mondiale. Durante
questo conflitto la città
venne occupata da truppe
italiane ed annessa al Regno
d'Italia, come buona parte
della Dalmazia. La città
venne liberata dai partigiani
di Tito nel 1944. Dopo aver
fatto parte della Repubblica
Socialista di Croazia
all'interno della nuova
Jugoslavia per oltre 40 anni,
dal 1991 fa parte della
Repubblica di Croazia.

Traù
fu teatro, dopo la prima
guerra mondiale, di un
tentativo irredentista simile
a quello dannunziano a Fiume.
Il
23 settembre 1919, sotto la
suggestione dei contemporanei
eventi della Impresa di Fiume,
un vero e proprio atto in
stile dannunziano fu
organizzato in città dal
conte Nino Fanfogna,
trentaduenne appartenente ad
una delle più importanti ed
antiche famiglie di Traù
nonché discendente
dell'ultimo podestà italiano
della città.
Siccome
le truppe italiane avevano
occupato le aree della
Dalmazia assegnate all'Italia
dal Trattato di Londra del
1915, ma Traù non era inclusa
in queste aree distanti una
quindicina di chilometri, Nino
Fanfogna tentò di forzare la
situazione come aveva fatto
D'Annunzio a Fiume.
Infatti
il conte Fanfogna convinse il
tenente Emanuele
Torri-Mariani, che comandava
alcuni ufficiali italiani di
stanza a Prapatnica (Pianamerlina),
al confine fra il territorio
dalmata occupato dall'Italia e
la regione controllata dagli
Jugoslavi, ad organizzare una
spedizione che occupasse la
sua città nativa.
 La
notte del 23 settembre un
centinaio di soldati italiani
e il Fanfogna, con 4
autocarri, oltrepassarono i
posti di frontiera jugoslavi e
di sorpresa e senza
spargimento di sangue
occuparono Traù. Il reparto
italiano assunse il comando
della città nominando
Fanfogna
"Dittatore". La
spedizione avrebbe potuto
provocare lo scoppio di un
conflitto militare fra Regno
d'Italia e Regno di
Jugoslavia, ma questa
eventualità venne scongiurata
dal pronto intervento degli
ufficiali italiani della nave
Puglia e dei militari
americani di stanza a Spalato. La
notte del 23 settembre un
centinaio di soldati italiani
e il Fanfogna, con 4
autocarri, oltrepassarono i
posti di frontiera jugoslavi e
di sorpresa e senza
spargimento di sangue
occuparono Traù. Il reparto
italiano assunse il comando
della città nominando
Fanfogna
"Dittatore". La
spedizione avrebbe potuto
provocare lo scoppio di un
conflitto militare fra Regno
d'Italia e Regno di
Jugoslavia, ma questa
eventualità venne scongiurata
dal pronto intervento degli
ufficiali italiani della nave
Puglia e dei militari
americani di stanza a Spalato.



Giunta
a Spalato nella prima
mattinata la notizia
dell'occupazione di Traù,
alle ore 10 del 24 settembre
il capitano di corvetta Paolo
Maroni - comandante in seconda
della "Puglia" - e
l'ufficiale americano Field
partirono per Traù con il
compito di persuadere i
soldati sconfinati a rientrare
nelle linee italiane. Convinti
i comandi serbi a non lanciare
per il momento nessun attacco,
Maroni e Field giunsero a Traù
ed iniziarono a negoziare con
gli occupanti e Fanfogna il
ritiro dalla città. Fanfogna,
descritto nei documenti
italiani come uomo "incosciente"
e privo di capacità politica,
enormemente preoccupato per
quanto gli poteva capitare
all'allontanarsi degli
Italiani, insistette perché
le truppe italiane non
partissero, ma poi si lasciò
convincere.
Nel
frattempo a Traù arrivarono
alcune navi americane al
comando dell'ammiraglio Van
Hook. A quella vista la
popolazione croata della città,
ripreso animo, cominciò sulla
riva e in piazza una violenta
dimostrazione contro i soldati
italiani, alcuni dei quali
vennero anche aggrediti e
disarmati. Alcune fucilate
sparate qua e là sortirono
l'effetto di far dileguare
rapidamente la folla e di
affrettare lo sbarco della
compagnia americana che era
sul "Cowell".
Nel
momento del trambusto il conte
Fanfogna si ritirò in casa
sua (il celebre palazzo
Garagnin-Fanfogna), vi si
rinchiuse e non si fece più
vedere. Solo un vecchio,
Achille De Michelis, si
avvicinò al comandante
Maroni, e dichiarandosi il più
anziano del "Fascio
Italiano", dopo aver
protestato contro
l'incredibile leggerezza del
conte Fanfogna, si mise a
disposizione del Maroni per
facilitargli il compito e per
tutto quello che potesse
occorrergli dagli Italiani di
Traù. Frattanto,
disordinatamente, la compagnia
italiana coi tenenti De Toni,
Manfredi e Mantica evacuava
Traù e fra le ore 14 e le 15
rientrava nelle linee.
La
sciagurata spedizione di Traù
ebbe pesanti ripercussioni
sulle comunità italiane di
Traù e Spalato. Il
governatore jugoslavo,
colonnello Plesnicar,
procedette all'arresto di
numerosi esponenti italiani
della cittadina. Finirono
arrestati Nino, Simeone e
Umberto Fanfogna, Vincenzo
Santich, Achille De Michelis,
Giorgio De Rossignoli, Lorenzo
Lubin, Giacomo Vosilla,
Antonio Strojan, Marino,
Michele e Spiridione Marini e
altri, anche se molti di
questi erano estranei alla
vicenda. Molti furono quelli
che scamparono all'arresto
fuggendo nella Dalmazia
italiana.
Per
alcuni giorni gruppi di
teppisti, aizzati dalle
autorità governative
jugoslave, si diedero ad atti
vandalici contro abitazioni e
proprietà degli Italiani di
Traù e della regione dei
Castelli. La conseguenza della
spedizione fu la distruzione
politica del Fascio
Nazionale Italiano di Traù
e un deciso peggioramento
delle condizioni di vita dei
traurini di lingua italiana,
la maggior parte dei quali
successivamente emigrò in
Italia.
Fra
gli emigrati, la neonata Maria
Carmen Nutrizio, figlia del
farmacista di Traù e di una
Luxardo della nota famiglia
produttrice del Maraschino di
Zara, che diverrà celebre
come creatrice di moda col
nome di Mila Schön. Assieme a
lei il fratello decenne Nino
Nutrizio, anni dopo fondatore
del quotidiano La Notte.

La
città sorge su due isole
collegate alla terraferma da
due ponti ed è unita alla
vicina isola di Bua per mezzo
di un ponte girevole. Detta
anche la piccola Venezia, è
un piccolo gioiello che
conserva numerosi edifici
medievali di impronta
veneziana.
Traù,
con il suo centro storico
risalente quasi interamente al
XIII secolo e comprendente più
di 10 chiese diverse, ha nella
cattedrale romanica di San
Lorenzo (1180-1250) il suo
punto di maggiore interesse.
Altri
monumenti sono la Loggia
pubblica (1308), il Castello
del Camerlengo (1420-1437), il
Maschio di San Marco, la Torre
dell'orologio, palazzo
Cippico, la chiesa di san
Domenico, la chiesa di san
Nicola con annesso il convento
delle benedettine, la porta di
terraferma, la porta Marina e,
a fianco, la loggia della
Pescheria del 1527.
Parecchi
leoni di San Marco ornavano la
città, a memoria dell'antica
dominazione veneziana. Negli
strascichi della
pluridecennale lotta che
opponeva i croati ai
concittadini italiani ed
italianizzati (gli autoctoni
dalmatici ed i ricchi croati),
nei primi giorni di dicembre
del 1932 otto leoni vennero
distrutti da un gruppo di
Croati, anche con l'ausilio
della dinamite. Fra questi un
celebre leone andante,
bassorilievo di Nicolò
Fiorentino e Andrea Alessi del
1471, che ornava l'interno
della Loggia Pubblica.
Attualmente alcuni leoni
mutilati sono esposti al museo
cittadino o giacciono nell'ex
convento di S. Domenico.
Il
lungomare deve il suo fascino
alla contrapposizione tra le
belle architetture delle
abitazioni e le barche (spesso
veri e propri yacht di gran
lusso) ormeggiati lungo il
canali.
Cattedrale
di San Lorenzo

La
cattedrale è stata costruita
sulle fondamenta di cattedrale
paleocristiana distrutta dai
Saraceni nel 1123, durante il
sacco di Traù. I lavori
dell'attuale edificio
iniziarono nel 1213 e
terminarono nel XVII secolo.
Come la vecchia cattedrale è
dedicata a San Lorenzo, ma è
nota per la devozione a San
Giovanni. Il vescovo di Traù
Giovanni da Traù con il suo
stile di vita santa ha
attirato il re ungherese
Colomanno d'Ungheria che aveva
rilevato la Croazia e la
Dalmazia. La maggior parte del
lavoro ha avuto luogo nel XIII
secolo essendo per lo più
completo nel 1251. Questo vuol
dire che la maggior parte
della cattedrale è in stile
romanico, mentre l'interno
della volta, costruita nel XV
secolo, è in stile gotico.
I
lavori del campanile
iniziarono alla fine del XIV
secolo ed è stata completata
alla fine del XVI secolo. Il
primo piano è in stile gotico
ed è stato edificato dai
maestri Stejpan e Matej. Dopo
che era stato demolito dai
veneziani nel 1420, fu
ristrutturato ad opera di
Matija Gojkovič. Il secondo
piano, anch'esso in stile
gotico, è probabilmente opera
di maestri veneziani, in
quanto le finestre ricordano
quelle del Ca' d'Oro.
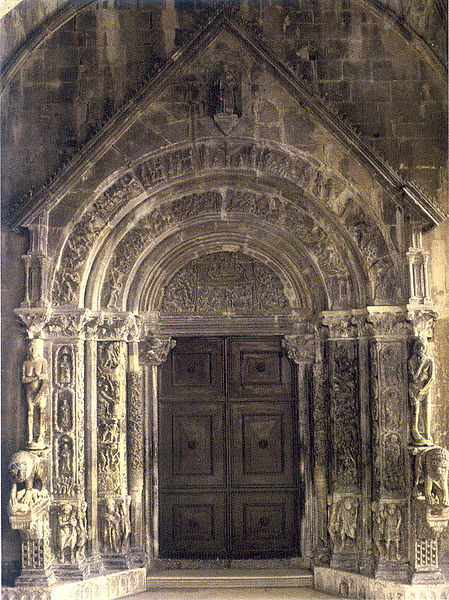 Il
piano definitivo fu costruito
da Trifun Bokanič
(1575-1609). In cima al
campanile ci sono quattro
statue, opera dello scultore
veneziano Alessandro Vittoria
(1525-1608). Al centro della
facciata, all'interno di una
piccola apertura circolare, vi
è scolpito lo stemma araldico
del più potente sovrano
ungherese della dinastia
angioina, Re Luigi I
d'Ungheria. Il
piano definitivo fu costruito
da Trifun Bokanič
(1575-1609). In cima al
campanile ci sono quattro
statue, opera dello scultore
veneziano Alessandro Vittoria
(1525-1608). Al centro della
facciata, all'interno di una
piccola apertura circolare, vi
è scolpito lo stemma araldico
del più potente sovrano
ungherese della dinastia
angioina, Re Luigi I
d'Ungheria.
La
Cattedrale di Traù è
l'esempio più arcaico in
Dalmazia nella costruzione
delle arcate interne con
pilastri allungati che
separano le due navate
laterali da quella centrale.
Ci sono tre absidi
semicircolari e una a volta
sopra il quale sorge il
campanile. Le volte a crociera
e le terrazze precedenti sopra
le navate sono di influenza
pugliese.
Un
ampio vestibolo è stato
aggiunto nel XV secolo e il
rosone gotico artisticamente
ben eseguito sulla facciata
occidentale è della stessa
epoca. In fondo alla sala
d'ingresso, vi è un
battistero in gotico e
romanico che è stato aggiunto
alla cattedrale nel 1467 da
Andrea Alessi (1430-1505), uno
scultore di origine albanese
allievo di Giorgio di Matteo.
La sacrestia gotica è stata
aggiunta nel XV secolo. La
parete esterna è divisa da
pilastri e fori con aperture
ad arco.



L'architetto
e maestro croato Radovan ha
lavorato sulla porta del
portale della cattedrale. La
maggior parte del portale è
stato scolpito dal maestro
stesso, ma sono riconoscibili
anche altre mani, come i suoi
allievi e i suoi seguaci.
Il
lavoro, finito e firmato nel
1240, è un'opera monumentale
e forse unica di questo grande
artista croato, infatti
l'iscrizione sulla lunetta
dice "il migliore di
tutti in questo
artigianato". In termini
di tematica il portale è
diviso in due parti: superiore
e inferiore. La parte
superiore mostra scene del
Vangelo e la vita di Cristo.
Sulla lunetta vi è la scena
della Natività, e dentro
l'arco sopra la lunetta vi
sono angeli che adorano Cristo
nella scena sottostante. La
lunetta e questo arco sono
opera di Radovan.
Sugli
stipiti interni ci sono scene
che mostrano i vari lavori
realizzati durante la stagioni
dell'anno. Radovan ha anche
lavorato sulle due piccole
colonne ricoperte dda rilievi.
Sugli stipiti esterni sono
raffigurati i santi e gli
apostoli e all'interno le
immagini sono decorate con
figure di animali esotici e
creature fantastiche come
centauri e sirene. A dominare
il portale sono però le forme
umane di Adamo ed Eva: i
nostri antenati peccaminosi
sono posti sul dorso di due
leoni. Altri artigiani degni
di nota che hanno partecipato
alla costruzione del portale
sono Ivan Budislavić e
Gregorio Vidov.

|