|
La
splendida cittadina di Amiens,
capoluogo della regione francese di Piccardia,
ha sempre avuto nella storia una posizione di
rilevo, grazie alla sua collocazione geografica
strategica: importante porto fluviale sulla
Somme era conosciuta ai Romani come "Samarobriva",
che significa, appunto, "Ponte
sulla Somme". Situata a metà strada
tra Parigi e Calais, Amiens era l’avamposto
ideale per cominciare la conquista della
Britannia. L’attuale toponimo sembra derivare
dal nome dell’antica tribù gallica degli
Ambiani (Ambianis),
che avevano in questa zona il proprio centro
principale.
Divenne
ricca e prospera durante il periodo medievale
grazie al fiorente commercio tessile, cosa che
tuttora la contraddistingue: era famosa
soprattutto per una pregiata varietà di lana,
che veniva tinta di azzurro grazie agli estratti
di una pianta che cresce abbondantemente in
questa zona.
Fu
proprio alle ricche gilde di lanaioli e
tessitori che il vescovo di
Fouilloy si rivolse, nel XII secolo, per
la raccolta dei fondi destinata alla costruzione
di una grandiosa Cattedrale, dedicata a Nostra
Signora (Nôtre-Dame
d’Amiens), che doveva rendere la sua
sede più prestigiosa di qualunque altra.
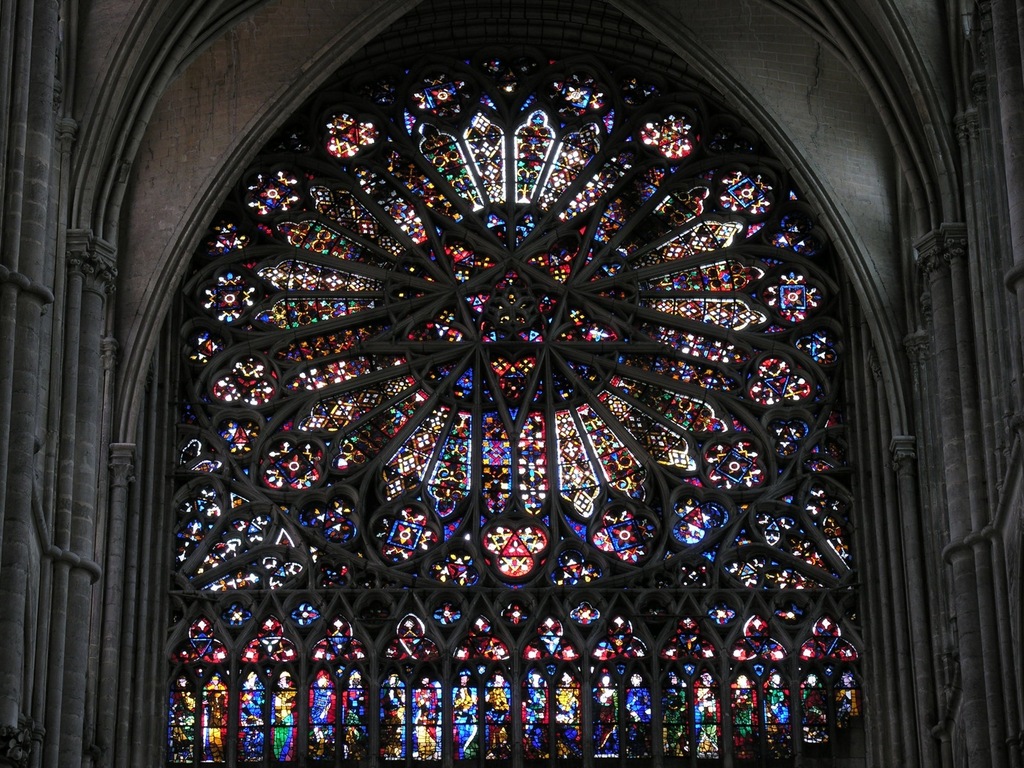
La
lapide sepolcrale del vescovo Evrard de
Fouilloy, nella cattedrale di Amiens, non lascia
dubbi sull'identità di colui che volle la
costruzione della chiesa, in quanto porta
scritto: "Fondamenta hujus basilica
locavit. Anno 1220". Infatti, fu
proprio lui a porre la prima pietra di questo
tempio nel quale sarebbe stato poi seppellito
sotto una magnifica tomba in bronzo, in cui è
effigiato con volto sereno, ma energico.
Agli
inizi del XIII secolo, in questa città di
lanaioli e mercanti arricchiti, devota al
martire pamplonese San Firmino che nel IV secolo
ne era stato vescovo, e a cui era consacrata la
prima cattedrale romanica, arrivò, in qualità
di vescovo, l'aristocratico Evrard de Fouilloy,
che aveva legami di parentela con l'alta nobiltà
ed era determinato a fare della sua sede una
delle più illustri di Francia. Com'era fin
troppo usuale all'epoca, un incendio avvenuto
nel 1218 distrusse la cattedrale in stile gotico
consacrata nel 1152 sotto la protezione della
Madonna, sorta sulla preesistente chiesa
romanica di San Firmino.
A
partire da allora, il gotico si era molto
evoluto, per cui il vescovo Fouilloy era già in
grado di intraprendere la costruzione di
un'opera molto più ambiziosa: la più grande,
la più bella mai costruita fino a quel momento.
Risulta evidente che un'opera simile richiedeva
un cospicuo investimento.
Vennero
fatte le consuete raccolte di denaro, portando
di paese in paese la collezione di reliquie
della cattedrale, ma la maggior parte dei fondi
furono devoluti dai borghesi della città, fieri
di poter vantare un così splendido monumento.









Come
indicato sulla lapide sepolcrale del vescovo, i
lavori iniziarono nel 1220. Incaricato del
progetto fu il canonico Robert de Luzarches. Il
suo nome appariva, assieme a quello di Thomas de
Cormont e del figlio Renault de Cormont, suoi
successori nella direzione dei lavori, in
un'iscrizione situata al centro del labirinto
costruito nella navata centrale. Qualcuno ebbe
l'avvertenza di copiare questo testo prima che
fosse smantellato. Nel 1288, data a cui risale
l'iscrizione, la cattedrale, a parte alcuni
lavori secondari, era praticamente terminata.
Contrariamente
alla consuetudine, i lavori cominciarono dalla
parte frontale, in modo che la facciata fu la
prima a essere conclusa, nel 1236. In
diciassette anni, dal 1220 al 1236, si
costruiscono alacremente la navata centrale, il
transetto e la fronte fino al rosone; dal 1236,
data della morte di Geoffroy d'Eu, successore di
Evrard de Fouilloy, fino al 1247, si dà opera
alle cappelle radiali; il coro è terminato nel
1269.
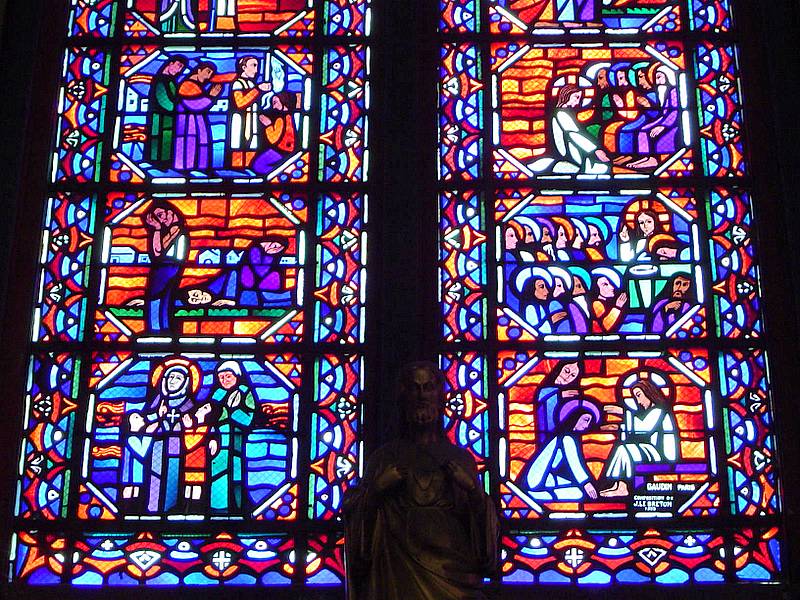
Il
più netto individuarsi del transetto, lo
sviluppo dato al coro, il moltiplicarsi delle
cappelle raggianti (ben sette, contro le cinque
di Chartres e Reims) sono tutti elementi che si
legano per contrasto fra loro rispetto al valore
sintetico dello spazio. Il tema della continuità
della struttura, dal pavimento alle coperture,
ha una compiuta soluzione: nel riprendere il
modello di Chartres, infatti, l'architetto porta
all'estremo il principio del pilastro composito,
liberando completamente la colonna su cui si
imposta l'arco nervato di separazione fra le
crociere e differenziandone altamente l'innesto
nel nodo costruito dai capitelli alla base degli
archi di passaggio alle navate secondarie. Così
lo sfaccettarsi dei capitelli delle colonne di
base, a causa della riduzione dimensionale di
quelli relativi agli archi della navata, e la
loro successiva interruzione dovuta al
sovrapporsi ad essi delle colonne continue,
creano una dialettica figurale accentuata dagli
elementi portanti le nervature di crociera.
Una
delle più geniali innovazioni di Robert de
Luzarches sono i nodi complessi dei capitelli,
che entrano in risonanza con la fascia continua
posta a cingere l'intero perimetro parietale al
di sotto del triforio, con il suo eccezionale
trattamento naturalistico a fogliami, vera e
propria cesura narrativa in un contesto
altamente antirappresentativo.
Il
transetto costituisce una chiave di lettura
fondamentale: al ritmo continuo della campata
della navata si sostituisce qui un'insaziabilità
spaziale che funge da centro di un molteplice
moto centrifugo verso i due bracci del transetto
a campate progressivamente digradanti. Un'altra
innovazione è costituita dall'uso delle
nervature supplementari nella crociera centrale.
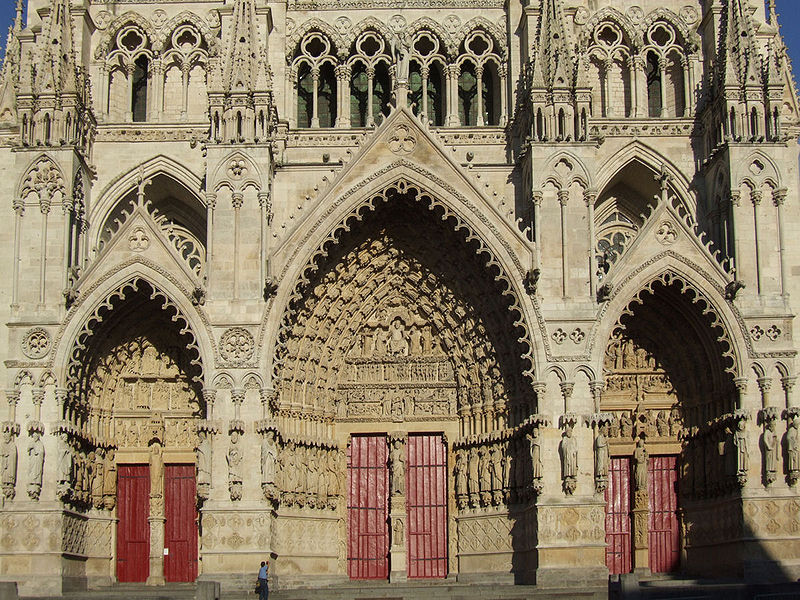
La
facciata principale, articolata in tre portali e
due imponenti torri disuguali per altezza e
disegni è impreziosita da un grande rosone. Fu
inoltre arricchita di un ciclo scultoreo
più imponente del previsto e fu aumentata
l'altezza delle volte, che raggiunse i
42,30 metri
, superando qualsiasi altra cattedrale francese,
salvo quella di Beauvais, che, però, pagò
tanta audacia con il suo prematuro crollo.
Questa
altezza smisurata, che rese obbligatorio l'uso
di doppi archi rampanti di sostegno, è in
armonia con la pianta di dimensioni eccezionali:
133,50 metri
di lunghezza e 65,25 metri
di larghezza sul transetto. Il modello segue i
canoni stabiliti a Chartres, con tre navate sia
nella parte frontale che nel transetto, e
un'ampia abside divisa in quattro settori. Il
deambulatorio, doppio ai lati ma semplice nel
tratto curvo, immette in sette cappelle radiali.
All'interno, le pareti sono suddivise
verticalmente in tre livelli, archi, trifore e
finestre, con la particolarità che la parte di
sfondo del triforio, generalmente chiusa, qui
adotta la struttura a vetrata.
L'iconografia
dei portali segue il modello di Notre Dame di
Parigi. Sul pilastro del portale centrale appare
la famosa statua di Cristo in atteggiamento
maestoso, popolarmente conosciuta come Beau
Dieu, e nel timpano la scena del Giudizio
universale. Il portale destro descrive la vita
di Maria, mentre quello sinistro è dedicato a
San Firmino e a storie del Santo.
La
statua più popolare tra tutte è la Vierge
Dorée, risalente
alla fine del XIII secolo e collocata nel
portale che si apre all’inizio del transetto
sud della chiesa. La rappresentazione mariana si
distacca notevolmente da quelle presenti sul
portale d’ingresso, molto più statiche e
ieratiche, mentre questa presenta una vivacità
che rappresenta pienamente la nuova tendenza del
gotico ad umanizzare maggiormente la figura di
Maria, accentuandone l’aspetto materno.


Nel
corso della storia la cattedrale di Amiens è
stata più fortunata di molte delle chiese
coeve. Quando, durante
la Rivoluzione francese, fu ordinata la
distruzione di tutte le immagini di re e di
santi, le autorità locali riuscirono a
proteggere quelle della cattedrale. Più tardi,
il tempio scampò ai bombardamenti delle due
guerre mondiali, per cui il suo ricco patrimonio
scultoreo è arrivato fino ai nostri giorni
praticamente intatto, benché in parte
modificato dai mediocri restauri del XIX secolo.
A questo ciclo è stato dato il nome di
"Bibbia di Amiens", data la
completezza delle rappresentazioni
iconografiche, che comprendono quasi tutti gli
episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento.
La
maggior parte delle sculture, che risale al XIII
secolo, inaugura uno stile che si diffonderà
oltre le frontiere francesi: basti pensare alla
cattedrale di Burgos in Spagna. Questa scuola
nacque forse in funzione di una richiesta
crescente di opere, che indusse gli artisti e
gli artigiani a cercare forme sempre più
stilizzate e uniformi, in modo da permettere la
produzione in serie. Il risultato sono figure
molto accademiche, dalle linee eleganti e di
grande bellezza, però fredde e distanti.
Nell'apparato
simbolico scolpito sulla facciata della
cattedrale, tra le centinaia di formelle
quadrilobate che decorano la facciata, tutte di
pregiata fattura, ne spiccano dodici che
rappresentano uno Zodiaco
completo, ai due lati del portale laterale
sinistro.
Sul
lato sinistro vi sono sei formelle che iniziano
con il segno Cancro e finiscono con quello del
Sagittario; dall’altro lato la sequenza
ricomincia con il Capricorno e finisce con i
Gemelli.
La scena, forse, più interessante dal punto di
vista simbolico, si trova attorno al portale
centrale. Essa rappresenta il tema del Giudizio
Universale, ed ha una carica espressiva
davvero notevole. Nella lunetta che sormonta il
portale troviamo la scena principale: Al centro
si trova il Cristo giudice in Gloria, ai cui
lati si trovano dei personaggi inginocchiati che
lo pregano, e due arcangeli: quello di sinistra
reca una croce, mentre quello di destra reca una
lancia.
Sotto
una schiera di angeli, si trova una fascia di
persone che subiscono una sorte diversa: quelli
di sinistra, gli Eletti, sono ben vestiti e sono
in fila per presentarsi al cospetto di un
angelo. Gli angeli sopra di loro recano delle
corone e sono in atteggiamento di porle sul loro
capo. Quelli di destra, invece, sono i Dannati;
sono anch’essi in fila ma sono nudi, in attesa
di essere di essere divorati da una bestia
immane che li inghiotte all’estremità della
scena. Gli angeli sopra di loro non hanno
corone, ma degli oggetti che sembrano delle
sferze.
Nella
fascia inferiore appare, al centro, un angelo
con una Bilancia, che soppesa le virtù e i
vizi: essi sono rappresentati sui piatti come un
agnello ed una testa mostruosa, e la bilancia
pende al momento a favore dell’agnello.
Intorno a lui vi sono degli angeli che suonano
le trombe del giudizio e un folto gruppo di
tombe scoperchiate da cui le anime dei defunti
stanno risorgendo.
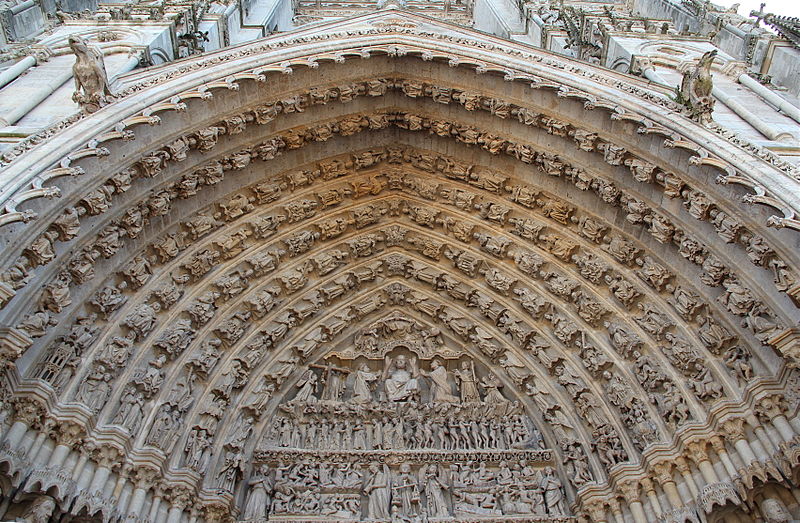
Ai
lati del portale vi sono delle nicchie, il cui
contenuto è estremamente significativo, ed
ancora una volta è suddiviso nella dualità su
esposta. In basso, a sinistra, vi è un albero
rigoglioso, che reca due enormi frutti dalla
forma vagamente fallica. Seguono, dal basso
verso l’alto, cinque figure femminili che
recano in mano, sollevati, dei recipienti di
varie fogge e misure: sono vasi, calici e olle.
Dall’altro lato la situazione si capovolge: le
figurine femminili recano dei calici o dei vasi
che sono tutti rivolti verso il basso, svuotati,
e l’albero alla base ha i rami dritti e
spogli.
L’iconografia
calice sollevato/calice abbassato ricorda molto
da vicino una rappresentazione simile nel culto
di Mitra, con i due Dadofori, i portatori di
fiaccole, rappresentati sempre uno con la torcia
sollevata e l’altro con la torcia sollevata.
La coppa, o vaso, è simbolo dell’utero
materno, e della generazione della vita. Anche
la scelta della "donna con il vaso",
per rappresentare questa allegoria, desta
numerosi interrogativi...


Seguendo
l’esempio delle Cattedrali di Chartres,
a cui questa era nettamente ispirata, e di
Reims, i cui lavori di costruzione erano
cominciati circa dieci anni prima, anche Nôtre-Dame
di Amiens si dotò di un immenso labirinto
pavimentale, che fu posto nella navata
centrale, di fronte all’ingresso principale.
Il labirinto, di forma ottagonale, venne
realizzato nel 1288, come attesta l’iscrizione
che venne apposta lungo il perimetro della
placca centrale, che riportava anche i nomi
degli architetti:
En
l’an de grâce 1220,
cette oeuvre fut commencée.
L’évêque béni de ce
diocèse était alors Evrard
et le roi de France Louis
fils de Philippe le Sage.
Celui qui était maître d’oeuvre
était nommé "Maître Robert"
et surnommé "de Luzarches".
Après lui vint Maître Thomas
de Cormont et après celui-ci
son fils Maître Renaut qui fit
mettre, à cet endroit-ci,
cette inscription en l’an de
l’Incarnation 1288. |
Nell’anno
di grazia 1220,
questo lavoro è stato iniziato.
Il vescovo benedetto di questa
diocesi è stato allora Evrard
e il re di Francia Luigi
figlio di Filippo il Saggio.
Colui che è stato maestro d’opera
si chiamava "Maestro Robert"
ed era nominato "di
Luzarches".
Dopo di lui venne il Maestro Thomas
de Cormont e dopo di lui
suo figlio il Maestro Renaut che fece
mettere, in questo posto,
questa iscrizione nell’anno della
Incarnazione 1288. |

|
Inizialmente, al centro dello schema, era stata
incastonata una sbarra d’oro, insieme ad un
semicerchio dello stesso metallo, che dovevano
simboleggiare la levata del sole
sull’orizzonte. Successivamente il sole
d’oro venne sostituito da un sole di rame, poi
anche questo venne tolto. Oggi la placca
centrale riporta una croce fatta con scettri,
orientata secondo i punti cardinali, e tutto
intorno sono le figure del vescovo Evrard e
degli architetti della cattedrale. Pesantemente
danneggiato durante la Rivoluzione Francese, il
labirinto venne rimosso. Quella che vediamo oggi
è una riproduzione fedele che è stata
realizzata nel XIX secolo.
È
un’opera di carattere simbolico, per non dire
iniziatico, che simboleggia il cammino di
evoluzione spirituale che a ciascuno è permesso
d’intraprendere e che deve essere portato a
compimento fino in fondo. C’è una sola via da
percorrere, e per quanto tortuosa possa
sembrare, essa conduce inesorabilmente al centro
(si dice che il labirinto è "unicursale",
cioè ha una sola via obbligata, caratteristica
comune a tutti i labirinti pavimentali delle
chiese), a testimonianza della portata
universale del cammino evolutivo.
Come
in ogni labirinto che si rispetti, basta
rovesciare la visione comune del mondo, come
fanno gli iniziati, e le cose complicate
diventano immediatamente semplici e
comprensibili. Qui, usualmente, le strisce nere
rappresentano le "vie" mentre quelle
bianche rappresentano i "muri", il
loro intreccio è il percorso del labirinto.
Capovolgendo il modo comune di pensare, ecco che
il "Cammino
dell’Iniziato" appare
immediatamente alla vista, come un percorso
rettilineo (bianco) che porta dritto al centro!
Oltre
al Labirinto, è opportuno notare che le
decorazioni pavimentali, sempre nella loro
natura duale di accostamenti bianco/nero (motivo
ampiamente sfruttato dai Cavalieri Templari nel
loro stemma chiamato Beauceant, egregiamente
simboleggiato nella scacchiera da gioco e
riprodotto all’interno di ogni tempio
massonico), formano tanti altri motivi
geometrici che possono sembrare puramente
decorativi ma non lo sono. Davanti al coro, per
esempio, una combinazione di tre quadrati
concentrici con alcune delle linee mediane
ricorda troppo da vicino il simbolo della
"Triplice Cinta" da non sembrare
affatto casuale ma sottilmente voluto.

L’immenso
apparato statuario presente all’interno della
Cattedrale è riuscito a salvarsi sia dalla
furia iconoclasta dei rivoluzionari, nel XVIII
sec., sia dai bombardamenti delle due guerre
mondiali, nel XX sec., giungendo fino a noi in
tutto il suo splendore. Per la ricchezza dei
motivi rappresentati, che coprono tutti gli
episodi più importanti del Vecchio e del Nuovo
Testamento, queste sculture sono note
complessivamente come la "Bibbia
di Pietra" di Amiens.
 Nel
XIV secolo, il complesso scultoreo fu completato
con una serie di figure di personaggi storici,
come il re Carlo V il Buono e suo figlio, il
Delfino, addossate ai pilastri che separano le
cappelle dal coro. Prive della solennità di
quelle della facciata, ma dotate di un lirico
naturalismo, rappresentano un contrasto che
permette di apprezzare l'evoluzione della
scultura negli ultimi secoli del Medioevo
francese. Nel
XIV secolo, il complesso scultoreo fu completato
con una serie di figure di personaggi storici,
come il re Carlo V il Buono e suo figlio, il
Delfino, addossate ai pilastri che separano le
cappelle dal coro. Prive della solennità di
quelle della facciata, ma dotate di un lirico
naturalismo, rappresentano un contrasto che
permette di apprezzare l'evoluzione della
scultura negli ultimi secoli del Medioevo
francese.
Tra
il 1508 e il 1519, vennero intagliati i 110
stalli del coro, che ancora oggi si conservano
come ulteriore dimostrazione della miracolosa
sopravvivenza del patrimonio artistico di
Amiens, dato che la maggior parte degli stalli
delle altre cattedrali è andata distrutta
durante
la Rivoluzione. Appartenenti a un'epoca in cui
la religione aveva perduto molto della sua
solennità medievale, i temi degli stalli di
Amiens sono essenzialmente popolari: mestieri,
allegorie e leggende evangeliche narrate con una
deliziosa abbondanza di particolari della vita
quotidiana.
A
questo tempio manca però l'elemento essenziale
di ogni cattedrale gotica: tutte le vetrate
originali sono andate praticamente perdute,
fatta eccezione per alcuni frammenti del XIV
secolo, eccessivamente restaurati ma comunque
preziosi per testimoniare l'impoverimento che
questa arte subì nei cent'anni trascorsi dalla
meraviglia di Chartres.

L’apparato
iconografico della Cattedrale rivela, però,
anche altri aspetti, che sono un po’ più
estranei al contesto cristiano e vanno invece a
"pescare" in tematiche un po’ più
pagane. Ne è testimonianza, ad esempio, il
ciclo di affreschi dedicato alla Sibille
(realizzato nel 1506), le profetesse delle
religioni più antiche che vaticinavano ispirate
dagli dei. Le loro rappresentazioni, molto
vivaci e colorate, si trovano nel sito
dell’antica Cappella di Saint-Éloi (1243),
dedicata al Vescovo di Noyon del XIII sec.
 La
Cattedrale di Amiens va famosa per ospitare al
suo interno un’importante reliquia, il cranio
di San Giovanni Battista. Si tratta, a
dire il vero, di uno
dei crani del Battista, perché ad esempio molti
sostengono che il vero cranio sia quello
conservato nella chiesa di San Silvestro in
Capite, a Roma, arrivato nella Capitale italiana
durante il pontificato di Innocenzo II
(1130-1143). La
Cattedrale di Amiens va famosa per ospitare al
suo interno un’importante reliquia, il cranio
di San Giovanni Battista. Si tratta, a
dire il vero, di uno
dei crani del Battista, perché ad esempio molti
sostengono che il vero cranio sia quello
conservato nella chiesa di San Silvestro in
Capite, a Roma, arrivato nella Capitale italiana
durante il pontificato di Innocenzo II
(1130-1143).
Il
cranio francese, invece, si dice sia stato
portato dal canonico Walon de Sarton, di ritorno
da Costantinopoli al termine della IV Crociata,
ed offerto al vescovo Richard de Gerberoy. Esso
è stato posto nel Tesoro della Cattedrale nel
17 Dicembre 1206 e da allora è stato venerato
da re, principi e schiere di pellegrini che
hanno visitato la Cattedrale.
Il re Carlo VI nel
1385 offrì un reliquario d’oro per la sua
conservazione, di cui l’attuale è una copia
realizzata nel 1876.
Esso
si trova nella navata sinistra della cattedrale,
e davanti ad esso, negli stalli del coro, si
estende un prezioso lavoro di sculture e
formelle, suddivise in due sezioni, che
raccontano in ogni dettaglio la vita di San
Giovanni Battista, la storia della sua
decollazione e quella del ritrovamento del
cranio e con il susseguente arrivo in Francia.


|
DIMENSIONI
lunghezza
esterna:
145 metri
lunghezza
interna:
133,50 metri
larghezza della navata, tra i
pilastri:
12,15 metri
larghezza della navata, al
centro dei pilastri:
14,60 metri
larghezza delle banchine, tra
i pilastri:
6,07 metri
lunghezza
esterna del transetto:
70 metri
lunghezza
interna del transetto:
62 metri
altezza della navata, sotto la
chiave di volta:
42,30 metri
superficie
coperta:
7.700 m²
volume: circa
200.000 m³
(il doppio di Notre-Dame a Parigi)
|

|
|