|
Situata
sulla collina di Saint-Eutrope, non lontano dal
fiume Aigues, a dominare una vasta pianura che
si estende fino al Rodano, quella che oggi è la
città di Orange fu fondata da una popolazione
di origine celtica.
Nel
II e nel I secolo a.C. fu capitale della
confederazione della tribù gallica dei Cavari
che dominava la regione da Valence ad Arles.
Ebbe nome di Aurosia (dal nome di un dio
celtico delle acque) quindi di Aurasio o Aurasium.
L'insediamento celtico era localizzato sulla
collina di Sant'Eutropia, che domina la città
odierna, presso il Rodano e il suo affluente
Aygues (Meyne). La confederazione commerciava
con i marsigliesi e con i Romani. A causa della
minaccia determinata dalle invasioni dei Cimbri
e dei Teutoni, provenienti da nord, un
accampamento militare romano fu creato sulla
stessa collina di Sant'Eutropia, per controllare
la via costituita dalla valle del Rodano.
La
colonia romana, con il nome di Colonia Iulia
Firma Secundanorum Aurasio fu fondata da
Ottaviano nel 36-35 a.C., avendo ottenuto il
territorio da assegnare ai coloni dalla tribù
dei Tricastini. La colonia fu occupata da
veterani della Legio II Gallica e si ebbe
un'ulteriore deduzione di coloni all'epoca di
Vespasiano, che fece redigere nel 77 d.C. un
catasto inciso su marmo (les Cadastres),
attualmente conservato al Museo Municipale. Vi
passava la strada costruita da Agrippa tra Arles
e Lione; un'altra strada romana conduceva a
Vaison. La cinta muraria circondava
un'estensione di circa 70 ettari e comprendeva
gran parte della collina di Sant'Eutropia,
estendendosi verso nord per circa un chilometro.
La città appartenne alla provincia romana della
Gallia Narbonense.
All'epoca
delle invasioni fu saccheggiata dagli Alamanni e
dai Visigoti (nel 412). Nel IV secolo divenne
sede episcopale e vi si tennero due sinodi: il
primo nel 441 si svolse nella ecclesia
justinianesis e fu presieduto dal vescovo
Sant'Ilario di Arles; nel 529 un secondo sinodo
fu tenuto nella città contro l'eresia
pelagiana.
 Nel
793 la città fu liberata dai Saraceni ad opera
di Guglielmo au Cornet, compagno di Carlo
Magno, che divenne il primo conte di Orange.
Abdicò per entrare in monastero
(St-Guilhem-le-Désert). Il suo successore,
conte Raimbaud II, partecipò alla prima
crociata nel 1096. Nel
793 la città fu liberata dai Saraceni ad opera
di Guglielmo au Cornet, compagno di Carlo
Magno, che divenne il primo conte di Orange.
Abdicò per entrare in monastero
(St-Guilhem-le-Désert). Il suo successore,
conte Raimbaud II, partecipò alla prima
crociata nel 1096.
Passò
quindi nel 1150 ai signori di Baux, che avevano
formato uno stato feudale semi-indipendente
nell'ambito del Sacro Romano Impero, staccandosi
dal regno di Arles dopo il 1033.
Nel
1163 l'imperatore Federico I Barbarossa elevò
Orange al rango di principato e nel 1184 vi si
iniziò a battere moneta. Nel 1208 vi fu
consacrata la cattedrale di Notre-Dame de
Nazareth e nel 1365 vi fu creata un'università:
Nel 1348 la popolazione venne quasi dimezzata
dall'epidemia di peste nera.
Nel
1393 il principato passò alla casata di Châlon
e nel 1431 vi fu istituito un parlamento. Nel
1530 alla morte di Filiberto di Châlon, che non
lasciava eredi, il principato passò al nipote
Renato di Nassau, la cui casata aveva ampi
possedimenti in Germania e nei Paesi Bassi. Si
creò il principato di Orange-Nassau e la casata
prese il nome di casa d'Orange.



Guglielmo
I di Nassau, detto il Taciturno, principe di
Orange, divenne nel 1544 Stathouder di
Olanda e combatté contro la Spagna rivendicando
l'indipendenza per i Paesi Bassi, che sono
tuttora governati dalla casa di Orange-Nassau.
Nel 1584 Guglielmo I fu assassinato a Delft.
Durante
le Guerre di Religione la città era stata dalla
parte dei protestanti e subì le conseguenze del
conflitto. Nel 1571 durante un massacro durato
11 giorni (Notre-Dame la Massacreuse)
furono uccisi 140 ugonotti.
Il
figlio di Guglielmo I, Maurizio di Nassau,
divenuto principe d'Orange dopo la morte del
fratello maggiore nel 1618, continuò la lotta
per l'indipendenza olandese. Nel 1665 divenne
principe di Orange Guglielmo III, che divenne re
di Inghilterra nel 1689. Alla sua morte nel 1702
il principato di Orange passò a Francesco Luigi
della casata dei Borbone-Conti, ma l'anno
seguente Luigi XIV se ne impadronì, decretando
l'espulsione dei protestanti. Nel 1713 con la
pace di Utrecht il principato fu annesso alla
Francia, ma fu restituito nel 1718 a Luigi
Armando di Bornone-Conti, fino al 1731, quando
entrò definitivamente a far parte del regno di
Francia e venne annesso alla provincia del
Delfinato.
Nel
1757 i fratelli Wetter vi aprirono una fabbrica
di tessuti di cotone stampato detti
"indiani".
Con
la Rivoluzione francese la città fu inserita
prima nel dipartimento del Drôme, poi in quello
delle Bocche del Rodano e infine nella Vaucluse
(1793.
Nel
1824 si iniziarono sotto la direzione
dell'architetto Auguste Caristie i restauri del
teatro, dove a partire dal 1869 si iniziò a
tenere il festival musicale delle fêtes
romaines divenuto poi delle Chorégies.
A partire dal 1850 fu restaurato anche l'arco di
Orange.
Nel
1924 la città subì una grande alluvione, nella
quale le acque raggiunsero tra 1.50 e 2 m
di altezza nel centro cittadino.
Arco
di Orange

L'arco
di Orange è un arco romano degli
inizi del I
secolo d.C., situato a Orange,
nel dipartimento francese di Vaucluse.
L'arco,
a tre fornici,
segnava l'ingresso della città romana di Arausio (oggi
Orange) dal lato nord e scavalcava una delle vie
costruite in Gallia da Agrippa,
che dalla capitale provinciale di Lugdunum (Lione)
conduceva al Mediterraneo e
quindi verso Roma.
L'arco
venne probabilmente eretto negli anni 20-25 d.C.
per commemorare le vittorie di Germanico,
morto nell'anno 19.
L'arco fu in seguito ridedicato a Tiberio nel 26-27 d.C.
e in tale occasione fu aggiunta la dedica.
 In
epoca medievale fu fortificato e inserito in un
bastione avanzato di difesa della città. Fu
restaurato negli anni
1820 dall'architetto Auguste Caristie,
che lo liberò dai contrafforti utilizzati per
la sua fortificazione e dalle strutture che gli
erano state addossate e rimpiazzò le parti
mancanti o troppo danneggiate. Un restauro e
pulitura dell'arco si è concluso nel 2009. In
epoca medievale fu fortificato e inserito in un
bastione avanzato di difesa della città. Fu
restaurato negli anni
1820 dall'architetto Auguste Caristie,
che lo liberò dai contrafforti utilizzati per
la sua fortificazione e dalle strutture che gli
erano state addossate e rimpiazzò le parti
mancanti o troppo danneggiate. Un restauro e
pulitura dell'arco si è concluso nel 2009.
L'arco
è edificato in opera
quadrata di blocchi di pietra
locale. Misura 19,57 m di larghezza e 8,40 m di
profondità e raggiunge un'altezza di 19,21 m.
Sui
lati maggiori fra i fornici e agli angoli sono
presenti semicolonne corinzie rialzate
su pinti che sorreggono la trabeazione principale
sui quattro lati. Al di sopra di questa si trova
un doppio attico, che sporge nella parte
centrale, dove lo spazio dell'attico inferiore
è occupato da un frontone.
L'attico superiore era destinato a fungere da
basamento per delle statue monumentali oggi
scomparse. I lati corti dell'arco sono decorati
con quattro semicolonne (comprese quelle
angolari) che sorreggono la trabeazione e un
frontone con arco centrale, che occupa lo spazio
dell'attico inferiore.
Su
molte delle superfici libere dell'arco sono
presenti rilievi.
Sulla
facciata principale gli spazi sopra i fornici
minori e sotto la trabeazione sono decorati da
rilievi con cumuli di armi, tra le quali alcuni
scudi presentano iscrizioni con nomi,
interpretati come i nomi degli scultori, ovvero
come nomi di famosi fabbricanti. Sempre in
corrispondenza dei fornici laterali, l'attico
inferiore è decorato con pannelli raffiguranti
delle spoglie navali, come prue di navi, ancore,
tridenti.
Il
fregio della trabeazione principale mostra sui
quattro lati del monumento un fregio con
combattimenti tra Galli e Romani,
rappresentati come una serie di duelli. I Galli
dai lunghi capelli combattono nudi e armati di
scudi, mentre i Romani indossano la tunica e
talvolta la corazza. I personaggi sono di
fattura grossolana, con mani e piedi
sproporzionati.
Nella
parte centrale dell'attico superiore, che doveva
sorreggere un grande gruppo scultoreo equestre,
si trovano dei pannelli con scene di battaglia,
alla quale partecipava la II
legione Gallica, riconoscibile dal suo
emblema con il capricorno, presente sullo scudo
di un ufficiale. Intorno al rilievo, privo di
incorniciatura, i blocchi della muratura
presentano numerosi fori disposti
irregolarmente, che dovevano servire a fissare
elementi decorativi in bronzo oggi
scomparsi.
Tra
le colonne dei lati corti sono presenti
altorilievi con trofei, ai piedi dei quali sono
mostrati due prigionieri barbari incatenati. Gli
altorilievi sul lato ovest sono in gran parte
frutto della ricostruzione ottocentesca.

Sui
lati lunghi dell'arco la fascia inferiore
dell'architrave della trabeazione principale
recava un'iscrizione con lettere in bronzo,
applicate per mezzo di grappe di cui restano
visibili i fori, in particolare sul lato nord.
Dallo
studio delle cavità per grappe fu proposta nel 1862 da
Pierre Herbert una prima lettura
dell'iscrizione:
IMP
CAIO I CÆ AVGVSTI DUVI I FIL ÆGYPT TRP XI
COMAT TRIBVT GERMANIA VICTA
COH XXXIII VOLVNT COLONIA ARAUS I SECVNDAN HVNC
ARC DED PVBLICE
"Imp(eratori)
Caio I(ulio) Cæ(sari) Augusto divi I(ulii)
fil(io) Ægypt(o) Tr(ibunicia) P(otestate) XI
comat(a) tribut(aria) Germania victa
Coh(ors) XXXIII volunt(ariorum) (et) colonia
Araus(io) I(iulia) Secundan(orum) hunc arc(um)
ded(icavit) publice"
All'imperatore
Gaio Giulio Cesare Augusto, figlio del divo
Giulio, che ha esercitato per l'XI volta la
potestà tribunizia, la XXXIII coorte dei
volontari e la colonia di Arausio Giulia dei
Secundani, in ricordo dell'Egitto, della Gallia
comata sottoposta a tributo e della Germania
vinta, dedica a nome di tutti quest'arco.
Secondo
Pierre Herbert l'iscrizione avrebbe dunque
indicato chiaramente l'erezione dell'arco nel 12
a.C.. La città è indicata come una colonia
romana fondata dai veterani della
legione cesariana. Le vittorie a cui
l'iscrizione si riferisce sarebbero la battaglia
di Azio nel 31
a.C. (Egitto) e le vittorie di Druso sui Germani nel
12 a.C.

In
seguito a studi più recenti la lettura
dell'iscrzione della trabeazione principale è
stata modificata:
TI
CAESAR DIVI AVGUSTI F DIVI IVLI NEPOTI AVGVSTO
PONTIFICI MAXI
POTESTATE XXVIII IMPERATORI IIX COS IIII
RESTITVIT R P COLONIAE (ovvero alla fine RESTITVTORI
COLONIAE)
"Ti(berio)
Caesar(i), divi Augusti f(ilio), divi Iuli
nepoti Augusto, pontifici max(imo)
(tribunicia) potestate XXVIII, imperatori IIX,
co(n)suli IIII restituit R(es) p(ublica)
coloniae (ovvero restitutori
coloniae)"
A
Tiberio Cesare, figlio del divo Augusto, nipote
del divo Giulio, Augusto, pontefice massimo, che
ha esercitato per la XVIII volta la potestà
tribunicia, imperatore per l'ottava volta,
console per la quarta volta restituì la colonia (ovvero restitutore
della colonia)
La
datazione appare essere spostata al 26 -27 d.C.,
in occasione di una restituzione di terre da
parte di Tiberio o per una strana
"restituzione" dell'arco a questo
imperatore. L'iscrizione sarebbe stata collocata
in epoca successiva alla prima costruzione
dell'arco, su una zona non normalmente destinata
a quest'uso. L'arco sarebbe stato iniziato
intorno al 20 e completato intorno al 25 e
inizialmente sarebbe stato dedicato a Germanico,
figlio adottivo di Tiberio e comandante della II
legione, morto nel 19.
Teatro
romano

Edificato
in epoca augustea, tra il I sec. a.c. e il I
sec. d.c., deve la sua fama all'ottima
conservazione della scena e del muro
retrostante, che raggiunge un'altezza di 37 m e
una lunghezza di 103 m.
La
decorazione della scena e le statue appartengono
ad un rifacimento dell'epoca di Antonino Pio. I
blocchi sporgenti in cima al muro, sulla
facciata esterna, erano utilizzati per fissare
il velario che proteggeva gli spettatori dal
sole.
Questo teatro, ornato da
statue, poteva ospitare 9000 spettatori divisi
in tre ordini e ha una scena chiusa da un
imponente e suggestivo muro alto
38 metri
e lungo 103, che ne costituisce anche la
facciata rivolta verso l’esterno. Dato che il
pubblico provinciale non era quello della
raffinata Roma, per lungo tempo esso ospitò
spettacoli di carattere popolare, dalle comiche
fabulae atellanae ai giochi di acrobati e di
mimi, fino alle commedie di Plauto.
La
sua acustica notevole, dovuta alla conservazione
della scena, consente di adoperarlo tuttora per
il festival musicale delle Chorégies.







La
ricostruzione nel disegno dell'architetto
francese August Caristie ricostruisce la
bellezza e la grandezza del gigantesco teatro
costruito durante il regno di Augusto nel I
secolo a.c. dai veterani della II Legione di
Giulio Cesare, a dimostrare quanto fossero
eclettici i famosi legionari.
Poi,
nel IV secolo d.C, con il declino dell'impero e
il diffondersi del cristianesimo, l'interesse
per gli spettacoli scemò e nel 391 il vescovo
di Arausio, che deplorava il teatro come
un'empietà pagana, ne ordinò la chiusura. Con
l'arrivo dei barbari, quel luogo deputato agli
svaghi venne trasformato in un deposito di armi
e, nel corso dei secoli, addossate all'imponente
facciata crebbero povere e disordinate
abitazioni di legno.
  Ormai
fatiscente, il teatro sopravvisse alla guerra
tra le truppe di Luigi XIV contro Guglielmo III
di Nassau: il Re Sole, che aveva ordinato di
radere al suolo la fortezza del principe
ribelle, decise di risparmiare quello che
considerava "il più bel muro del
reame". Fu nel 1860, grazie allo scrittore
Prosper Mérimée - allora direttore dei
Monuments Historiques di Francia - che
iniziarono i lavori di restauro. Ormai
fatiscente, il teatro sopravvisse alla guerra
tra le truppe di Luigi XIV contro Guglielmo III
di Nassau: il Re Sole, che aveva ordinato di
radere al suolo la fortezza del principe
ribelle, decise di risparmiare quello che
considerava "il più bel muro del
reame". Fu nel 1860, grazie allo scrittore
Prosper Mérimée - allora direttore dei
Monuments Historiques di Francia - che
iniziarono i lavori di restauro.
Il
teatro, che venne restaurato dall'architetto
Caristie, figlio di italiani, è uno dei teatri
romani meglio conservati al mondo. Oggi il teatro di Orange
ospita un festival estivo e il suo palcoscenico
è tornato a vivere, calcato da attori di
prestigio internazionale, come ai tempi d'oro
dell'antica Roma. Soltanto una volta - in
quell'abbandono durato più di un millennio - un
grande "attore" vi aveva fatto la sua
fugace comparsa: si trattava di Napoleone. Una
notte, in viaggio verso Parigi dopo la fuga
dall'esilio sull'isola d'Elba, chiese al suo
cocchiere di fermarsi a Orange. Entrò, da solo,
nel teatro. E su quel palcoscenico magnifico e
spettrale assaporò l’idea di quello che
sarebbe stato il suo ultimo ed effimero trionfo.
Dal
2018, il Teatro offre ai visitatori un tour
virtuale: un dispositivo in realtà virtuale
permette di immergersi in una ricostruzione
digitale del monumento come sarebbe stato nel 36
a.c.. Al momento della fondazione della città
di Arausio dai Romani. Un film immersivo
proiettato sullo schermo di un casco di realtà
virtuale è proposto sul sito dal responsabile
del sito, Culturespaces.
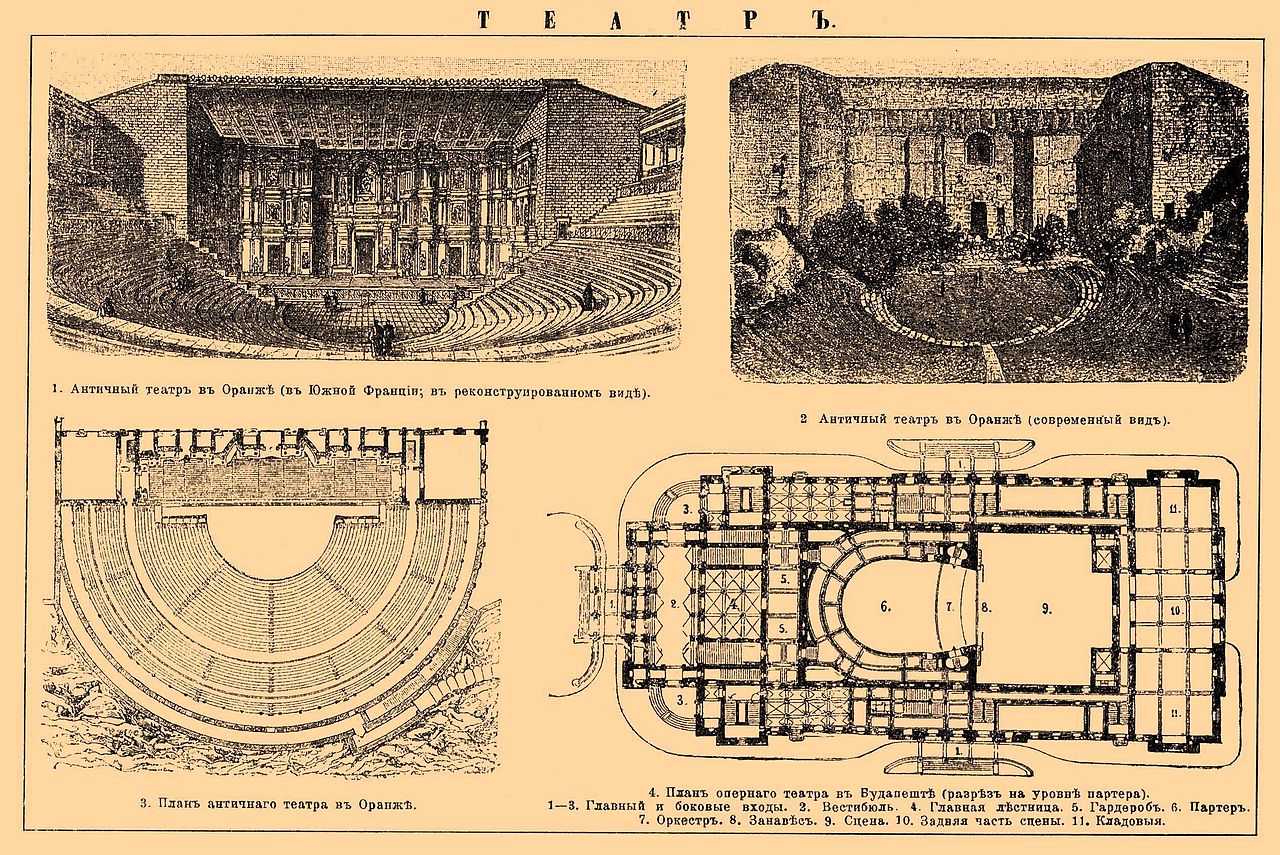
|