|
L'ordine
cistercense, nato da un movimento riformatore
all'interno della comunità benedettina, mirava
a un'osservanza più severa delle regole di San
Benedetto da Norcia. A un primo monastero che i
cistercensi fondarono nel 1098 nella località
di Citeaux, all'epoca circondata da paludi, ne
seguirono altri, tutti costruiti nella
solitudine delle campagne. L'ordine rifiutava
qualsiasi forma di ricchezza e le sue comunità
monastiche abitavano in edifici modesti, vivendo
esclusivamente dei propri raccolti.
L'edificio,
situato in una piccola e boscosa valle a 60
chilometri a nordovest di Digione, venne fondato
nel 1118 da Bernardo di Chiaravalle, pochissimi
anni dopo che egli era uscito dall'Abbazia di Cîteaux
per fondare l'Abbazia di Clairvaux.
Inizialmente
la comunità si insediò in un luogo di
romitaggio situato a nord dell'abitato di
Montbard, all'estremità della foresta di
Petit-Jailly, di proprietà della famiglia di
Bernardo. Il primo abate, Godefroy de la
Roche-Vanneau, imparentato con lo stesso
Bernardo, governò il cenobio in questo sito per
dodici anni. L'accresciuto numero di vocazioni
rese necessaria intorno al 1130 la costruzione
di un secondo insediamento di maggiori
dimensioni; i monaci si spostarono quindi a
valle di circa un chilometro, occupando un'area
donata dal vescovo di Autun e da Rainardo di
Montbard, zio materno di Bernardo. Prima di
rifondare l'abbazia venne realizzato un sistema
di canalizzazione delle acque, tuttora
funzionante; in quel momento fu costruita anche
una piccola cappella, dedicata a San Paolo,
rimasta in uso fino al XVI secolo.
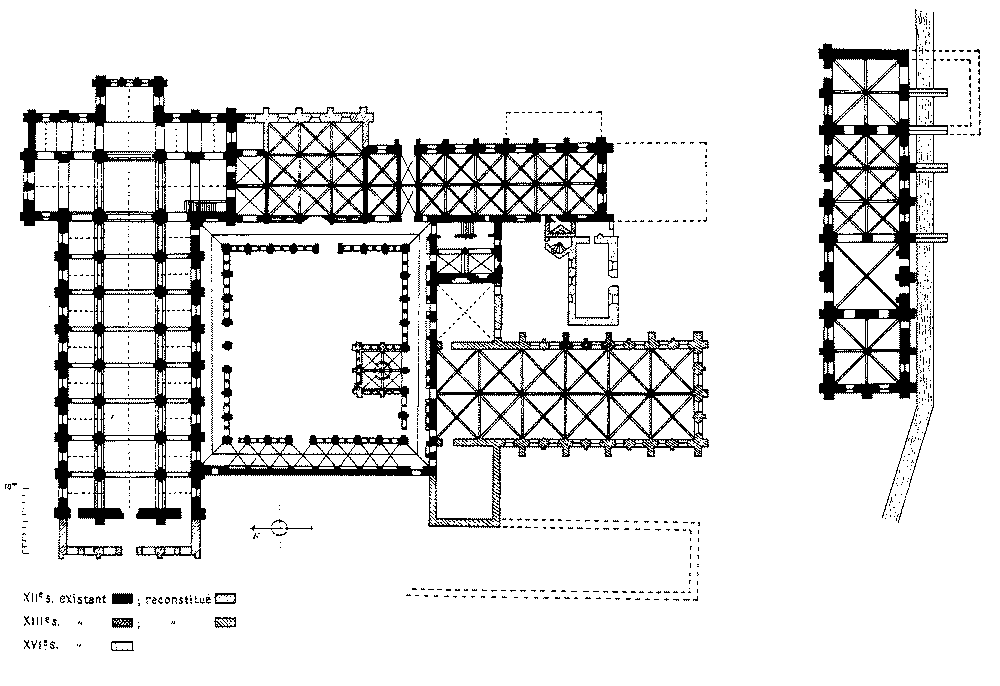
Nel
1132 Godefroy ritornò a Clairvaux, dove, eletto
priore, collaborò alla progettazione della
grande abbazia. Il secondo abate di Fontenay,
Guglielmo di Epiry (1132-1154), accolse nel 1139
il vescovo Everardo di Norwich, del potente
casato degli Arundel; la generosità di questo
ricco e potente prelato inglese permise la
costruzione del nuovo monastero. Nel 1269 Luigi
IX di Francia prese Fontenay
sotto
la sua protezione e la proclamò abbazia regia.
Nel
1359 essa fu saccheggiata dalle truppe di
Edoardo III d'Inghilterra, che, due anni dopo,
donò quarantamila pezzi d'oro per il restauro
delle fabbriche monastiche; soltanto al
principio del XV secolo fu realizzato il muro di
cinta con il fossato. L'istituto della commenda,
introdotto a Fontenay
nel
1557, segnò l'inizio del declino e delle
difficoltà finanziarie del monastero.
Dopo
la Rivoluzione francese, Fontenay
venne
messa in vendita e quindi trasformata in una
cartiera la cui attività produttiva si
interruppe definitivamente nel 1906, quando fu
intrapreso il restauro del monumento.
L’abbazia di Fontenay
rappresenta uno dei più belli e più completi
insiemi di costruzioni monastiche dei primi
decenni dell’ordine di Cîteaux, il più
intatto che ci sia pervenuto poiché esistono
ancora pressoché tutti gli edifici e la maggior
parte di esse risale al XII secolo.

La chiesa rappresenta il
tipo più puro e più perfetto di quella forma
canonica che san Bernardo impose alle chiese
legate alla casa madre di Clairvaux. La facciata
è molto semplice, a capanna spezzata, la
larghezza della navata centrale è sottolineata
da due contrafforti in mezzo ai quali si apre il
portale centrale. La tipologia a croce latina
definisce l’impianto interno con geometrie
esclusivamente ad angolo retto e lo spazio è
ritmato dalle teorie di pilastri che dividono la
navata centrale e le due laterali in otto
campate.
Il transetto è composto
da un coro ad abside quadrangolare, a due
campate, sopraelevato di due gradini e da
quattro cappelle, anch’esse a pianta quadrata,
aperte, due per lato, sui bracci del transetto.
Il tutto è coperto da volte a botte a sezione
ogivale, longitudinali nel “vaisseau”
centrale, trasversali nei bracci del transetto e
nelle navate laterali.
Da qualunque parte si
muova lo sguardo, mentre ci si aggira e ci si
sposta sul pavimento in terra battuta
(originariamente coperto da lastre di pietra o
da piastrelle nude) non si percepisce che il
ritmo, geometria di forme, nudità, semplicità
alla luce dei materiali e dello spazio. Anche il
colore è appena accennato, come del resto la
modellazione plastica dei capitelli a foglie
stilizzate o a semplici figure geometriche.
Fontenay conserva un certo numero di
bassorilievi e nel coro sono conservate numerose
pietre tombali e statue funerarie, anticamente
disposte sulla pavimentazione della chiesa e
delle cappelle.
Nel chiostro, le gallerie
che formano un rettangolo molto prossimo al
quadrato, sono coperte da volte a botte in
pietra, con lunette corrispondenti
all’apertura delle arcate, solo la galleria
occidentale è voltata a crociera. Ogni lato è
suddiviso da otto arcate a tutto sesto che
ricadono su forti pilastri, rinforzati
all’esterno da grossi contrafforti, ogni
arcata è a sua volta divisa in due piccoli
archi a tutto sesto, sostenuti da colonne
binate. Basi, fusti, capitelli, abachi, colonne,
sono spesso tagliati in uno stesso blocco di
pietra.

La decorazione dei
capitelli, sobria ma più ricca rispetto alla
chiesa, e la disposizione ricercata delle
colonne, rendono il suo aspetto meno severo. La
sala del Capitolo, vasta e ben illuminata, è
aperta sulla galleria orientale del chiostro
tramite una grande arcata a tutto sesto e altre
quattro aperture poste ai lati di questa.
All’interno, le ogive poggiano su quattro
pilastri centrali che dividono la sala in due
navate; questi pilastri sono formati da otto
colonne che ricevono il ritorno di volta. I
capitelli, come nel chiostro, sono ornati da
semplici foglie stilizzate.
In fondo all’ala
orientale del chiostro si trova la sala dei
monaci, risalente alla seconda metà del XII
secolo. Più sobria della sala capitolare, è
divisa in due navate di sei campate ciascuna, da
una fila di quattro colonne e un pilastro
ottagonale al centro. Essa è coperta da volte a
crociera ogivali che ricadono lungo i muri su
mensole a piramide rovesciata. Il dormitorio
occupa tutto il primo piano del lato dei monaci.
Oggi vi si può accedere solamente attraverso
una scala situata nel braccio sud del transetto
della chiesa. Gli unici elementi risalenti alla
costruzione primitiva sono le strette finestre a
tutto sesto che danno sul chiostro.
Nell’angolo del chiostro
presso la sala dei monaci si trova la sala del
riscaldamento (calefactorium). Si tratta di una
piccola stanza bassa coperta da volte ogivali
che ricadono su pilastri quadrati. Il refettorio
è l’unico edificio importante ad essere stato
completamente distrutto. In origine era
parallelo al chiostro: solo nel XIII secolo fu
collocato perpendicolarmente. Era una grande
sala con volte a crociera ogivali, divisa in due
navate da una fila di cinque colonne.









Da sempre i monasteri
avevano assunto come principio quello di badare
a se stessi, senza dover ricercare al di fuori i
prodotti che potevano essere loro necessari. La
fucina di Fontenay era una vera “fabbrica”
che utilizzava il minerale della collina vicina
ed è la più importante che ci è pervenuta.
Costruita alla fine del XII secolo sul bordo di
un canale che forniva la forza motrice, è
divisa in quattro sale.
La prima, partendo da
ovest, ha volte a crociera ogivali e comunica
attraverso due arcate con la sala vicina,
l’officina vera e propria, senza più volte.
La terza sala è divisa in due navate, di tre
campate ciascuna, da due colonne centrali ed è
coperta da volte ogivali. La costruzione, il cui
primo piano era adibito a magazzino, è
provvista di robusti contrafforti ed è
rischiarata da alte finestre a tutto sesto.
Nel
1905 l'abbazia venne acquistata e
successivamente restaurata da Édouard Aynard. Attualmente è proprietà privata della famiglia Aynard.








|