|
Nizza è
il maggior centro della Costa
Azzurra e si trova a pochi chilometri dal confine
franco-italiano.
Fino al 1860 Nizza appartenne al Regno
di Sardegna e
fu ceduta alla Francia un anno prima dell'Unità
d'Italia;
la città conserva pertanto
stretti legami con il Paese
confinante, anche alla luce del
fatto che è il luogo di nascita
di Giuseppe
Garibaldi,
uno dei principali artefici
dell'unificazione italiana.
Gli
scavi archeologici del sito di Terra
Amata fanno
risalire i primi insediamenti
umani nella zona addirittura a
400.000 anni fa.
Nizza
fu fondata attorno al 350 a.C. dai
coloni greci di Marsiglia e ricevette il nome di Nikaia (Νίκαια)
, in onore della dea della
vittoria Nike,
a ricordo della vittoria sui Liguri. La città si trasformò velocemente in un importante porto commerciale
della costa ligure. In età romana Nicaea rivaleggiò
con la vicina città di Cemenelum che
continuò ad esistere fino
all'invasione longobarda del
territorio. Le rovine di questa
città sono visibili a Cimiez,
attualmente uno dei quartieri di
Nizza.
Sotto
l'Impero
Romano Nizza rimase sempre nella regione
romana di Liguria.
Alla caduta dell'Impero
romano d'Occidente,
la Liguria divenne parte dei regni
romano-germanici d'Italia.
La dominazione
gotica durò
fino alla riconquista nel 552, a seguito delle guerre gotiche, da parte dell'Impero
romano d'Oriente che
ne fece un importante caposaldo
marittimo. I Bizantini istituirono la provincia di Liguria come Provincia
Maritima Italorum;
il ritrovato periodo di pace vi
comportò una ripresa destinata a
durare fino alla conquista
longobarda di Rotari della Liguria nel 642. Nizza con tutta la Liguria fece quindi parte del Regno
longobardo nel Ducato
di Liguria, che diventerà
sotto la dinastia
carolingia il Regno
d'Italia.
Fin
dall'epoca longobarda vi
operavano i monaci colombaniani della
potente abbazia
di San Colombano di Bobbio,
attivissimo centro di
evangelizzazione e di rinascita
agricola sotto la protezione del
Papa. Essi a partire dal vasto feudo
reale ed imperiale monastico, di cui facevano parte l'abbazia
di San Dalmazzo di Pedona presente
nell'opera di evangelizzazione fra
il territorio piemontese e la
marittima ligure di ponente,
specie con i possedimenti di Tenda e nelle valli del Roja, Lantosca,
della Vesubia, della Tinea e
del Varo, anche in raccordo e collaborazione con l'Abbazia
di Lerino,
che accogliendo la regola
benedettina di San Colombano,
aveva avuto la possibilità di
diffondersi in tutta la Costa
Azzurra, nelle Isole di
Hyères di
fronte
a Tolone, Saint-Tropez, Cannes e le sue isole, Nizza, Monaco, Mentone,
e in seguito anche a Ventimiglia e nel Ponente
ligure.
Diedero impulso all'agricoltura con il recupero di aree incolte o
abbandonate, le bonifiche e le
migliorie agronomiche con il
recupero e la diffusione di
oliveti (fra cui la cultivar di oliva
taggiasca), vigneti, castagneti, mulini, frantoi, ecc. I monaci diedero, inoltre, un
notevole apporto alimentare grazie
agli allevamenti e alla conservazione
degli alimenti,
proteine e grassi,
come olio, burro, formaggi, salumi, grazie a sale e spezie; inoltre si adoperarono per la riapertura delle vie commerciali e delle vie
del sale e
il commercio dalla marittima
ligure lungo le valli alpine ed
appenniniche verso il piemonte e
con gli altri monasteri fondati
nei territori liguri con scambi di
merci varie come olio, sale,
legname, carne, ecc.

Fra
il VII e VIII secolo vi furono
numerose fondazioni, l'abbazia di
San Martino dell'Isola
Gallinara di Albenga,
che ebbe possedimenti in Italia,
in Catalogna e Barcellona,
in Provenza specie nella zona di Fréjus (fra
cui la chiesa
di San Leonzio) e in Corsica, il monastero di
Villaregia di Santo Stefano al
Mare,
i monaci di Pedona fonderanno
anche l'abbazia
di Nostra Signora del Canneto di
Taggia e
sulle alture di Nizza fra il VII e
VIII secolo il monastero
di Cimiez poi
distrutto dai saraceni e ricostruito dai monaci dell'abbazia di Saint-Pons di Nizza fondata
dai monaci di Lerino verso la fine
dell'VIII secolo.
Nel 729 Nizza espulse i Saraceni dal suo territorio, ma questi tornarono a saccheggiarla nel 850 e 880.
Infatti nel IX
secolo si
fecero sempre più pressanti e
distruttive le incursioni, le
razzie e distruzioni da parte dei
Saraceni che verso il X
secolo occuparono la Provenza stabilendo una base operativa fortificata a Frassineto (oggi la
Garde-Freinet,
presso Saint-Tropez) da cui muovere incursioni in un'ampia area marittima da Marsiglia a Genova
e nell'entroterra provenzale,
ligure e piemontese, con ampie
distruzioni di intere città,
abitazioni, chiese e monasteri.
Nel 941 la flotta bizantina distrusse quella frassinetana, e nel 973 si ebbe la battaglia
di Tourtour con
la successiva distruzione di
Frassineto, combattuta dalle forze
congiunte di liguri e provenzali
organizzate dal conte Guglielmo
I di Provenza con
l'aiuto del marchese di Torino Arduino
il Glabro e
col sostegno di Papa
Giovanni XIII e
dell'imperatore Ottone
I di Sassonia,
che pose fine definitivamente alle
razzie e all'occupazione saracena
in Provenza.
La
città medievale circondava la
città antica, protetta sul lato
di terra dal fiume Paviglione, più
tardi coperto (oggi percorso del
tram). Il lato orientale era
invece protetto dalle
fortificazioni del Castello. Un
altro fiume sboccava in mare
presso il porto sul lato orientale
del castello. Anche l'area del
porto era circondata da mura,
secondo i disegni pervenuti fino a
noi.
Nel 1108 Nizza si organizzò sotto forma di libero comune e dal 1144 il governo della città fu affidato a quattro consoli, che negli anni
acquisirono abbastanza potere da
poter mettere in discussione la
supremazia del vescovo. In
questa fase Nizza fu alleata
fedele di Genova,
al fianco della quale combatté
contro Pisa e Venezia.
Nel 1162, il conte di
Provenza Raimondo
Berengario
II cercò
di estendere il suo territorio, al
fine di controllare il passaggio
alle Alpi. Pertanto, intimò i
cittadini nizzardi di
sottomettersi e giurargli fedeltà,
ma la città oppose un netto
rifiuto, al fine di mantenere le
proprie libertà comunali. Così,
Raimondo Berengario II cercò di
prendere la città con la forza,
ma questa cadde soltanto nel 1176 per mano del suo primo cugino e successore Alfonso
I.
Nel 1215, con la morte di Alfonso I, la città riconquistò la propria libertà e
rinnovò la propria alleanza con
Genova. Soltanto nel 1229 Raimondo
Berengario IV riuscì
a espugnare nuovamente la città,
che però restò sempre ostile al
governo provenzale.
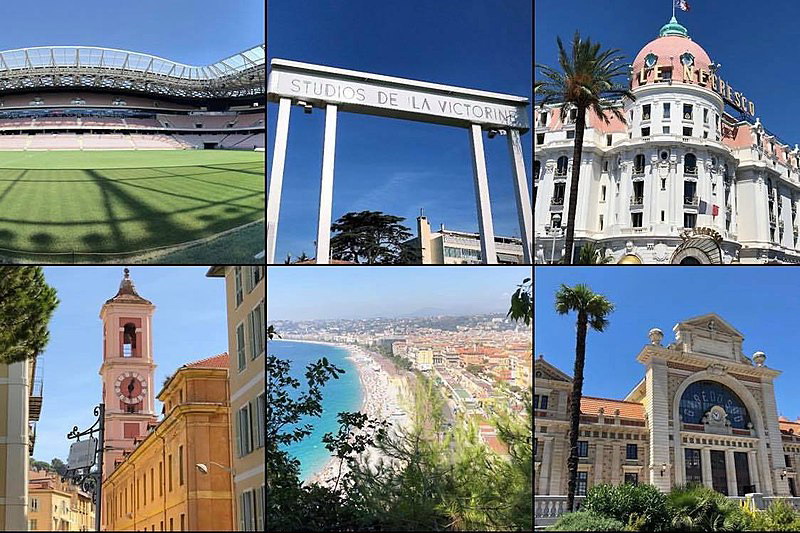
Approfittando
dei disordini scoppiati in
Provenza a seguito della nascita
dell'Unione
di Aix,
il 27 settembre 1388 il comune di Nizza, in funzione antiprovenzale, si mise sotto la
protezione di Amedeo
VII di Savoia,
il quale assunse il titolo di conte
di Nizza. La città resterà parte delle vicende storiche della casa Savoia fino al
1860.
Nizza
ebbe anche un suo cittadino fra i
protagonisti delle spedizioni
mirate alla scoperta e alla
conquista delle terre del
continente americano, vicenda
nella quale egli giocò un ruolo
determinante sebbene non
particolarmente encomiabile. Fra Marco
da Nizza lasciò l'Europa nel 1531 per raggiungere le Americhe, dove prese parte alla spedizione in Perù guidata da Francisco
Pizarro ed
assistette alla sconfitta
dell'impero Inca.
In seguito si convinse
dell'esistenza delle sette
città dorate di Cibola;
partecipò alla spedizione di Francisco
Vázquez de Coronado,
che verificò come le città
dorate fossero soltanto villaggi
indigeni. Frate Marco fu congedato
e si ritirò in un convento dove
visse per il resto della vita.
La
forza marittima di Nizza andò
aumentando progressivamente, fino
a poter competere con i corsari
barbareschi;
le sue fortificazioni furono
ampliate e le sue strade
migliorate.
Durante sesta
guerra d'Italia Nizza
soffrì molto, a causa anche di
un'epidemia di peste che la colpì. Dopo qualche anno di guerra la pace fu stipulata nella
vicina Villeneuve-Loubet dietro
mediazione di papa
Paolo III (Trattato di
Nizza).
Dopo
dieci anni la città fu però
nuovamente attaccata dall'alleanza
franco-ottomana tra Francesco I e
il pirata turco Khayr
al-Din Barbarossa.
Nonostante i nizzardi avessero
respinto l'assedio
del 1543 che
aveva fatto seguito ai
bombardamenti, furono alla fine
costretti ad arrendersi, e il
Barbarossa poté saccheggiare la
città e portare con sé 2.500
prigionieri. La peste ricomparve
nel 1550 e
nel 1580.
Nel
1561 Emanuele
Filiberto di Savoia abolì
l'uso del latino come lingua
amministrativa e introdusse la lingua
italiana come lingua ufficiale del governo a Nizza. Nel 1600 il duca di
Guisa,
governatore della Provenza, tentò
di conquistare la città, che però
venne brillantemente difesa dal
suo governatore, Annibale
Grimaldi. Nel 1626 il governo
cittadino decise di proclamare la
libertà di commercio dando inizio
un periodo di prosperità. Nel 1642, in virtù dell'alleanza di Carlo
Emanuele II con
la Francia, la guarnigione
spagnola presente in città venne
cacciata. Nel 1691, durante la Guerra
della Grande Alleanza,
la città venne occupate dalle
truppe del generale Nicolas
Catinat, nel 1697 Nizza fu restituita al ducato
di Savoia per
effetto del trattato
di Torino.
Pochi anni dopo, nel
1705, un nuovo assedio da
parte dei francesi portò alla
distruzione del Castello, della
cittadella e delle mura. L'anno
successivo la controffensiva
sabauda giunse fino
a Tolone, sottoposta anche a blocco navale dagli inglesi che avevano occupato le Isole
di Lerino nella
cui baia, bloccata dalla marina
britannica, si trovava larga parte
della flotta francese.
Nel 1713 il Trattato
di Utrecht riconobbe
al duca sabaudo Vittorio
Amedeo II il Regno
di Sicilia,
che venne permutato con il Regno
di Sardegna nel 1718. Nel periodo di pace che vi seguì, venne ricostruita la "città
nuova". Durante la Guerra
di successione
austriaca l'entroterra
nizzardo venne più volte invaso
dalle truppe franco-spagnole,
senza che però queste riuscissero
a prendere la città. Nel 1775 il re sabaudo abolì tutte le libertà comunali sopravvissute. Caduta
nel 1792 nelle mani dell'esercito
della Repubblica Francese, la
contea di Nizza restò parte della
Francia metropolitana fino al
1814, dopodiché ritorno a far
parte degli Stati
Sabaudi.

L'8
settembre 1792 il ministro degli
esteri del governo
rivoluzionario francese Lebrun-Tondu diede
ordine all'esercito d'invadere la
Savoia: e il 22 settembre dello stesso anno le truppe francesi, agli ordini del generale
Montesquiou,
entravano a Chambéry.
Anche la contea
di Nizza si apprestava a subire la medesima sorte: Nizza venne abbandonata
precipitosamente dal governatore
piemontese, generale Courten, al
primo apparire delle truppe
francesi e il 29 settembre 1792,
alle ore 16, il generale francese d'Anselme entrava
con le sue truppe nella città,
che fino a quel momento era
appartenuta ai territori del regno
di Sardegna,
e v'instaurava un'amministrazione
provvisoria.
Il
27 novembre, con decreto della Convenzione,
tutta la Savoia venne annessa alla
Francia e poco dopo, il 13 gennaio 1793, la stessa sorte toccò a Nizza.
Tuttavia,
molto presto, l'opinione generale
si volse contro i francesi a causa delle requisizioni ordinate dai militari, dei saccheggi e
delle esazioni compiuti dalle
truppe occupanti. Questi eccessi
furono denunciati anche dal
rappresentante delle autorità
rivoluzionarie, inviato in
missione nella zona, Filippo
Buonarroti.
Tutto
ciò diede origine a una spontanea
reazione di resistenza clandestina
della popolazione nizzarda alle
soperchierie, quando non atrocità,
compiute dalle truppe di
occupazione francese e nasceva così
il barbetismo. La volontà di scristianizzare il paese, com'era avvenuto in Vandea ed in Bretagna,
le requisizioni militari e la
coscrizione obbligatoria dei
giovani seguita dal loro
arruolamento forzato, aumentarono
notevolmente le schiere dei barbets, i componenti del movimento armato semiclandestino detto appunto
"barbetismo".
Verso
la fine della Rivoluzione
francese la
comparsa di briganti che
mascheravano i loro atti di
violenza spacciandoli per
resistenza all'occupante,
gettarono parecchio discredito sul
movimento.
L'annessione
di Nizza alla Francia venne
confermata all'inizio dell'epoca napoleonica, con l'armistizio di
Cherasco del 1796, confermato poche settimane dopo dal Trattato
di Parigi.
L'anno
1799 vide un periodo di nuova,
violenta, persecuzione religiosa,
condotta dal generale francese di
origine nizzarda Andrea
Massena, che causò un forte incremento dell'attività dei barbets, i
cui ranghi si rafforzarono
notevolmente. Ai primi di maggio
del 1800, le truppe
austro-piemontesi, comandate dal
generale Melas occuparono Nizza e gran parte della contea, ma il ritorno al
regno di Sardegna durò molto
poco: già a fine mese le truppe
del generale francese Suchet la
riportavano sotto il dominio della
repubblica francese, occupazione
poi consolidata con la vittoria di Napoleone
Bonaparte a Marengo.
Nel
periodo consolare e
successivamente in quello
imperiale, l'atteggiamento delle
autorità francesi divenne molto
più conciliante con la
popolazione, riducendo così i
motivi di scontento che avevano
dato origine alla nascita del barbetismo.
Diciotto
anni dopo tuttavia, con la caduta
dell'impero napoleonico e
l'avvento della restaurazione,
Nizza tornò al regno
di Sardegna con
il trattato
di Parigi del 1814. Giuseppe
Garibaldi vi
era nato nel 1807, quindi in un periodo in cui Nizza era francese.

Nel 1860 Nizza fu nuovamente, e definitivamente, annessa
alla Francia,
assieme alla Savoia,
in seguito agli Accordi
di
Plombières (1858)
e al Trattato
di Torino (1860),
come compenso territoriale per
l'aiuto dato dalla Francia al Risorgimento Italiano
nella guerra con l'Austria, che aveva portato all'annessione della Lombardia. L'annessione fu ratificata anche dal plebiscito della popolazione con 25.743 a favore, 160 voti contrari e 5.000
astenuti. Giuseppe
Garibaldi,
nato a Nizza durante il precedente
periodo francese, era opposto alla
cessione, e affermava che il
plebiscito fosse stato pilotato in
funzione filo-francese, con il
consenso dei Savoia.
Un
quarto circa della popolazione di
Nizza, quelle famiglie più legate
all'Italia e spesso più abbienti,
abbandonarono la città (esodo
nizzardo), conservando la cittadinanza sabauda (e quindi italiana) e si trasferirono
prevalentemente nelle località di Ventimiglia, Bordighera e Ospedaletti, dando vita al movimento dell'irredentismo
italiano a Nizza.
Su un totale di 44.000 abitanti,
emigrarono in Italia oltre 11.000
persone da Nizza nel decennio
successivo al 1861. Altri
nazionalisti nizzardi
continueranno a lungo a contestare
l'illegittimità dell'annessione.
Il
centralismo dello Stato francese
fa inoltre tramontare in pochi
anni le libertà civiche di cui la
città aveva a lungo goduto. Viene
anzitutto soppressa la stampa non
filo-francese e per ordine del
governo vengono chiusi i giornali
nizzardi di lingua
italiana:
nel 1861 Il diritto di
Nizza e La
Voce di Nizza,
momentaneamente riaperto nel 1871
durante i Vespri
nizzardi,
e più tardi, nel 1895, Il Pensiero
di Nizza,
testate per le quali scrivono i più
importanti giornalisti e scrittori
di lingua italiana della città,
come Giuseppe Bres, Enrico
Sappia e Giuseppe
André. Alcune importanti istituzioni cittadine quali la corte
di appello vengono
in quegli stessi anni soppresse e
Nizza passa a dipendere sotto il
profilo giuridico da Marsiglia. Viene inoltre avviato un processo di francesizzazione dei cognomi dei
residenti (numerosi i Bianchi
diventati Le Blanc, i Del Ponte
diventati Dupont, i Pastore
diventati Pastor, etc.). Tali
politiche portano a una
progressiva omogeneità culturale
tra la città e il resto della
Francia metropolitana. Il
risultato fu un rigetto iniziale
della Francia da parte di molti
nizzardi: gli irredentisti
italiani si
fecero portavoce di questo rigetto
tramite il loro capo, il nizzardo Giuseppe
Garibaldi.
Nel
decennio successivo cresce il
malcontento nei confronti della
Francia, alimentato da molti
aristocratici restati fedeli alla
dinastia sabauda e da frange di
sinistra repubblicane e
garibaldine. Nel 1871, alla caduta del II
Impero,
dei quattro deputati eletti nel
dipartimento nizzardo delle Alpi
Marittime, ben tre hanno fama di essere filo-italiani o comunque separatisti, incluso
lo stesso Giuseppe
Garibaldi.

Sempre
nel 1871 il malcontento degli italiani a Nizza verso la Francia si esprimere
nei tre giorni di rivolta popolare
(Vespri
nizzardi),
promossi dallo stesso Garibaldi. Dopo che ebbero ottenuto la quasi totalità dei voti alle elezioni
generali (26.534 voti su 29.428
voti espressi), i filo-italiani
scesero in strada al grido di Viva
Nizza, Viva Garibaldi. Il
governo francese inviò a Nizza
10.000 soldati, chiuse il giornale Il
Diritto e incarcerò
molteplici irredentisti. La
popolazione di Nizza si sollevò
dall'8 al 10 febbraio ma fu
repressa dalle truppe francesi. Il
13 febbraio Garibaldi, cui era
stato negato di prendere la parola
davanti al parlamento francese
riunito a Bordeaux per rivendicare la riunificazione del Nizzardo alla madrepatria
italiana si dimette da deputato. Il
fallimento dei Vespri portò
all'espulsione degli ultimi
irredentisti da Nizza, tra cui Luciano
Mereu e Giuseppe
Bres.
A
Nizza restano comunque numerose
tracce dell'appartenenza sabauda:
nell'omonima piazza si erge la
statua di Giuseppe
Garibaldi (oggi
corredata da un'iscrizione in
francese dedicata "al nostro
concittadino Giuseppe Garibaldi,
eroe dei 2 mondi"), mentre
nel centro vecchio, principalmente
nella zona compresa fra la Piazza
del tribunale e il Quai
des Etats-Unis si trovano
ancora numerose tavole che
mostrano la contea di Nizza prima
dell'annessione alla Francia,
oltre alle chiese seicentesche e
settecentesche, che esprimono il
medesimo stile architettonico
piemontese.
Nel 1882 l'architetto Charles
Garnier costruì il celebre Osservatorio di Nizza aiutato da Alexandre
Gustave Eiffel,
che ideò anche la Torre Eiffel a
Parigi. Nel 1900 la linea dei tram
di Nizza venne elettrificata ed
estesa all'interno département,
da Mentone a Cagnes-sur-Mer.
La Belle
Époque fa di Nizza una delle mete del turismo di alto bordo in Europa. Vi
affluiscono nobili tedeschi,
austriaci e russi per godere del
mite inverno della riviera. Con la rivoluzione
russa saranno
poi in molti a trasferirvisi in
pianta stabile negli anni '20 e
'30, riuniti attorno alla Chiesa
russa ortodossa di San Nicola. Negli anni '30 Nizza ospitava gare automobilistiche internazionali del
circuito Formula
Libre (predecessore
della Formula
Uno)
sul circuito di Nizza,
che prendeva inizio sul lungomare
a sud dei giardini Albert I,
proseguiva a occidente lungo la Promenade
des Anglais e
quindi girava di 180 gradi all'Hôtel
Négresco per
tornare a oriente fino al Quai
des Etats-Unis.
La
crescita tumultuosa della città,
dovuta principalmente al turismo,
fra la fine dell'Ottocento e la
prima metà del Novecento, e
l'arrivo di immigrati provenienti
da ogni parte della Francia e
dall'estero sommerge l'antico
nucleo etnico nizzardo. Il
rapporto con l'Italia si allenta
sempre più fin quasi a scomparire
negli anni trenta e quaranta del
Novecento, complice anche la
seconda guerra mondiale e
l'aggressione nazifascista alla Francia.

Allo
scoppio della seconda
guerra mondiale Nizza
si distinse per la resistenza
antinazista, fu vittima di
rappresaglie e di deportazioni di
ebrei che vi avevano trovato
rifugio durante i mesi di
occupazione da parte del Regno
d'Italia.
Nel
settembre 1939 Nizza divenne
rifugio di molti stranieri
sfollati, in particolare ebrei in
fuga dall'occupazione nazista in
Europa orientale. Da Nizza molti
cercarono ulteriore rifugio nelle
colonie francesi, in Marocco e nel Nord e Sud America. Dopo il luglio del 1940 e l'instaurazione
del regime
di Vichy,
le aggressioni antisemite
accelerarono l'esodo, iniziando
nel luglio 1941 e continuando fino
al 1942. Il 26 agosto 1942, 655
ebrei di origine straniera furono
rastrellati dal governo di Laval e
internati nella caserma di Auvare.
Di questi, 560 furono deportati
nel campo
di internamento di Drancy il
31 agosto 1942.
I
primi résistants nizzardi
a partire dal settembre 1940
furono un gruppo di ex studenti
del liceo di Nizza (oggi Lycée
Masséna), poi arrestati e
giustiziati nel 1944 presso
Castellane (gola
del Verdon).
Il 14 luglio 1942 per la prima
volta diverse centinaia di
manifestanti scesero in strada
lungo l'Avenue de la Victoire e in
Place Masséna.
L'11
novembre 1942, in risposta all'operazione
Torch scatenata
dagli Alleati, le truppe tedesche
occuparono la maggior parte della
Francia di Vichy, mentre le truppe
italiane presero possesso di una
zona più piccola, inclusa Nizza.
La popolazione nizzarda, molti dei
quali erano recenti immigrati di
discendenza italiana, mostrò una
certa ambivalenza verso le forze
di occupazione. Grazie all'opera
dell'avvocato ebreo Angelo
Donati e del cappuccino Padre
Maria Benedetto le
autorità fasciste frenarono
l'applicazione delle leggi
antisemite e la deportazione degli
ebrei.
Dopo
il ritiro del Regio Esercito a
seguito dell'Armistizio
di Cassibile,
all'indomani dell'8 settembre 1943
fu occupata dalle forze tedesche.
La resistenza nizzarda acquisì
slancio e le rappresaglie si
intensificarono tra il dicembre
del 1943 e il luglio del 1944,
quando molti partigiani furono
torturati e giustiziati dalla Gestapo locale e dalla milizia collaborazionista francese. Nizza fu anche
pesantemente bombardata il 26
maggio 1944 da aerei americani in preparazione dello sbarco alleato in Provenza
(1000 morti o feriti e più di
5600 persone senza fissa dimora) e
subì la carestia dell'estate del
1944. I paracadutisti americani
entrarono in città il 30 agosto
1944 e Nizza fu finalmente
liberata (Operazione
Dragoon).
Le conseguenze della guerra furono
pesanti: la popolazione diminuì
del 15% e la vita economica fu
completamente distrutta.

Nella
seconda metà del XX secolo, Nizza
ha goduto di un boom economico
principalmente guidato dal turismo
e dalle costruzioni.
Due
uomini hanno segnato questo
periodo: Jean
Médecin,
sindaco per 33 anni dal 1928 al
1943 e dal 1947 al 1965, e suo
figlio Jacques
Médecin,
sindaco per 24 anni dal 1966 al
1990. Sotto la loro guida, c'è
stato un ampio rinnovamento
urbano, inclusa la costruzione del
centro congressi, i teatri, le
nuove arterie e le superstrade.
Jean Médecin era figlio del
notabile
nizzardo Alessandro
Medico (poi
francesizzato in Alexandre Médecin).
L'ondata
migratoria dei Pieds-noirs negli anni
sessanta -
ex coloni francesi profughi
dall'Algeria dopo l'indipendenza
del 1962, tra cui anche molti italo-algerini - ha anche dato un impulso alla città e ha in qualche modo modificato
la composizione della popolazione
e le opinioni tradizionali; i pieds-noirs restano
visti da taluni come un corpo
estraneo alla città, e unitamente
alla globalizzazione di fine
millennio, spingeranno anzi alcuni
nizzardi a riporre le proprie
speranze in una forma di
nazionalismo sempre più
escludente ed acceso e, in taluni
casi, anche intollerante.
Alla
fine degli anni '80, voci di
corruzione politica nel governo
della città sono emerse sempre più
di frequente; indagato, Jacques
Médecin nel
1990 abbandonò il paese, per
essere arrestato tre anni più
tardi in Uruguay ed estradato in Francia nel 1994, dove venne condannato per vari reati
di corruzione e crimini associati
e incarcerato.
Nel
febbraio 2001, i leader europei si
sono incontrati a Nizza per
negoziare e firmare quello che fu
poi noto come Trattato
di Nizza,
che modificò le istituzioni dell'Unione
europea.
L'attuale
sindaco di Nizza, Christian
Estrosi (eletto
nel marzo di 2008) è membro del partito di destra UMP.
La
sera del 14 luglio 2016 sul Lungomare
degli Inglesi,
il franco-tunisino Mohamed
Lahouaiej Bouhlel scagliò un
camion contro la folla riunita per
gli annuali festeggiamenti della presa
della Bastiglia,
facendo 87 morti e 202 feriti (Strage
di Nizza).

Monumenti
e luoghi d'interesse
“Nizza,
città della villeggiatura
invernale della Riviera”.
Con questa motivazione la capitale
della Costa Azzurra è entrata a
far parte del patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Il perimetro
interessato copre un’area
di 500 ettari e comprende l'intero
lungomare: Promenade des Anglais,
Quai des Etats-Unis, terrazze
delle Ponchettes che sono una
delle più antiche strutture
turistiche in Francia, progettate
nel diciottesimo secolo. Incorpora
inoltre Rauba-Capeu, comprende la
Colline du Château e il porto.
L’area
si estende poi al Mont Boron, alle
colline di Cimiez e delle
Baumettes che costituiscono
l'anfiteatro rivolto verso il
mare, caratteristico delle città
della Riviera. Lo spazio della
città interessato parte dal mare
per giungere, a nord, alla linea
ferroviaria con alcune ulteriori
estensioni come la Cattedrale
ortodossa russa.
Alla
luce di questo Riconoscimento si
può rileggere la storia più
recente di Nizza come quella di
località creata per i turisti e
non luogo che si è adattato al
turismo. Una affermazione che può
sembrare paradossale per quella
che è oggi la quinta città di
Francia per popolazione. Ma se
riandiamo al periodo precedente al rattachement, il
ricongiungimento tramite
plebiscito alla nazione
transalpina del 1860, troviamo una
località piuttosto piccola,
costretta negli spazi di quella
che oggi si definisce la Vecchia
Nizza, il Vieux-Nice. Erano i
tempi della Contea di Nizza,
appartenente agli Stati Sardi che
estendevano i loro confini fino al
fiume Var.
Vicende
storiche a parte, riandando agli
esordi del turismo, Alexandre
Dumas aveva sintetizzato questo
cambiamento in atto. Nel Impressions
de voyage del
1851 scriveva: “Ci sono due città
a Nizza, la città vecchia e la
città nuova, “l’antica
Nizza” e la Nizza nuova: la
Nizza italiana e la Nizza
francese. In realtà erano stati i
Piemontesi che, avendo intuito le
potenzialità turistiche della
città, avevano cominciato a
indirizzare l’urbanistica verso
la valorizzazione dell’amenità
del paesaggio.
Passeggiata
degli Inglesi

La Promenade
des Anglais è una passeggiata che costeggia il lungomare della baia
degli Angeli (baie
des Anges).
All'inizio
del XIX secolo vi era un piccolo
sentiero in terra battuta e pietre, largo un paio di metri, chiamato
"Cammino degli Inglesi",
che collegava la riva destra del
fiume Paglione al sobborgo della Croce di Marmo (Croix de Marbre). Fu
realizzato dalla comunità
britannica per trascorrere
l'inverno in città e fu
finanziato dal reverendo Lewis
Way.
Il
documento nº 107 allegato al piano
regolatore predisposto
dall'agenzia urbanistica del
Consiglio d'Ornato prevedeva un percorso sul bordo del mare, dalla foce del Paglione fino a
valle del torrente Magnan. Il litorale fu messo a libera disposizione della municipalità
con la regia
patente del
5 maggio 1835 firmata dal re Carlo
Alberto di Savoia.
Il 29 aprile 1836 il consiglio
municipale approvò il progetto
presentato dall'architetto
comunale Antoine (Antonio)
Scoffier, che disegnò il
tracciato già presente nel 1830, con un'estensione e uno schema tuttora presenti nell'attuale lungomare.
Nel 1844 furono finanziati i primi lavori che completarono il primo tratto
dall'angolo sud-est della foce del
Paglione fino al quartiere San
Filippo, sopraelevato di 5 metri
rispetto al livello del mare. Il
progetto ne prevedeva una
larghezza di 23 metri, ma ne
furono realizzati solo 12 metri.
Negli
anni 1854-1856 la strada prese il nome di lungomare degli Inglesi (promenade des
Anglais) e fu prolungata fino
al torrente Magnan come da
progetto dell'architetto François
Aune. Vi si realizzarono
importanti lavori che portarono
all'allargamento della strada di
ulteriori 11 metri, in modo da
formare un percorso con una doppia
fila di alberi. Dopo l'annessione
alla Francia del 1860, il lungomare fu poi prolungato fino ai quartieri di Sant'Elena (Sainte-Hélène)
nel 1878,
di Carras nel 1882 e successivamente fino al fiume
Varo nel 1903.
Il
13 aprile 1902 Léon Serpollet conquistò
il record
di velocità terrestre a
bordo del suo veicolo "Œuf
de Pâques" (Uovo di
Pasqua)
con motore
a vapore,
percorrendo il lungomare degli
inglesi alla velocità di 120,8 km/h.
 Le
ville e i giardini presenti lungo
il percorso furono Le
ville e i giardini presenti lungo
il percorso furono
distrutti gradualmente
e vennero sostituiti da palazzi e
alberghi di lusso, casinò ed edifici residenziali. Il traffico crebbe e cominciò a causare
problemi già nel 1920,
tanto che l'amministrazione
comunale iniziò ulteriori lavori
tra l'Opera e viale Gambetta
nel 1929-1931 realizzando l'attuale vista del lungomare. L'allargamento proseguì
tra viale Gambetta e viale Ferber
nel 1949-1953.
Il
lungomare è ora congestionato
dalla circolazione
stradale e in
alcuni punti forma una grande
arteria urbana con due corsie per
senso di marcia.
Il
lungomare degli Inglesi, chiamato
semplicemente Promenade o
abbreviato in Prom’, è oggi una delle attrazioni panoramiche più conosciute di Nizza ed è stata dichiarata come area di valorizzazione dell'architettura e
del patrimonio (AVAP)
dall'amministrazione comunale, che
ha anche richiesto la sua
candidatura a patrimonio
mondiale dell'umanità.
Grazie
alla lieve brezza marina quasi costante, il lungomare è un luogo di incontro, anche per
gli amanti del pattinaggio e del jogging. Sulla parte meridionale è stata tracciata una pista
ciclabile, che permette di attraversare velocemente la città in bicicletta da est ad
ovest.
Oltre
che per le importanti
manifestazioni che vi si svolgono,
tra cui, fino al 2016, il
Carnevale di Nizza e le battaglie
dei fiori, il lungomare è
rinomato per le sue "sedie
blu" (chaises bleues,
un simbolo di Nizza) e i suoi pergolati,
ideali per
un farniente tipicamente
mediterraneo e per la
contemplazione della Baia degli
Angeli.
Dal
1988 sul lungomare è posizionato
il traguardo della corsa
ciclistica a
tappe Parigi-Nizza. Il lungomare di Nizza è stato utilizzato anche come percorso per la tappa
a cronometro del Tour
de France del 2 luglio 2013.
Nella
notte tra il 14 e il 15 luglio
2016, il lungomare degli Inglesi
è stato soggetto a un attentato che
ha provocato 86 vittime (di cui
una decina sono bambini) e più di
200 feriti.
L'attacco
terroristico è stato attuato
durante la notte dei
festeggiamenti per la presa
della Bastiglia verso
le 22:30 mentre sul lungomare si
teneva uno spettacolo
pirotecnico.
Un camion è riuscito ad entrare
sul lungomare ad una velocità di
circa 80 km/h facendo
movimenti a zig zag in mezzo alla
folla per uccidere più civili
possibili, mentre lo stesso
conducente sparava sui civili con
un fucile
d'assalto.
Il carnefice, un uomo
franco-tunisino di 31 anni, è
stato ucciso in seguito dalla Gendarmeria
Nazionale Francese. Si
sospetta che l'attentato sia stato
effettuato sotto l'ordine dello Stato
Islamico dell'Iraq e del Levante.
Questo
enorme viale è un'opera
architettonica speciale, con un
rivestimento di colore marroncino,
chioschi e pergolati posti lungo
gli 8 km di spiaggia.
Anche
i lampioni hanno caratteristiche
uniche, perché oltre ad
illuminare la strada e la
passeggiata, servono anche come
fari di avvicinamento degli
aeromobili che giungono da ovest
e, dopo una curva, devono
allinearsi con le piste
rispettando il percorso di luce in
modo da non sorvolare la città.
Durante
il giorno e alla sera è possibile
osservare, seduti sulle sedie blu,
gli aerei che volano a bassa quota
sul mare.
Gli
edifici si trovano nel lato nord
del lungomare ed inizialmente
erano numerati con numeri
progressivi, anziché con i soli
numeri dispari come avviene oggi.
I
primi hotel di lusso (Royal,
Negresco) e l'Opera si affacciano
a nord sulla rue de France verso
la Promenade: Nizza era stazione
invernale per gli amanti del clima
mite e secco in inverno (non il
mare).
Piazza
Massena
È
una delle piazze più
rappresentative di Nizza e ospita La
conversazione, gruppo di sette
opere d'arte moderna di Jaume
Plensa dedicate
ai sette continenti, un monumento
alla Costa Azzurra e una grande
fontana.
Piazza
Garibaldi
È
la piazza più antica di Nizza, i
palazzi che la circondano furono
edificati secondo i canoni
dell'architettura sabauda. Al suo
interno è presente una statua
di Giuseppe Garibaldi,
nativo di Nizza, rivolta verso l'Italia.
 Cattedrale
di Santa Reparata Cattedrale
di Santa Reparata
La cattedrale
di Santa Reparata è il principale
luogo di culto cattolico di Nizza
ed è
situata nel centro storico della
città.
Costruita in stile
barocco nel XVII
secolo e basilica
minore dal 1949, è sede della cattedra
del vescovo
di Nizza. Ciononostante, essa non è la chiesa più grande della città, primato
che spetta alla basilica
di Notre-Dame de l'Assomption.
La
prima cattedrale di Nizza,
dedicata a Santa
Maria Assunta,
sorse nel V
secolo all'interno della città fortificata, sulla collina del Castello; era
a navata unica e terminava con un'abside a pianta quadrangolare, sostituita in epoca carolingia da una
semicircolare; era dotata di un battistero, costituito da un edificio a sé stante, le cui tracce però non sono
pervenute nel corso degli scavi
archeologici che hanno interessato
l'area nei
secoli XIX e XX.
Nell'XI secolo l'edificio
venne ulteriormente ampliato e
portato a tre navate; terminati i
lavori, fu consacrato nel 1049. La cattedrale, che si presentava in condizioni di fatiscenza, venne
ricostruita tra il 1429 e
il 1486; furono edificati un
ampio coro con cripta sottostante
e di numerose cappelle laterali.
Nel 1531 la sede vescovile venne trasferita dalla chiesa di Santa Maria Assunta
a quella di Santa Reparata. La
vecchia cattedrale divenne la
chiesa del castello e, gravemente
danneggiata da un bombardamento
nel corso dell'assedio francese
del 1691,
venne definitivamente demolita
nel 1706 (insieme al resto del complesso) per ordine di Luigi
XV di Francia.
La
chiesa di Santa Reparata era sorta
nel medesimo luogo in cui, nel 1078,
il ricco borghese Raimbald
Rostagni aveva fatto edificare una
cappella per accogliere le
reliquie di santa
Reparata (martire
a Cesarea
di Palestina durante
la persecuzione
di Decio del 250-251 e particolarmente venerata nell'Italia medioevale), delle quali era entrato in possesso durante un viaggio a Roma; essa era situata al di fuori del centro abitato dell'epoca, lungo la carriera
Draperium, ai piedi della
collina del Castello di Nizza. A partire dal 1185 l'oratorio
con le terre circostanti divenne
priorato dell'abbazia benedettina di
Saint-Pons e, dopo esser stato ricostruito in forme più ampie agli inizi del XIII
secolo, divenne sede parrocchiale nel 1246. In seguito all'aumento della popolazione, la chiesa, che venne così
ad essere compresa entro il
perimetro urbano, fu ampliata tra
il 1455 e il 1468.
La
chiesa fu ceduta nel 1531 dall'abbazia di Saint-Pons alla diocesi
di Nizza per
diventarne cattedrale; nel 1533 il trasferimento venne accettato dai Duchi
di Savoia e ufficialmente ratificato e attuato nel 1590 con una cerimonia presieduta dal vescovo Luigi Pallavicini, alla
presenza di Carlo
Emanuele I di Savoia.
Giudicato
l'edificio inadeguato alle nuove
esigenze, il vescovo Desiderio
Palletta, C.R.L. affidò nel 1649 all'architetto
Giovanni Andrea Guiberto
l'incarico di progettarne uno
nuovo. I lavori iniziarono il 7
gennaio 1650 e Guiberto ne mantenne la direzione fino al 1680. Nella fase iniziali la costruzione procedette speditamente, tanto che
nel corso del 1651 vennero
completati sia il transetto, sia la cupola;
successivamente subì una battuta
d'arresto a causa della difficoltà
di reperire i fondi. Nel 1651 venne demolito il campanile della vecchia chiesa, mentre nel 1655 crollò la volta della navata, ferendo a morte il vescovo Palletta. Fu
il vescovo Enrico Provana di
Leyni, O.C.D. a
dare nel 1673 un nuovo impulso per il completamento dell'opera, compiuto entro il 1685 sotto la direzione di Marc' Antonio Grigho. La cattedrale venne
finalmente consacrata il 30 maggio 1699 dal vescovo Provana di Leyni.
 L'edificio
si presentava mancante della torre
campanaria e della facciata: il primo venne edificato su disegno di Carlo Antonio Castelli (coadiuvato
da Carlo Gioanetti) L'edificio
si presentava mancante della torre
campanaria e della facciata: il primo venne edificato su disegno di Carlo Antonio Castelli (coadiuvato
da Carlo Gioanetti)
nel 1731-1757 per
volere del vescovo Raimondo
Recrosio, B. (morto 1732); il prospetto, invece, fu costruito soltanto tra il 1825 e il 1830 seguendo
i disegni originali di Giovanni
Andrea Guiberto. Nel 1899 il
vescovo Henri-Louis Chapon modificò
l'area del coro facendo
proseguire le navate laterali ai suoi lati oltre il transetto, e facendo edificare tra
il 1900 e 1903 l'abside
semicircolare.
Nel 1906 la cattedrale divenne monumento
storico di
Francia, mentre nel 1949 fu
elevata alla dignità di basilica
minore.
Nel 2009 iniziò un intervento di restauro conservativo sia all'esterno, sia
all'interno edificio, in parte
finanziato
dal dipartimento
delle Alpi Marittime e
completato nel 2015.
Il
15 luglio 2016 è stata celebrata nella cattedrale una messa in suffragio per le
vittime della strage
di
Nizza (avvenuta la sera precedente); la cerimonia è stata presieduta dal vescovo André
Marceau e vi hanno partecipato
numerose personalità del mondo
politico, tra le quali il sindaco
di Nizza Philippe Pradal e l'ex presidente
della Repubblica francese Nicolas Sarkozy.
ESTERNO
- La
facciata della cattedrale di Santa
Reparata venne edificata in stile
barocco tra 1825 e il 1830 seguendo
il progetto originario secentesco
di Giovanni Andrea Guiberto. Il prospetto è a
capanna ed è
suddiviso orizzontalmente in due
ordini da un alto cornicione che
riporta l'epigrafe dedicatoria,
ciascuno dei quali è tripartito
da lesene composite lisce.
In
basso si apre l'unico portale,
sormontato da una nicchia
circolare all'interno della quale
vi è una statua raffigurante Santa
Reparata orante; ai lati, le
statue di San Basso (a
sinistra) e San Siagrio (a
destra), ciascuna entro una
propria nicchia. Similmente, ai
lati del finestrone rettangolare
che si trova al centro dell'ordine
superiore, vi sono due nicchie con
le statue di San Valeriano (a
sinistra) e San Ponzio (a
destra). Il coronamento della
facciata è costituito da un timpano triangolare
spezzato sormontato da quattro
fiaccole marmoree.
Alla
destra della facciata vi è il campanile settecentesco, costituito da una torre a pianta quadrangolare; la cella si apre verso
l'esterno con un'ampia monofora ad arco a
tutto sesto su ogni
lato affiancata da lesene ioniche, e
la copertura è costituita da una
slanciata cuspide. La crociera è
esternamente sottolineata dalla
presenza della cupola,
la cui sommità raggiunge
l'altezza di 39 metri; essa
presenta sia il tamburo,
sia la lanterna,
ed è caratterizzata dalla
copertura della calotta costituita
da riggiole policrome.
INTERNO
NAVATE
- Internamente,
la cattedrale di Santa Reparata
presenta una pianta
a croce latina. L'aula è suddivisa in tre navate (quella maggiore coperta con volta
a botte lunettata, quelle
minori con volta
a vela) di quattro campate ciascuna da due file
di archi
a tutto sesto poggianti
su pilastri ai quali, nella navata
centrale, sono addossate delle lesene corinzie con
i capitelli dorati; queste
sorreggono l'alto cornicione che
corre alla base della volta anche
nel transetto e nell'area
absidale, e che presenta a bassorilievo elementi vegetali e stemmi sorretti da puttini. La fastosa decorazione barocca in
stucco dell'interno venne
realizzata da Giovanni Pietro Riva
tra il 1655 e la fine del XVII
secolo, ispirata al barocco genovese. In corrispondenza di ogni campata delle
navate laterali si apre una
cappella a pianta rettangolare,
coperta con volta a botte.

CAPPELLE
LATERALI
- La
prima cappella di sinistra è
adibita a battistero, con fonte
battesimale sormontato
da una statua del nizzardo Joseph Raimondi raffigurante San Giovanni Battista (XIX
secolo). Segue la cappella dei santi
Quattro Coronati, già
della corporazione dei muratori,
con le tele Martirio dei
santi Quattro Coronati di
Ercole Trachel (XIX
secolo, sull'altare), San Serafino da Montegranaro (fine del XVIII
secolo, a destra)
e il Martirio dei santo Quattro Coronati (XVII
secolo, a sinistra); la balaustra in marmo venato verde-grigio risale al XVIII
secolo.
La terza cappella, dedicata a santa Reparata, ospita al di sopra dell'altare
marmoreo seicentesco finemente
intarsiato in marmi policromi la
tela Decollazione di santa
Reparata di Ercole
Trachel (1839) e sulle pareti laterali le tele degli inizi del XVII
secolo Tortura di santa Reparata con le torce infiammate (a
destra) e Tortura di santa Reparata con il piombo fuso.
L'ultima cappella è quella di San Giuseppe, già patronato della famiglia
Turati e sede della confraternita
degli agonizzanti; la pala
d'altare è opera di Jean-Baptiste
Biscarra e raffigura
la Morte di San Giuseppe (1842), mentre ai lati vi sono due tele del 1685 con i santi patroni della famiglia Turati, rispettivamente San
Luigi di Francia e San Carlo
Borromeo (a destra) e Sant'Andrea
e San Pietro apostoli.
L'ancona dell'altare della prima cappella di destra, dedicata alla Vergine
Addolorata, è
caratterizzata da una ricca
decorazione dorata a rilievo, con
la rappresentazione della Veronica sulla
trabeazione; al centro, entro una
nicchia, vi è la statua lignea
policroma della Pietà (XVIII
secolo).
Segue la cappella del Crocifisso, che prende nome dalla grande scultura secentesca posta
sull'altare, alle cui spalle si trova a completamento la tela di Joseph Provensau La
Madonna, la Maddalena e san
Giovanni Battista ai piedi della
croce (1837); vi sono anche le tele di Jean-Baptiste Passadesco Santi
Geronimo e Domenico (parete
di destra) e La
Madonna presenta Gesù bambino a
sant'Antonio di Padova (1682, parete di sinistra).
Vi è poi la cappella di Santa Rosa da Lima, fatta erigere dalla famiglia
Dettati-Doria (imparentata con la
santa), che ospita le tele di
Bernardino Baldoïno Sant'Eligio
tra i san Giovanni Battista e
sant'Andrea (1646,
sull'altare), Santa Rosa che guarisce un bambino (1680, a destra) e Apparizione della Vergine a santa Rosa (1680, a sinistra). Infine vi è la cappella di Sant'Alessandro, devastata da un
incendio nel 1989 che
causò la perdita delle tre tele;
rimangono integri l'altare, gli
stucchi e i dipinti sulla volta.


Il transetto presenta il medesimo schema della navata, con volta
a botte lunettata e
lesene corinzie lungo le pareti.
La crociera è
coperta dalla cupola, alla base della quale vi sono quattro pennacchi con bassorilievi in stucco
dorato raffigurati
gli Evangelisti (1655); le vetrate policrome del tamburo risalgono
al 1900. A ridosso del pilastro nord-orientale, vi è il Monumento a
Jean-Pierre Sola, vescovo
di Nizza dal 1857 al 1877,
edificato nel 1885, con statua marmorea del presule. Sul pilastro sud-orientale, invece,
vi è il pulpito marmoreo secentesco, rivolto verso la navata maggiore.
Ciascuno
dei due bracci del transetto termina
con una cappella. Quella di destra
è adibita a custodia del Santissimo
Sacramento, con grande
altare marmoreo la cui ancona è
costituita da un'alta trabeazione
sorretta da quattro colonne
tortili; al centro, al di sopra del tabernacolo vi è la tela Disputa del Sacramento e Cristo in gloria,
del XVII
secolo, liberamente
ispirata all'analogo
affresco di Raffaello
Sanzio situato nella Stanza
della Segnatura, in Vaticano; sulle pareti laterali, altre due tele del XVII
secolo incentrate sul tema dell'Eucaristia, ovvero Mosè e la manna (a sinistra) e Aronne
e l'Arca dell'Alleanza (a
destra). La cappella del
transetto di sinistra venne
edificata nel 1699 in seguito ad un voto fatto a santa
Rosalia di Palermo per
scongiurare la fine della peste;
la pala d'altare del XVII
secolo Santa
Rosalia e san Rocco inquadra
la nicchia entro la quale è
accolta la statua lignea policroma
della Vergine Immacolata (1655). Ai lati, le tele Presentazione di Maria al Tempio (a
destra) e Sposalizio
della
Vergine (a sinistra), degli inizi del XIX
secolo.
CORO
E ABSIDE - Oltre
la crociera,
la navata centrale prosegue con il coro secentesco, che termina con l'abside edificata su modello delle due cappelle del
transetto nel 1900-1903; coeve a quest'ultima sono i due prolungamenti delle navatelle oltre la
nave trasversa, dei quali quello
di sinistra presenta una cappella
dedicata a san
Giovanni XXIII e
adibita a sepolture dei vescovi di
Nizza, con diverse lapidi che
commemorano i presuli defunti.
L'area
presbiterale occupa
interamente sia il coro, sia
l'abside, ed è delimitata da una
balaustra in marmi policromi
intarsiati risalente al XVII
secolo, che presenta gli
stemmi della famiglia
Grimaldi. Immediatamente alle spalle di quest'ultima, sulla sinistra, trova
luogo la cattedra episcopale,
in legno intagliato, il cui seggio
è sormontato da un baldacchino a
padiglione. A ridosso della
parete di fondo vi è l'altare
maggiore marmoreo, che presenta le medesime decorazioni della coeva balaustra;
al centro
del paliotto si
apre un oculo ovale entro il quale è posta un'urna con le reliquie di Saint-Victor. Nell'abside vi
sono tre dipinti
del 1655: Gloria
di Santa Reparata (al di
sopra dell'altare), San
Siagrio (a sinistra) e San
Basso (a destra).

ORGANI
A CANNE
- La
presenza di un organo
a canne all'interno
della cattedrale è testimoniata
fin dal XVII
secolo; un nuovo strumento
venne costruito nel 1732 per volere del vescovo Recrosio, privato di parte delle canne durante la rivoluzione
francese e
ricostruito ex novo da
Giuseppe Concone nel 1805;
quest'ultimo organo, che aveva 24 registri su due manuali e pedale, fin da subito mostrò segni di
malfunzionamento, tanto che già
nel 1808 dovette intervenire per una manutenzione straordinaria lo stesso
costruttore, e nel 1831 Giosuè
Agati. Nel 1843 il figlio di Giosuè, Nicomede, presentò un progetto di un nuovo
organo in stile italiano con 34
registri su due manuali (dei quali
il secondo in cassa espressiva) e
pedale, che venne respinto; lo
strumento fu realizzato invece
dalla ditta
Serassi di Bergamo nel 1845-1848 (opus 589, collaudato da padre
Davide da Bergamo il
14 febbraio 1848), con 77 registri su due manuali e pedale, ma venne rimosso nel 1899 per far posto ad un nuovo organo in stile francese, costruito da
Florentin Martella (già operaio
presso Aristide
Cavaillé-Coll) e terminato
nel 1901.
Nel 1974 venne realizzato l'attuale organo da Jean-Loup Boisseau su progetto di
Pierre Cochereau, riutilizzando la
cassa di inizio secolo.
L'organo
maggiore, in abbandono dal 2005,
si trova sulla cantoria in
controfacciata. Esso è a trasmissione
mista, meccanica per i
manuali e il pedale ed elettrica
per i registri ed è in stile
neoclassico; dispone di 69 registri disposti su quattro manuali e pedale e la sua consolle è a finestra,
al centro della parete anteriore
della cassa.
Sotto
l'arcata tra il coro e la cappella
di San Giovanni XXIII, si trova a
pavimento un secondo organo a
canne, costruito da Federico
Valencini nel 1866 e successivamente più volte modificato (delle quali l'ultima dalla
ditta Delangue nel 2007);
a trasmissione elettronica con
consolle mobile indipendente a
pavimento nel transetto, dispone
di 17 registri su due manuali e pedale.

 Pag.
2
Pag.
2
|