|
Cattedrale
di Maria Santissima Assunta in Cielo
Il Duomo
di Reggio (nome completo: Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria
Santissima Assunta in Cielo), dedicato a Maria Santissima Assunta, è il più
grande edificio religioso della Calabria, e sorge nel centro storico della
città, dove mostra il suo prospetto principale sull'ampia Piazza del
Duomo.
 Le
origini della Cattedrale di Reggio sono da ricondurre agli inizi del II
millennio quando, con l'invasione normanna dell'Italia
meridionale, Reggio subì un processo di "latinizzazione" e
progressivo abbandono del culto greco-bizantino di cui era il centro. Nel 1061 infatti
giunsero in città i Normanni di Roberto il Guiscardo che,
scacciati i Bizantini e creato in Reggio il Ducato di Calabria,
lasciarono alla popolazione di etnia greca l'antica cattedrale (chiamata
"La Cattolica"), per ordinare la costruzione di una nuova cattedrale
che fosse sotto l'ordinamento del Papa di Roma, cui erano legati i Normanni. Le
origini della Cattedrale di Reggio sono da ricondurre agli inizi del II
millennio quando, con l'invasione normanna dell'Italia
meridionale, Reggio subì un processo di "latinizzazione" e
progressivo abbandono del culto greco-bizantino di cui era il centro. Nel 1061 infatti
giunsero in città i Normanni di Roberto il Guiscardo che,
scacciati i Bizantini e creato in Reggio il Ducato di Calabria,
lasciarono alla popolazione di etnia greca l'antica cattedrale (chiamata
"La Cattolica"), per ordinare la costruzione di una nuova cattedrale
che fosse sotto l'ordinamento del Papa di Roma, cui erano legati i Normanni.
Dunque
la cattedrale originaria era probabilmente un edificio gotico a cinque navate.
Secondo alcuni studiosi questo tempio presentava analogie sensibili e perfette
con la Cattedrale di Cefalù nella forma, nella pianta e nelle
dimensioni.
Comunque
informazioni documentate sulla cattedrale reggina risalgono agli anni 1453 e
1477, quando l'arcivescovo Antonio De Ricci fece aggiungere alla chiesa un
campanile, fino ad allora probabilmente assente.
Durante
il XVI secolo, come molti edifici della città, la chiesa venne
saccheggiata e incendiata dalle incursioni dei turchi per ben due
volte: dopo l'incendio del 1574 fu ricostruita e riconsacrata dall'arcivescovo
Gaspare Ricciullo del Fosso nel 1580 e, dopo il nuovo incendio del 1594, subì
diversi interventi di restauro tra i quali uno ad opera dell'arcivescovo
Annibale D'Afflitto nel 1599, uno dell'arcivescovo Gaspare Creales nel 1665;
infine il tempio fu ancora abbellito e restaurato dall'arcivescovo Ybañez, il
quale terminati i lavori nell'anno 1682, faceva porre una grande lapide
commemorativa nella quale sono elencati i privilegi dell'arcivescovado reggino
sia nel campo civile sia in quello religioso. Questa lapide si può leggere
entrando nella Basilica sulla destra:
|
(LA)
«D.O.M.
/ ALMÆ VIRGINI MATRI AD ÆTHERA ASSUMPTÆ / RHEGINA ECCLESIA / MAGNÆ
OLIM GRECIÆ METROPOLIS PROVINCIARUM MATER ET CAPUT / AB PAULO APOSTOLO
/ ANNO LVIII FUNDATA / EIUSQ. DISCIP. MARTIRI STEPHANO I RHEGIN.
ANTISTTI COMMISSA / IN SPIRITUALIBUS / ARCHIEPISCOPUS RHEGINUS PROVINCIÆ
CALABRIÆ ULTRA ET ULTRA METROPOLITANUS / YOPPULI ARCHIMANDRITA ABBAS
S.DIONUSII DECEM PRÆEST CATHEDRALIBUS ECCLESIIS CASSANENSIS CATACENSIS
CROTONENSIS HIERACENSIS / NEOCASTRENSIS NICOTERENSIS OPPIDENSIS
SQUILLACENSIS TROPIENSIS / IN TEMPORALIBUS / EST AD REGIAM CATUOLICAM PRÆSENTATIONEM
REGIÆQUE MAIESTATIS CONSILIARIUS / COMES CIVITATIS BOVÆ AC RURIS
ADRICI BARO OPPIDI CASTELLACII CUM JURISDICTIONE / MERI ET MIXTI IMPERII
AB IMPERAT. HENRICO IV AN.NO / 1199 CONCESS. ET FEDERICO II AN. 1223
CONFIRMATA D.F. MARTINUS YBAÑEZ ET VILLANUEVA HISPANUS / ORD. SS.
TRINITATIS REDEMPTOR S. AC GNLIS INQUISITIONIS HISPANIAR. QUALIFICATOR /
COMPLUTENSIS SCHOLÆ S. THEOLOG. DOCTOR AC CATHEDRATICUS PRIMARI. EX
EPISCOP. GAETANO ARCHIEPS RHEGINORUM TOTAM HANC ECCLESIAM VETUSTATE PENE
COLLAPSAM ET DEFORMEM INTERIUS / EXTERIUSQ. REPARAVIT ET AD PRÆSENTEM
FORMAM DEO MISERANTE REDUXT AN.D.NI 1682» |
(IT)
«A
Dio Ottimo Massimo. All'Alma Vergine Madre Assunta al Cielo la Chiesa
reggina metropoli della Magna Grecia di un tempo, madre e capo delle
province, fondata nell'anno 58 dall'apostolo Paolo, affidata al suo
discepolo martire Stefano, I vescovo dei Reggini, per la cura dei beni
spirituali Arcivescovo reggino della Calabria Ulteriore e metropolita
della stessa, Archimandrita di Ioppolo, Abate di S. Dionigi, è a capo
di dieci Chiese Cattedrali, i cui vescovi sono suffraganei, quello di
Bova, di Cassano, di Catanzaro, di Crotone, di Gerace, di Nicastro, di
Nicotera, di Oppido, di Squillace, di Tropea; per la cura dei beni
temporali, è alla presentazione del Re cattolico e Consigliere della
regia Maestà, Conte della città di Bova e della campagna di Africo,
barone di Oppido di Castellace con giurisdizione di pura e mista
sovranità, per concessione data dall'imperatore Federico II nell'anno
1223, Martino Ybañez del Villanueva, spagnola dell'Ordine della SS.
Trinità, avvocato e qualificatore della Santa e Generale Inquisizione
Spagnola, dottore e primo cattedratico della scuola complutense di Sacra
Teologia, dall'episcopato di gaeta arcivescovo di Reggio, con la
misericordia di Dio restaurò all'interno e all'esterno e riportò allo
stato presente tutta questa Chiesa, deforme e quasi crollata per la
vetustà. Nell'anno del Signore 1682.» |
Nel
1741 monsignor Polou fece riedificare un nuovo tempio in stile tardo
barocco, in un periodo in cui si cominciava a risentire delle influenze neoclassiche tipiche
del vicino barocco siciliano, con una struttura a croce latina e a tre
navate, ubicata accanto all'attuale via Castello e che si inoltrava
verso il corso Garibaldi (da est a ovest).
Pochi decenni
dopo la cattedrale venne danneggiata dal terremoto del 1783. Dopo il sisma
l'ing. Giovan Battista Mori fece eseguire ulteriori interventi di
restauro, e la chiesa fu riconsacrata da mons. Capobianco, portata a termine da
mons. Cernicola, abbellita da mons. Converti, con quasi tre restauri ogni due
secoli.
La facciata
recava l'iscrizione di San Paolo in latino: «CIRCUMLECENTES
DEVENIMUS RHEGIUM» («Costeggiando,
giungemmo a Reggio»)

Un nuovo evento
catastrofico, quale fu il terremoto del 1908, provocò notevoli danni,
perciò ne conseguì la decisione di ricostruire integralmente l'edificio
religioso, adeguandosi al nuovo piano di ricostruzione della città redatto
dall'ing. De Nava. Così nel 1913 l'arcivescovo Rinaldo Rousset decise di
riedificare la Cattedrale di Reggio affidando l'incarico al padre carmelitano
Carmelo Umberto Angiolini che, prevedendo l'uso di nuovi materiali e
accorgimenti tecnici antisismici, progettò il nuovo edificio nel 1917
definendolo di stile neo-romanico.
Alcune
modifiche al progetto furono apportate dall'ing. Mariano Francescone, e i lavori
furono eseguiti dalla ditta Chini e terminarono agli inizi del 1928 per
consentire la celebrazione del Congresso Eucaristico Calabrese. La
cattedrale quindi fu riconsacrata il 2 settembre 1928 dall'arcivescovo Carmelo
Pujia.
Il 21 giugno
1978 con bolla pontificia, la cattedrale di Reggio venne elevata alla
dignità di Basilica minore.
La Cattedrale
di Reggio ripropone un'architettura dallo stile eclettico-liberty (largamente
diffuso in città durante l'ultima ricostruzione) che tende a reinterpretare
l'arte medievale romanica e gotica, fondendo elegantemente alcuni
elementi di entrambi gli stili.
Il prospetto
principale è diviso in tre parti con quattro torri traforate di forma
ottagonale sormontate da croci. La parte centrale della facciata presenta una
trifora sormontata da un rosone racchiusi da una cornice decorata a motivi
floreali.
Sulla
scalinata che conduce all'ampia e imponente facciata, sopraelevata insieme
all'edificio rispetto alla prospiciente piazza, sorgono le sontuose statue di San
Paolo, che secondo la leggenda convertì i reggini al cristianesimo, e di Santo
Stefano di Nicea, primo vescovo della città. Le statue furono scolpite nel 1928
da Francesco Jerace e collocate sul sagrato nel 1934. Jerace è
inoltre autore del monumentale pergamo che si trova all'interno.


|
DIVO
PAULO TARSENSI
QUI PRIMUM RHEGINIS JULIENSIBUS CHRISTUM NUNTIAVIT
RHEGINI JULIENSES
ANNO MCMXXXIV
AB HOMINUM GENERE REDEMPTIO
A Paolo di Tarso, servo di Dio che per la prima volta annunciò Cristo
ai Reggini Giuliensi. Nell'anno 1934, dal popolo redento. |
DIVO
STEPHANO NICÆNO
PRIMO RHEGINORUM JULIENSIUM PONTIFICI
RHEGINI JULIENSES
HOMINUM GENERE REDEMPTO
ANNO MCMXXXIV
AB HOMINUM GENERE REDEMPTIO
A Stefano di Nicea, servo di Dio, primo Vescovo dei Reggini Giuliensi.
Nell'anno 1934, dal popolo redento.
|
All'ingresso
si trovano i tre portali in bronzo:
-
il portale centrale, di Luigi Venturini, fu inaugurato in occasione del XXI
congresso eucaristico nazionale del 1988 svoltosi a Reggio. Dedicato alla
titolare della cattedrale, Maria SS. Assunta, illustra le scene di vita della
Madonna.
-
la porta d'ingresso di sinistra, di Biagio Poidomani, illustra episodi che
narrano la storia della devozione di Reggio alla Madonna della
Consolazione.
-
la porta d'ingresso di destra, di Nunzio Bibbò, è dedicata a San
Paolo e raffigura episodi dell'apostolato di Paolo di Tarso cui si legano
le origini della chiesa reggina.

Accanto
al portale centrale, sul lato sinistro una lapide ricorda la visita di Giovanni
Paolo II a Reggio e alle chiese di Calabria del 7 ottobre 1984; mentre sul
lato destro un'altra lapide ricorda il discorso di Giovanni Paolo II del 12
giugno 1988 in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale tenutosi a Reggio.
Il
Campanile del Duomo, alto 28,15 m (43,67 m s.l.m.), fu ultimato
il 30 settembre 1931, e mantiene nella forma lo stile della Cattedrale. Ha
sostituito il campanile diroccato dal terremoto del 1908.
In
una lapide un tempo murata alla base della torre campanaria, ricuperata e
ricomposta nel 1977 (oggi collocata nella galleria auditorium San Paolo a fianco
della Cattedrale), viene ricordata la dignità dell'antico monumento costruito
nel 1453 dall'arcivescovo De Ricci, e ricostruito nel 1841 dall'arcivescovo Pietro
De Benedetto:
|
(LA)
«D.O.M.
/ DISIECTA IAM PRIDEM PERANTIQUA TORRI / QUÆ SACRIS ÆDIBUS ADDICTA /
IAM INDE A MEDIO FERME SÆCULO XV / ARCHIEP. ANTONIO DE RICCIS AUCTORE /
MIRA IN COELUM ALTITUDINE ASSURGEBAT / NOVAM HANC AB INTEGRO INSTABIUS
PRO SOLI INGENIO / HUMILIORI EXTRUENDAM FASTIGIO / ARCHIEP. PETRUS DE
BENEDICTO / AH CR MDCCCXU PRÆSULATUS SUI VI / SUO SUMPTU CURAVIT»
|
(IT)
«A
Dio Ottimo Massimo. Distrutta già da tempo l'antica torre, che era
annessa al sacro tempio, già appena dopo la metà del XV secolo, a cura
dell'arcivescovo Antonio De Ricci, si innalza verso il cielo di
un'altezza meravigliosa. Questa del tutto nuova, da costruire di minore
elevazione a motivo del suolo instabile, l'arcivescovo Pietro De
Benedetto, nell'anno del Signore 1841, VP del suo episcopato, curò a
proprie spese.» |

La prima delle
due celle campanarie si trova nel secondo ripiano, la seconda cella è nella
parte elevata:
- nella prima
cella campanaria fu posta la Campana della Conciliazione;
-in quella
superiore furono collocate: la Campana del Congresso, detta anche della
Consolazione e la Campana del Capitolo, chiamata il campanone.
Il Campanone è
la campana più grande, dopo il terremoto del 1750 l'arcivescovo Damiano Polou,
la fece rifondere ad opera del napoletano Nicola Astarita. Porta inciso lo
stemma del vescovo ed alcune figure sacre (Crocefisso, Vergine Assunta in Cielo
e San Giuseppe).
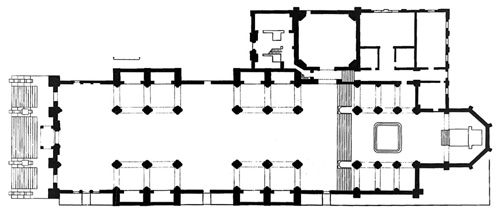 La Campana
della Consolazione fu fatta fondere nel 1926 a Gallico, dall'arcivescovo
Rousset a ricordo del Congresso Eucaristico Regionale. La Campana
della Consolazione fu fatta fondere nel 1926 a Gallico, dall'arcivescovo
Rousset a ricordo del Congresso Eucaristico Regionale.
L'interno è in stile
romanico con motivi d'ispirazione classica. Le colonne a fascio, che
delimitano le navate reggono le capriate scoperte che ricevono il peso del
tetto. Ad ogni incrocio delle travi dello stesso è dipinta una svastica,
per un totale di circa duecento croci uncinate, che nulla hanno a che vedere con
il nazismo, perché sono state dipinte nel 1928, esse simboleggiano il sole e la
luce dell'avvento del Cristo.
Il Duomo si presenta di pianta
basilicale, con tre navate divise da colonne portanti ed intersecate da
crociere che terminano con altrettante absidi separate da archi che poggiano su
pilastri. Le tre navate, interrotte da tre transetti,
terminano con abside poligonale per una lunghezza di 93 metri e una larghezza di
26 metri, e ne fanno il più vasto edificio della regione.
La navata centrale è separata dalle laterali da due
file di colonne, rivestite in marmo con base in pietra di Trani.
Lungo le navate laterali si aprono, con distanza diversa in corrispondenza dei
transetti al di sotto del presbiterio, otto cappelle contenenti opere di
notevole interesse storico-artistico.
La navata destra accoglie i sepolcri dei vescovi
seicenteschi, e quelli recenti degli ultimi vescovi del XX
secolo Aurelio Sorrentino e Giovanni Ferro, quest'ultimo deceduto nel
1992 è sepolto nella seconda cappella di destra il cui monumento sepolcrale è
opera di Michele
Di Raco.
Nella parte terminale della navata destra, ai piedi
della grande tela del XIX
secolo di Minaldi,
che raffigura la "Consacrazione di Santo
Stefano Vescovo di Reggio da parte di San
Paolo", si trova, protetto da un'urna di vetro, un tronco di colonna
che secondo la tradizione sarebbe quella del Prodigio
di San Paolo.
Nell'abside centrale l'altare è in stile romanico,
opera del XX
secolo dello scultore calabrese Concesso
Barca, con la cattedra arcivescovile in marmo, opera del XIX
secolo di Alessandro
Monteleone. Al centro sorge l'altare maggiore della basilica, opera di Antonio
Berti, decorato con un bassorilievo in bronzo.
Sulla navata di sinistra si aprono otto cappelle, tra le
quali nel transetto sorge
la "Cappella del Santissimo Sacramento", che costituisce il più
significativo monumento barocco della
città, per preziosità dei marmi policromi intarsiati a mosaico fiorentino fu
dichiarata monumento
nazionale nel XIX
secolo.

Il Duomo inoltre custodisce preziose opere d'arte come:
- le tele ottocentesche del Crestadoro e
del Minali
- un pulpito marmoreo,
opera di Francesco
Jerace, decorato con due palme in travertino. il tutto proveniente dalla vecchia
cattedrale.
Sull'altare maggiore, da settembre a novembre, viene
esposto il quadro della patrona della città, la Madonna
della Consolazione che attira il pellegrinaggio di centinaia di
migliaia di fedeli.
Dichiarata nel XIX
secolo monumento nazionale, è il più importante monumento d'arte
barocco-seicentesca dell'arcidiocesi reggina. Fu fatta erigere nel 1539
dall'arcivescovo Agostino
Gonzaga come "Cappella della Santissima Trinità", e
successivamente fu trasformata dalla Congregazione del Santissimo Sacramento -
con bolla apostolica del 1548 - in "Cappella del Santissimo
Sacramento"; a quel tempo infatti la congrega era una delle istituzioni più
fiorenti della città.
Nel 1599 fu fatta restaurare dall'arcivescovo D'Afflitto
(1594-1638), e successivamente da mons. Polou, che ne commissionò un'opera di
abbellimento iniziata nel 1640, ma nel 1642 i lavori furono interrotti. Il 14
febbraio 1655 i Rettori della Cappella del Santissimo Sacramento affidarono al
maestro scalpellino messinese Placido
Brandamonte l'opera di abbellimento della Cappella. L'opera fu
terminata nell'agosto del 1655.
La cappella fu danneggiata dal terremoto
del 1783 e da quello
del 1908, e diversamente da quanto accadde per la Cattedrale, che fu
demolita e ricostruita ex novo in un luogo differente, si ebbe il buon senso di
salvare la Cappella, che fu collocata all'estremità del transetto sinistro del
nuovo Duomo di Reggio.
I lavori compiuti per riportare la Cappella allo stato
originario durarono parecchi decenni, perché nel frattempo i bombardamenti
aerei del 1943 causarono un incendio che danneggiò gravemente la Cappella, ma
per volontà dell'arcivescovo Ferro la Cappella fu nuovamente restaurata ed
inoltre arricchita con dei quadri del pittore reggino Nunzio
Bava, quindi fu riaperta al culto il 28 dicembre 1965.

I quadri di Nunzio
Bava rappresentano episodi dell'Antico e
del Nuovo
Testamento:
- sulla destra entrando vi è "Elia Profeta che dorme
sotto un tamarindo svegliato dall'Angelo", l'opera è sormontata dalla
scritta "panem angelorum manducavit homo";
- nella lunetta in alto vi è invece "Mosè che fa
sgorgare l'acqua dalla roccia";
- in basso a sinistra il dipinto rappresenta la scena dei
"discepoli di Emmaus", con la scritta "caro mea vere est
cibus";
- sopra invece vi si trova la scena della
"moltiplicazione dei pani e dei pesci".
La cappella, che nella cattedrale originaria era situata
nell'abside, è a pianta quasi quadrata e le pareti sono totalmente rivestite di
intarsi marmorei policromi.
Le pareti della cappella sono decorate con intarsi a
mosaico fiorentino del XVIII
secolo, mentre i soggetti floreali e animali sono realizzati con marmi
teneri colorati e smalti di Venezia.
Negli angoli, in otto nicchie, sono inserite le statue
rappresentanti i santi apostoli Pietro e Paolo, i quattro Evangelisti, ed i due
dottori eucaristici San Tommaso e San Bonaventura, tutte in marmo bianco, opere
di Francesco Jerace e Concesso Barca.
Sull'altare maggiore fanno spicco le quattro colonne in
pregiatissimo porfido nero con venature gialle, ed il quadro di Domenico
Marolì da Messina,
olio su tela del 1665 raffigurante il "Sacrificio di Melchisedeck".
Al di sopra dell'altare maggiore c'è una piccola
vetrata decorata con i simboli eucaristici.
Il primo organo dell'attuale cattedrale di Reggio
Calabria fu costruito nel 1930 dalla ditta
Balbiani: era a due tastiere con pedaliera e fu rimosso nel 1968 e collocato
nella chiesa
di San Giorgio al Corso. Al suo posto fu costruito un nuovo strumento più
grande, di Fratelli
Ruffatti, con tre tastiere e pedaliera per un totale di 3252 canne. Fra il
2001 e il 2008, poi, venne ampliato e restaurato dalla ditta
Michelotto che, fra le altre cose, ha sostituito la consolle Ruffatti
con una nuova di sua costruzione ed ha realizzato il corpo d'eco, corrispondente
alla quarta tastiera, davanti al corpo principale.
L'organo è a trasmissione
elettronica-computerizzata. La sua consolle, mobile indipendente, si trova a
pavimento nel transetto e ha quattro tastiere di 61 note ed una pedaliera di 32.
L'organo dispone di 4805 canne e 13 campane
tubolari, suddivise fra i 73 registri, di cui 51 reali e 22 in prolungamento
e trasmissione.
Il museo
diocesano di Reggio Calabria, presso la Cattedrale, raccoglie pregevoli
oggetti e arredi sacri. Fra questi un bacolo d'argento
e smaltato del XIV sec., un calice e
una pisside d'oro massiccio donati da Pio
XI in occasione del Congresso Eucaristico Regionale Calabrese del 1928
e un ostensorio d'oro
di Francesco
Jerace.

Pag.
4   Pag.
6
Pag.
6
|