La Valle
dei Templi è un parco archeologico caratterizzato
dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti templi
dorici del periodo ellenico. Corrisponde all'antica Akragas,
monumentale nucleo originario della città di Agrigento.
Dal 1997 l'intera
zona è stata inserita nella lista dei patrimoni
dell'umanità redatta dall'UNESCO. È considerata un'ambita meta
turistica, oltre ad essere il simbolo della città e uno dei
principali di tutta l'isola.
Storia
- Nel 581
a.C. alcuni coloni provenienti da Gela e
da Rodi fondarono una nuova città col nome di Ἀκράγας
(Akragas) in un luogo strategico, vicino al mare e protetto dalle alture
della Rupe Atenea e di Girgenti a nord e dalla Collina
dei Templi a sud, nonché circondato dal corso dei fiumi Akragas (odierno
torrente San Biagio) a est e Hypsas (odierno torrente Santa Anna) a ovest.
L'insediamento si dotò di un ampio sistema difensivo, consistente in un
circuito di mura lungo dodici chilometri e dotato di nove porte di accesso
che sfruttava le caratteristiche topografiche del luogo. Alla fine
del VI secolo a.C. risalirebbe anche la costruzione del primo
grande tempio, quello dedicato ad Eracle, che sorse a ridosso di una
delle porte più importanti della città, la cosiddetta Porta Aurea.
 Akragas
conobbe diverse tirannidi prima con Falaride (570-554
a.C.) ed infine con Terone (488-473 a.C.), il quale diede
particolare impulso all'espansionismo militare della città con la vittoria
sui Cartaginesi nella battaglia di Himera (480 a.C.).
Seguì un periodo democratico instaurato dal
filosofo Empedocle (446-444 a.C.).
Akragas
conobbe diverse tirannidi prima con Falaride (570-554
a.C.) ed infine con Terone (488-473 a.C.), il quale diede
particolare impulso all'espansionismo militare della città con la vittoria
sui Cartaginesi nella battaglia di Himera (480 a.C.).
Seguì un periodo democratico instaurato dal
filosofo Empedocle (446-444 a.C.).
I
grandi templi dorici, costruiti nel corso del V secolo
a.C. in segno di ringraziamento agli dèi per la vittoria sui
Cartaginesi, testimoniano la prosperità raggiunta in questo periodo storico
dalla città (che arrivò a toccare i 20.000 abitanti), tanto da suscitare
l'ammirazione del poeta Pindaro: uno dopo l'altro furono innalzati,
quasi a formare una corona intorno al centro abitato, il Tempio di
Atena sul colle di Girgenti, il Tempio di Demetra sulle
pendici della Rupe Atenea e il Tempio detto L (480-460 a.C.),
quelli detti di Giunone e dei Dioscuri (450 a.C.),
il Tempio detto della Concordia e di Efesto (440-430
a.C.), il santuario d'Esculapio fuori le mura (420-410 a.C.), dove
fu collocata una statua d'Apollo opera del celebre scultore
greco Mirone, per non parlare dell'Olympeion, dedicato a Zeus
Olimpio e considerato il più grande tempio dorico dell'antichità
classica, sicuramente iniziato nel 480 a.C. e proseguito almeno
fino al 406 a.C. ma mai completato.
Durante
il suo apogeo, la pianta urbanistica di Akragas era a griglia con sei larghi
viali (plateiai) incrociati da trenta strade più strette
(stenopòi) ed era così suddivisa: la Rupe Atenea era sede
dell’acropoli con funzione sacra e difensiva, la Collina dei Templi
ospitava i santuari dedicati alle divinità e la zona centrale le abitazioni
civili e gli edifici pubblici mentre più a valle, fuori dalla cinta
muraria, sorgeva l'emporio (odierna frazione balneare di San
Leone), ossia lo scalo marittimo dove approdavano le navi commerciali
provenienti da Cartagine e
dalla Grecia. Sotto Terone, grazie all'ingegno
dell'architetto Feace, la città si dotò anche di un sistema di cisterne,
canali ed acquedotti sotterranei per la raccolta delle acque del
suolo che sboccavano in un grande lago artificiale, la
famosa Kolymbethra.
Dopo
l'assedio e il saccheggio subito da parte dei Cartaginesi nel 406
a.C. durante la seconda guerra greco-punica, seguì un periodo di
decadenza per Akragas, che fu sottoposta all'Epicrazia punica finché
entrò nell'orbita di Siracusa con il condottiero
corinzio Timoleonte (339 a.C.), che ricostruì le mura e la
ripopolò con nuovi abitanti. Alle riforme promosse da Timoleonte si
deve probabilmente la costruzione di nuovi edifici pubblici che occuparono
l'area dell'agorà, ossia l'Ekklesiastérion (sede dell'ekklesia,
l'assemblea popolare) e il Bouleuterion (sede della boulè,
l'assemblea dei rappresentanti eletti dal popolo).
Dopo
alcuni tentativi di liberarsi dell'influenza siracusana, Akragas tornò
nuovamente sotto il giogo cartaginese fino al 210 a.C. quando passò
definitivamente sotto il dominio romano, che latinizzò il nome
della città in Agrigentum e la trasformò in civitas
decumana, cioè tenuta a versare annualmente la decima parte del raccolto
a Roma. Nei primi due secoli dopo la conquista romana furono eretti
sempre nell'area dell'agorà il teatro e un tempietto (falsamente
attribuito al tiranno Falaride) che sorse
sull'Ekklesiastérion ormai abbandonato. Ad ovest dell'agorà si
sviluppò anche un nuovo quartiere in cui si concentrarono abitazioni di
lusso (domus) e botteghe artigiane: esso presentava una pianta a griglia
uguale al centro abitato greco con quattro strade strette (cardi) che
incrociano tre viali larghi (decumani).
Racconta Cicerone nelle
sue Verrine che nel 73 a.C. Verre, governatore romano
della Sicilia, fece rubare la famosa statua d'Apollo dal Tempio di
Esculapio e poi mandò degli uomini a sottrarre anche quella
di Ercole dal Tempio omonimo ma questo tentativo fu
bloccato dalla reazione violenta dei cittadini di Agrigentum armati di
bastoni.
Nel
22 a.C., a causa della riforma voluta dall'imperatore Augusto,
Agrigentum divenne municipium, cioè poteva assumere una certa
autonomia da Roma ed avere perciò magistrature proprie. Nel periodo
successivo (I secolo d.C.) furono terminati il foro (piazza)
con triportico colonnato ed adiacente santuario a tempietto (forse
un iseion, cioè dedicato alla dea Iside) ma anche il ginnasio
(palestra).

A
partire dal VI secolo d.C., a causa delle invasioni barbariche,
l'antica Agrigentum si spopolò ed il centro abitato si spostò
oltre la vecchia cinta muraria, verso la parte alta del colle di Girgenti,
dove si svilupperà la città medievale e poi moderna. La
Collina dei Templi perse così la sua importanza, venendo adibita in un
primo tempo a luogo di sepoltura per i primi cristiani (come
dimostrano le numerose necropoli, risalenti già all'età
romana) e poi a luogo destinato all'artigianato e
all'allevamento. Nel 597 l'area, ormai esclusa dall'abitato,
fu trasformata in luogo di culto cristiano dal vescovo Gregorio, che
decise di trasferire la cattedrale nel Tempio della
Concordia consacrandola al culto degli Apostoli Pietro e
Paolo e distruggendo gli idoli pagani.
Nel
1154, Al-Idrisi, geografo arabo alle dipendenze del re
normanno Ruggero II, fece un vago cenno indiretto alla bellezza
paesaggistica ed architettonica dei templi in rovina nella sua famosa opera
geografica Il libro di Ruggero, probabilmente dopo averli visitati di
persona.
Nel
corso dei secoli successivi, l'area fu completamente abbandonata ed
utilizzata esclusivamente per ricavare i blocchi necessari alla costruzione
della nuova città di Girgenti e del molo antico di Porto Empedocle.
Dopo
secoli di totale abbandono, i Templi furono studiati nel '500 dal
frate domenicano Tommaso Fazello, che ne visitò i resti per la
scrittura della sua grande opera storica De rebus Siculis (1558),
e poi nel '600 dal geografo tedesco Filippo Cluverio, il
quale si trovava in Sicilia per le sue ricerche. Il sito fu tuttavia
riscoperto soltanto nel corso del XVIII secolo grazie allo
studioso tedesco Johhann Joachim Winckelmann (considerato il padre
dell'archeologia moderna e della storia dell'arte), che ne
descrisse la bellezza in un famoso trattato d'architettura ispirato
dagli studi effettuati sul posto dal
monaco teatino toscano Giuseppe Maria Pancrazi tra
il 1751 ed il 1752. L'ascendente di Winckelmann fu
determinante per i viaggiatori europei del Grand Tour, che resero la
Valle dei Templi una tappa obbligata del loro viaggio: tra i più celebri di
essi possiamo ricordare Johann Hermann von Riedesel, Jacques
Philippe D'Orville, Patrick Brydone, Jean-Pierre
Houël, Jean-Claude Richard de Saint-Non, Karl Friedrich
Schinkel ma soprattutto Johann Wolfgang von Goethe, che ne parlò
ampiamente nel suo Viaggio in Italia (1816) e ne rimase
affascinato.

Grazie
all'operato di Gabriele Lancillotto Castello, Principe di
Torremuzza (1727-1794), incaricato della conservazione del patrimonio
archeologico siciliano dal re Ferdinando IV di Borbone, si
effettuò il restauro dei Templi della Concordia e di
Giunone (1787-1788) realizzato dal regio architetto Carlo
Chenchi. Le sue orme furono seguite dall'archeologo Domenico Lo
Faso Pietrasanta, Duca di Serradifalco (1783-1863), nominato
nel 1827 primo presidente della Commissione di antichità e
belle arti per la Sicilia, che curò la maggior parte degli scavi e la
ricostruzione del Tempio dei Dioscuri.
Durante
gli anni '20 del XX secolo, le ricerche archeologiche furono
generosamente finanziate da Sir Alexander Hardcastle, il quale
nel 1925 acquistò una proprietà nella zona, la
cosiddetta Villa Aurea, e collaborò con l'archeologo Pirro
Marconi, incaricato della direzione degli scavi da Paolo Orsi,
Soprintendente alle Antichità classiche della Sicilia. Fu durante queste
campagne che si realizzarono il raddrizzamento delle otto colonne sul lato
sud del tempio di Eracle, il ritrovamento dei quattro telamoni
dell'Olympeion, del santuario delle divinità ctonie e del Tempio di
Demetra, nonché l'abbattimento delle case coloniche sorte sui
resti del Tempio di Asclepio e di quello di Efesto. Per
i suoi contributi agli scavi, Sir Hardcastle fu nominato cittadino onorario
della città di Agrigento, con la concessione dell'onorificenza
di Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.
Nel
corso del '900, notevoli furono le campagne di scavo condotte dagli
archeologi Antonino Salinas (1900), Catullo Mercurelli (1940-41)
e Pietro Griffo (anni '50), che riportarono gradualmente alla luce
le necropoli paleocristiane, le strutture ipogee di
Villa Aurea, i resti dell'Agorà superiore e del
quartiere ellenistico-romano. Nel 1967 fu finalmente
inaugurato il Museo archeologico regionale, fortemente voluto da Pietro
Griffo, cui poi fu intitolato.
Ai
primi anni 2000 risalgono gli scavi nel tempietto
romano situato nel poggio San Nicola condotti dall'equipe
dell'archeologo Ernesto De Miro, ex Sovrintendente ai beni
culturali di Agrigento, che hanno portato alla scoperta di altre due
statue togate marmoree prive di testa che un tempo abbellivano il triportico
del foro romano.

La
nascita del Parco archeologico e il problema dell'abusivismo edilizio
- La
Valle dei Templi fu sottoposta a tutela a seguito della gravissima
frana che nel 1966 distrusse interi quartieri di Agrigento:
venne emanato il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 (convertito
con la legge 28 settembre 1966, n. 749), con cui la Valle dei Templi veniva
dichiarata “zona archeologica di interesse nazionale”, mentre il
perimetro della zona sottoposta a vincolo venne concretamente individuato
dal decreto interministeriale del 16 maggio 1968 emanato dai
ministri della pubblica istruzione Luigi Gui e dei lavori
pubblici Giacomo Mancini (c.d. decreto Gui-Mancini), poi
modificato con decreto ministeriale del 7 ottobre 1971 (c.d. decreto
Misasi-Lauricella), che suddivisero l'area vincolata in cinque zone
denominate rispettivamente "A", "B", "C",
"D" e "E", la prima dichiarata di assoluta
inedificabilità e tutte le altre di edificabilità parziale.
Nonostante
questi provvedimenti di legge, la Valle dei Templi fu interessata da casi
di abusivismo edilizio, denunciati per diversi decenni
dall'allora Sovrintendente ai beni culturali di Agrigento, Graziella
Fiorentini, e dagli attivisti locali di Legambiente rappresentati
da Giuseppe Arnone. Secondo una stima del 1988, nell'area
sorgevano circa duemila costruzioni realizzate in assenza di autorizzazione
o concessione edilizia, di cui 500 nella zona "A" dichiarata
di inedificabilità assoluta.
 Una legge
regionale del 1985 (legge 10 agosto 1985, n. 37) prevedeva una nuova
perimetrazione della Valle dei Templi ma demandò la definizione della sua
estensione al Presidente della Regione Siciliana Rino Nicolosi, il
quale, con un decreto arrivato soltanto nel 1991 tra varie
contestazioni e polemiche (D.P.R.S. n. 91/1991, c.d. decreto Nicolosi),
stabiliva che i confini del Parco archeologico della Valle dei Templi
coincidevano con quelli della zona "A" ed ampliava l'estensione
della zona "B".
Una legge
regionale del 1985 (legge 10 agosto 1985, n. 37) prevedeva una nuova
perimetrazione della Valle dei Templi ma demandò la definizione della sua
estensione al Presidente della Regione Siciliana Rino Nicolosi, il
quale, con un decreto arrivato soltanto nel 1991 tra varie
contestazioni e polemiche (D.P.R.S. n. 91/1991, c.d. decreto Nicolosi),
stabiliva che i confini del Parco archeologico della Valle dei Templi
coincidevano con quelli della zona "A" ed ampliava l'estensione
della zona "B".
Dopo
la promulgazione del decreto Nicolosi, una lettera aperta pubblicata
sul quotidiano Repubblica e firmata da diversi intellettuali
quali Umberto Eco, Massimo Cacciari, Leonardo
Benevolo, Corrado Stajano e Tullio De Mauro auspicava la
realizzazione effettiva del Parco archeologico della Valle dei Templi e
l'esproprio delle costruzioni abusive.
Il
9 maggio 1993 la Valle dei Templi ricevette la visita solenne
di Papa Giovanni Paolo II, il quale durante la celebrazione
eucaristica nel piano San Gregorio nei pressi del Tempio di
Esculapio (dove fu eretta
un'artistica croce in ferro per ricordare
l'avvenimento) colse l'occasione per lanciare uno storico e
particolarmente duro appello ai mafiosi per la loro conversione.
La Regione
Siciliana con la legge regionale n. 20 del 2000 istituì
ufficialmente il "Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei
Templi di Agrigento", che si sviluppa per circa 1.300 ettari, che ha
come finalità la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici,
ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi.
Dopo
anni di rinvii e sospensioni, la demolizione delle costruzioni abusive
iniziò nel 2000 con l'abbattimento di un magazzino ai piedi del Tempio di
Giunone confiscato ad un boss mafioso e continuò nel 2001 ma
riguardò soltanto sei immobili, abbattuti dal Genio militare tra
le proteste dei residenti.
A
quattordici anni di distanza, nel maggio del 2015 la Procura di
Agrigento, con una lettera inviata all'Ufficio tecnico del Comune di
Agrigento, alla Soprintendenza e all'Ente Parco Archeologico, intimò di
dare esecuzione alle sentenze emesse e rese esecutive tra
il 1992 e il 1999 che disponevano l'abbattimento di
tutti gli altri immobili abusivi. A luglio dello stesso anno emise un
nuovo richiamo, minacciando stavolta una denuncia per abuso
d'ufficio e omissione d'atti d'ufficio.
Nell'agosto
del 2015 le ruspe entrarono in azione per dare il via alle prime
demolizioni, che continuarono nel mese di settembre e di ottobre. Nel
gennaio 2016 venne pubblicato il bando per la seconda tranche di
demolizioni nella zona "A". Nel febbraio 2016 le ruspe
tornarono in azione. e a fine maggio venne completata la prima tranche
di demolizioni. Ad ottobre 2016 la procura di Agrigento invia il
secondo elenco di immobili da abbattere, che comprendeva tredici manufatti
abusivi, di cui quattro già demoliti nei mesi precedenti dagli stessi
proprietari. A febbraio del 2017 venne appaltata la seconda
tranche di demolizioni.
Area
archeologica
La
Valle
dei
Templi
di
Agrigento
rappresenta
la
massima
espressione
della
civiltà
greca
classica
in
Sicilia.
Sorge sul
fianco
di
una
collina
che
degrada
dolcemente
verso
il
mare,
incorniciata
dal
letto
dei
fiumi
Akragas
e
Hipsas.
Immersa
nell'incanto
di
un
paesaggio
caratterizzato
da
mandorli
che
già
a
gennaio
si
coprono
di
una
nuvola
di
candidi
fiori
bianchi
e
profumati,
la
Valle
degli
Dei
o
Akragas
venne
fondata
nel
580
a.C.
da
coloni
provenienti
dalla
vicina
Gela
guidati
da
Aristinoo
e
Pistilo.
Insieme
a
Gela
e
alla
potentissima
Siracusa,
Akragas
costituì
per
secoli
un
grosso
ostacolo
alle
ambizioni
cartaginesi
sulla
Sicilia.
Lo
splendore
architettonico
dell'antica
città
era
ben
noto
già
nel
mondo
di
allora,
tant'è
che
il
filosofo
Empedocle
scriveva:
''gli
abitanti
costruivano
come
se
non
dovessero
morire
mai''.
Infatti
ben
sette
Templi
dedicati
ad
altrettante
divinità
si
ergevano
lungo
il
perimetro
della
città,
dando
un'idea
d'imponenza
e
maestosità
soprattutto
ai
naviganti
che
approdavano
nelle
vicine
coste.
Akragas
fu
citata
da
scrittori
del
calibro
di
Virgilio
nell'Eneide,
e
dal
poeta
Pindaro
che
per
la
sua
magnificenza
la
definì
''la
più
bella
tra
le
città
dei
mortali,
l'amica
del
fasto,
la
sede
di
Persefone''.
L'antica
Akragas,
nel
V
secolo
a.C.,
era
un
fiorente
centro
culturale,
patria
del
filosofo
Empedocle,
frequentata
da
Pindaro
e
Simonide.
In
epoca
romana
la
Valle
dei
Templi
fu
visitata
da
Cicerone,
alla
ricerca
di
prove
che
incastrassero
l'ex
governatore
della
Sicilia
Verre
(73-71
a.C.)
accusato
di
avere
imposto
tributi
eccessivi
ai
coloni,
e,
come
detto,
fu
descritta
da
Virgilio
nell'Eneide.
Dal
medioevo
fino
ai
nostri
giorni,
ha
richiamato
e
ispirato
diversi
filosofi,
scrittori,
poeti
e
pittori.
Solo
per
citare
i
più
noti:
Ludovico
Ariosto,
Goethe,
Maupassant,
Alexandre
Dumas,
Anatole
France,
Murilo
Mendes,
Lawrence
Durrell,
Francesco
Lojacono,
Nicolas
de
Stael,
Salvatore
Quasimodo,
Luigi
Pirandello.
Dichiarata
nel
1998
dall'Unesco
Patrimonio
Mondiale
dell'Umanità
conserva
ancora
in
ottimo
stato
antichi
templi
costruiti
in
tufo
arenario
conchiglifero,
dal
colore
giallo
intenso,
che
alla
luce
del
tramonto
diventa
rosa
o
acquista
il
tono
caldo
dell'ambra.
Lo
stile
utilizzato
è
quello
dorico
con
sei
colonne
sul
lato
frontale,
tranne
nel
Tempio
di
Zeus
Olimpio
che
presentava
sette
semicolonne
incassate
in
un
muro
che
chiudevano
tutto
l'edificio.
I
templi
furono
orientati
verso
est
in
maniera
tale
da
permettere
al
sole
nascente,
fonte
di
ogni
forma
di
vita,
di
illuminare
le
statue
delle
divinità
poste
all'interno
della
cella
d'ingresso.
Gli
edifici
furono
denominati
con
nomi
greci,
tutti
quasi
allineati
ed
eretti
durante
il
V
secolo
a.C.
a
testimonianza
della
prosperità
della
città.
Incendiati
dai
Cartaginesi
nel
406
a.C.,
furono
restaurati
dai
Romani
intorno
al
I
sec.
a.C.
rispettando
l'originale
stile
dorico.
Oggi
l'unico
che
rimane
intatto
è
il
Tempio
della
Concordia,
mentre
gli
altri
crollarono
in
seguito
a
diverse
scosse
sismiche
o
alla
furia
devastatrice
dei
cristiani
avallati
da
un
editto
dell'imperatore
d'Oriente
Teodosio
(IV
sec.).
Durante
il
Medioevo
i
materiali
di
costruzione
furono
smontati
ed
utilizzati
per
costruire
altri
edifici.
Ad
esempio
il
Tempio
di
Zeus
Olimpo,
chiamato
per
questo
motivo
Cava
dei
Giganti,
fornì
materiale
per
la
Chiesa
di
San
Nicola
e
per
il
braccio
settecentesco
del
molo
di
Porto
Empedocle.

L'area
della penisola che raccoglie le testimonianze più imponenti della Magna
Grecia è probabilmente la Sicilia, isola che il tedesco Johann Wolfgang
Goethe, tra i più grandi poeti europei, grande amante della civiltà
classica, definisce come: "Una splendida visione".
Sempre
Goethe, parlando dell'imponente spettacolo offerto dalla Valle dei Templi di
Agrigento, afferma estatico: "Mai ho visto in tutta la mia vita uno
splendore di primavera come stamattina al levar del sole".
Quasi
trecento anni dopo la pubblicazione del suo celebre Viaggio in Italia,
da cui soo tratte queste parole, la splendida visione di cui Goehte parla è
tuttora uno dei più importanti siti turistici del mondo, dal 1997 iscritto
nella lista dei Patrimoni dell'Unesco, e non smette di affascinarci perchè
rappresenta non solo un trionfo di grazia e bellezza, ma una delle
testimonanze più vivide e spettacolari del mondo greco in Occidente, la
cosiddetta Magna Grecia.
Akragas
brulicava di vita e quando si passeggia per il cardo primo, la strada
principale, dobbiamo immaginarcelo affollato di persone, costellato di
edifici religiosi, mercati, botteghe, teatri, persino un ginnasio. C'erano
edifici pubblici come l'ekklesiasterion, una cavea di tipo teatrale dove si
tenevano raduni a cui partecipavano tutti i cittadini. Abitazioni private
lussiose, case con peristilio e pavimenti con ricchi mosaici. Nel momento
del suo massimo splendore, sotto il tiranno Terone, nel V secolo a.C.,
Akragas arriva a ospitare trecentomila abitanti tanto che ha bisogno di
espandersi e si lancia alla conquista della costa tirrenica della Sicilia.
Nel corso
della sua storia, la città attraverserà fasi di crescita e di declino, la
vittoria e poi la sconfitta con i cartaginesi, l'arrivo dei romani: una
storia che proseguirà fino all'VIII secolo finchè verrà progressivamente
abbandonata e la zona dei templi si trasformerà in un terreno agricolo. Un
luogo così pieno di passato e significato, che diventa uno spazio come
tanti: solo in un Paese fin troppo ricco di bellezza come l'Italia poteva
succedere. E non per qualche anno e neanche per qualche secolo: la
situazione rimarrà immutata a lungo, fin dopo la Seconda guerra mondiale,
circa settant'anni fa.
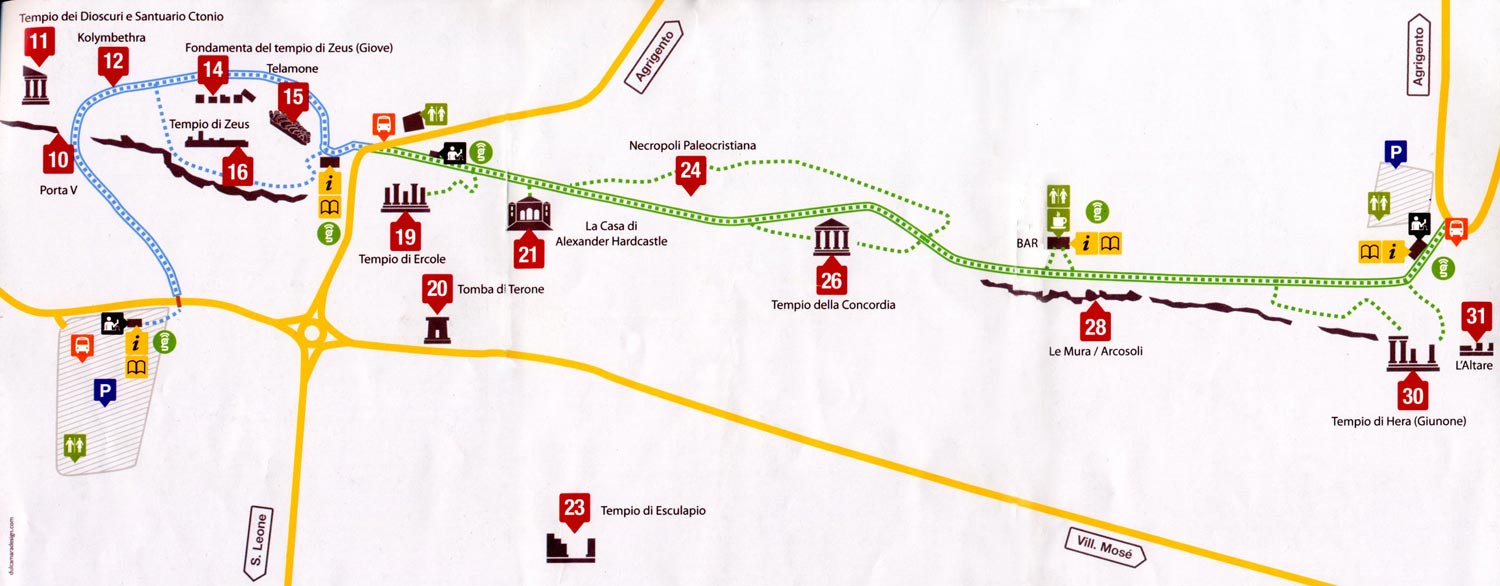
La
Valle
dei
Templi
è
caratterizzata
dai
resti
di
ben
sette
templi
in
ordine
dorico:
le
loro
denominazioni
e
relative
identificazioni,
tranne
quella
dell'Olympeion,
si
presumono
essere
pure
speculazioni
umanistiche,
che
sono
però
rimaste
nell'uso
comune.
Il
Tempio
di
Hera
Lacinia,
dedicato
all'omonima
dea
greca,
fu
costruito
nel
V
secolo
a.C.
e
incendiato
nel
406
dai
cartaginesi.
Era
il
tempio
in
cui
di
solito
si
celebravano
le
nozze.
Il
Tempio
della
Concordia,
il
cui
nome
deriva
da
un'iscrizione
latina
ritrovata
nelle
vicinanze
dello
stesso
tempio,
costruito
anch'esso
nel
V
secolo.
Attualmente
è
con
ogni
probabilità
quello
meglio
conservato.
Fu
trasformato
in
tempio
sacro
nel
VI
secolo
d.C.
Il
Tempio
di
Eracle,
il
più
antico,
era
dedicato
alla
venerazione
del
dio
Eracle
(o
Ercole),
uno
dei
più
rispettati
dagli
abitanti
dell'antica
Akragas.
Distrutto
da
un
terremoto,
è
oggi
formato
da
appena
otto
colonne.
Il
Tempio
di
Zeus
Olimpico
(Giove),
edificato
per
onorare
l'omonimo
dio
dopo
la
vittoria
del
480
a.C.
sui
cartaginesi,
è
caratterizzato
dalla
presenza
dei
cosiddetti
telamoni,
statue
di
notevoli
dimensioni
con
sembianze
umane.
Il
Tempio
dei
Dioscuri
(o
di
Castore
e
Polluce)
fu
costruito
per
onorare
i
due
gemelli
figli
di
Sparta
e
Giove.
Restano
appena
quattro
colonne.
È
il
simbolo
della
città
di
Agrigento.
Il
Tempio
di
Vulcano,
anch'esso
risalente
al
V
secolo,
che
si
pensa
essere
una
delle
costruzione
più
imponenti
della
valle,
è
però
uno
dei
templi
più
danneggiati
dal
tempo
e
dai
fenomeni
naturali.
Il
Tempio
di
Esculapio,
costruito
lontano
dalle
mura
delle
città,
era
luogo
di
pellegrinaggio
dei
malati
in
ricerca
di
guarigione.
La
valle
dei
Templi
inoltre
ospita
la
tomba
di
Terone,
un
monumento
di
tufo
di
notevoli
dimensioni
a
forma
di
piramide,
che
si
pensa
eretto
per
ricordare
i
caduti
della
Seconda
guerra
punica.

Pag.
3 
 Pag.
5
Pag.
5
Agosto
2018