|
Una
striscia
di
verde
in
mezzo
al
giallo
del
deserto,
i
campi
coltivati
e
sullo
sfondo
le
rosse
rocce
della
«catena
libica».
Qui
si
stende
Luxor
che,
con
l'area
di
Karnak,
costituiva
una
delle
grandi
capitali
del
mondo
antico.
Piena
di
fascino
e
di
suggestione,
con
le
rive
del
Nilo
su
cui
si
allineano
i
moderni
hotels,
le
feluche
che
scivolano
sulle
tranquille
acque
del
fiume,
le
piccole
strade
silenziose
del
bazar
che
si
animano
verso
sera
di
colori,
di
suoni,
di
luci.

Tebe
custodisce
le
più
alte
testimonianze
della
storia,
dell'arte
e
della
religione
dell'antico
Egitto,
di
cui
fu
capitale
nell'epoca
di
maggior
splendore.
Centinaia
di
sovrani,
dai
faraoni
agli
imperatori
romani,
la
glorificarono
con
architetture,
obelischi
e
sculture.
Secondo
Omero,
"Tebe
dalle
cento
porte"
possedeva
una
tale
quantità
di
ricchezze
da
essere
superata
solo
da
quella
dei
granelli
di
sabbia.
L'esaltazione
della
vita
trovò
espressione
nella
"Tebe
dei
vivi",
identificabile
nelle
favolose
Luxor
e
Karnak,
sulla
riva
destra
del
Nilo,
sedi
dei
templi
dedicati
alla
triade
divina
di
Montu,
Amon
e
Mut,
mentre
la
celebrazione
della
morte
si
materializzò
nella
"Tebe
dei
morti",
cioè
nelle
grandiose
necropoli
distribuite
sulla
riva
sinistra
del
grande
fiume.
Dal
Medio
Regno
alla
fine
dell'età
antica,
la
città
fu
sacra
all'antico
dio
Amon,
suprema
divinità
solare:
a
lui
vennero
dedicati
templi
di
dimensioni
e
di
splendore
incomparabili.
Tra
le
cerimonie
che
vi
si
svolgevano,
la
più
fastosa
era
quella
che
si
svolgeva
in
occasione
dell'anno
nuovo,
durante
la
quale
i
vascelli
dorati
degli
dei
partivano
dai
santuari
di
Karnak
e
giungevano
attraverso
il
Nilo
nella
selva
di
colonne
del
tempio
di
Luxor.
Qui
aveva
luogo
il
rito
che
legittimava
il
potere
del
faraone,
cioè
il
suo
congiungimento
con
il
"ka",
l'essenza
soprannaturale
degli
dei.
Questa
era
l'antica,
grande
città
di
Tebe,
capitale
dell'impero
egizio
per
quasi
mille
anni,
quella
che
Omero
nei
IX
canto
dell'Iliade
aveva
chiamato
"Tebe
dalle
cento
porte"
e
per
cui
"solo
i
granelli
di
sabbia
del
deserto
superavano
la
quantità
delle
ricchezze
che
vi
erano
racchiuse".
I
copti
la
chiamarono
Tape,
da
cui
il
greco
Thebai,
ma
per
gli
abitanti
egizi
era
Uaset,
che
vuole
dire
"la
dominante"
e
Niut,
"la
Città";
in
epoca
tarda
fu
chiamata
poi
Diospolis
Magna.
Il
nome
attuale
di
Luxor
deriva
dall'arabo
El-Qusùr,
traduzione
del
castra
latino
con
cui
i
romani
avevano
indicato
la
città
dove
avevano
installato
due
accampamenti.
In
epoca
menfita
era
un
piccolo
villaggio:
vi
veniva
adorato
il
dio
della
guerra
Montu
e
i
suoi
templi
segnavano
i
confini
del
territorio.
A
partire
dal
Medio
Regno,
grazie
alla
sua
posizione
geografica
e
a
motivi
politici,
la
sua
importanza
cominciò
ad
aumentare
sensibilmente,
finché
i
successi
militari
dei
suoi
principi
ne
fecero
una
potenza.
L'apice
della
gloria
è
raggiunto
con
il
Nuovo
Regno:
i
Tebani
sconfiggono
le
tribù
degli
Hyksos
invasori,
grazie
all'appoggio
del
dio
Amon,
che
diventa
così
il
dio
del
regno
e
viene
adorato
con
grande
sfarzo
associato
nella
triade
a
Mut
e
a
Khonsu.
Era
l'epoca
delle
grandi
vittorie
e
dei
grandi
trionfi
in
Asia
Anteriore,
nella
Nubia
e
nella
Libia.
È
un
periodo
felice,
forse
il
più
felice
della
storia
egiziana
e
Tebe
non
ha
rivali:
i
faraoni
vittoriosi
vi
hanno
accumulato
incredibili
ricchezze
provenienti
dal
bottino
bellico;
Thutmosi
III,
Amenhotep
III
e
Ramesse
II
costruiscono
templi
superbi;
dal
Mar
Rosso,
dal
golfo
Persico
e
perfino
dal
Sahara
-
attraverso
la
via
delle
oasi
-
giungono
i
mercanti
per
arricchirsi
e
per
arricchire
gli
abitanti
di
Tebe,
che,
si
dice,
raggiungessero
l'incredibile
cifra
di
mezzo
milione!
Sulla
riva
orientale
del
fiume
sorgono
i
templi
dimore
degli
dei,
su
quella
occidentale
si
costruiscono
gli
edifici
per
il
culto
dei
sovrani
morti:
al
di
là
di
questa
teoria
di
templi,
corre
parallela
al
fiume
la
poderosa
cortina
di
roccia
che
nasconde
la
Valle
dei
Re.
Poi,
inesorabile
anche
per
Tebe,
il
declino.
Quella
posizione
geografica
che
mille
anni
prima
aveva
favorito
la
nascita
della
sua
potenza,
adesso
diventava
il
primo
fattore
della
sua
decadenza:
troppo
lontana
dalla
calda
zona
del
Delta,
dove
i
Ramessidi
erano
stati
costretti
a
creare
postazioni
militari
per
arginare
le
invasioni
straniere,
Tebe
perde
la
supremazia
politica,
spirituale
e
militare.
 Le
dinastie
successive
saranno
originarie
del
Delta
e
le
città
di
Tanis,
Bubasti
e
Sais
prenderanno
il
suo
posto
come
capitale
dell'Egitto.
Lasciata
senza
difesa,
Tebe
è
facile
preda:
le
invasioni
assire
del
VII
secolo,
quella
di
Assarhaddon
prima
e
Assurbanipal
poi,
sono
devastanti:
gli
abitanti
deportati
in
schiavitù,
le
statue
e
i
tesori
saccheggiati,
i
templi
distrutti.
In
età
tolemaica
Tebe
è
ridotta
a
città
di
provincia.
Dopo
un
tentativo
di
ribellione
sotto
Tolomeo
IX
Sotere
II
e
un'insurrezione
a
seguito
dell'oppressione
romana,
viene
distrutta
da
Cornelio
Gallo.
Nel
27
a.C.
un
terribile
terremoto
da
a
tutta
la
regione
il
colpo
di
grazia.
Con
il
diffondersi
del
cristianesimo,
i
templi
degli
dei
e
le
tombe
dei
faraoni
perdono
anche
la
loro
originaria
destinazione:
case,
capanne,
stalle
per
gli
animali,
tutto
viene
costruito
sopra
o
a
ridosso
di
templi
e
di
tombe.
Così
Tebe
lentamente
scompare
e
Luxor
prende
il
suo
posto.
Nel
corso
dell'Ottocento
Luxor
era
un
tranquillo
e
operoso
villaggio
dell'Alto
Egitto
che
sonnecchiava
pigro
mentre
al
Cairo
e
a
Suez
si
svolgevano
i
grandi
eventi
politici
e
mondani.
Nel
1811
Thomas
Cook
dette
vita
alla
prima
agenzia
di
viaggi
e
tutto
l'Egitto
si
aprì
velocemente
alla
nuova
industria
del
turismo. Le
dinastie
successive
saranno
originarie
del
Delta
e
le
città
di
Tanis,
Bubasti
e
Sais
prenderanno
il
suo
posto
come
capitale
dell'Egitto.
Lasciata
senza
difesa,
Tebe
è
facile
preda:
le
invasioni
assire
del
VII
secolo,
quella
di
Assarhaddon
prima
e
Assurbanipal
poi,
sono
devastanti:
gli
abitanti
deportati
in
schiavitù,
le
statue
e
i
tesori
saccheggiati,
i
templi
distrutti.
In
età
tolemaica
Tebe
è
ridotta
a
città
di
provincia.
Dopo
un
tentativo
di
ribellione
sotto
Tolomeo
IX
Sotere
II
e
un'insurrezione
a
seguito
dell'oppressione
romana,
viene
distrutta
da
Cornelio
Gallo.
Nel
27
a.C.
un
terribile
terremoto
da
a
tutta
la
regione
il
colpo
di
grazia.
Con
il
diffondersi
del
cristianesimo,
i
templi
degli
dei
e
le
tombe
dei
faraoni
perdono
anche
la
loro
originaria
destinazione:
case,
capanne,
stalle
per
gli
animali,
tutto
viene
costruito
sopra
o
a
ridosso
di
templi
e
di
tombe.
Così
Tebe
lentamente
scompare
e
Luxor
prende
il
suo
posto.
Nel
corso
dell'Ottocento
Luxor
era
un
tranquillo
e
operoso
villaggio
dell'Alto
Egitto
che
sonnecchiava
pigro
mentre
al
Cairo
e
a
Suez
si
svolgevano
i
grandi
eventi
politici
e
mondani.
Nel
1811
Thomas
Cook
dette
vita
alla
prima
agenzia
di
viaggi
e
tutto
l'Egitto
si
aprì
velocemente
alla
nuova
industria
del
turismo.
Luxor,
con
il
fascino
delle
sue
rovine,
i
facili
approdi
per
le
dahabieh
lungo
il
fiume,
il
suo
clima
così
dolce
rispetto
ai
tristi
e
rigidi
inverni
europei,
divenne
ben
presto
un
luogo
di
vacanza
per
i
nuovi
turisti
o
l'abituale
residenza
invernale
per
i
ricchi
inglesi
o
la
sosta
obbligata
durante
i
lunghi
trasferimenti
dei
funzionari
europei.
Luxor,
con
i
suoi
palazzi
e
il
mistero
della
Valle
che
si
stendeva
al
di
là
del
fiume,
attirò
presto
anche
numerosi
archeologi,
scrittori,
pittori
che
si
installarono
qui
per
studiare,
documentare,
descrivere
quanto
rimaneva
del
glorioso
passato
di
Tebe
o
per
scoprire
quanto
ancora
vi
si
celava.
Ed
ecco
allora
arrivare
Champollion
e
Rosellini,
Heìnrich
e
Emit
Brugsch
e
lady
Lucy
Duff-Gordon
che
visse
per
sei
anni
in
una
casa
costruita
sul
tetto
del
tempio
di
Amon.
Ma
a
Luxor
nasce
anche
un'altra
categoria,
quella
degli
archeologi
improvvisati,
dei
ricercatori
di
antichità
e
di
tesori,
di
collezionisti
senza
scrupoli
ma
con
molto
denaro,
di
tombaroli
pronti
a
sparare
o
a
tradire
per
un
pugno
di
piastre.
E
con
loro
fiorisce
tutto
un
mercato
clandestino
di
antichità,
di
reperti
autentici
e
di
paccottiglia,
di
oggetti
veri
e
di
falsi
clamorosi.
Fu
grazie
a
questi
personaggi
e
alle
loro
storie
e
vicende
talvolta
stranamente
intrecciate
che
fu
possibile
squarciare
lo
spesso
velo
di
mistero
che
circondava
ancora
la
civiltà
egiziana.
Luxor,
con
la
città
in
costante
crescita,
con
gli
alberghi
sempre
più
numerosi
e
moderni,
entrò
a
far
parte
dei
più
importanti
circuiti
turistici,
storici
e
archeologici
dell'Egitto.

Tempio
di
Amon-Ra
-
A
Luxor,
unica
testimonianza
del
suo
glorioso
passato,
è
il
tempio
che
gli
egiziani
antichi
eressero
alla
gloria
di
Amon-Ra,
re
degli
dei,
e
che
chiamarono
con
il
nome
di
"harem
meridionale
di
Amon".
Riportato
alla
luce
nel
1883
da
Gaston
Maspero,
il
tempio
è
lungo
260
metri
e
la
sua
costruzione
si
deve
essenzialmente
a
due
faraoni,
Amenhotep
III,
figlio
di
Hapu,
architetto
e
uomo
di
fiducia
del
re
Amenhotep
III,
che
lo
iniziò
nel
XIV
secolo
a.C.
e
Ramesse
II
che
lo
portò
a
termine
aggiungendovi
il
grande
cortile
porticato
con
l'asse
spostato
verso
est.
Numerosi
altri
sovrani,
fra
i
quali
Tutankhamon,
Horemheb
e
Alessandro
Magno,
contribuirono
ad
arricchirlo
con
rilievi,
iscrizioni
ed
edifici
minori.
Il
tempio
di
Luxor
era
unito
a
quello
di
Karnak
da
un
lungo
dromos
lastricato
di
pietra,
un
viale
processionale,
fiancheggiato
da
sfingi
a
testa
umana.
Questa
strada
non
è
stata
riportata
alla
luce
nella
sua
integrità
e
si
sta
ancora
lavorando
perché
possa
ritornare
completamente
visibile.
Il
viale
terminava
all'ingresso
del
tempio
di
Luxor,
segnato
dal
grande
pilone
innalzato
da
Ramesse
II,
che
presenta
un
fronte
di
ben
65
metri
e
che
è
ornato
da
bassorilievi
che
illustrano
scene
delle
campagne
militari
del
faraone
contro
gli
Ittiti.
Sul
lato
sinistro
il
campo
egizio,
il
consiglio
di
guerra;
sul
lato
destro
la
battaglia
di
Qadesh.
In
basso,
su
bande
verticali,
è
inciso
in
geroglifici
il
poema
detto
"di
Pentaur"
che
celebra
il
coraggio
del
faraone.
 Le
quattro
grandi
fessure
che
si
aprono
verticalmente
sulla
facciata
accoglievano
le
aste
portabandiera.
Il
pilone
anticamente
era
preceduto
da
due
obelischi,
da
due
colossi
seduti
e
da
quattro
stanti.
Oggi,
dei
due
obelischi
resta
solo
quello
di
sinistra
alto
25
metri:
l'altro
fu
portato
nel
1833
a
Parigi
ed
eretto
dall'ingegnere
Lebas
il
25
ottobre
1836
nella
Place
de
la
Concorde.
I
due
colossi
in
granito
rappresentano
il
faraone
seduto
in
trono,
15
metri
e
mezzo
di
altezza
su
una
base
di
circa
un
metro.
Delle
altre
quattro
statue
in
granito
rosa,
addossate
al
pilone,
una
doveva
rappresentare
la
regina
Nefertari
e
un'altra,
a
destra
molto
rovinata,
la
figlia
Merit-Amon. Le
quattro
grandi
fessure
che
si
aprono
verticalmente
sulla
facciata
accoglievano
le
aste
portabandiera.
Il
pilone
anticamente
era
preceduto
da
due
obelischi,
da
due
colossi
seduti
e
da
quattro
stanti.
Oggi,
dei
due
obelischi
resta
solo
quello
di
sinistra
alto
25
metri:
l'altro
fu
portato
nel
1833
a
Parigi
ed
eretto
dall'ingegnere
Lebas
il
25
ottobre
1836
nella
Place
de
la
Concorde.
I
due
colossi
in
granito
rappresentano
il
faraone
seduto
in
trono,
15
metri
e
mezzo
di
altezza
su
una
base
di
circa
un
metro.
Delle
altre
quattro
statue
in
granito
rosa,
addossate
al
pilone,
una
doveva
rappresentare
la
regina
Nefertari
e
un'altra,
a
destra
molto
rovinata,
la
figlia
Merit-Amon.
A
sinistra
dell'obelisco
si
può
ammirare
una
testa
di
Ramesse
II
appartenente
a
uno
dei
colossi
antistanti
il
pilone.
Oltrepassato
l'ingresso
trionfale,
si
entra
nel
cortile
di
Ramesse
II,
con
doppia
fila
di
colonne
con
capitello
a
papiro
chiuso
e
statue
negli
intercolunni.
Sul
lato
nord-ovest
del
cortile
si
trova
il
tempietto-deposito
delle
barche
sacre
costruito
da
Thutmosi
III
e
dedicato
alla
triade
Amon,
Mut
e
Khonsu.
Iscrizioni
commemorative,
scene
sacrificali
e
cerimonie
religiose
decorano
le
pareti
interne
del
cortile.
Da
sinistra,
personificazioni
dei
distretti
minerari
recanti
tributi
al
dio,
Ramesse
II
che
sacrifica
alla
dea
Seshat,
cerimonia
di
inaugurazione
dell'ingresso
monumentale
con
i
figli
del
faraone,
che
portano
fiori,
in
testa
alla
processione.
Il
possente
muro
di
fondo
costituisce
il
secondo
pilone,
eretto
da
Amennotep
III;
era
l'ingresso
originario
del
tempio,
seguito
da
un
imponente
colonnato
di
due
file
di
sette
colonne
campaniformi,
lungo
52
metri.
Opera
anche
questa
di
Amenhotep,
mentre
le
decorazioni,
posteriori,
sono
di
Tutankhamon
e
Horemheb
e
rappresentano
con
vivacità
la
grande
festa
di
Opet
con
la
processione
di
barche
sacre
che
da
Karnak
giunge
a
Luxor
e
viceversa.
La
festa,
che
durava
poco
più
di
quindici
giorni,
iniziava
il
diciannovesimo
giorno
del
secondo
mese
dell'inondazione,
cioè
verso
la
fine
di
agosto.
Il
culmine
della
cerimonia
era
quando,
dal
tempio
di
Karnak,
usciva
la
barca
sacra
di
Amon-Ra
che,
portata
da
trenta
sacerdoti
e
seguita
da
quella
di
Mut
e
da
quella
di
Khonsu,
percorreva
tutto
il
viale
di
sfingi
e
arrivava
al
tempio
di
Luxor:
qui
le
barche
venivano
chiuse
nel
santuario
per
alcuni
giorni,
dopo
di
che
ritornavano
al
tempio
di
Karnak,
sempre
accompagnate
da
una
folla
festante,
da
canti
e
da
danze
sacre.
All'inizio
del
colonnato
si
trovano
due
bei
gruppi
calcarei,
raffiguranti
il
faraone
e
una
regina.
Percorso
il
colonnato,
si
entra
nel
secondo
cortile,
o
cortile
di
Amenhotep
III,
circondato
su
tre
lati
da
due
file
di
colonne
fascicolate
a
papiro
chiuso.
Il
quarto
lato
è
in
realtà
una
sala
ipostila
trasversale
con
quattro
file
di
otto
colonne
ciascuna,
dello
stesso
tipo
delle
precedenti:
vera
e
propria
foresta
pietrificata
di
grande
suggestione.
Da
qui
si
accede
al
vestibolo,
affiancato
da
due
ambienti;
quello
di
sinistra
consacrato
a
Mut,
quello
di
destra,
diviso
in
due,
a
Khonsu
e
ad
Amon-Min
(a
Luxor,
Amon,
quale
dio
della
fecondazione,
aveva
preso
la
forma
dell'itifallico
Min).
Si
passa
poi
nella
stanza
delle
offerte,
con
quattro
colonne,
decorata
con
scene
di
cerimonie
religiose
in
cui
compare
Amenhotep,
e
successivamente
nel
sacrario
o
deposito
delle
barche
sacre,
trasformato
in
una
cappella
aperta
lungo
l'asse
del
tempio
da
Alessandro
Magno
che
compare
al
cospetto
di
Amon
nelle
decorazioni
parietali
interne
ed
esterne.


Altri
ambienti
si
aprono
intorno
al
sacrario;
particolarmente
interessante
è
la
"camera
della
nascita"
le
cui
decorazioni
a
rilievo
rappresentano
varie
scene
dal
concepimento
divino
alla
nascita
del
re:
Amon
che
parla
con
Thot,
con
il
faraone
e
con
la
regina;
Khnum
che
sulla
ruota
da
vasaio
da
forma
a
due
neonati
(Amenhotep
e
il
suo
ka);
Thot
che
annuncia
il
concepimento
alla
madre
di
Amenhotep,
Mutemuya
che,
incinta,
è
portata
al
cospetto
di
Iside
e
Khnum;
Mutemuya
sul
letto
assistita
dalle
divinità
preposte
al
parto;
allattamento
del
neonato
e
sua
presentazione
ad
Amon.
Dietro
il
sacrario,
una
sala
a
due
file
di
otto
colonne
introduce
all'ambiente
più
sacro
del
tempio,
detto
il
"santo
del
santi",
inaccessibile
ai
comuni
mortali.
Qui
era
conservata
la
statua
del
grande
Amon,
al
cui
cospetto
erano
ammessi
solo
il
faraone
e
i
sacerdoti
di
rango
più
elevato
per
celebrare
le
cerimonie
liturgiche.
Al
di
là
della
sala
ipostila,
le
cui
colonne
recano
i
cartigli
di
Ramsess
IV
e
Ramsess
VI,
si
trova
il
vestibolo,
che
in
epoca
romana
venne
trasformato
in
cappella
di
culto
imperiale
e
in
onore
di
Serapide.
Il
sacrario,
destinato
a
ospitare
le
barche
sacre
al
tempo
di
Amenhotep
III,
fu
ricostruito
in
forma
di
cappella
da
Alessandro
Magno,
che
si
fece
così
ritrarre
in
veste
di
faraone,
offerente
verso
gli
dei
egizi,
sulle
pareti
interne
ed
esterne,
racchiudendo
il
proprio
nome
nel
cartiglio.
E'
un
documento
raro
e
importante,
che
attesta
il
passaggio
breve
ma
oltremodo
significativo
del
monarca
macedone
in
terra
egiziana.
Nelle
vicinanze
del
sacrario
si
trova
un
altro
ambiente
decorato
di
grande
interesse:
la
sala
della
teogamia,
o
"nascita
sacra",
del
re
Amenhotep
III.
Per
legittimare
la
propria
autorità,
questo
sovrano
scelse
di
farsi
ritrarre
in
una
serie
di
rilievi
che
enfatizzavano
il
so
concepimento
di
origine
divina,
come
aveva
fatto
prima
di
lui
Hatshepsut
sulle
pareti
del
proprio
tempio
funerario
a
Deir
el-Bahari.
Durante
i
lavori
di
consolidamento
delle
strutture,
nel
cortile
porticato
di
Amenhotep
III
venne
alla
luce
una
serie
di
statue
di
straordinaria
qualità
artistica,
raffiguranti
divinità
e
re
del
Nuovo
Regno:
i
simulacri
erano
collocati
in
una
fossa
all'interno
del
tempio
destinata
a
custodire
le
immagini
"depotenziate"
e
pur
tuttavia
ancora
sacre,
patrimonio
dell'intera
comunità.
Oggi
queste
sculture
affascinanti
si
possono
ammirare
nelle
sale
del
Museo
di
Luxor.

|

Tempio
di
Amon:
1
pilone
di
Ramses
II
-
2
cortile
di
Ramses
II
-
3
moschea
di
Abu
el
Haggag
-
4
cappella
delle
barche
di
Thutmosi
III
-
5
pilone
di
Amenhotep
III
-
6
galleria
di
Amenhotep
III
-
7
grande
cortile
di
Amenhotep
III
-
8
prima
sala
ipostila
-
9
seconda
sala
ipostila
-
10
cappella
della
barca
sacra
di
Amon
-
11
sala
ipostila
-
12
santuario. |
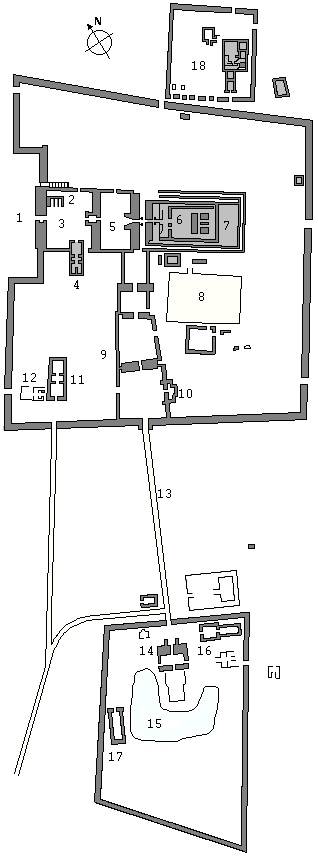
Complesso
monumentale
di
Karnak:
1
primo
pilone
del
grande
tenpio
di
Amon
-
2
tempio
di
Sethi
II
-
3
grande
cortile
-
4
tempio
di
Ramses
III
-
5
sala
ipostila
-
6
santuario
-
7
sala
delle
feste
-
8
lago
sacro
-
9
Propilei
del
Sud
-
10
tempio
del
giubileo
di
Amenhotep
II
-
11
tempio
di
Khonsu
-
12
tempio
di
Opet
-
13
viale
delle
sfingi
-
14
tempio
di
Mut
-
15
lago
sacro
-
16
tempio
di
Amenhotep
III
-
17
tempio
di
Ramses
III
-
18
tempio
di
Montu. |
A
circa
tre
chilometri
dal
tempio
di
Luxor
si
stende
la
vasta
zona
monumentale
di
Karnak,
che
i
greci
chiamarono
Hermonthis:
il
sito
archeologico
comprende
tre
aree
divise
fra
loro,
separate
da
una
cinta
di
mattoni
crudi.
La
più
grande
è
quella
centrale,
circa
trenta
ettari,
che
Diodoro
Siculo
ci
tramanda
come
la
più
antica
e
racchiude
il
dominio
di
Amon;
a
sud,
ancora
inesplorato
per
circa
la
metà
della
sua
estensione
(quasi
nove
ettari)
e
collegato
al
precedente
da
un
dromos
di
criosfingi,
è
il
dominio
della
dea
Mut,
moglie
di
Amon
e
raffigurata
simbolicamente
sotto
forma
di
un
avvoltoio;
a
nord,
infine,
si
estende
su
circa
due
ettari
e
mezzo
il
dominio
di
Montu,
dio
della
guerra.
Ciascun
complesso
ha
modificato,
nel
tempo,
le
sue
dimensioni
e
i
faraoni
che
si
sono
avvicendati
sul
trono
vi
hanno
lasciato
il
segno,
o
ampliando
il
tempio,
o
aggiungendovi
sale
e
cappelle.
La
struttura
dei
tre
complessi
sacri
è
la
stessa:
al
centro
di
ciascuna
cinta
si
trova
il
tempio
principale
dedicato
al
dio
e
accanto
a
questo
si
estende
il
lago
sacro
per
le
cerimonie,
di
forma
generalmente
quadrangolare.
Il
grande
tempio
di
Amon,
principale
divinità
di
Tebe
almeno
a
partire
dalla
XII
dinastia,
epoca
alla
quale
risalgono
i
primi
edifici
sacri
attestati
nell'area
e
oggi
completamente
scomparsi,
è
il
santuario
per
eccellenza
delle
memorie
storiche
dell'intero
Nuovo
Regno,
ossia
delle
dinastie
tebane
all'apogeo
della
loro
gloria.
Pressoché
tutti
i
faraoni
-
da
Thutmosi
I,
all'inizio
della
XVIII
Dinastia,
sino
ad
Amenhotep
III
e
a
Ramesse
II
e
III,
per
giungere
ai
sovrani
della
XXII
dinastia
-
contribuirono
all'edificazione
o
all'ampliamento
dei
numerosissimi
ambienti
che
si
sono
via
via
aggiunti
al
nucleo
originario
del
tempio.
Prima
di
entrare
nel
grande
cortile
interno,
il
visitatore
si
trova
dinanzi
ai
grandiosi
piloni
d'ingresso,
massicci
murari
fatti
costruire
probabilmente
da
Nectanebo
I
e
II
e
dai
primi
Tolomei;
qui
si
può
osservare
una
piattaforma,
o
pontile
da
sbarco,
per
l'attracco
dei
natanti
che
solcavano
i
canali
di
collegamento
tra
i
vari
templi
nel
corso
delle
feste
solenni
in
onore
delle
divinità.
All'interno
del
primo
cortile,
porticato
sui
lati
settentrionale
e
meridionale
con
colonne
a
capitelli
papiriformi
chiusi,
sorgono
diversi
altri
edifici
sacri,
tra
i
quali,
a
sinistra,
un
piccolo
tempio
dedicato
da
Sethi
II
alla
triade
tebana
formata
da
Amon,
Mut
e
Khonsu.
All'ingresso
di
questo
tempietto
erano
in
origine
collocate
due
statue
di
proporzioni
colossali.
Entrambe
si
trovano
oggi
fuori
d'Egitto:
una
è
conservata
al
Louvre
di
Parigi,
l'altra
al
Museo
Egizio
di
Torino.
Sulla
destra
del
cortile,
inserito
entro
il
cosiddetto
"Portico
dei
Bubastiti",
dal
nome
della
città
del
Delta
che
diede
origine
a
questa
dinastia
(la
XXII)
di
regnanti,
si
trova
l'importante
tempio
di
Ramesse
III,
forse
adibito
alla
celebrazione
del
giubileo
reale
o
festa-sed,
ossia
il
trentennale
di
regno
che
ciascun
sovrano
era
chiamato
a
celebrare
con
solennità.
Il
primo
cortile
di
tale
tempio
è
decorato
da
una
serie
di
pilastri
osiriaci,
mentre
sulle
pareti
le
raffigurazioni
riguardano
una
processione
in
onore
del
dio
Min.

Una
piccola
rampa
da
accesso
alla
sala
ipostila
e
al
sacrario
della
barca
di
Amon,
a
sua
volta
affiancato
da
due
altre
cappelle
più
piccole
per
le
barche
di
Mut
e
di
Khonsu.
Al
centro
del
cortile
sorgeva
l'imponente
chiosco
di
Taharqa
(XXV
dinastia),
con
colonne
alte
più
di
20
metri
(ne
rimane
attualmente
una
sola).
Il
secondo
pilone,
preceduto
da
un
paio
di
statue
colossali
di
Ramesse
II,
introduce
alla
grande
sala
ipostila,
costituita
da
ben
134
colonne
di
proporzioni
gigantesche:
la
navata centrale,
sopraelevata
rispetto
alle
altre
file
di
colonne,
permette
l'apertura
di
grandi
finestre
sulla
sommità
per
meglio
illuminare
l'ambiente.
Mentre
il
secondo
pilone
si
deve
all'opera
di
Horemheb,
che
si
servì
abbondantemente
di
materiali
di
recupero,
soprattutto
dell'epoca
di
Akhenaton,
le
12
colonne
della
navata
centrale
furono
innalzate
da
Amenhotep
III.
La
decorazione
interna
della
sala
ipostila,
iniziata
da
Ramesse
I,
fu
completata
in
massima
parte
da
Sethi
I
e
Ramesse
II,
con
scene
devozionali
e
di
offerte
alle
divinità,
come
d'abitudine
in
ambienti
riservati
ai
sacerdoti
e
agli
addetti
al
culto.
Sulle
pareti
esterne
della
stessa
sala
ipostila
si
celebrano
invece
le
virtù
guerriere
di
due
grandi
faraoni
della
XIX
dinastia:
Sethi
I,
rappresentato
nelle
sue
imprese
militari
in
Siria
e
Palestina,
oppure
contro
i
Libici,
e
Ramesse
II,
ritratto
nell'epico
scontro
di
Qadesh
contro
gli
Ittiti.
Il
terzo
pilone,
eretto
da
Amenhotep
III,
nascondeva
all'interno
centinaia
di
blocchi
di
reimpiego,
provenienti
da
una
serie
di
edifici
poi
smantellati
(due
di
questi,
la
"cappella
bianca"
di
Sesostri
I
e
quella
in
alabastro
di
Amenhotep
I,
sono
stati
ricostruiti
in
un'area
riservata
a
nord
del
primo
cortile).
Sulla
facciata
interna
del
terzo
pilone,
piuttosto
in
degrado
come
struttura
complessiva,
venne
però
ritrovata
una
preziosa
decorazione
a
rilievo
che
mostra
il
giovane
Amenhotep
IV
nella
tradizionale
scena
di
"massacro
dei
prigionieri"
davanti
ad
Amon.
È
la
prova
che,
nei
suoi
primi
anni
di
regno,
anche
il
futuro
Akhenaton
promosse
azioni
militari
contro
i
nemici
dell'Egitto,
smentendo
così
la
sua
fama
di
pacifista
a
oltranza.
Un
cortile,
in
cui
si
trovavano
in
origine
anche
quattro
obelischi,
mette
in
comunicazione
con
il
quarto
pilone,
dovuto
a
Thutmosi
I
ma
decorato
sotto
Thutmosi
IV,
che
serviva
d'accesso
al
più
antico
tempio
del
Nuovo
Regno.
Nel
vestibolo,
ricavato
tra
il
quarto
e
il
quinto
pilone,
si
trovano
statue
che
rappresentano
il
faraone
abbigliato
con
la
veste
tipica
della
festa-sed
e
un
obelisco,
in
granito
rosa
di
Assuan,
alto
30
metri,
fatto
elevare
dalla
regina
Hatshepsut
in
occasione
del
proprio
giubileo.

Sulle
pareti
del
sesto
pilone,
oltre
a
frammenti
degli
Annali
di
Thutmosi
III,
resoconto
e
cronaca
delle
numerose
campagne
militari
del
sovrano
in
Oriente,
compaiono
anche
i
nomi
delle
città
e
dei
popoli
soggiogati,
chiusi
in
una
sorta
di
"cartiglio-fortezza".
Il
tempietto
delle
barche
sacre
contiene
molte
interessanti
raffigurazioni,
tra
le
quali
spicca
la
scena
del
trasporto
del
battello
di
Userhat;
di
fronte
e
attorno
a
quest'ultimo
edificio,
in
un
groviglio
di
piccoli
ambienti
più
volte
ricostruiti,
si
segnalano
le
due
statue
in
arenaria
rossa
di
Amon
e
Amonet,
attribuite
a
Tutankhamon,
e
un'altra
ricca
sezione
degli
Annali
di
Thutmosi
III,
con
l'elenco
del
bottino
di
guerra
riservato
come
donazione
al
tempio
di
Amon
a
Karnak.
Un
vasto
cortile
spianato
è
quanto
rimane
del
primitivo
nucleo
templare
del
Medio
Regno,
dopo
i
lavori
effettuati
da
un
gruppo
di
studiosi
francesi,
che
hanno
permesso
la
rilevazione
dell'area
e
l'esame
dei
reperti
affioranti.
La
cosiddetta
"sala
delle
feste"
o
Akhmenu
di
Thutmosi
III,
che
si
trova
al
di
là
del
cortile
del
Medio
Regno,
è
un
edificio
a
peristilio
formato
da
32
pilastri
e
20
colonne,
probabilmente
destinato
alla
celebrazione
della
festa-sed,
in
occasione
del
trentesimo
anniversario
di
regno
di
ciascun
sovrano.
Molti
ambienti
circostanti
la
sala
principale
contengono
importanti
testimonianze
storielle
o
artistiche,
fra
le
quali
la
celebre
"camera
degli
antenati",
ossia
un
rilievo
in
cui
Thutmosi
III
compie
offerte
di
fronte
a
57
sovrani
suoi
predecessori
(ora
conservato
al
Louvre),
e
il
"giardino
botanico",
le
cui
raffigurazioni
parietali
di
piante
e
animali
esotici,
in
parte
realistiche
in
parte
di
fantasia,
costituiscono
un
documento
unico
circa
le
conoscenze
che
si
avevano
in
Egitto
all'epoca
di
Thutmosi
III
(circa
1504-1450
a.C).
Nelle
immediate
vicinanze
del
corpo
principale
del
tempio
di
Amon
sono
situati
molti
altri
edifici,
già
scavati
o
ancora
da
esplorare;
le
misteriose
statue
"espressioniste"
di
Akhenaton
ritrovate
poco
oltre
il
muro
di
cinta
perimetrale
hanno
permesso
di
riconoscere
il
luogo
originario
in
cui
furono
collocate
le
prime
costruzioni
dedicate
all'Aron,
quando
ancora
il
sovrano
risiedeva
a
Tebe.

L'ampliamento
verso
sud
del
grande
tempio
di
Amon
comprende
altri
quattro
piloni,
eretti
a
partire
da
Thutmosi
II
e
III
fino
a
Horemheb,
il
quale
si
servì
ampiamente
dei
materiali
(talatat)
adoperati
per
la
costruzione
dei
templi
dell'Aton
come
riempimento
delle
proprie
strutture
(oggi
le
migliaia
di
talatat
recuperate
giacciono
in
una
sorta
di
museo
all'aperto
in
un'area
poco
distante
da
qui).
Un
lago
sacro
dell'epoca
di
Taharqa,
riservato
alle
navigazioni
rituali
previste
dal
calendario
liturgico
locale,
e
uno
splendido
esempio
di
tempio
a
cella
dedicato
a
Khonsu
da
Ramesse
III
e
fatto
decorare,
fra
gli
altri,
anche
dal
re-sacerdote
Herihor
(ritratto
in
veste
di
faraone
e
con
il
nome
racchiuso
nel
cartiglio),
completano
idealmente
la
visita
al
complesso
principale
del
santuario
di
Amon.
Altre
due
cinte
murarie,
consacrate
rispettivamente
alla
dea
Mut
e
al
dio
Montu,
sorgono
nell'area
di
Karnak.
Il
tempio
di
Montu,
assai
rovinato
e
tuttora
oggetto
di
scavi,
celebra
il
nume
più
antico
della
regione
tebana,
solo
in
un
secondo
tempo
soppiantato
da
Amon,
che
presto
sarebbe
divenuto
il
dio
dinastico
e
nazionale.
Costruito
da
Amenhotep
III,
l'edificio
era
collegato
attraverso
una
serie
di
canali
all'altro
tempio
di
Montu
a
Medamud,
località
che,
insieme
a
Tod
ed
Ermonti,
rappresentava
un
sito
privilegiato
per
officiare
i
riti
in
onore
di
questa
divinità
nel
distretto
tebano.
Nella
vasta
area
dedicata
a
Mut,
in
larga
parte
ancora
inesplorata,
oltre
a
un
grande
bacino
sacro
di
forma
irregolare
si
trovano
un
tempio
destinato
al
culto
della
dea
e
due
templi
più
piccoli,
uno
dedicato
ad
Amon-Ra
e
fatto
costruire
da
Amenhotep
III,
l'altro
edificato
da
Ramesse
III:
tutte
le
strutture
sono
assai
deteriorate
e
attendono
restauri
e
consolidamenti.
Ricordiamo
infine
che
proprio
dal
tempio
di
Mut
a
Karnak
provengono
le
tante
statue
raffiguranti
la
dea
Sekhmet
(data
una
possibile
assimilazione
di
quest'ultima
a
Mut)
esposte
in
diverse
collezioni
europee.
Tutti
i
simulacri
in
oggetto
(si
tratta
di
300
esemplari
circa)
furono
scolpiti
al
tempo
di
Amenhotep
III
e,
secondo
un'interpretazione
recente,
costituivano,
grazie
alle
formule
che
recano
incise,
una
vera
e
propria
"liturgia"
in
pietra,
il
cui
significato
più
autentico
ancora
ci
sfugge.




















 Pag.
2
Pag.
2
|