|
Nel
tentativo
di
sottrarsi
all'ingiuria
del
tempo
e
di
assicurarsi
quella
sorta
di
immortalità che gli era concessa dal credo religioso, il re
egizio,
in
ogni
epoca,
ha
considerato
un
privilegio
e
un
dovere
allestire
per
se
stesso
la
tomba
più
ricca
e
adeguata
al
proprio
rango.
A
differenza
di
quanto
era
avvenuto
nell'Antico
Regno,
quando
l'estrema
dimora
dei
faraoni
finì
per
assumere
la
forma
regolare
di
una
piramide,
comprensiva
di
un
luogo
di
culto
annesso
alla
sepoltura
vera
e
propria,
così
da
formare
un
corpo
unico,
nel
Nuovo
Regno
si
preferì
scindere
l'area
cultuale
da
quella
più
propriamente
funeraria.
Con l'inizio della XVIII Dinastia, infatti, i
sovrani
tebani
scelsero
quella
parte
della
catena
libica
che,
in
forma
di
piramide
naturale,
sovrasta
la
vasta
pianura
che
circonda
Tebe
per
tagliare
nella
roccia
i
loro
profondi
ipogei.
Nella
stretta
fascia
di
terra
che
corre
tra
il
limite
della
zona
coltivata
e
le
prime
pendici
della
montagna
tebana,
sulla
riva
occidentale
del
fiume,
sorse
invece
la "Tebe
dei
morti".
Per
quasi
1500
anni
qui,
ai
piedi
dei
colli,
perché
fossero
accessibili
alla
visita
e
all'omaggio
dei
devoti,
furono
edificati
grandi
templi
funerari
completamente
separati
dalle
tombe
corrispondenti,
che
erano
invece
scavate
nella
montagna,
al
riparo
da
violazioni
e
furti.
Conservatisi solo in parte, tali edifici sacri sono
disposti
in
una
sorta
di
allineamento
nell'area
di
Tebe
Ovest,
ma
mantengono
anche
una
connessione
ideale
con
le
rispettive
inumazioni,
trovandosi
talvolta
esattamente
in
asse
con
queste.
Esempio
particolarmente
ammirevole
di
tale
consuetudine
è
il
caso
della
regina
Hatshepsut
(1498-1483
a.C.
circa),
la
quale,
dopo
aver
fatto
costruire
le
rampe
e
i
porticati
del
proprio
tempio
funerario,
ben
visibili
anche
in
lontananza,
in
uno
scenario
naturale
fra
i
più
suggestivi,
ai
piedi
di
un'imponente
parete
rocciosa
dai
riflessi
rossastri,
si
fece
tagliare
la
tomba
sull'opposto
versante
della
montagna,
cioè
nella
Valle
dei
Re.
Il
suo
sepolcro
"da
faraone"
-
il
secondo,
dato
che
la
dama
possedeva
già
un
avello
ove
essere
inumata,
costruito
quando
non
aveva
ancora
assunto
le
prerogative
regali
-,
situato
in
una
valletto
non
troppo
distante
dal
tempio,
trovava
sbocco,
con
un
percorso
singolarmente
disagevole
e
sinuoso,
nella
stanza
del
sarcofago,
scavata
proprio
a
ridosso
della
stessa
parete
di
fondo
del
proprio
tempio
funerario.
A
nord,
vennero
costruiti
il
tempio
di
Qurna
al-Gedida
dedicato
ad
Amon-Re,
e
quello
consacrato
a
Hathor,
la
dea
della
dolcezza
e
della
gioia
venerata
sotto
forma
di
vacca,
commissionato
dalla
regina
Hatshepsut
per
sé
e
per
il
padre
Tutmosi
I.
Ancora
più
celebre
è
il
grandioso
tempio
funerario
di
Ramses
II
(Ramesseum),
una
costruzione
situata
al
limite
delle
aree
coltivate
che,
per
i
cortili
e
i
sacrari
fitti
di
statue,
le
decorazioni
e
i
colossi,
fu
celebrato
da
molti
antichi
scrittori.
Del
tempio
di
Amenofi
III rimangono
soltanto
i
colossi
di
Memnone,
due impressionanti monoliti di quarzite che ritraggono il
faraone
seduto
sul
trono,
accompagnato
dalle
figure
della
madre
e
della
moglie.
- Tempio
di
Hatshepsut

È
un
tempio
di
tipo
funerario
il
gigantesco
complesso
della
regina
Hatshepsut
(1479-1458
a.C.),
una
donna
ambiziosa,
moglie
di
Tuthmosi
II,
che
assunse
il
titolo
di
faraone.
Nel
trarre
ispirazione
dal
più
immediato
e
antico
precedente
tipologico,
appartenente
all'Xl
Dinastia
(2040-1972
a.C.
circa)
e
situato
proprio
a
fianco
del
tempio
di
Hatshepsut,
l'architetto
Senmut
seppe
realizzare
un
capolavoro
unico,
dal
fascino
irripetibile,
che
sfrutta
appieno
le
risorse
dell'ambiente
naturale,
nel
quale
appare
inserito
quasi
si
trattasse
di
un
fondale
di
scena:
una
parete
rocciosa
alta,
squadrata,
che
si
staglia
maestosa
a
racchiudere
le
diverse
terrazze
di
cui
si
compone
l'edificio,
purtroppo
giunto
a
noi
non
del
tutto
integro.
Forse
non
a
caso
Hatshepsut,
cui
vanno
attribuiti
molti
di
quegli
impulsi
culturali
e
religiosi
destinati
a
fruttificare
solo
in
seguito,
con
la
riforma
di
Akhenaton,
scelse
d'innalzare
proprio
qui
il
suo
tempio
funerario.
Poggiando
direttamente
sulla
parete
di
fondo,
ma
senza
più
valersi
di
strutture
tagliate
nella
roccia,
con
una
successione
di
vaste
terrazze
-
in
parte
adibite
a
giardini
e
collegate
fra
loro
per
mezzo
di
larghe
rampe.







L'edificio,
provvisto
nella
terrazza
superiore
di
un
cortile
con
un
semplice
altare,
in
luogo
della
piramide
o
dell'obelisco
come
era
di
regola
nei
templi
solari
della
V
dinastia,
si
configura
quale
splendido
e
originale
prodotto
del
genio
di
Senmut.
A
quest'ultimo,
architetto
e
uomo
di
fiducia
della
regina
Hatshepsut,
va
dunque
il
merito
di
aver
saputo
inventare
soluzioni
nuove,
non
più
riprese
in
seguito
anche
per
ragioni
di
opportunità
politica.
I
suoi
successori
tornarono
a
costruire
i
propri
templi
funerari
nella
piana
di
Tebe
Ovest,
e
forse
soltanto
gli
edifici
sacri
realizzati
in
Nubia
da
Ramesse
II,
primo
fra
tutti
quello
di
Abu
Simbel,
seppero
recuperare
almeno
alcuni
dei
dettami
lasciati
in
eredità
da
questo
personaggio
geniale,
per
infondere
ai
grandiosi
templi
rupestri
affacciati
sul
Nilo
qualcosa
di
quel
sentimento
di
comunione
con
la
natura
che
a
Deir
el-Bahari
parve
toccare
il
suo
apogeo.
Al
tempio
di
Hatshepsut
si
accede
mediante
una
lunga
rampa
che
ha
origine
da
un
cortile
esterno e
conduce
alla
terrazza
inferiore.
Dai
portici
colonnati
si
giunge
sia
alle
cappelle
di
Anubi
e
Hathor -
rispettivamente
il
dio-cane
e
la
dea-vacca
-
potenti
divinità
dell'oltretomba
-
sia
a
quelle
minori,
dedicate
alla
regina
e
a
suo
padre
Tuthmosi
I,
tutte
scavate
nella
roccia.
Il
Sancta
sanctorum
era
la
cella
più
sacra
e
interna
del
tempio.
Sulle
pareti
dei
portici
colonnati
si
sono
conservati
alcuni
rilievi
che
raffigurano
diversi
momenti
significativi
del
regno
di
Hatshepsut,
esaltandone
anche
la
natura
divina.
Del
resto,
non
era
raro
trovare
decorazioni
come
queste:
le
pareti
dei
templi
erano
spesso
dipinte
e
incise,
secondo
una
tradizione
che
prosegue
dall'Antico
al
Nuovo
Regno,
con
cicli
che
raccontavano
le
imprese
del
faraone,
le
sue
battaglie,
le
sue
spedizioni
alla
ricerca
di
oro
o
gioielli.
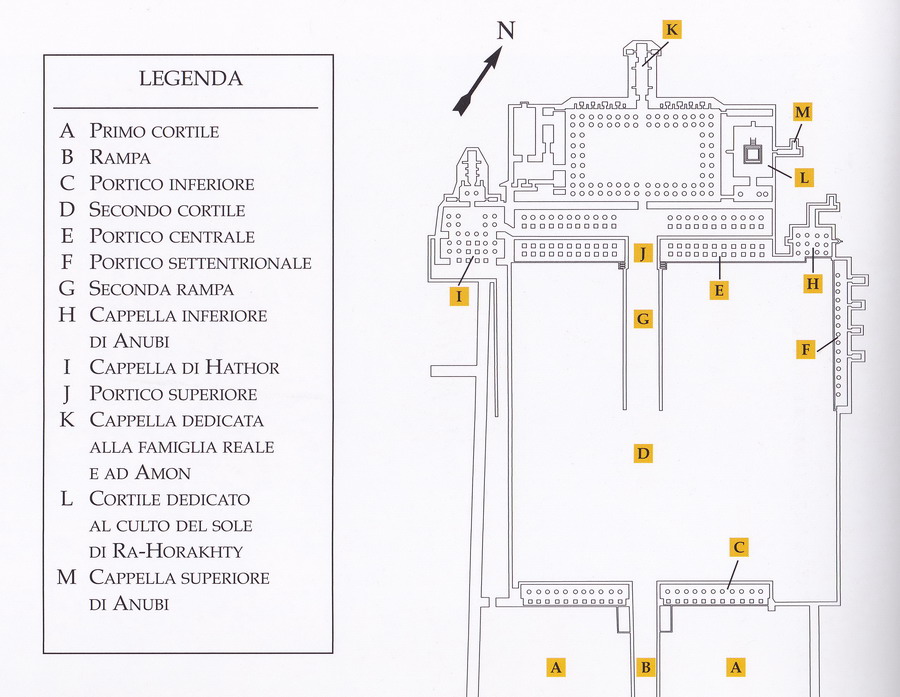
- Tempio
di
Amnhotep
III
Del
monumentale
tempio
funerario
di
Amenhotep
III,
opera
dell'influente
architetto
Amenhotep
figlio
di
Hapu,
già
autore
di
molti
altri
edifici
sacri
in
Tebe
e
più
tardi
divinizzato
come
il
più
antico
Imhotep,
non
sussistono
che
i
due
colossi,
detti
di
Memnone.
I
Colossi
di
Memnone
sono
due
enormi
statue
di
pietra
del
faraone
Amenhotep
III.
Eretti
oltre
3400
anni
fa
nella
necropoli
di
Tebe,
lungo
le
rive
del
Nilo,
di
fronte
all'attuale
città
di
Luxor,
le
due
statue
facevano
parte
del
complesso
funerario
eretto
da
Amenhotep
III.
Le
statue
successivamente
alla
morte
del
faraone
divennero
già
famose
nell'antichità,
quando,
in
seguito
al
loro
progressivo
degrado,
da
una
di
esse
si
propagarono
dei
rumori,
che
all'epoca
furono
interpretati
come
il
saluto
dell'omonimo
eroe
a
sua
madre.
Le
statue
gemelle
rappresentano
Amenhotep
III
(XV
secolo
a.C.)
in
posizione
seduta,
con
le
mani
sulle
ginocchia
e
lo
sguardo
rivolto
a
est,
verso
il
fiume
e
il
sole
nascente.
Due
figure
più
basse
sono
scolpite
sulla
parte
anteriore
del
trono,
a
fianco
alle
sue
gambe:
la
moglie
Tiy
e
la
madre
Mutemuia.
I
pannelli
laterali
rappresentano
il
dio
del
Nilo
Hapy.
Sono due statue gigantesche
(alte
20
metri,
con
i
soli
piedi
di
2
metri
di
lunghezza
e
uno
spessore
di
1
metro),
tagliate
in
blocchi
monolitici
di
arenaria
e
rappresentano
il
faraone
seduto
sul
trono,
con
ambedue
le
mani
posate
sulle
ginocchia.

La
funzione
originale
dei
Colossi
era
di
stare
a
guardia
dell'entrata
del
Tempio
di
Milioni
di
Anni
di
Amenhotep:
un
gigantesco
centro
di
culto
costruito
quando
il
faraone
era
ancora
in
vita,
dove
venne
riconosciuto
come
reincarnazione
in
terra
del
dio,
sia
prima
che
dopo
la
sua
partenza
da
questo
mondo.
Ai
suoi
tempi,
questo
tempio
era
il
più
grande
ed
opulento
nell'intero
Egitto.
Con
una
superficie
di
35
ettari,
anche
i
rivali
successivi
come
il
Ramesseum
di
Ramesse
II
o
il
Medinet
Habu
di
Ramesse
III
non
reggevano
il
confronto,
non
raggiungendone
l'area;
anche
il
tempio
di
Karnak,
all'epoca
di
Amenhotep,
era
più
piccolo.
Il
colosso
a
sud,
anche
se
molto
rovinato,
sembra
tuttavia
avere
sofferto
meno
dell'altro:
a
quest'ultimo
si
ricollega
una
leggenda.
Sembra
che
nel
27
a.C.
un
terribile
terremoto
danneggiasse
gravemente
quasi
tutti
i
monumenti
di
Tebe
e
che
aprisse
un'enorme
fessura
dall'alto
fino
alla
metà
del
colosso,
che
rovinò
al
suolo.
Si
notò
che
ogni
mattina,
all'alba,
la
statua
emetteva
un
suono
vago
e
prolungato,
in
cui
alcuni
viaggiatori
credettero
di
udire
un
canto
triste
ma
armonioso.
Su
questo
strano
fatto
testimoniato
da
grandi
storici
come
Strabone,
Pausania,
Tacito,
Luciano
e
Filostrato,
i
poeti
greci
fecero
fiorire
una
bella
leggenda.
La
"pietra che canta", dissero, rappresenta
Memnone,
il
mitico
figlio
dell'Aurora
e
di
Titone.
Inviato
dal
padre
in
aiuto
di
Troia
assediata
dall'esercito
greco,
Memnone
uccise
in
combattimento
Antiloco,
figlio
di
Nestore,
ma
a
sua
volta
cadde
sotto
la
mano
vendicatrice
di
Achille.
L'Aurora,
pregò allora Zeus di far resuscitare, almeno una volta
al
giorno,
il
figlio:
così,
ogni
mattina,
mentre
lo
accarezzava
con
i
suoi
raggi,
egli
rispondeva
alla
madre
inconsolabile
emettendo
un
lungo
suono
lamentoso.
Il
fenomeno
è
dovuto
invece
a
cause
del
tutto
naturali.
I
suoni
emessi
sarebbero
dovuti
alle
vibrazioni
prodotte
nella
superficie
spezzata,
dal
brusco
passaggio
dal
freddo
della
notte
al
calore
dei
primi
raggi
del
sole.
Incise
sulle
gambe
del
colosso,
numerose
e
talvolta
curiose
incisioni
si
sono
aggiunte
nel
corso
dei
secoli.
Oggi
il
tempio
è
quasi
completamente
scomparso,
causa
i
ripetuti
saccheggi,
un
terremoto
e
l'erosione
delle
annuali
inondazioni
del
Nilo,
che
si
alzava
ogni
anno
invadevano
probabilmente
i
cortili
e
le
sale
esterne,
risparmiando
il
solo
sacrario.
- Tempio
di
Sethi
I
Nei
pressi
del
villaggio
di
Qurna
sorge
il
tempio
di
Sethi
I,
uno
dei
maggiori
monumenti
dell'antichità,
di
cui
si
conserva
piuttosto
bene
solo
la
sezione
centrale,
a
partire
dalla
sala
ipostila,
che
rivela
decorazioni
interessanti
e
di
qualità.
Preceduti
da
due
piloni
in
mattone
crudo,
oggi
quasi
interamente
scomparsi,
gli
ambienti
superstiti
rimandano
a
una
tripartizione
che
vuole
le
sale
interne
dedicate
rispettivamente
ad
Amon
e
Sethi
I
(centro),
ad
Amon
e
Ramesse
I
(sud),
ad
Amon-Ra
(nord).
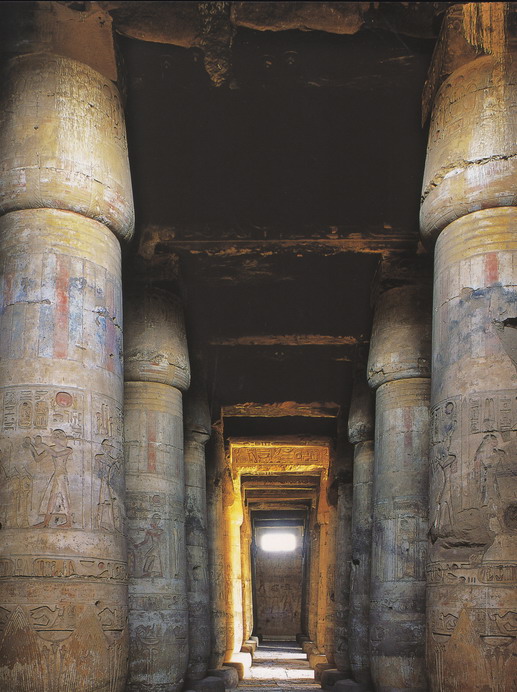 La
presenza
di
una
camera
dedicata
al
culto
del
padre
Ramesse
I,
sul
trono
per
soli
due
anni,
dimostra
la
pietà
filiale
di
Sethi
I
che,
come
già
avvenne
nel
caso
del
sepolcro
nella
Valle
dei
Re,
volle
portare
a
compimento
ciò
che
era
stato
previsto
per
il
suo
predecessore,
scomparso
troppo
presto
dalla
scena,
del
quale
egli
volle
però
garantire
memoria
e
culto
specifico. La
presenza
di
una
camera
dedicata
al
culto
del
padre
Ramesse
I,
sul
trono
per
soli
due
anni,
dimostra
la
pietà
filiale
di
Sethi
I
che,
come
già
avvenne
nel
caso
del
sepolcro
nella
Valle
dei
Re,
volle
portare
a
compimento
ciò
che
era
stato
previsto
per
il
suo
predecessore,
scomparso
troppo
presto
dalla
scena,
del
quale
egli
volle
però
garantire
memoria
e
culto
specifico.
Il
Tempio
di
Seti
I
contiene
7
sacrari
dedicati
a
7
diverse
divinità:
Isis,
Horus,
Amon
Ra,
Osiris,
Ra
Hor
Akhty
,
Ptah
e
Seti
I
rappresentato
come
un
re
deificato.
All’interno
vi
si
possono
trovare
anche
i
migliori
rilievi
e
testi
risalenti
alla
XVIII
Dinastia.
Il
Tempio
fu
costruito
con
del
marmo
bianco
e,
una
volta,
vi
era
un
grande
pilastro
costruito
da
Ramses
II.
La
parte
anteriore
del
tempio
è
costituita
da
una
facciata
quadrata
di
colonne,
vi
sono
12
pilastri
rettangolari
con
decorazioni
di
Ramses
II
che
da
il
benvenuto
agli
dei
Isis,
Osiris
e
Horus.
Originariamente
il
tempio
aveva
7
portoni
ognuno
dei
quali
conduceva
a
7
sacrari
costruiti
da
Seti
I.
Ramses
II
apportò
ulteriori
modifiche,
attualmente
è
aperto
un
solo
portone.
La
sala
ipostila
a
sei
colonne
papiriformi
evidenzia
scene
d'offerta
ad
Amon
e
all'Enneade
da
parte
di
Sethi
I
e
del
figlio
e
successore
Ramesse
II,
il
quale
a
sua
volta
portò
a
termine
la
costruzione
degli
edifici
sacri,
che
comprendono
anche
un
cosiddetto
"palazzo
reale",
il
primo
del
genere
ritrovato
nell'area,
destinato
a
ospitare
il
"rivitalizzato"
re
defunto
in
occasione
di
importanti
feste.
Noto
per
le
sue
imprese
militari,
sotto
il
regno
di
Sethi
I
furono
realizzati
alcuni
grandiosi
monumenti,
quali
la
Grande
Sala
Ipostila
di
Karnak,
anch’essa
completata
da
Ramses
II,
e
il
suo
tempio
ad
Abido,
nel
Medio
Egitto.
La
tomba
di
Sethi
I
è
sicuramente
la
più
spettacolare
tra
quelle
della
Valle
dei
Re
e
possiede
alcune
fra
le
più
splendide
decorazioni
parietali.
Purtroppo,
i
piloni
e
i
cortili
del
tempio
funerario
sono
stati
in
gran
parte
distrutti,
rendendolo
meno
imponente
di
quanto
fosse
in
origine.
Si
è
conservato
solo
il
nucleo
centrale
dell'
edificio,
il
portico
sostenuto
da
otto
colonne
papiriformi
e
la
sala
ipostila,
che
è
più
piccola
però
rispetto
a
quella
di
Karnak.
I
bassorilievi
che
abbelliscono
le
pareti
del
tempio
sono
tra
i
più
raffinati
ed
eleganti
esempi
dell'arte
del
Nuovo
Regno.
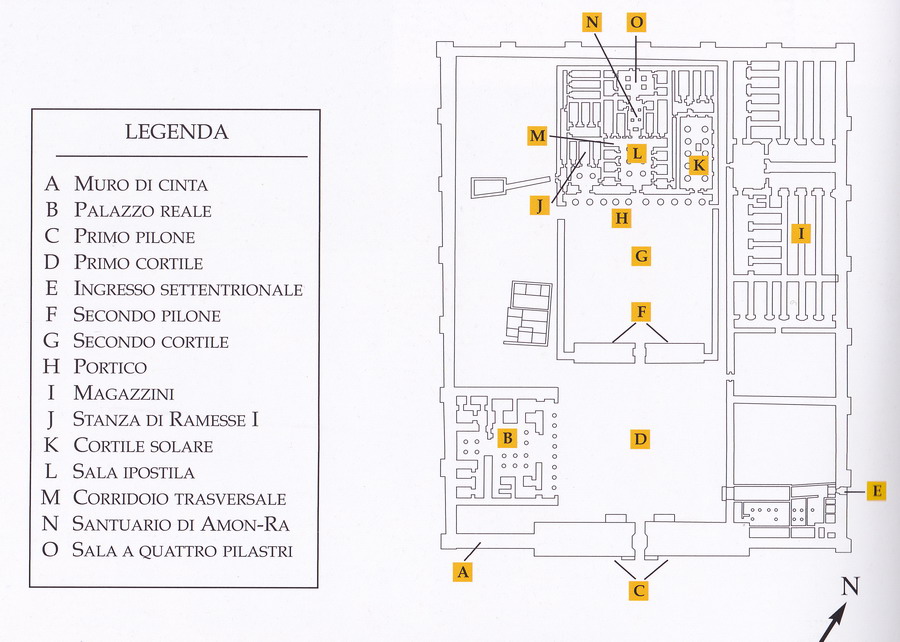
- Tempio
di
Ramesse
II
Il
tempio
funerario
di
Ramesse
II,
è
collocato
a
Tebe,
nell'Alto
Egitto,
nei
pressi
del
fiume
Nilo
a
poca
distanza
dalla
moderna
città
di
Luxor.
E'
uno
splendido
complesso
di
edifici
che
ricalca
nel
modello
l'analogo
tempio
di
Sethi
I,
padre
di
Ramesse
II.
Definito
nel
secolo
scorso
"Ramesseo"
dallo
stesso
Champollion,
che
ne
rimase
affascinato
e
ne
lasciò
una
puntuale
descrizione,
il
tempio
di
Ramesse
II
appare
ancor
oggi
nella
sua
grandiosità,
nonostante
il
degrado.
Circondato
da
una
cinta
esterna
e
da
una
serie
di
grandi
magazzini
costruiti
in
mattoni
crudi,
così
come
le
volte
dei
soffitti
(tra
i
pochi
esempi
di
struttura
curvilinea
in
Egitto,
dove
si
rifuggiva
da
questa
tipologia
sia
in
pianta
sia
in
elevato),
il
Ramesseo
rivela,
nella
struttura
principale,
due
piloni
e
due
cortili
che
conducono
a
più
sale
ipostile.
Ramesse
II
modificò,
usurpò
o
costruì
molte
tra
le
più
belle
strutture
del
Nuovo
Regno
tra
le
quali
proprio
il
Ramesseum,
un
tempio
dedicato
al
faraone,
dio
in
terra,
dove
la
memoria
sarebbe
stata
nota
per
generazioni
a
tutto
il
mondo
dopo
la
sua
morte
corporale.
I
lavori
per
la
costruzione
del
tempio
iniziarono
secondo
i
registri
all'inizio
del
suo
regno
e
si
conclusero
in
20
anni.
Il
disegno
del
tempio
di
Ramesse
aderisce
perfettamente
ai
canoni
standard
dell'architettura
dei
templi
del
Nuovo
Regno.
Orientato
da
nord-ovest
a
sud-est,
il
tempio
stesso
comprendeva
due
piloni
di
pietra
per
ingresso
che
conducevano
al
cortile
del
tempio.
Oltre
il
secondo
cortile,
al
centro
del
complesso,
si
trovava
una
sala
ipostila
sorretta
da
48
colonne
che
circondava
il
santuario
interno.
Nel
primo
cortile
inoltre
si
trovava
una
gigantesca
statua
del
re
di
cui
ancora
oggi
si
possono
ammirare
i
resti.

La
facciata
interna
del
primo
pilone,
fortemente
danneggiato,
evidenzia
scene
di
combattimento
contro
i
popoli
del
Vicini
Oriente
e
in
particolare
gli
Ittiti,
con
la
rappresentazione
della
celebre
battaglia
di
Qadesh.
L'epico
scontro,
avvenuto
sulle
rive
dell'Oronte,
in
area
siro-palestinese,
fu
riprodotto
anche
in
altri
edifici
a
Karnak,
Abido
e
soprattutto
ad
Abu
Simbel,
dove
tra
l'altro
è
accompagnato
da
un
resoconto,
noto
oggi
come
Poema
di
Pentaur,
dal
nome
dello
scriba
che
lo
redasse.
Della
gigantesca
statua
di
Ramesse
II
(alta
19
metri
e
del
peso
di
1000
tonnellate)
oggi
rimangono
solo
dei
frammenti
ancora
visibili
sul
terreno.
Dalle
cave
in
cui
venne
sbozzata,
la
statua
venne
trasportata
poi
per
170
miglia.
I
resti
oggi
rappresentano
i
più
grandi
resti
in
situ
di
statua
colossale
al
mondo
assieme
ai
colossi
di
Ramesse
a
Tanis.
I
resti
che
si
trovano
nel
secondo
cortile
includono
parte
della
facciata
interna
dei
piloni
e
una
porzione
del
portico
di
Osiride
sulla
destra.
Altre
scene
di
guerra
con
gli
ittiti
a
Kadesh
si
ripetono
sui
muri.
Nella
parte
alta
si
trovano
invece
feste
in
onore
della
dea
Min,
dea
della
fertilità.
Sul
lato
opposto
al
cortile
di
Osiride
si
trovano
altre
colonne
che
forniscono
l'idea
originaria
di
splendore
del
sito
perché
meglio
conservate.
Qui
si
trovano
anche
parti
di
due
statue
del
re,
una
in
granito
rosa
e
l'altra
in
granito
nero,
affiancate
all'entrata
del
tempio.
Una
delle
teste
di
queste
statue
venne
rimossa
e
si
trova
oggi
al
British
Museum.
31
delle
48
colonne
della
sala
ipostila
(misure
41m
x
31m)
si
trovano
ancora
in
piedi.
Esse
sono
decorate
con
scene
che
raffigurano
il
re
con
diversi
dei.
Parte
del
soffitto
è
decorata
con
stelle
dorate
su
sfondo
blu
ed
è
ancora
conservato
in
pittura.
I
figli
e
le
figlie
di
Ramesse
appaiono
in
processione
sulle
mura
di
sinistra.
Il
santuario
è
composto
da
tre
camere
consecutive
con
otto
colonne
ed
una
cella
tetrastila.
Parte
della
prima
stanza,
col
soffitto
decorato
con
scene
astrali,
è
ancora
oggi
conservata.

Adiacente
alla
sala
ipostila
si
trova
un
tempio
più
piccolo
dedicato
alla
madre
di
Ramesse,
Tuya
ed
alla
sua
amata
prima
moglie
Nefertari.
Il
complesso
è
circondato
da
numerose
sale
di
rappresentanza,
granai,
laboratori,
e
costruzioni
accessorie,
alcune
costruite
in
epoca
romana.
Nell'area
della
sala
ipostila
si
trovava
precedentemente
un
tempio
fatto
costruire
da
Sethi
I,
ma
oggi
ne
sono
emerse
le
sole
fondamenta.
Esso
consisteva
di
una
corte
a
peristilio
e
da
due
cappelle.
Papiri
tra
l'XI
e
l'VIII
secolo
a.C.
indicano
il
tempio
come
il
sito
di
un'importante
scuola
di
scribi.
- Tempio
di
Ramesse
III
Per
lungo
tempo
Medinet
Habu
non
fu
altro
che
una
ricchissima
cava
dove
si
potevano
recuperare
grandi
pietre
squadrate.
In
epoca
cristiana
sorse
in
questa
zona
un
villaggio
che
i
copti
chiamarono
Djeme,
e
che
occupava
gran
parte
della
zona
dove
sorgeva
il
tempio:
fu
proprio
questa
sua
nuova
utilizzazione
che,
in
questo
caso,
permise
di
salvare
numerose
vestigia
che
altrimenti
sarebbero
forse
andate
perdute.
Gli
scavi
hanno
messo
in
luce
le
tracce
di
tutta
una
città
che
si
stendeva
intorno
al
palazzo
dei
faraoni,
ma
solo
una
casa
è
stata
ritrovata:
quella
di
un
ispettore
della
necropoli.
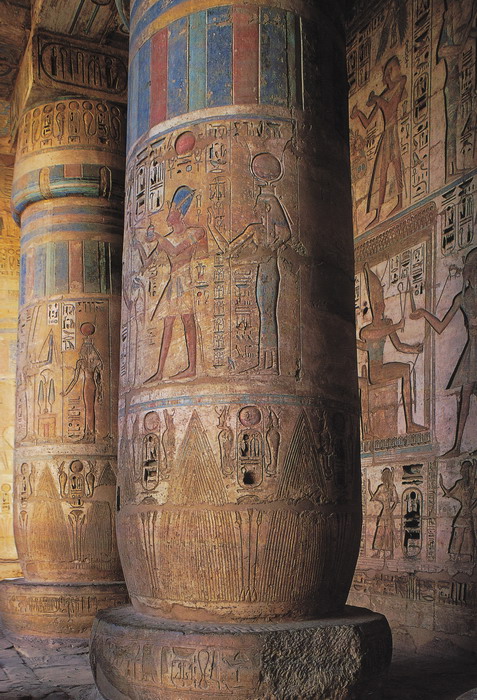
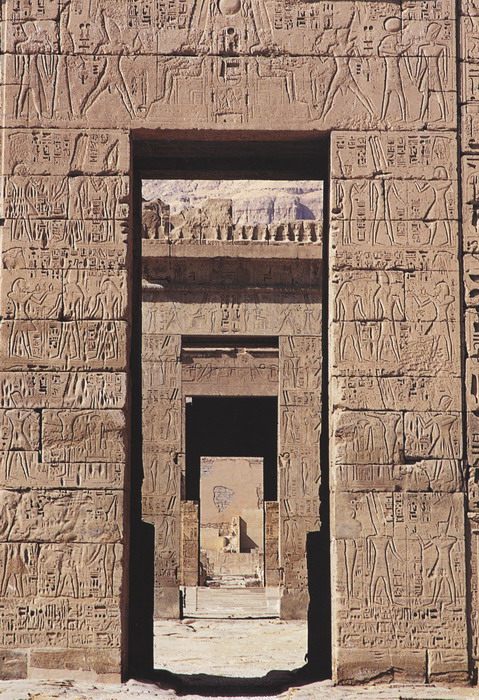
Il
grande
complesso
archeologico
di
Medinet
Habu
racchiude
numerosi
edifici
di
età
diversa
e
conserva
una
spessa
cinta
muraria
in
mattoni
crudi,
risalente
per
lo
più
a
Ramesse
III.
Questo
sovrano,
che
per
innalzare
il
proprio
tempio
funerario
scelse
un
sito
particolarmente
sacro
ad
Amon,
come
dimostrano
le
più
antiche
testimonianze
ritrovate
in
situ,
volle
creare
a
propria
imperitura
memoria
un
insieme
di
edifici
religiosi
celebrativi
tale
da
rivaleggiare
per
imponenza
nell'area
tebana
solo
con
Karnak.
 Di
aspetto
imponente,
quasi
militaresco,
è
la
bella
Porta
del
Sud,
detta
padiglione
reale,
incassata fra
le
due
torri
alte
più
di
20
metri
e
sopra
cui
si
aprono
due
ordini
di
finestre
longitudinali.
All'interno
presenta
una
sorta
di
passaggio
che
va
restringendosi
verso
il
fondo.
Anche
i
bassorilievi
scolpiti
sulle
pareti
delle
torri
ribadiscono
il
carattere
"guerresco"
di
questa
costruzione:
massacri
simbolici
di
prigionieri,
il
faraone
che
presenta
al
dio
Amon
i
nemici
catturali
e
così
via. Di
aspetto
imponente,
quasi
militaresco,
è
la
bella
Porta
del
Sud,
detta
padiglione
reale,
incassata fra
le
due
torri
alte
più
di
20
metri
e
sopra
cui
si
aprono
due
ordini
di
finestre
longitudinali.
All'interno
presenta
una
sorta
di
passaggio
che
va
restringendosi
verso
il
fondo.
Anche
i
bassorilievi
scolpiti
sulle
pareti
delle
torri
ribadiscono
il
carattere
"guerresco"
di
questa
costruzione:
massacri
simbolici
di
prigionieri,
il
faraone
che
presenta
al
dio
Amon
i
nemici
catturali
e
così
via.
Il
grande
tempio
di
Ramesse
III,
che
ripete
il
modello
del
Ramesseo,
con
due
cortili
porticati,
tre
sale
ipostile
e
il
sacrario
della
barca
sacra,
attorniati
da
cappelle,
alcune
delle
quali
destinate
a
ospitare
il
tesoro
proveniente
dalle
offerte
al
dio
Amon,
è
ottimamente
conservato.
Il
primo
pilone
riporta
in
facciata
la
consueta
scena
del
sovrano
che
sacrifica
i
prigionieri
davanti
ad
Amon
e
una
lunga
lista
di
Paesi
sconfitti,
tra
i
quali
figurano
i
famosi
"popoli
del
mare"
che
tentarono
di
sbarcare
nel
Delta
del
Nilo,
ma
vennero
respinti,
come
attestano
le
iscrizioni
e
i
rilievi
sulle
pareti
esterne
del
tempio.
Sulla
parete
interna
del
primo
pilone
Ramesse
III
è
ritratto
in
presenza
degli
dèi
protettori,
alla
testa
dell'esercito
mentre
massacra
i
nemici
e
celebra
la
vittoria
ostentando
le
membra
mozzate
e
accatastate
degli
avversari.
Sul
muro
di
fondo,
a
sinistra
del
primo
cortile,
si
apre
la
"finestra
dell'apparizione",
da
cui
si
accedeva
al
palazzo
reale
e
che
consentiva
al
faraone
di
assistere
alle
cerimonie.
Il
secondo
pilone,
preceduto
da
un'elegante
rampa
e
parimente
decorato
con
un'ampia
descrizione
delle
imprese
militari
del
sovrano,
immette
in
un
altro
cortile
porticato,
adorno
di
scene
religiose
e
di
raffigurazioni
dei
cortei
della
barca
divina.
Nella
grande
sala
ipostila
rimangono
solo
i
tronconi
dei
fusti
di
24
colonne
che
originariamente
reggevano
il
soffitto.
Sulle
pareti
esterne
del
lato
sud-occidentale
della
sala
sono
visibili
scene
di
caccia
e
un
importante
calendario
religioso,
mentre
sul
fianco
nord-orientale
si
possono
ammirare
le
celebri
immagini
di
battaglie
navali
e
combattimenti
contro
i
Libici.
Il
comprensorio
di
Medinet
Habu
include
anche
un
tempio
risalente
all'inizio
della
XVIII
Dinastia,
come
attestano
i
cartigli
di
Amenhotep
I
e
Thutmosi
I;
completato
successivamente,
l'edificio
fu
dotato
di
un
ingresso
monumentale
sotto
gli
ultimi
Tolomei,
mentre
Antonino
Pio
fece
costruire
un
cortile
e
un
avancorpo.
La
decorazione
interna
ed
esterna
del
sacrario
riporta
i
nomi
di
molti
dei
più
celebri
faraoni
del
Nuovo
Regno,
da
Thutmosi
III
a
Horemheb,
da
Sethi
I
ad
Amenemes,
mentre
le
decorazioni
delle
porte
risalgono
all'epoca
tolemaica.

Pag.
1

 Pag.
3
Pag.
3
|