|
La
Valle
dei
Re
La
valle
di
Biban
el-Muluk,
la
Porta
dei
Re:
in
questa
celebre
gola,
dominata
da
una
montagna
a
punta
chiamata
"cima
tebana",
si
trova
la
necropoli
dei
grandi
sovrani
egiziani
dalla
XVIII
alla
XX
dinastia.
Nelle
viscere
della
montagna,
tra
valli
deserte
e
silenziose,
per
un
periodo
di
quasi
500
anni,
ovvero
dal
1552
a.C.
al
1069
a.C.,
un'operosa
comunità
di
lavoratori
e
di
artigiani
taglia
la
roccia
approntando
vaste
pareti
sulle
quali
troveranno
posto
bellissime
figure
di
uomini,
dèi
e
animali,
protagonisti
del
complesso
mondo
mitologico-religioso
che
s'immagina
permeare
tutto
l'Aldilà.
All'inizio
della
sua
storia
sta
l'improvvisa
e
imprevedibile
decisione
di
Thutmosi
I
di
separare
la
sua
tomba
dal
tempio
funebre:
non
solo,
ma
di
dare
sepoltura
al
suo
corpo
non
più
in
uno
sfarzoso
monumento
bensì
in
un
luogo
segreto
e
inaccessibile.
La
sua
risoluzione
interrompeva
bruscamente
una
tradizione
che
durava
da
ben
1700
anni.
Il
suo
architetto-capo,
che
si
chiamava
Ineni,
scavò
una
tomba
a
pozzo
in
un
vallone
solitario,
tagliando
nella
roccia
una
ripida
scalinata
e
collocandovi
giù
il
sepolcro,
secondo
uno
schema
che
sarebbe
stato
seguito
da
tutti
i
faraoni
successivi.
Fu
lo
stesso
Ineni
che
volle
documentare
la
segretezza
della
sua
impresa,
facendo
incidere
sulla
parete
della
cappella
funeraria
la
frase
"io
solo
ho
sorvegliato
la
costruzione
della
tomba
rupestre
di
sua
maestà.
Nessuno
ha
visto,
nessuno
ha
udito
nulla".
Questa
ultima
frase,
effettivamente
poco
credibile,
va
intesa
nel
senso
che
i
pochi
operai
erano
in
grado
di
mantenere
il
segreto.
Ma
il
riposo
di
Thutmosi
I,
come
quello
degli
altri
sovrani,
era
destinato
a
durare
poco,
perche
già
in
epoca
faraonica,
nonostante
la
sorveglianza
di
squadre
di
guardiani
notte
e
giorno,
ebbero
inizio
dei
sistematici
saccheggi
per
asportare
il
prezioso
corredo
funebre:
una
delle
prede
più
ambite
era
il
cosiddetto
"scarabeo
del
cuore",
l'amuleto
che,
posto
sul
cuore
della
mummia,
permetteva
al
defunto
di
salvarsi
il
giorno
del
giudizio,
allorché
le
sue
azioni
sarebbero
state
messe
sul
piatto
della
bilancia.
Per
un
curioso
destino,
questi
potenti
sovrani
non
ebbero
pace
neppure
da
morti.
Era
successo,
infatti,
che
all'epoca
del
debole
regno
dei
Ramessidi,
i
sacerdoti
di
Amon,
un
tempo
così
potenti,
avessero
perso
ogni
autorità.
Nella
loro
devozione,
per
assicurare
ai
loro
defunti
sovrani
una
vita
tranquilla
nell'aldilà
e
per
evitare
la
loro
profanazione,
iniziarono
a
trasportare
le
mummie
reali
da
una
sepoltura
all'altra
e
questi
trasferimenti
erano
così
frequenti
che
Ramesse
III
fu
sepolto
addirittura
per
tre
volte.
Finalmente,
decisero
di
preparare
in
gran
segreto
un
nascondiglio
pressoché
inaccessibile:
avevano
fatto
scavare
sulla
montagna
di
Deir
el-Bahari
un
pozzo
profondo
circa
dodici
metri,
da
cui
partiva
un
lunghissimo
corridoio
che
sfociava
in
un
vasto
ambiente.
Di
notte
e
in
gran
segreto,
alla
luce
di
poche
fiaccole,
furtivi
essi
stessi
come
dei
saccheggiatori,
i
sacerdoti
avevano
tolto
i
faraoni
dai
loro
sarcofagi
nella
Valle
e
li
avevano
riuniti
nell'antro
della
montagna,
appendendo
al
collo
di
ciascuno
uno
scudo
con
il
nome
per
l'identificazione.
Erano
morti
da
pochi
anni
o
da
molti
secoli,
avevano
regnato
per
poco
tempo
o
per
lunghi
decenni,
alcuni
di
loro
erano
stati
i
più
potenti
sovrani
della
terra:
adesso
giacevano
tutti
insieme,
senza
ordine,
l'uno
accanto
all'altro.
Ahmosi,
il
fondatore
della
XVIII
dinastia
accanto
al
conquistatore
Thutmosi
III,
il
grande
Ramesse
II
accanto
al
padre
Sethi
I.
In
tutto,
erano
quaranta
i
corpi
dei
faraoni
che
sarebbero
rimasti
nascosti,
in
questo
anonimo
sepolcro
nel
cuore
della
montagna,
per
tremila
anni.

Fu
un
giovane
tombarolo
di
nome
Ahmed
Abd
el-Rasul,
del
villaggio
di
Qurna,
che
per
puro
caso,
un
giorno
del
1875,
scoprì
questo
nascondiglio:
per
sei
anni
lui
e
i
suoi
fratelli
riuscirono
a
mantenere
il
segreto,
arricchendosi
con
il
commercio
degli
oggetti
che
saccheggiavano
dalle
mummie
reali.
Poi
il
segreto
venne
meno
e,
il
5
luglio
1881,
dopo
un
lungo
interrogatorio,
il
giovane
arabo
condusse
l'allora
vice
direttore
del
Museo
del
Cairo,
Emil
Brugsch,
fratello
del
celebre
egittologo
Heinrich,
all'ingresso
del
pozzo.
È
difficile
immaginare
cosa
deve
avere
provato
lo
studioso,
quando
l'incerta
luce
della
fiaccola
illuminò
le
spoglie
mortali
di
quaranta
sovrani
del
mondo
antico.
Pochi
giorni
dopo,
le
mummie
vennero
imballate
e
trasportate
giù
a
valle,
dove
una
nave
le
avrebbe
portate
al
Cairo.
E
allora
accadde
un
fatto
strano
e
commovente:
alla
notizia
che
i
faraoni
ritrovati
lasciavano
la
loro
secolare
sepoltura,
i
contadini
della
valle
con
le
loro
mogli
si
ammassarono
sulle
rive
del
Nilo
e,
al
lento
passaggio
della
nave,
resero
omaggio
ai
loro
antichi
re,
gli
uomini
scaricando
in
aria
i
fucili
e
le
donne
alzando
alti
lamenti
e
cospargendosi
il
viso
e
il
petto
di
polvere.
Oggi
alla
Valle
si
accede
per
una
comoda
strada
carrozzabile
che
segue,
in
gran
parte,
l'antico
tracciato
che
doveva
percorrere
il
corteo
funebre.
Le
tombe
hanno
mantenuto
intatto
il
loro
antico
fascino:
gli
innumerevoli
graffiti
sulle
pareti
ci
dicono
che
fin
dall'epoca
greco-romana
esse
furono
meta
di
viaggiatori
e
pellegrini
che
lasciavano
così
il
ricordo
della
loro
visita.
Uno
di
questi,
l'inglese
Dean
Stanley
che
nel
1856
fece
un
bel
resoconto
dei
suoi
viaggi,
scrisse
che
"avere
visto
le
tombe
dei
re
è
avere
visto
l'intera
religione
dell'Egitto
svelata
come
appariva
ai
più
grandi
potenti
dell'Egitto
nei
momenti
più
salienti
della
loro
vita".
Le
tombe
presentano
tutte
più
o
meno
le
stesse
caratteristiche,
cioè
porta
tagliata
nella
parete
rocciosa,
un
corridoio
lungo
un
centinaio
di
metri
in
discesa
con
nicchie
e
ambienti
vari
i
cui
soffitti
sono
sorretti
da
pilastri,
con
la
sala
del
sarcofago
verso
il
fondo.
Le
tombe
della
XVIII
dinastia
sono
generalmente
scavate
nelle
pareti
della
valle
(salvo
rare
eccezioni
come
quella
di
Tutankhamon,
KV62)
sfruttando
spesso
(come
nel
caso
della
tomba
di
Thutmosi
III)
il
"letto"
di
antiche
cascate.
Spesso,
proprio
per
tale
caratteristica,
le
loro
entrate
sono
state
ricoperte
da
detriti
trascinati
in
basso
dalle
piogge.
Le
tombe
della
XIX
dinastia
vennero
invece
scavate
nel
vallone,
insinuandosi
nel
sottosuolo;
per
tale
motivo,
sono
quelle
che
maggiormente
hanno
sofferto
nel
corso
dei
millenni
di
infiltrazioni
d'acqua
piovana.
Le
tombe
della
XX
dinastia
infine
vennero
scavate
a
livello
del
suolo
e
sono
dunque
quelle
che
meno
hanno
sofferto
per
le
infiltrazioni
d'acqua.
|
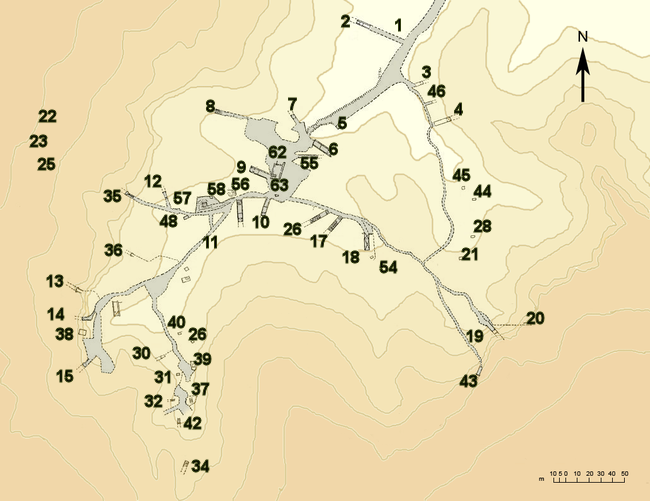 Le
63
sepolture
principali
(l'ultima
importante
scoperta
è
stata
quella
di
Tutankhamon
nel
1922
mentre
l'ultima
scoperta,
cronologicamente,
la
KV63,
è
stata
scoperta
solo
nel
marzo
2006)
sono
numerate
progressivamente
(sigla
“KV”=
King's
Valley,
seguita
da
un
numero),
ma
è
bene
tener
presente
che
la
numerazione
non
ha
nulla
a
che
vedere
con
la
progressione
sul
trono
dei
proprietari;
nel
1827
infatti
l'egittologo
inglese
John
Gardner
Wilkinson
numerò
le
tombe
già
scoperte
da
1
a
22
seguendo
l'ordine
geografico
da
nord
a
sud. Le
63
sepolture
principali
(l'ultima
importante
scoperta
è
stata
quella
di
Tutankhamon
nel
1922
mentre
l'ultima
scoperta,
cronologicamente,
la
KV63,
è
stata
scoperta
solo
nel
marzo
2006)
sono
numerate
progressivamente
(sigla
“KV”=
King's
Valley,
seguita
da
un
numero),
ma
è
bene
tener
presente
che
la
numerazione
non
ha
nulla
a
che
vedere
con
la
progressione
sul
trono
dei
proprietari;
nel
1827
infatti
l'egittologo
inglese
John
Gardner
Wilkinson
numerò
le
tombe
già
scoperte
da
1
a
22
seguendo
l'ordine
geografico
da
nord
a
sud.
Da
tale
data
però,
ovvero
dalla
KV23
in
poi,
il
numero
corrisponde
all'ordine
di
scoperta;
di
qui
il
numero
62
assegnato
alla
sepoltura
del
faraone
fanciullo.
In
alcuni
casi
è
possibile
leggere
la
sigla
"WVxx"
(West
Valley)
per
indicare
che
la
tomba
in
questione
si
trova
nella
Valle
Occidentale,
ma
è
bene
tener
presente
che
la
numerazione
fa
comunque
riferimento
alla
sigla
KV;
esempio,
la
WV23,
di
Ay,
è
la
KV23.
- ·
KV1
Ramses
VII (XX
dinastia);
- ·
KV2
Ramses
IV (XX Dinastia);
- ·
KV3
mai
usata
come
sepoltura
(forse
per
un
figlio
di
Ramses
III);
- ·
KV4
ultima
tomba
scavata
nella
valle
forse
per
Ramses
XI
(XX
Dinastia);
- ·
KV5
figli
di
Ramesse
II
(XIX
dinastia);
- ·
KV6
Ramses
IX (XX dinastia);
- ·
KV7
Ramses
II (XIX dinastia);
- ·
KV8
Merenptah
(XIX
dinastia);
- ·
KV9
Ramses
VI
(XX
dinastia);
- ·
KV10
Amenmose
(?),
poi
della
Regina
Takhat
(XX
dinastia);
- ·
KV11
Ramses
III (XX Dinastia);
- ·
KV12
(?)
- ·
KV13
Cancelliere
Bay
(XIX
dinastia),
poi
principesse
Mentuherkhepeshef
e
Amenherkhepeshef
(XX
dinastia);
- ·
KV14
Sethnakht
e
Tausert
(XIX
dinastia);
- ·
KV15
Seti
II
(XIX
dinastia);
- ·
KV16
Ramses
I
(XIX
dinastia);
- ·
KV17
Seti
I
(XIX
dinastia);
- ·
KV18
incompiuta
(Ramses
X ?);
- ·
KV19
originariamente
Ramses
VIII,
poi
Mentuherkhepershef,
figlio
di
Ramesse
IX;
- ·
KV20
originariamente
Thutmosi
I,
poi
Hatshepsut
(XVIII
dinastia);
- ·
KV21
(?)
conteneva
due
mummie
femminili;
- ·
KV22
iniziata
sotto
Thutmosi
IV
e
finita
sotto
Amenhotep
III
(ancora
in
fase
di
scavo);
- ·
KV23
Ay
(XVIII
dinastia);
- ·
KV24
vuota;
- ·
KV25
forse
Amenhotep
IV/Akhenaton
(XVIII
Dinastia);
- ·
KV26
inutilizzata;
- ·
KV27
inutilizzata;
- ·
KV28
forse
Thutmosi
IV;
- ·
KV29
ancora
piena
di
detriti;
- ·
KV30
vuota;
- ·
KV31
ancora
piena
di
detriti;
- ·
KV32
Tia'a
moglie
di
Amenhotep
II
(?);
- ·
KV33
forse
Thutmosi
III,
poi
del
Visir
Rakhmira
(inutilizzata);
- ·
KV34
Thutmosi
III
(XVIII
dinastia);
- ·
KV35
Amenhotep
II
(XVIII
Dinastia);
|
- ·
KV36
Mahierpi
(fanciullo
dell'harem
reale
di
Thutmose
IV)
(?);
- ·
KV37
vuota;
- ·
KV38
Thutmosi
I
(XVIII
dinastia)
(?);
- ·
KV39
Amenhotep
I
(XVIII
dinastia)
(?);
- ·
KV40
ancora
piena
di
detriti;
- ·
KV41
Regina
Tetisheri
moglie
di
Sequenenra
Ta'o
(XVII
dinastia);
- ·
KV42
destinata
ad
Hatshepsut-Meryet-Ra
(moglie
di
Thutmosi
III),
poi
Sennefer
Sindaco
di
Tebe
(XVIII
dinastia);
- ·
KV43
Thutmosi
IV
(XVIII
dinastia);
- ·
KV44
titolare
sconosciuto,
all'interno
i
resti
di
sette
corpi
differenti;
- ·
KV45
Userhat
(?)
supervisore
dei
campi
di
Amon
(XVIII
dinastia);
- ·
KV46
Yuya
e
Thuya,
genitori
della
Regina
Tye,
moglie
di
Amenhotep
III
(XVIII
dinastia);
- ·
KV47
Siptah
(XIX
dinastia);
- ·
KV48
Amenemipet,
Visir
e
Governatore
durante
il
regno
di
Amenhotep
II
(XVIII
dinastia);
- ·
KV49
vuota;
- ·
KV50
ubicazione
non
nota:
conteneva
le
mummie
di
un
cane
e
di
una
scimmia;
- ·
KV51
conteneva
le
mummie
di
tre
scimmie,
un
babbuino,
un
ibis,
e
tre
oche;
- ·
KV52
ubicazione
non
nota:
conteneva
la
mummia
di
una
scimmia;
- ·
KV53
ubicazione
non
nota;
- ·
KV54
vuota,
conteneva
oggetti
abbandonati
dai
ladri
della
KV62
di
Tutankhamon;
- ·
KV55
Amenhotep
IV/Akhenaton
(?);
Smenkhkhara
(?);
Tye
(?);
Nefertiti
(?)
(XVIII
dinastia);
- ·
KV56
un
figlio
di
Seti
II
(?);
- ·
KV57
Haremhab
(XVIII
dinastia);
- ·
KV58
deposito
di
corredo
funebre
(?);
- ·
KV59
nessuna
informazione;
- ·
KV60
Sit-Ra,
nutrice
di
Hatshepsut
(XVIII
dinastia);
nascondiglio
della
mummia
di
Hatshepsut
- ·
KV61
vuota;
- ·
KV62
Tutankhamon
(XVIII
dinastia);
- ·
KV63
sconosciuti
(in
fase
di
svuotamento
marzo
2006).
|
|
Con
Sethi
I
e
il
suo
splendido
sepolcro
si
può
dire
inizi
quel
programma
decorativo
che
prevede,
all'interno
di
uno
schema
di
massima
rispettato
fino
agli
ultimi
sovrani
ramessidi
(XX
Dinastia),
il
disporsi
di
testi
e
figurazioni
in
connessione
con
la
struttura
architettonica
della
tomba.
Nei
lunghi
corridoi
d'ingresso
incontreremo
dapprima
testi
e
immagini
delle
Litanie
di
Ra
o
Litanie
del
Sole.
E'
questa
una
sorta
d'introduzione
per
il
visitatore,
e
per
lo
stesso
sovrano
defunto,
al
complesso
mondo
ultraterreno,
popolato
di
molti
dei
e
demoni.
In
queste
prime
formule
e
raffigurazioni
si
enumerano
le
75
qualità
e
manifestazioni
del
dio
sole
(l'egizio
Ra),
che
il
re
deve
conoscere
prima
di
potersi
unire
a
lui.
Ancora
nel
corridoio,
e
più
oltre
nella
camera
del
sarcofago,
fa
la
sua
apparizione
il
celebre
Libro
di
ciò
che
è
nella
Duat,
conosciuto
anche
con
il
nome
di
Amduat.
Nel
testo
in
oggetto,
che
si
può
considerare
un
resoconto
del
viaggio
e
degli
incontri
che
il
dio
sole
compie
nel
mondo
sotterraneo
nel
corso
delle
dodici
ore
della
notte,
si
trova
anche
la
chiave
per
poter
comprendere
la
struttura
architettonica
della
sepoltura.
Uno
studioso
tedesco
recentemente
ha
formulato,
alla
luce
di
motivazioni
religiose
che
trovano
conforto
proprio
nel
Libro
dell'Amduat,
una
nuova,
interessante
ipotesi
a
proposito
del
pozzo
ricavato
lungo
il
percorso
della
tomba
reale.
Come
ogni
stanza
e
corridoio
del
sepolcro,
anche
il
pozzo
avrebbe,
secondo
l'autore
dello
studio,
una
precisa
funzione
religiosa:
non
sarebbe
quindi
stato
scavato
come
difesa
contro
i
profanatori
di
sepolture
o
per
evitare
possibili
infiltrazioni
d'acqua,
come
finora
si
è
pensato,
ma
farebbe
anch'esso
parte
dello
schema
religioso
sul
quale
è
basata
la
pianta
della
tomba.
Il
Libro
delle
Porte,
opera
del
tutto
analoga
all'Amduat
per
significato,
descrive
il
pericoloso
viaggio,
irto
di
ostacoli
(ovvero
le
"porte")
che
il
sovrano
deve
saper
affrontare
e
superare.
Con
questo
testo
appaiono
decorate
le
stanze
che
si
trovano
al
di
là
del
vano
in
cui
è
scavato
il
pozzo,
le
cui
pareti
mostrano
invece
scene
che
si
possono
genericamente
definire
di
adorazione
e
d'offerta
alle
divinità.
Nell'ulteriore
tratto
di
corridoio
che
mette
in
comunicazione
questi
primi
ambienti
della
tomba
con
la
cripta
vera
e
propria,
ossia
la
camera
del
sarcofago
in
cui
sono
presenti
altre
riproduzioni
del
Libro
delle
Porte,
si
profilano
illustrazioni
e
formule
riconducibili
al
rituale
dell'"apertura
della
bocca".
Con
questo
nome
ci
sono
noti,
nel
Nuovo
Regno,
riti
e
pratiche
magiche
in
virtù
dei
quali
i
sacerdoti
iniziati
alla
scienza
sacra
avevano
facoltà
di
ridare
vita
al
defunto,
assicurandogli
la
sopravvivenza
eterna.
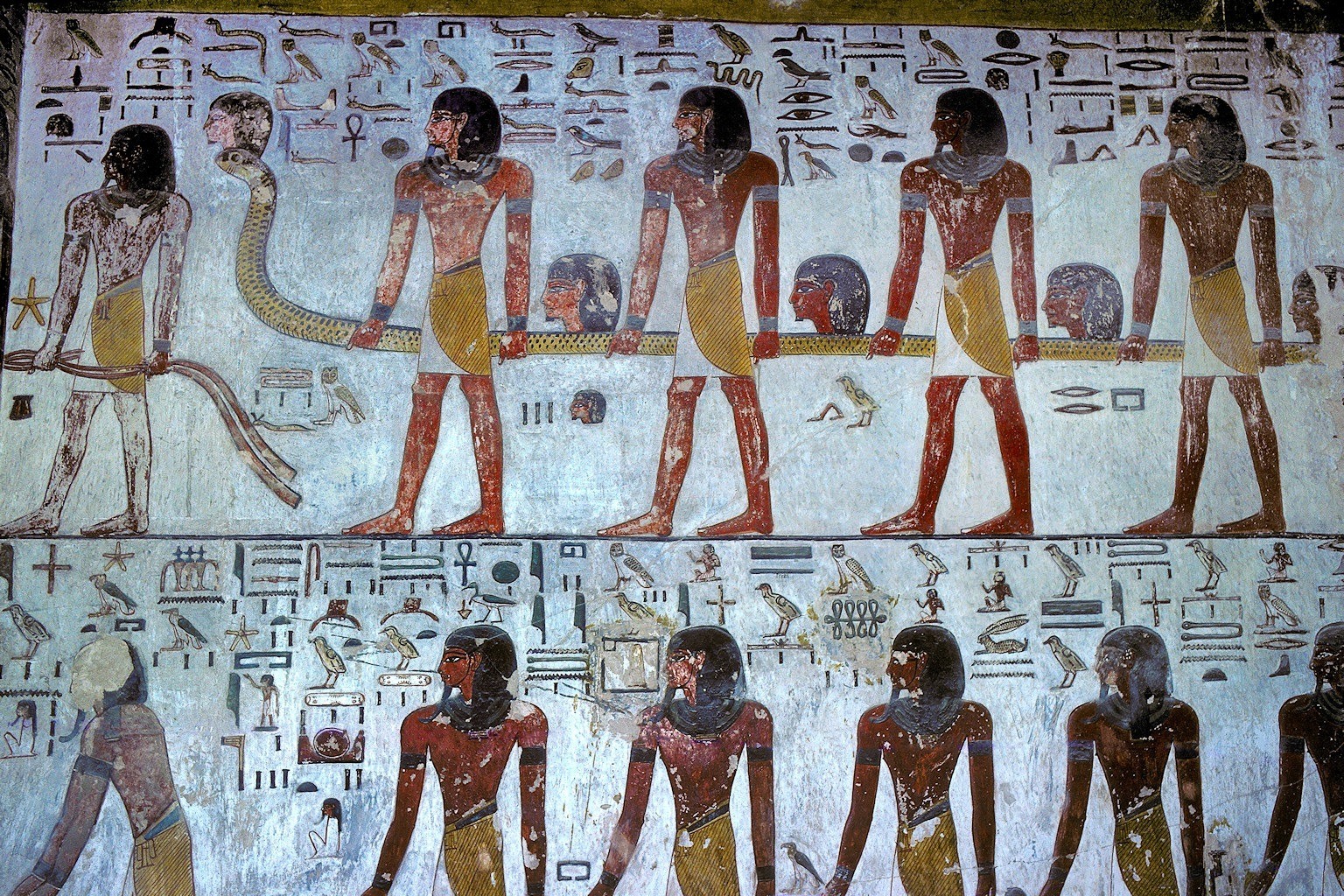
ARCHITETTURA
DELLE
TOMBE
-
È
possibile
rilevare
concrete
differenze
tra
le
tombe
delle
diverse
dinastie
anche
dal
punto
di
vista
strettamente
architettonico.
La
valle
ospita,
come
detto,
fondamentalmente
tombe
delle
dinastie
XVIII,
XIX
e
XX.
Come
fattore
comune
tuttavia
le
tombe
si
sviluppano
secondo
uno
schema
logico
che
prevede
la
sequenza
di
quattro
"passaggi",
indipendentemente
dalla
struttura
planimetrica:
ad
una
"entrata"
segue
un
"santuario
in
cui
riposano
gli
dei
dell'est
e
dell'ovest",
poco
oltre
la
"sala
dell'attesa",
quindi
una
prima
sala
colonnata
detta
anche
"sala
del
carro"
cui
segue
la
"camera
funeraria"
(o
seconda
sala
colonnata),
detta
anche
"sala
dell'oro",
che
ospita
il
sarcofago
(il
nome
di
sala
d'oro
deve
intendersi
nel
senso
che
di
tale
metallo
prezioso
era
la
carne
degli
dei,
cui
il
re
defunto
era
pienamente
assimilato).
Dal
punto
di
vista
planimetrico,
le
tombe
della
XVIII
dinastia
si
sviluppano
secondo
un
asse
"piegato"
o
"a
gomito",
riprendendo
di
fatto
la
struttura
dei
passaggi
esistenti
nelle
precedenti
sepolture
piramidali
del
Medio
Regno,
che
rappresenterebbe
il
percorso
contorto
e
pericoloso
che
il
sole
deve
percorrere,
secondo
i
testi
sacri,
nel
suo
viaggio
notturno
per
poter
risorgere
al
mattino,
così
come
il
faraone
defunto
risorgerà
nel
mondo
oltreterreno.
Non
è
escluso
tuttavia
che
le
prime
tombe
di
questa
dinastia
siano
state
strutturate
in
tal
modo
così
da
adattarsi
all'andamento
delle
rocce
in
cui
erano
scavate,
seguendo
linee
naturali
più
facili
da
lavorare.
L'entrata
è
generalmente
preceduta
da
una
scala,
cui
segue
un
corridoio
in
discesa
che
sfocia
nel
"Santuario
in
cui
gli
Dei
dell'est
e
dell'ovest
riposano".
Si
tratta
sostanzialmente
di
due
nicchie
scavate
nelle
pareti,
verosimilmente
con
una
funzione
pratica:
dato
il
peso
delle
suppellettili
e
specialmente
del
sarcofago,
in
fase
di
sepoltura
qui
si
procedeva
ad
una
prima
sosta
di
riposo.
Altri
locali
che
forse
rivestivano
la
medesima
utilità
pratica
(oltre
che
rituale)
erano
la
"Sala
dell'Attesa"
ove,
peraltro,
si
procedeva
ad
organizzare
la
volta
che
il
sarcofago
avrebbe
dovuto
compiere
per
poter
iniziare
la
discesa
verso
la
camera
funeraria,
e
la
prima
sala
colonnata.
La
tomba
si
sviluppa,
in
ogni
caso,
verso
il
basso,
mediante
il
ricorso
a
scale
intagliate
della
roccia.
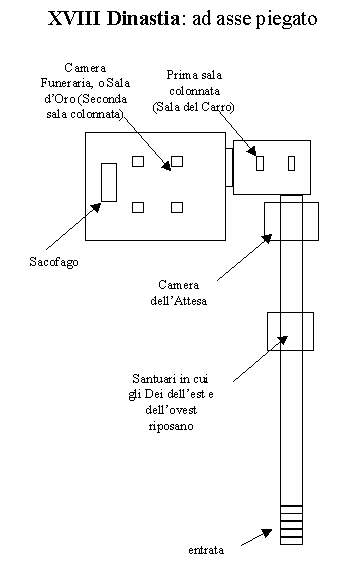
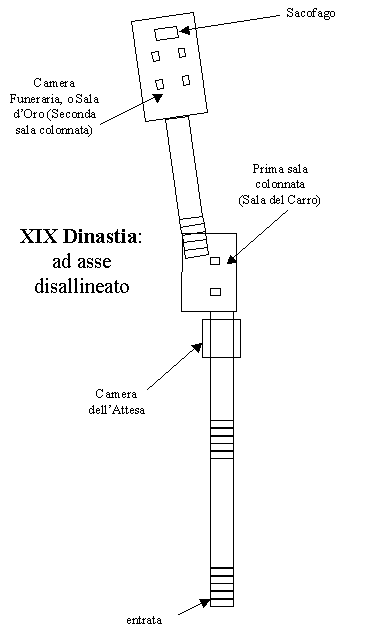
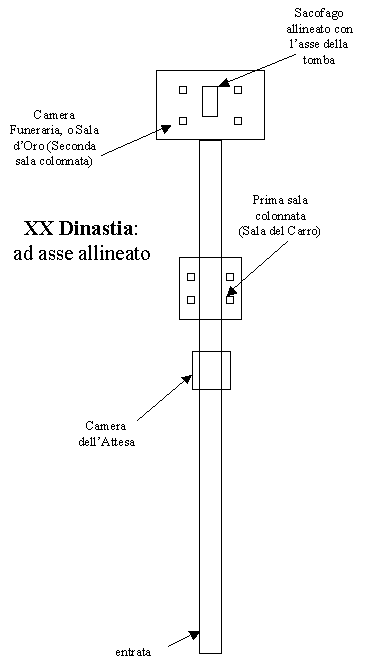
Il
sarcofago
è
posto
con
andamento
ortogonale
rispetto
al
corridoio
di
accesso
alla
camera
funeraria.
È
interessante
rilevare
che,
almeno
per
le
prime
tombe
di
questa
dinastia,
la
camera
funeraria
ha
gli
spigoli
angolari
arrotondati,
costituendo
così
in
pianta
la
figura
del
cartiglio.
Nelle
tombe
della
XIX
dinastia
si
assiste
ad
una
rettifica
del
percorso
contorto
precedente,
ma
ancora
entrata
e
camera
funeraria
sono
disallineate
(vedi
schema)
ed
ancora
il
raggiungimento
della
camera
funeraria
avviene
mediante
scale.
Si
ritiene
che
la
variazione
architettonica
sia
derivata
dalla
struttura
delle
tombe
realizzate
ad
Akhetaton,
oggi
Tell
el-Amarna,
durante
il
breve
periodo
dell'Eresia
Amarniana
di
Akhenaton.
Le
tombe
peraltro
-
al
contrario
di
quanto
avveniva
con
quelle
della
precedente
XVIII
dinastia,
le
cui
entrate
erano
sigillate
con
pietrame
-
presentavano
porte
in
legno
per
garantire,
unitamente
al
servizio
di
sicurezza
che
presidiava
la
valle
da
intrusioni
estranee,
più
agevoli
ispezioni
da
parte
dei
funzionari
preposti.
Normalmente
nella
prima
sala
colonnata
si
apriva
una
camera
laterale
(non
riportata
nello
schema)
che
doveva
servire
verosimilmente
quale
falsa
camera
sepolcrale,
dunque
per
scoraggiare
eventuali
ladri.
Anche
in
queste
sepolture
il
sarcofago
è
posizionato
ortogonalmente
rispetto
al
corridoio
di
entrata.
Con
la
XX
Dinastia
si
giunge
alla
definitiva
semplificazione
della
struttura
architettonica:
la
tomba
si
apre
a
livello
del
suolo
anche
se
il
percorso
è
pur
sempre
in
discesa,
ma
vengono
eliminate
le
scale
ed
allargati
i
corridoi;
Camera
funeraria
ed
entrata
sono
sullo
stesso
asse
e
sul
medesimo
asse
viene
posizionato
anche
il
sarcofago.
A
riprova
della
valenza
pratica
delle
nicchie
esistenti
nel
"Santuario
in
cui
gli
Dei
dell'est
e
dell'ovest
riposano",
nelle
tombe
della
XX
Dinastia
queste
spariscono
per
lasciar
spazio,
inoltre,
ad
un
pozzo
il
cui
scopo
è
raccogliere
l'acqua
piovana
ed
evitare
l'allagamento
della
tomba.
È
evidente
l'intento
pratico
esistente
nella
realizzazione
di
queste
strutture,
così
come
il
risparmio
di
risorse
vuoi
per
la
realizzazione
materiale
del
sito,
vuoi
per
le
operazioni
di
sepoltura
in
senso
stretto.
Tra gli ipogei della Valle dei re, gli inglesi lord
Carnarvon
e
Howard
Carter
scoprirono
nel
1922
un
piccolo
sepolcro
che
presto
divenne
il
più
celebre
dell'Egitto,
quello
del
giovane
faraone
Tutankhamon,
morto
a
soli
19
anni,
il
cui
corredo
strabiliante
comprendeva
il
gruppo
di
oggetti
che
oggi
costituisce
uno
dei
più
preziosi
tesori
del
Museo
del
Cairo.
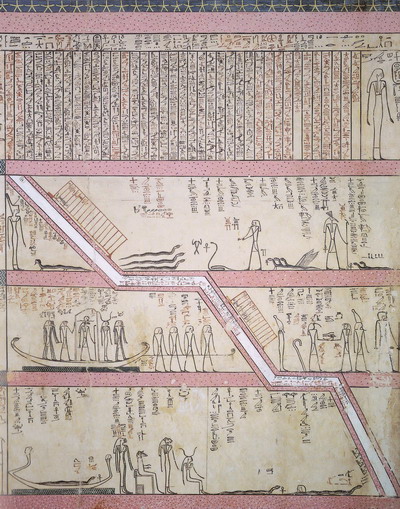 Tomba
di
Thutmosi
III
(kv
34) Tomba
di
Thutmosi
III
(kv
34)
Quando
Hatshepsut
muore,
Thutmosi
III
doveva
avere
più
o
meno
trentasette
anni
ed
era
vissuto
nell'ombra
per
i
venticinque
anni
in
cui
la
poco
amata
zia
e
matrigna
aveva
regnato
come
faraone
unico
e
assoluto.
Il
forzato
esilio
a
cui
era
stato
obbligato
per
così
lungo
tempo
lo
aveva
talmente
umiliato
che,
dopo
avere
allontanato
i
funzionari
più
importanti
del
regno
dai
loro
posti
chiave,
si
era
lasciato
andare
ad
una
sua
personale
e
tardiva
vendetta,
facendo
cancellare
da
quasi
tutti
i
monumenti
d'Egitto
il
nome,
i
cartigli
e
l'immagine
di
Hatshepsut.
Questa
meschinità
del
sovrano,
tuttavia,
non
ha
offuscato
l'importanza
e
la
grandezza
di
Thutmosi
III,
che
al
contrario
è
forse
il
più
grande
faraone
che
l'Egitto
abbia
avuto.
Fu
l'archeologo
americano
James
Henry
Breasted
a
dargli
il
nome
di
"Napoleone
dell'antichità".
Hatshepsut
gli
aveva
lasciato
in
eredità
un
regno
stabile
e
pacifico,
ma
il
suo
prolungato
non
intervento
aveva
fatto
sì
che
ai
confini
orientali
del
paese
nascessero
tutta
una
serie
di
piccoli
principati
e
regni
in
ascesa
vogliosi
di
coalizzarsi
contro
il
prospero
e
vicino
Egitto.
Fra
tutti,
il
regno
dei
Mitanni,
nel
nord
della
Mesopotamia,
era
quello
che
destava
più
inquietudine.
Le
diciassette
campagne
militari
che
Thutmosi
III
condusse
in
Siria
furono
caratterizzate
da
un
grande
senso
strategico
e
da
una
profonda
conoscenza
della
tattica
militare.
La
lista
delle
sue
conquiste,
che
fu
iscritta
sulle
pareti
del
Tempio
di
Amon
a
Karnak,
elenca
ben
350
città
che
furono
conquistate
dal
suo
esercito.
Verso
la
fine
del
suo
trentatreesimo
anno
di
regno
ebbe
luogo
l'ottava
campagna
che
doveva
portare
l'attacco
decisivo
nei
cuore
del
regno
dei
Mitanni.
Thutmosi
III
dapprima
concentrò
le
truppe
a
Gaza,
quindi
si
spostò
a
Byblos
dove
fece
costruire
numerose
navi
in
legno
di
cedro
che
furono
caricate
su
pesanti
carri
a
quattro
ruote
trainati
da
buoi.
Così,
dopo
avere
percorso
circa
250
chilometri
via
terra,
l'esercito
del
faraone
poté
attraversare
il
fiume
Eufrate.
Il
combattimento
decisivo
si
svolse
ad
ovest
di
Aleppo,
presso
la
città
di
Karkhemish.
Quando
Thutmosi
III
morì,
verso
la
metà
del
mese
di
marzo,
aveva
circa
settantanni
e
lasciava
un
paese
solido
e
ricco,
un'amministrazione
statale
efficiente
e
un
impero
vastissimo,
i
cui
confini
andavano
dal
fiume
Eufrate
alla
quarta
cateratta
del
Nilo
in
Sudan.

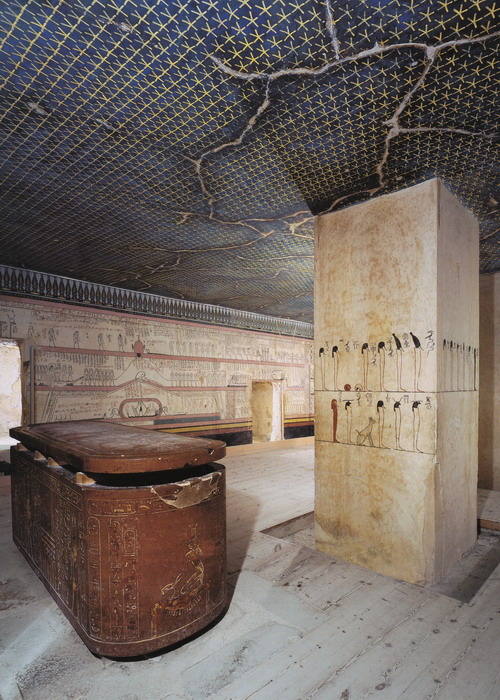
La
sepoltura
di
Thutmosi
III,
sovrano
fra
i
più
illustri
e
potenti
nella
storia
dell'antico
Egitto,
è
situata
al
fondo
della
Valle
dei
Re,
all'interno
di
una
gola
angusta,
a
una
trentina
di
metri
di
profondità.
La
tomba,
una
delle
prime
scavate
nel
sito,
presenta
una
via
d'accesso
"a
gomito",
come
usava
durante
la
XVIII
Dinastia:
un
ripido
corridoio
in
discesa
conduce,
attraverso
due
piccoli
ambienti
e
un
profondo
pozzo,
a
una
prima
sala
sorretta
da
pilastri
dipinti
con
immagini
di
divinità.
Una
scala
permette
infine
l'accesso
alla
camera
sepolcrale
vera
e
propria,
la
cui
conformazione
a
grande
cartiglio
ripete
il
modello
predisposto
per
il
primo
ipogeo
realizzato
nella
Valle
dei
Re,
quello
di
Thutmosi
I,
nel
cui
caso,
però,
costituiva
l'unico
ambiente
ed
era
privo
di
decorazioni.
La
tomba
di
Thutmosi
III
è
molto
particolare,
unica
nella
Valle
dei
Re.
Il
tipo
di
scrittura
è
il
geroglifico
corsivo,
i
colori
usati
sono
tenui
e
rosati,
la
tecnica
di
decorazione
è
la
pittura,
dimenticando
del
tutto
il
bassorilievo.
Così
che,
come
scrisse
Victor
Loret,
sembra
che
le
rotonde
pareti
della
stanza
abbiano
l'aspetto
di
un
papiro
di
enormi
dimensioni.
Mentre
tutta
la
decorazione
della
tomba
illustra
il
Libro
dell'Amduat,
c'è
solo
una
piccola
scena
tracciata
su
un
pilastro
della
camera
funeraria
che
è
un
riferimento
biografico
del
faraone:
in
essa
appare
Thutmosi
seguito
da
alcune
delle
sue
mogli
e
un
po'
più
avanti
ancora
il
sovrano
che
prende
il
latte
dalla
madre
Iside
il
cui
seno
pende
da
un
ramo
dell'albero
di
sicomoro
in
cui
la
dea
si
identifica.
Uno
scriba
del
Nuovo
Regno,
di
nome
Amenhotep,
vide
questa
rappresentazione
e
ne
fu
talmente
colpito
che
lasciò
il
suo
nome
inciso
sulla
parete
con
la
frase
"Mille
volte
bello
è
il
dipinto
qui
sotto".
All'interno
della
camera
sepolcrale
si
trova
tuttora
il
sarcofago
del
re,
che
venne
trovato
vuoto
e
con
il
coperchio
spezzato
a
terra.
La
mummia
di
Thutmosi
III,
invece,
era
stata
rinvenuta
nel
nascondiglio
delle
mummie
reali
a
Deir
el-Bahari
quasi
vent'anni
prima
dell'apertura
della
tomba,
avvenuta
per
opera
di
Victor
Loret
nel
1898.
Tomba
di
Amenhotep
II
(kv
35)

Di
origine
menfita,
Amenhotep
II
era
figlio
di
Thutmosi
III,
il
"Napoleone
dell'antichità":
era
difficile
eguagliare
la
gloria
e
la
potenza
di
un
così
grande
padre.
Amenhotep
II
è
famoso
non
per
grandi
imprese
militari
ma
per
le
sue
doti
sportive.
La
"Qrande
Stele
della
Sfinge
di
Amenhotep
III"
ce
lo
ha
tramandato
infatti
come
un
sovrano
di
una
vigoria
trionfante,
imbattibile
nel
tiro
con
l'arco,
abile
domatore
di
cavalli,
velocissimo
nella
corsa,
potente
ai
remi,
capace
di
manovrare
un
remo
di
quasi
nove
metri
ad
una
velocità
molto
superiore
a
quella
di
un
normale
equipaggio.
Ebbe
anche
modo
di
dare
prova
di
buone
capacità
militari,
quando
fu
costretto
a
soffocare
le
rivolte
di
alcune
città
asiatiche.
Severo
fino
ai
limiti
della
crudeltà,
come
leggiamo
in
una
iscrizione
di
una
stele
a
Karnak,
Amenhotep
II
da
solo
avrebbe
fracassato
con
la
mazza
la
testa
a
sette
principi
durante
la
rivolta
del
Retenu:
i
corpi
di
sei
furono
poi
appesi
alle
mura
del
Tempio
di
Amon
a
Karnak
e
il
settimo
fu
portato
fino
a
Napata
per
spengere
ogni
velleità
di
ribellione
della
Nubia.
Da
un'altra
stele
proveniente
da
Menfi
sappiamo
che
il
faraone
tornò
da
una
spedizione
sulla
costa
fenicia
con
i
corpi
di
dieci
nemici
uccisi
appesi
al
suo
carro
e
con
venti
mani
mozzate
legate
alla
fronte
dei
cavalli.
Durante
il
suo
regno,
che
durò
venticingue
anni,
lo
sviluppo
artistico
conobbe
momenti
di
grande
splendore,
come
ci
testimoniano
le
tombe
dei
grandi
dignitari
di
corte,
il
visir
Rekhmira,
Viceré
e
governatore
di
Tebe,
e
Sennefer,
Amministratore
dei
granai
e
del
bestiame
di
Amon.
Amenhotep
II
morì
a
circa
50
anni:
nel
grande
sarcofago
di
quarzite
fu
trovata
la
sua
mummia,
intatta,
il
collo
circondato
da
una
ghirlanda
di
fiori
e
un
mazzo
di
mimose
sul
petto.
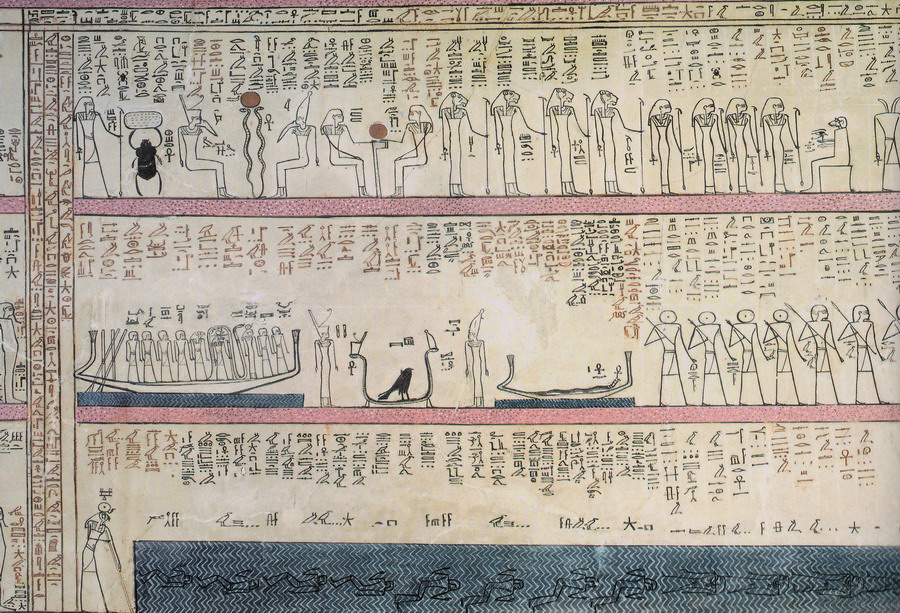
La
tomba
di
Amenhotep
II,
figlio
e
successore
di
Thutmosi
III,
venne
scoperta
da
Victor
Loret
nel
1898.
Per
struttura
e
decorazioni
ricorda
molto
da
vicino
la
sepoltura
del
padre,
con
analoga
successione
di
due
corridoi
e
di
un
pozzo
fino
a
una
prima
sala
a
pilastri,
da
cui
si
accede
a
una
più
vasta
camera
sepolcrale.
Le
pareti
sono
tinteggiate
a
imitazione
del
papiro
e
decorate
con
testi
e
illustrazioni
del
Libro
dell'Amduat,
mentre
sui
pilastri
compare
il
faraone
accompagnato
da
diverse
divinità.
Per
la
camera
sepolcrale
di
Amenhotep
II,
che
ha
un
soffitto
stellato
a
sfondo
blu,
viene
abbandonata
la
forma
ovale
a
cartiglio
che
ritroviamo
nelle
tombe
dei
primi
thutmosidi.
Al
fondo
di
quest'ultimo
ambiente
fu
rinvenuto
il
sarcofago
del
re,
in
arenaria
dipinta
di
rosso,
che
conteneva
ancora
intatta
la
mummia
di
Amenhotep
II,
adorna
di
una
collana
di
mimose.
Si
ignorano
le
ragioni
per
cui
i
profanatori
del
sepolcro
risparmiarono
le
spoglie
terrene
del
sovrano,
normalmente
arricchite
da
gioielli
e
amuleti
preziosi
avvolti
tra
le
bende.
Inoltre,
nella
tomba
di
Amenhotep
II,
e
più
precisamente
in
un
annesso
laterale,
vennero
rinvenuti
altri
nove
sarcofagi
reali
con
le
mummie
di
Thutmosi
IV,
Amenhotep
III,
Merenptah,
Sethi
II,
Siptah,
Sethnakht,
Ramesse
IV,
Ramesse
V
e
Ramesse
VI.
Fu
probabilmente
all'epoca
di
Pinedjem
I
(1070-1030
circa),
all'inizio
della
XXI
Dinastia,
che
si
provvide
al
loro
trasporto
in
questo
luogo,
come
sarebbe
avvenuto
poco
più
tardi
per
quasi
tutte
le
mummie
dei
faraoni
del
Nuovo
Regno,
allorché
si
decise
di
raccoglierle,
per
proteggerle
da
ulteriori
violazioni,
nel
nascondiglio
di
Deir
el-Bahari.
Oggi
quasi
tutte
le
salme
dei
sovrani
ritrovate
a
Tebe
Ovest
sono
conservate
nel
Museo
del
Cairo,
che
tuttavia
ne
espone
solo
una
piccola
parte
in
una
saletta
riservata
e
discreta.
- Tomba
di
Tutankhamon
(kv
62)
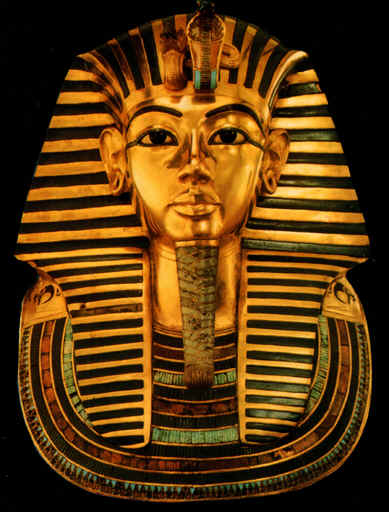 La
tomba
che
Howard
Carter,
nel
novembre
del
1922,
scoprì
poco
sotto
l'ingresso
di
quella
di
Ramesse
VI
rivelò
al
mondo
il
nome
di
un
sovrano,
Tutankhamon,
morto
giovanissimo
e
in
circostanze
oscure,
ma
soprattutto
fece
conoscere
un
corredo
funerario
senza
eguali
nella
storia
dell'egittologia.
All'interno
di
una
sepoltura
modesta
per
proporzioni
e
per
qualità
artistica
-
con
la
sola
camera
sepolcrale
decorata
da
pitture
parietali,
che
riproducono
tra
l'altro
il
trasporto
del
catafalco
del
re
da
parte
di
grandi
dignitari
di
corte
-
si
ritrovò
una
quantità
di
oggetti
preziosi,
arredi,
statue
e
altri
reperti
che,
trasportati
al
Museo
del
Cairo,
occupano
oggi
una
vasta
sezione
del
primo
piano.
È
questa
l'unica
sepoltura
reale
ritrovata
intatta
nella
Valle
dei
Re,
giacché
alcuni
tentativi
di
furto
avvenuti
durante
la
XXI
Dinastia
e
accertati
in
età
moderna
dagli
studiosi
non
sortirono
quasi
nessun
danno,
tanto
che
la
tomba
fu
nuovamente
sigillata
e
mai
più
profanata. La
tomba
che
Howard
Carter,
nel
novembre
del
1922,
scoprì
poco
sotto
l'ingresso
di
quella
di
Ramesse
VI
rivelò
al
mondo
il
nome
di
un
sovrano,
Tutankhamon,
morto
giovanissimo
e
in
circostanze
oscure,
ma
soprattutto
fece
conoscere
un
corredo
funerario
senza
eguali
nella
storia
dell'egittologia.
All'interno
di
una
sepoltura
modesta
per
proporzioni
e
per
qualità
artistica
-
con
la
sola
camera
sepolcrale
decorata
da
pitture
parietali,
che
riproducono
tra
l'altro
il
trasporto
del
catafalco
del
re
da
parte
di
grandi
dignitari
di
corte
-
si
ritrovò
una
quantità
di
oggetti
preziosi,
arredi,
statue
e
altri
reperti
che,
trasportati
al
Museo
del
Cairo,
occupano
oggi
una
vasta
sezione
del
primo
piano.
È
questa
l'unica
sepoltura
reale
ritrovata
intatta
nella
Valle
dei
Re,
giacché
alcuni
tentativi
di
furto
avvenuti
durante
la
XXI
Dinastia
e
accertati
in
età
moderna
dagli
studiosi
non
sortirono
quasi
nessun
danno,
tanto
che
la
tomba
fu
nuovamente
sigillata
e
mai
più
profanata.
Sul
ritrovamento
-
e
sulle
successive
vicende
che
riguardano
il
finanziatore
degli
scavi,
l'inglese
Lord
Carnarvon,
e
alcuni
altri
membri
della
missione
archeologica
-
fiorirono
leggende
circa
una
"maledizione"
legata
a
questo
faraone
e
al
suo
sepolcro
violato.
In
realtà,
i
misteri
sono
altri
e
ben
più
interessanti
da
risolvere!
Primi
fra
tutti
sono
i
quesiti
circa
l'origine
e
il
ruolo
esatto
di
Tutankhamon,
forse
figlio
dello
stesso
riformatore
religioso
Akhenaton
(ricordiamo
che
il
proprietario
della
tomba
al
momento
della
nascita
aveva
assunto
il
nome
di
Tutankhaton,
"immagine
vivente
di
Aton",
cioè
del
dio
unico,
il
disco
solare
Aton,
impostogli
dal
"faraone
eretico").
La
sepoltura
di
Tutankhamon
è
fonte
inesauribile
di
studi
e
di
pubblicazioni,
anche
perché
i
reperti
recuperati
da
quelle
anguste
camerette
sono
diverse
migliaia
e
occorsero
parecchi
anni
solo
per
svuotare
il
sepolcro
di
tutti
i
suoi
tesori.
La
tomba
di
Tutankhamon
ha
uno
schema
architettonico
molto
semplice:
un
corridoio
di
nove
metri
che
conduce
all'Anticamera
su
cui
si
affacciano
a
destra
la
Camera
Funeraria
e
la
Camera
del
Tesoro.
Dall'Anticamera
si
accede
all'Annesso,
destinato
ad
accogliere
le
offerte
e
l'arredo
funebre:
quest'ultimo
è
considerato
uno
dei
più
grandi
tesori
dell'antichità
che
ci
sia
pervenuto
intatto
e
oggi
è
conservato
al
Museo
Egizio
del
Cairo.
La
camera
sepolcrale
conteneva
il
sarcofago,
un
unico,
enorme
blocco
di
quarzite
racchiuso
in
quattro
cappelle
di
legno
dorate
che
entravano
l'una
dentro
l'altra,
come
delle
scatole
cinesi.
Al
suo
interno
si
trovava
un
primo
sarcofago
di
legno
ricoperto
da
una
lamina
d'oro
e
intarsiato
con
vetro
e
pietre
semi
preziose,
con
il
faraone
rappresentato
come
Osiride:
al
suo
interno,
sotto
bende
di
lino
e
ghirlande
di
fiori
c'era
un
secondo
sarcofago
antropoidale,
anche
questo
in
legno
coperto
da
una
lamina
d'oro
con
incrostazioni
di
vetro
colorato
e
pietre
semi
preziose.
Quando
fu
sollevato
anche
il
coperchio
di
questa
seconda
bara
nessuno
si
aspettava
di
trovare
un
terzo
sarcofago
costituito
da
un
blocco
di
oro
massiccio
pesante
110,4
kg:
il
solo
valore
materiale
era
inestimabile!
Il
re
portava,
oltre
al
copricapo
con
il
cobra
e
l'avvoltoio,
anche
una
barba
posticcia
e
una
pesante
collana
a
grani
d'oro
e
maiolica,
mentre
nelle
mani
teneva
il
flagello
e
lo
scettro.
Dentro
quest'ultima
bara
si
trovava,
intatta,
la
mummia
di
Tutankhamon,
completamente
ricoperta
di
gioielli
e
d'oro.
Una
splendente
maschera
d'oro
ricopriva
il
sovrano
fino
alle
spalle:
di
grande
eleganza,
il
pesante
nemes
a
strisce
blu
e
oro,
con
i
simboli
reali
sulla
fronte,
intarsiati
di
lapislazzulì,
turchesi
e
corniole.
Nel
sarcofago
in
quarzite,
ancora
in
situ,
è
tuttora
conservata
la
salma
mummificata
del
giovane
re,
che
purtroppo
ha
subito
vari
danneggiamenti
in
seguito
a
non
troppo
accorte
autopsie
eseguite
dagli
specialisti.
Altri
due
sarcofagi
antropomorfi
-
uno
in
legno
laminato
d'oro,
l'altro
in
oro
massiccio
-
insieme
alla
maschera,
aurea
anch'essa,
appoggiata
direttamente
sulla
mummia,
sono
invece
esposti
in
una
sala
apposita
del
Museo
del
Cairo,
a
eternare
ai
visitatori
il
ricordo
della
grandezza
di
un
passato
irripetibile.
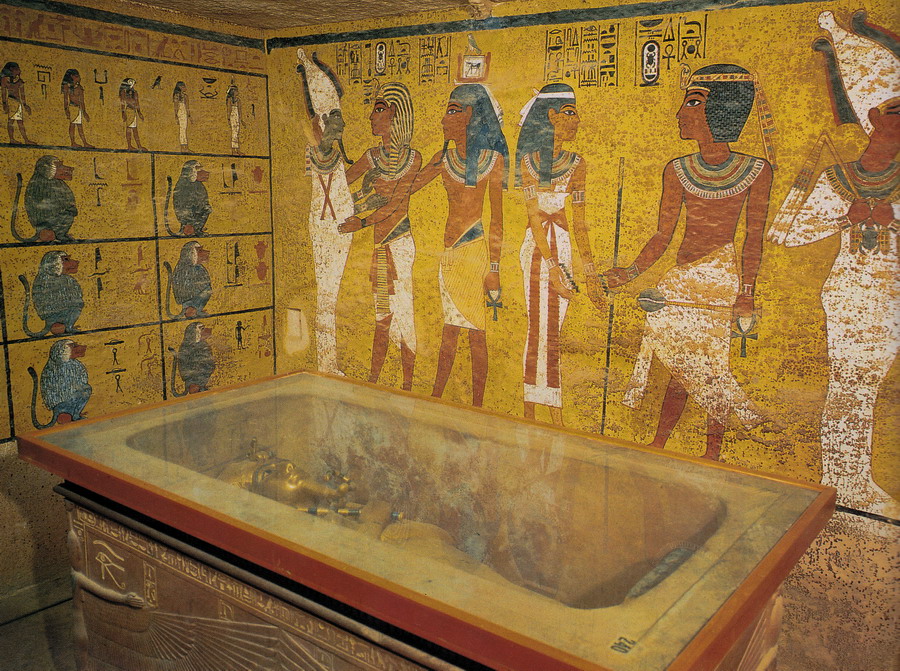
Tomba
di
Horemheb
(kv
57)
Horemheb,
alto
funzionario
e
generale
ad
Amarna
ai
tempi
di
Akhenaton,
conservò
gli
stessi
titoli
prestigiosi
anche
sotto
i
regni
dei
successori
Tutankhamon
e
Ay,
prima
di
ascendere
al
trono
e
governare
l'Egitto
per
un
trentennio.
Non
essendo
di
discendenza
reale,
come
il
suo
predecessore
Ay,
Horemheb,
anziano
uomo
di
fiducia
di
Tutankhamon,
ripudiò
la
prima
moglie
e
sposò
Mutnodjmet,
sorella
di
Nefertiti. 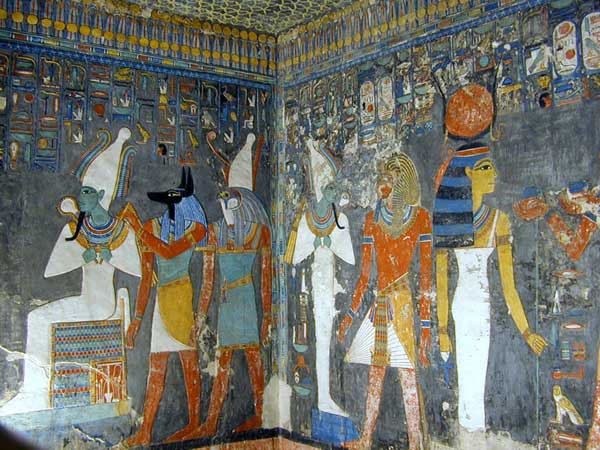
Come
documenta
il
bel
gruppo
statuario
conservato
nel
Museo
Egizio
di
Torino,
che
ritrae
i
due
personaggi
abbracciati
come
marito
e
moglie
secondo
la
consuetudine
dei
privati,
la
legittimità
al
trono
gli
era
assicurata
dalla
sposa;
gli
artisti
che
scolpirono
questo
monumento
evidentemente
risentivano
ancora
dei
dettami
"realistici"
imposti
dalla
cultura
dell'età
di
Akhenaton.
Prima
di
diventare
faraone,
Horemheb
si
era
già
fatto
approntare
una
tomba
a
Saqqara.
Solo
di
recente
questo
sepolcro
è
stato
"riscoperto"
e
ne
è
stata
identificata
l'esatta
ubicazione;
la
spoliazione
che,
nel
secolo
scorso,
aveva
fatto
seguito
al
primo
 ritrovamento
della
vasta
sepoltura
a
più
ambienti
decorati
aveva
infatti
causato
la
dispersione
di
molti
splendidi
bassorilievi,
avviati
verso
le
collezioni
di
Bologna,
Leida
e
Vienna,
finendo
per
cancellarne
la
memoria
sul
terreno.
ritrovamento
della
vasta
sepoltura
a
più
ambienti
decorati
aveva
infatti
causato
la
dispersione
di
molti
splendidi
bassorilievi,
avviati
verso
le
collezioni
di
Bologna,
Leida
e
Vienna,
finendo
per
cancellarne
la
memoria
sul
terreno.
Fu
l'archeologo
inglese
Edward
Ayrton
che
trovò
il
nome
del
generale,
scritto
in
ieratico,
su
una
tavoletta
relativa
alle
ispezioni
alle
tombe
reali
della
Valle.
Una
volta
scoperta,
la
tomba
di
Horemheb
apparve
come
il
trait-d'union
fra
le
tombe
precedenti
e
più
semplici
della
XVIII
dinastia
e
quelle
più
importanti
che
sarebbero
venute
in
seguito.
Il
corridoio,
infatti,
non
curva
più
con
decisione
ad
angolo
retto,
ma
dopo
un
lieve
scarto
iniziale
procede
praticamente
in
linea
retta
fino
alla
camera
del
sarcofago.
Al
momento
della
scoperta,
i
bassorilievi
dipinti
che
illustravano
le
consuete
scene
del
repertorio
funebre,
balzarono
agli
occhi
degli
archeologi
in
tutta
la
loro
brillante
policromia,
perfetti,
freschi
e
luminosi
come
se
fossero
stati
appena
terminati.
Le
decorazioni
parietali,
parzialmente
incompiute,
rivelano,
oltre
alla
brillante
policromia
delle
scene,
i
diversi
stadi
di
lavorazione
artistica
(dal
disegno
preparatorio
all'opera
dello
scultore).
Il
repertorio
iconografico
e
testuale
si
arricchisce
di
un
nuovo
capitolo
di
letteratura
funeraria
reale,
con
l'apparizione
del
Libro
delle
Porte,
che
descrive
i
diversi
ostacoli
o
"porte"
che
scandiscono
le
dodici
ore
della
notte,
a
completamento
del
Libro
dell'Amduat.
Tomba
di
Ramesse
I
(kv
16)
Il
fondatore
della
XIX
dinastia
era
un
militare
di
carriera,
generale
e
visir
di
Horemheb.
Il
suo
fu
un
regno
molto
breve,
appena
due
anni,
ma
in
questo
periodo
-
come
ci
attestano
i
bassorilievi
nella
sala
ipostila
di
Karnak
-
si
spinse
in
territorio
ittita
fino
al
paese
di
Kadesh.
Associò
subito
al
trono
il
figlio
Sethi
I
ed
elesse
Tanis
capitale
dell'impero.
La
sua
tomba,
scoperta
da
Belzoni,
ha
la
struttura
ridotta
all'essenziale
perché
evidentemente
l'anziano
faraone
morì
all'improvviso
mentre
ancora
gli
operai
vi
stavano
lavorando.

- Tomba
di
Sethi
I
(kv
17)
Questa
di
Sethi
I
è
fra
le
più
imponenti
tombe
della
Valle
dei
Re.
Anche
il
faraone
che
vi
fu
sepolto
fu
uno
dei
più
importanti
della
sua
dinastia,
la
XIX.
Figlio
di
Ramesse
I,
fu
capo
degli
arcieri
e
visir
quando
il
padre
era
ancora
in
vita.
Sethi
I
riprende
la
politica
di
espansione
in
Oriente,
spingendosi
in
Siria
fino
all'altezza
di
Tiro,
respinge
l'avanzata
di
Muwatalli,
capo
degli
Ittiti
e
riconquista
la
Fenicia.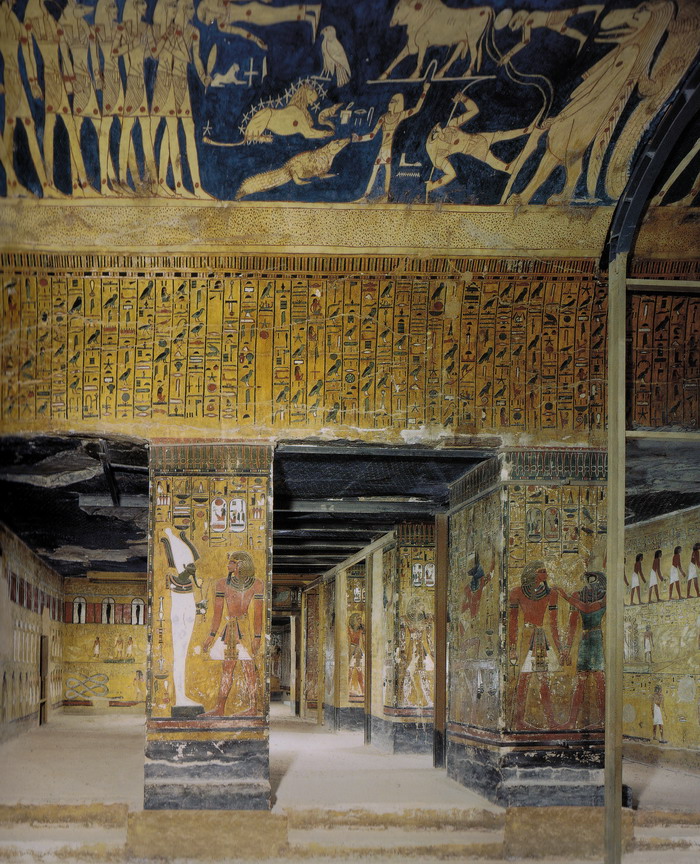
La
tomba
fu
scoperta
il
18
ottobre
1817
da
Belzoni:
ciò
spiega
perché
per
lungo
tempo
è
stata
chiamata
"tomba
di
Belzoni".
E'
lunga
105
metri:
una
rapida
scala
di
27
gradoni
scende
subito
ad
un
livello
molto
basso.
Qui
un
corridoio
porta
a
una
seconda
scala
che
conduce
ad
un
secondo
corridoio,
fino
ad
arrivare
ad
una
sala
dove
Belzoni
trovò
un
pozzo,
scavato
evidentemente
per
fuorviare
le
ricerche.
Belzoni
notò,
sull'altra
parete,
una
fessura
di
65
centimetri.
Una
volta
superato
avventurosamente
il
pozzo,
l'archeologo
allargò
l'apertura
e
scoprì
che
dava
accesso
alle
stanze
che
gli
antichi
costruttori
avevano
voluto
tenere
nascoste.
Tuttavia,
nessuna
di
queste
conteneva
il
sarcofago:
Belzoni
non
era
arrivato,
infatti,
che
a
metà
percorso.
Nuovi
corridoi,
nuove
scale
e
altre
camere,
infine,
portarono
alla
sala
del
sarcofago,
che
però
era
privo
della
mummia.
Questa
sarà
trovata,
settanta
anni
più
tardi,
a
Deir
el-Bahari,
mentre
il
bellissimo
sarcofago
fu
portato
a
Londra,
vanto
della
lussuosa
abitazione
che
fu
proprietà
dell'architetto
e
collezionista
d'arte
Sir
John
Soane,
poi
adibita
a
museo.
Ciò
che
e
curioso
e
inconsueto
è
il
fatto
che
questa
tomba
doveva
ancora
spingersi
più
profondamente
nel
cuore
della
terra.
Infatti,
da
sotto
il
sarcofago,
partiva
una
misteriosa
galleria
che
Belzoni
iniziò
a
scavare
per
circa
novanta
metri,
dovendosi
però
fermare
per
la
mancanza
d'aria
e
per
l'estrema
friabilità
della
roccia.
Altri
trenta
metri
furono
scavati
negli
anni
Cinquanta
di
questo
secolo.
Questa
galleria,
cosi,
è
rimasta
un
mistero:
a
cosa
servisse
e
dove
conducesse
non
si
sa,
ma
dice
una
antica
leggenda
della
Valle
che
il
tunnel
attraversa
tutta
la
montagna
per
sbucare
poi
all'aperto
vicino
al
tempio
di
Hatshepsut
a
Deir
El-Bahari.
Belzoni
riteneva
che
questa
fosse
la
più
bella
tomba
mai
scoperta
in
Egitto:
la
sua
decorazione,
infatti,
ricopre
pareti,
colonne
e
soffitti,
con
dipinti
e
bassorilievi
densi
di
significato
e
di
simbolismo.
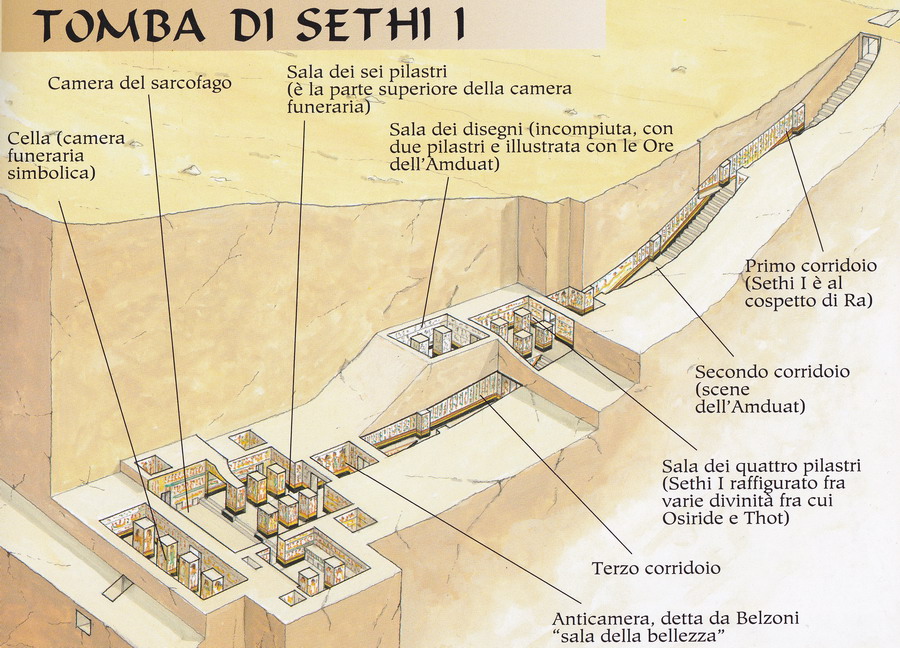
Tomba
di
Ramesse
III
(kv
11)
La
tomba
di
Ramesse
III
era
nota
già
ai
viaggiatori
greci
come
Strabone
e
fu
esplorata
per
la
prima
volta
in
età
moderna
dallo
scozzese
James
Bruce
nel
1768.
Incuneandosi
nella
roccia
per
ben
125
metri,
figura
tra
i
più
maestosi
esempi
di
sepoltura
reale,
con
ambienti
ricchi
di
decorazioni
anche
inconsuete
e
di
testi
funerari,
dalle
Litanie
di
Ra
al
Libro
dell'Amduat
e
al
Libro
delle
Porte.
Il
percorso
segue
la
consuetudine
delle
tombe
ramessidi
della
XX
Dinastia,
ma
evidenzia
una
leggera
deviazione
dell'asse
principale
(con
sviluppo
a
innesto
parallelo
dei
restanti
corridoi
e
ambienti
fino
alla
camera
del
sarcofago),
dovuta
alla
necessità
di
evitare
il
congiungimento
con
la
vicina
tomba
del
re
Amenemes. 
Ramesse
III
è
il
secondo
sovrano
della
XX
dinastia
ed
è
anche
l'ultimo
grande
faraone
del
Nuovo
Regno:
dopo
di
lui
si
aprirà
un
confuso
periodo
di
lotte
intestine
e
di
disordini,
e
l'Egitto
precipiterà
sempre
più
nel
caos.
Ramesse
III
operò
una
importante
riforma
amministrativa
e
sociale.
Nell'ottavo
anno
di
regno,
in
una
grossa
battaglia
sul
Delta,
inflisse
una
pesante
sconfitta
alla
coalizione
fra
i
"popoli
del
mare"
e
le
tribù
libiche:
la
battaglia
è
ricordata
in
un
rilievo
sul
tempio
di
Medinet
Habu,
dove
si
vedono
alcuni
prigionieri
Peleseth.
Costoro
si
insedieranno
in
seguito
in
Palestina
e
si
chiameranno
Filistei.
Da
un
papiro
conservato
al
Museo
Egizio
di
Torino
e
conosciuto
come
Papiro
giudiziario
sappiamo
che
nel
29°
anno
di
regno
Ramesse
III
rimase
vittima
di
una
congiura
di
palazzo:
i
colpevoli
furono
poi
catturati
e
processarti,
come
ci
documentano,
appunto,
gli
atti
nel
papiro.
Il
sarcofago
del
faraone,
uno
splendido
blocco
di
granito
rosa,
fu
portato
via
dall'archeologo
padovano
Giovanni
Battista
Belzoni
e
in
seguito
fu
venduto
al
e
di
Francia
che
lo
espose
al
Louvre.
La
fama
del
sepolcro
è
anche
dovuta
alla
presenza
di
raffigurazioni
piuttosto
eccezionali,
quali
la
preparazione
degli
alimenti,
la
presentazione
di
offerte,
armi
e
gioielli
e
il
ritratto
di
due
arpisti
inneggianti
al
re
di
fronte
agli
dèi
Onuris,
Shu
e
Atum.
Il
sarcofago
in
granito
rosa
di
Ramesse
III,
che
si
trovava
nella
camera
sepolcrale
a
otto
pilastri,
è
ora
esposto
al
Louvre,
mentre
il
coperchio
è
al
Fitzwilliam
Museum
di
Cambridge.
Tomba
di
Ramesse
IV
(kv
2)
E'
la
prima
tomba
che
si
scorge
avvicinandosi
al
centro
della
Valle.
E'
di
piccole
dimensioni
(66
metri
lunghezza)
e
racchiude
il
sarcofago
di
Ramesse
IV,
sovrano
della
XX
dinastia
e
figlio
di
Ramesse
III.
La
pianta
della
tomba
è
tracciata
su
un
papiro
conservato
al
Museo
di
Torino;
a
partire
dal
V
secolo
fu
utilizzata
come
chiesa
da
una
piccola
comunità
cristiana
della
Valle.
Nella
splendida
decorazione
della
tomba,
i
testi
sono
predominanti,
con
scene
tratte
dal
Libro
dei
Morti,
dal
Libro
delle
Porte
e
dal
Libro
delle
Caverne.
Tomba
di
Ramesse
IX
(kv
6)
Purtroppo
assai
rovinata,
appartiene
a
uno
degli
ultimi
Ramessidi
della
XX
dinastia,
e
il
cui
governo
fu
contraddistinto
da
una
lunga
serie
di
disordini
interni
e
di
carestie.
Al
momento
della
scoperta,
nella
tomba
fu
ritrovato
anche
un
enorme
paio
di
pattini,
provenienti
dalla
slitta
su
cui
fu
trasportata
la
bara
del
faraone,
e
diverse
centinaia
di
cocci
su
cui
gli
operai
che
lavoravano
al
sepolcro
del
re
avevano
annotato
il
numero
degli
attrezzi,
le
ore
di
lavoro,
l'elenco
delle
provviste
e
così
via.
La
tomba
è
costituita
da
una
lunga
scalinata
che
conduce
ad
un
corridoio
che
porta
a
due
sale,
di
cui
una
con
quattro
pilastri,
e
un
secondo
corridoio
più
piccolo
che
conclude
nella
sala
del
sarcofago.

Il
repertorio
iconografico
presente
sulle
pareti
di
questo
sepolcro
non
si
discosta
dai
modelli
ramessidi,
mostrando
in
particolare
molte
affinità
stilistiche
e
di
contenuto
con
la
tomba
di
Ramesse
VI,
ma
le
decorazioni,
nonostante
il
degrado,
appaiono
ancora
molto
interessanti.
Nei
primi
due
corridoi
si
trovano
testi
tratti
dalle
Litanie
di
Ra
e
un
capitolo
del
Libro
dei
Morti;
si
prosegue
poi
con
estratti
dal
Libro
delle
Caverne
e
dal
Libro
dell'Amduat
e
con
illustrazioni
di
divinità
infernali.
Infine,
i
soffitti
con
motivi
astronomici
e
la
duplice
figurazione
di
Nut
sulla
volta
della
camera
sepolcrale,
insieme
ad
alcuni
passi
del
Libro
del
Giorno
e
del
Libro
della
Notte,
riassumono
la
rigenerazione
del
sole
attraverso
la
dea
del
cielo.
Tomba
di
Ramesse
VI
(kv
9)
Chiamata
anticamente
"tomba
di
Meninone"
e
anche
"tomba
della
metempsicosi"
dagli
studiosi
della
spedizione
archeologica
del
1798,
fu
scoperta
dall'inglese
James
Burton.
Al
pari
delle
altre
grandi
tombe
dei
Ramessidi,
anche
questa
aveva
l'accesso
molto
più
in
alto
rispetto
al
fondovalle
-
circa
400
metri
-
esattamente
il
contrario
delle
tombe
profondamente
scavate
dei
sovrani
della
XVIII
dinastia.
La
parte
anteriore
è
più
antica
e
fu
iniziata
sotto
Ramesse
V.
Una
volta
ingrandita,
la
pianta
mostra
oggi
un
andamento
lineare,
con
un
corridoio
che
conduce
ad
una
anticamera,
una
sala
a
pilastri,
un
secondo
corridoio
e
una
seconda
anticamera
che
precede
la
sala
del
sarcofago.
Quest'ultima
ha
un
soffitto
"astronomico",
cioè
interamente
decorato
con
scene
astronomiche
e
della
creazione
del
sole.
Vi
giganteggia
la
dea
del
cielo
Nut,
ripetuta
due
volte,
che
avvolge
la
sfera
occidentale.
La
tomba,
in
cui
furono
ritrovati
numerosi
resti
dell'attrezzatura
degli
operai,
fu
visitata
fin
dai
tempi
più
antichi,
come
attestano
i
molti
graffiti
greci
e
copti
incisi
sulle
pareti.
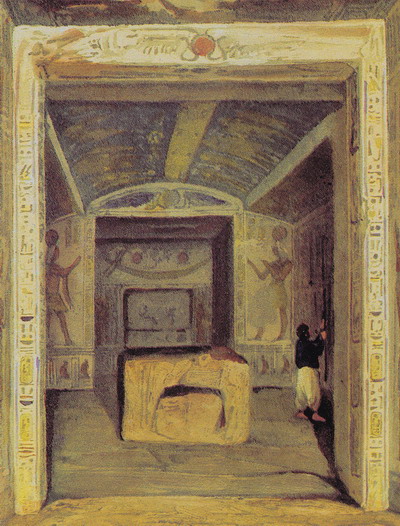

- Tomba
di
Merneptah
(kv
8)
Merneptah,
quarto
faraone
della
XIX
dinastia,
era
il
tredicesimo
figlio
di
Ramesse
II
e
Isinofre
e
arrivò
al
potere
in
età
già
avanzata.
La
pianta
della
tomba
è
semplice,
un
lungo
corridoio
a
sezioni
che
scende
fino
alla
sala
ipostila
a
tre
navate
che
conserva
il
coperchio
del
sarcofago.
Sopra
il
coperchio,
che
è
in
granito
rosso
ed
ha
la
forma
di
un
cartiglio,
è
scolpita
la
figura
del
sovrano,
con
il
copricapo
nemes
e
le
braccia
incrociate
sul
petto
che
reggono
lo
scettro
e
il
flagello.
Al
momento
della
scoperta
la
mummia
del
faraone
non
fu
trovata
all'interno
del
sarcofago
e
ciò
fece
pensare
che
fosse
proprio
lui
il
faraone
annegato
nel
Mar
Rosso
mentre
inseguiva
gli
ebrei:
in
realtà
la
mummia
di
Merneptah
fu
ritrovata
nel
1898
nella
tomba
di
Amenhotep
II.
Temi
della
pittura
egizia
Nella necropoli di Sheikh Abd
al-Quma,
che
custodisce
tombe
di
alti
funzionari
tebani
della
XVIII
dinastia,
è
custodita
la
tomba
di
Rekhmire,
"covematore
della
città
e
vizir"
sotto
Tutmosi
III
e
Amenofi
II,
una
delle
meglio
conservate
tra
le
grandi
tombe
civili
dell'epoca.
Nel
suo
vestibolo
sono
raffigurate,
oltre
a
scene
agricole,
le
cerimonie
di
presentazione
dei
tributi
da
parte
di
popoli
stranieri.
Questa
rappresentazione,
vivacemente
realista,
è
di
grande
interesse
storico
e
artistico,
con
i
cinque
gruppi
di
uomini
ben
delineati
dai
caratteri
somatici
e
dai
doni
che
recano:
i
somali,
dalle
corte
vesti,
offrono
ebano,
avorio,
piume
di
struzzo,
leopardi
e
scimmie;
i
cretesi,
con
elaborate
acconciature,
portano
coppe,
vasi
e
oggetti
di
oreficeria;
i
neri,
con
i
fianchi
cinti
da
pelli
di
pantera,
offrono
ebano,
avorio,
pelli,
uova
di
struzzo,
piume,
minerali
preziosi,
anelli
d'oro
e
animali,
come
un
giaguaro,
scimmie
e
una
giraffa.
Nelle
necropoli
reali
l'attività
pittorica
assume
un
rilievo
assoluto
per
la
possibilità
di
visualizzare
rituali
di
resurrezione,
scene
di
vita
reale
e
immagini
divine;
tra
i
cicli
meglio
conservati
si
ricorda
quello
della
regina
Nefertari,
moglie
di
Ramsete
II,
la
decorazione
della
tomba
della
regina
Tiyi
nella
quale
il
falco
reale
apre
le
sua
ali
a
protezione
del
sarcofago,
e
quella
di
Tutmosi
IV
in
cui
le
singole
divinità
dell'olimpo
egizio
aprono
la
bocca
all'anima
del
faraone
per
avviarlo
alla
vita
eterna.
Gli
schemi
iconografici
e
le
consuetudini
rappresentative
proprio
per
il
valore
sacrale
si
mantengono
inalterate
nel
tempo,
se
si
esclude
la
parentesi
naturalistica,
di
per
se
rimasta
isolata
del
regno
di
Amenofi
IV.
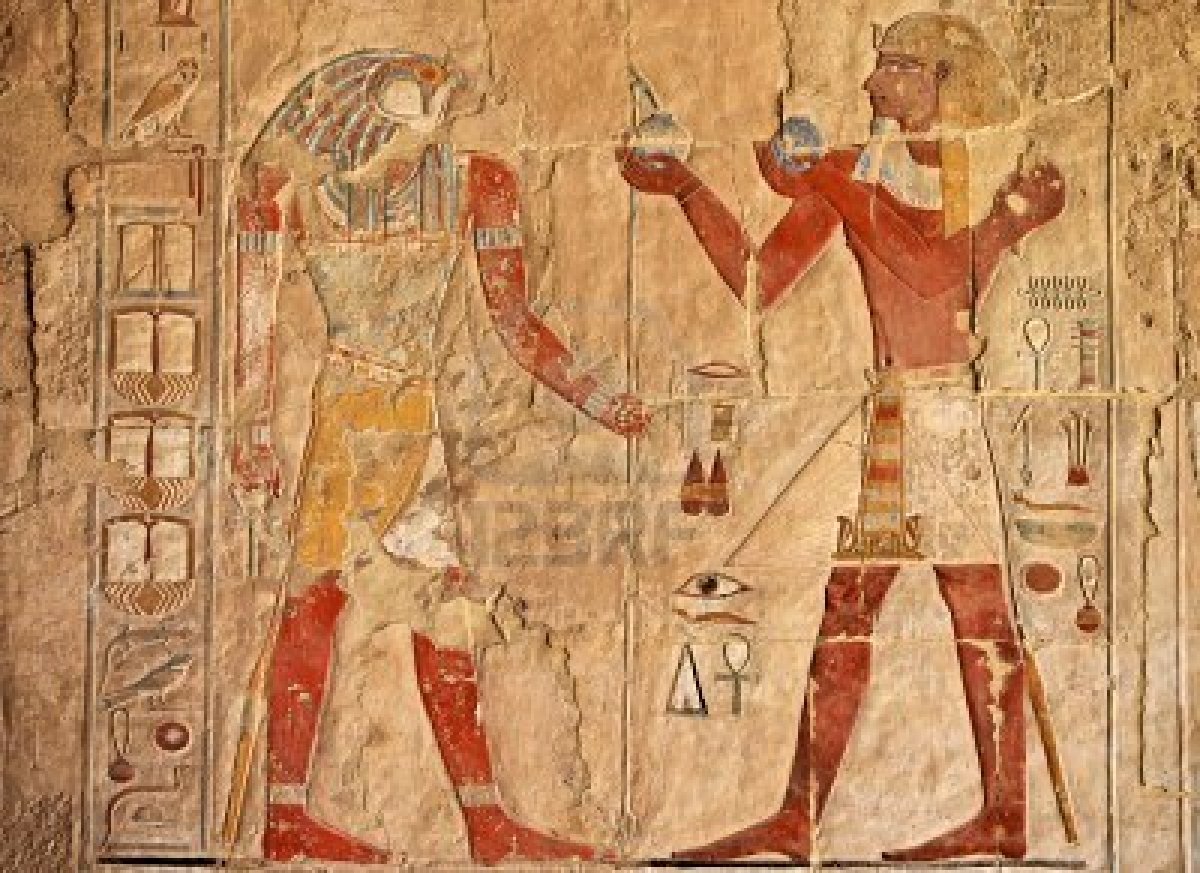
Pag.
2

 Pag.
4
Pag.
4
|