|
Betlemme
è una città della Cisgiordania, capitale del Governatorato di Betlemme
dell'Autorità Nazionale Palestinese, ed è famosa soprattutto perché i
Vangeli e la tradizione cristiana la indicano quale luogo di nascita di
Gesù Cristo; per questo motivo vi sorge la Basilica della Natività.
Secondo la Bibbia, a Betlemme nacque anche Davide, secondo re di
Israele; essa è quindi menzionata da Luca evangelista come "la
città di Davide".
Nella
storia antica, Betlemme è indicata in una tavoletta cuneiforme trovata
in Egitto e appartenente all'archivio del faraone Akhenaton: si parla
della città di Bit Lahmu, nel territorio di Gerusalemme. E’
molto probabile che il nome originario della città derivi dal termine Lahmo,
nome della divinità caldea della natura e della fertilità, termine
adottato e cambiato dai popoli cananei con Lahama.
Se
si da credito a questa ipotesi la traduzione del nome Beit el-Laham
potrebbe essere "Casa di Lahami", cosa possibile vista la
particolare caratteristica di questa terra molto feconda e ricca di
acque. Inoltre nell'Antico Testamento la città è chiamata con il nome Beth
Lechem, “Casa del Pane”, e anche Efrata, nome derivato dalla
tribù che viveva in questi luoghi, che letteralmente significa
"Fruttifera".
 Anche
i nomi più moderni rimandano all'idea di un luogo di fertilità e
abbondanza. In arabo Beit Lahm significa "Casa della
carne", per la grande quantità di greggi di pecore e capre, una
delle attività più importanti della zona. Mentre in erbaico Beit-Lehem
significa "la casa del pane", tema che introduce
all’immagine di Gesù come pane venuto del cielo. Anche
i nomi più moderni rimandano all'idea di un luogo di fertilità e
abbondanza. In arabo Beit Lahm significa "Casa della
carne", per la grande quantità di greggi di pecore e capre, una
delle attività più importanti della zona. Mentre in erbaico Beit-Lehem
significa "la casa del pane", tema che introduce
all’immagine di Gesù come pane venuto del cielo.
Nell'Antico
Testamento la città è ricordata quale capoluogo e insediamento della
tribù del re Davide, stabilitasi in queste terre dal 1200 a.C. e quale
luogo della sepoltura di Rachele, moglie del patriarca Giacobbe. Tra
queste memorie bibliche s’inserisce la storia di secoli di guerre e
spartizioni di territori che caratterizzano le vicissitudini di questo
territorio.
Nel
586 l'esercito caldeo di Nabucodonosor, dopo aver occupato la Giudea,
deportò il popolo ebraico a Babilonia, dove visse cinquant'anni di
esilio.
Finito
questo periodo il re persiano Ciro II permise agli ebrei di rimpatriare:
da questo momento la città di Betlemme tornò ad essere popolata.
La
Palestina divenne terra di conquista subendo una serie di successive
occupazioni: presa da Alessandro Magno nel 333 a.C. venne sottomessa al
regno dei Tolomei tra il 301 e il 198 a.C. e poi al governo dei
Seleucidi di Antiochia. Tra 167 e 164 a.C., dopo le persecuzioni dei
giudei e lo scoppio dell'insurrezione antisiriana dei Maccabei, ebbe
inizio la dinastia degli Asmonei che regnò su tutti i territori,
compresa la città di Betlemme, per circa 30 anni, fino all'arrivo delle
truppe romane.
Il
periodo romano - I territori della Palestina, conquistati
definitivamente da Pompeo nel 63 a.C. rientrano, all'epoca delle vicende
della vita di Gesù Cristo, sotto il dominio romano. Tutti i territori
conquistati dai romani erano divisi in varie tetrarchie. Tra queste, la
città di Betlemme era sottomessa al potere del re Erode I il Grande,
che nel 30 ca. fece costruire nei pressi della città un
palazzo-fortezza chiamato Herodion.
L'evento
della Nascita di Gesù segna quest'epoca. Nel 6 d.C. con la deposizione
dell'etnarca Archelao, la Giudea venne incorporata nella provincia
imperiale della Siria e amministrata dai procuratori residenti a Cesarea
Marittima.
Fortunatamente
Betlemme fu risparmiata dalla reazione di Tito contro i giudei avversi
al potere di Roma, rivolte che portarono alla distruzione di Gerusalemme
nel 70 d.C.
Betlemme
divenne presto luogo di culto per i primi cristiani dove veneravano la
grotta in cui era nato il Messia. Dopo la prima rivolta contro Roma
soppressa nel sangue si acuirono le tensioni, che divennero sempre più
forti, sfociando nella seconda Guerra giudaica, repressa sotto il
dominio dell'imperatore Adriano.
Quest'ultimo
decise di far costruire a Betlemme un tempio pagano dedicato al dio
Adone sopra la Grotta della Natività; il luogo venerato dai primi
cristiani fu interrato e distrutto in ogni segno di venerazione, come già
era avvenuto sopra il Santo Sepolcro di Gerusalemme.
La
grotta doveva presentarsi allo stato naturale, come descriverà poi
Girolamo nelle sue testimonianze. Restò sempre vivo il ricordo del
luogo esatto della nascita di Gesù, come ci testimonia Origene nei suoi
scritti. A causa delle forti repressioni molti cristiani lasciarono la
cittadina in mano ai pagani che continuarono il loro culto.

Il
periodo romano-bizantino - Dopo l'editto di Costantino del 313 d.C.
venne proclamata la libertà di culto e iniziò un periodo di rinascita
per tutti i luoghi santi. Con il concilio di Nicea e grazie alla forte
volontà della regina Elena, dopo opportuni scavi, iniziò la fabbrica
della basilica della Natività che ridava dignità al Luogo della
nascita del Messia. Il cantiere si concluse nel 333 d.C., come ricorda
il pellegrino Anonimo da Bordeaux. Betlemme divenne fin da subito un
importante centro religioso.
Con
l'arrivo di S. Girolamo nel 384 le grotte della Natività divennero polo
di una nuova esperienza monastica. Girolamo contribuì alla storia della
Chiesa con la trascrizione in latino della bibbia su richiesta di Papa
Damasco, opera conosciuta come "La Vulgata"
Un’altra
figura di rilievo per lo sviluppo del monachesimo sia maschile che
femminile fu la patrizia romana Paola che, insieme alla figlia
Eustochio, giunse a Betlemme nel 386 e destinò molto del suo patrimonio
all'erezione di due monasteri nelle prossimità dei luoghi della Natività
di Gesù. Nel 420 dopo la morte di Girolamo la vita monastica a Betlemme
non proseguì; inoltre la città venne conquistata dai Samaritani di
Naplus che, dopo le rivolte contro l'imperatore di Bisanzio dal 521-528,
saccheggiarono le chiese e i monasteri, attaccando duramente i cristiani
(529).
Successivamente
i saccheggi che provocarono la distruzione della Basilica della Natività,
nel 531 l'imperatore Giustiniano, su richiesta di S. Saba, restaurò il
santuario e ricostruì la città ormai in rovina. In questa occasione fu
realizzato un mosaico sul timpano maggiore, decorato con l'immagine dei
Magi in costumi persiani, iconografia frequentemente riprodotta
soprattutto dopo la Pace costantiniana a simboleggiare la regalità del
Cristo.
Questa
particolare scena di sapore orientale tornò utile quando, con
l'invasione capeggiata da Cosroe II nel 614, la basilica fu preservata
dalla distruzione a causa della visione del mosaico, che intimorì le
armate persiane. Nel 629 l'imperatore Eraclio riconquistò i territori
palestinesi dal dominio persiano.
Il
periodo arabo-musulmano - Con
l'occupazione arabo-musulmana da parte del Califfo Omar nel 638, anche
Betlemme fu sottomessa a questo nuovo potere. Il clima di tolleranza e
convivenza tra musulmani e cristiani fu garantito dal gesto simbolico
del Califfo che, dopo l'occupazione della città, entrò a pregare nella
basilica davanti all'abside sud. Da quel momento la basilica divenne un
luogo di preghiera sia per i cristiani che per i musulmani.
In un
primo tempo convivenza e tolleranza tra le due religioni furono
osservate, ma con il susseguirsi dei diversi califfati la situazione dei
cristiani di Betlemme peggiorò notevolmente. Questo fino alle
persecuzioni del 1009 da parte del Califfo fatimida el-Hakim, che ordinò
la distruzione dei santuari di Terra Santa, preservando miracolosamente
la Natività di Betlemme.
Questo
avvenne perché il luogo aveva importanza anche per la religione
islamica, essendo luogo di nascita di Gesù, che per i musulmani è il
profeta Issa, ma anche perché la basilica ospitava una piccola moschea.

Il
periodo crociato - Con
il movimento crociato per la liberazione dei Luoghi santi cristiani
inizia un nuovo periodo nella fase della storia della Terra Santa. A
causa delle difficili condizioni vissute nei territori di Betlemme, i
cristiani chiesero aiuto a Goffredo di Buglione, di stanza ad Emmaus.
L'arrivo
dei crociati inasprì i rapporti tra musulmani e cristiani che speravano
nella liberazione della città da parte dei cavalieri. Infatti, una
centuria di cavalieri guidata da Tancredi conquistò la città che da
quel momento visse un secolo d'oro in cui s’intensificarono i rapporti
con l'Europa tramite scambi commerciali e pellegrinaggi.
I
crociati diedero anche un nuovo aspetto alla città erigendo un
monastero per i canonici Agostiniani, che oggi corrisponde al convento
francescano, ai quali fu affidato il servizio liturgico nella Basilica e
l'accoglienza dei pellegrini, mentre ai riti orientali venne concessa la
possibilità di celebrare la propria liturgia.
Il 24
dicembre 1100 Baldovino I venne incoronato primo re di Gerusalemme: da
allora la città dipese direttamente dal Patriarca di Gerusalemme e
divenne sede episcopale e centro diocesano.
Tra
il 1165-1169 per volere del vescovo Rodolfo si procedette al restauro
della basilica, con il contributo economico del re crociato Almarico I e
dell'imperatore di Costantinopoli Manuele Porfirogeneto Comneno, come
testimonia il pellegrino Focas. Questa collaborazione fu chiaro segno
dell'unità tra le chiese d'Oriente e d'Occidente. Alla sconfitta dei
crociati nel 1187 ad Hattin, in Galilea, da parte di Saladino, Salah
al-Din ibn Ayyub, seguì una nuova occupazione di Betlemme.
La
comunità latina residente in città abbandonò Betlemme, ritornandovi
solo nel 1192, quando i musulmani consentirono ai latini di riprendere
il culto attraverso il pagamento di un alto tributo.
A
seguito delle due tregue, una tra l'imperatore Federico II e il Sultano
d'Egitto e l’altra tra il re di Navarra e il sultano di Damaso,
Betlemme passò nuovamente sotto il Regno Latino di Gerusalemme tra il
1229 e il 1244. Il Regno durò poco più di un decennio perché nel 1244
l'invasione dei Carismini in Palestina destabilizzò nuovamente i
territori.
Sicuramente la fama di Betlemme, come di tutti i Luoghi santi, ebbe un
incremento anche grazie al viaggio di Francesco d'Assisi, che tra
1219-1220 si recò in oriente con altri 12 frati. Si è supposto che
Francesco si fosse recato a Betlemme, perché la tradizione ricorda il
famoso attaccamento del santo all'immagine del presepe, ma questo non è
confermato da nessuna fonte storica.
Comunque,
è certo che il frate, entrato dal porto di Acri insieme ai Crociati, si
recò in Egitto alla corte del sultano Malek al-Kamil che, colpito dalla
sua personalità, gli accordò un salvacondotto per il viaggio in
Palestina. Alcuni dei suoi compagni, già arrivati in Palestina negli
anni precedenti, si fermarono a servizio della Chiesa in quella terra.

Il
periodo mamelucco - Nel 1263 con l'invasione di Gerusalemme da parte
dei Mamelucchi d'Egitto, il sultano Baybars cacciò i cristiani da
Betlemme e abbatté le mura fortificate della città. In questo periodo
i pellegrini poterono raggiungere la città solo dopo il pagamento di un
contributi.
In
seguito, con la caduta di Acri del 1291 e la fine del Regno latino di
Gerusalemme, la Palestina rimase sotto i mamelucchi fino alla conquista
dell'Impero Ottomano.
I
francescani a Betlemme - I frati minori, giunti già in Terra Santa
agli inizi del XIII sec., si stabilirono definitivamente a Betlemme nel
1347. Questi occuparono un convento dei canonici agostiniani, esiliati
dai mamelucchi, come testimonia Fra Niccolò da Poggibonsi, che giunse
in Terra Santa proprio in quell'anno.
Il sultano donò ai Frati della corda (così ricordati nelle cronache e
nei documenti antichi) la proprietà della basilica e della Grotta della
Natività. Gli
altri riti cristiani ottennero il permesso di celebrare la loro
liturgia. Da quest'epoca in poi furono i francescani a rappresentare i
religiosi di rito latino a Betlemme come in altri Luoghi santi.
Nel 1479 si mise mano alla fabbrica per il rifacimento del tetto della
Basilica grazie all'operosità dal guardiano Giovanni Tomacelli. Il
legname fu offerto da Filippo il Buono di Borgogna e trasportato
dall'Europa con navi veneziane, mentre il piombo fu donato dal re
Edoardo IV d'Inghilterra, come testimonia fra Francesco Suriano.
Il
periodo Turco - Nel 1517 la Palestina fu annessa all'Impero Turco
ottomano e il sultano Selim I abbatté i resti delle mura di Betlemme.
La città cadde così in una lenta rovina e i cristiani oppressi e
perseguitati lasciarono man mano il paese. I diritti di possesso e
liturgici sulla basilica vennero divisi tra francescani e ortodossi,
causa di continui scontri fomentati dal governo della Sublime Porta, che
appoggiava alternativamente una o l’altra confessione, concedendo
diversi privilegi.
Nel
1690 i frati francescani riuscirono a riacquistare i loro diritti, ma
nel 1757 vi fu un nuovo e definitivo cambio di proprietà.
Tra il 1831 e il 1841 il viceré d'Egitto Muhammed Alì e il figlio
Ibrahim Pascià liberarono per un breve tempo la Palestina dal dominio
dei Turchi. Con questa occasione i cristiani rivendicarono il diritto
sulla città di Betlemme e, dopo anni di sottomissione e persecuzione,
cacciarono i musulmani e distrussero il loro quartiere nel 1834. Da
allora la maggioranza della popolazione della città resterà sempre
cristiana.
 Uno
degli eventi più ricordati, che caratterizza il periodo di dispute tra
le diverse confessioni, è la sparizione della stella, posta dai latini
nel luogo esatto della nascita di Gesù. Il fatto fu commesso dai greci
ortodossi il 12 ottobre 1847 e provocò l'inasprimento dei contrasti tra
le due confessioni. Uno
degli eventi più ricordati, che caratterizza il periodo di dispute tra
le diverse confessioni, è la sparizione della stella, posta dai latini
nel luogo esatto della nascita di Gesù. Il fatto fu commesso dai greci
ortodossi il 12 ottobre 1847 e provocò l'inasprimento dei contrasti tra
le due confessioni.
A
causa di questi attriti il governo turco emanò un firmano, nel 1852,
che sanzionava i diritti di proprietà esistenti nei santuari cristiani
(Status quo), per cercare di mettere pace dopo secoli di scontri.
La Sublime Porta, per rendere grazie ai paesi europei che contribuirono
alla vittoria nella Guerra di Crimea contro la Russia, concesse ai
latini maggiori libertà. In questo periodo iniziarono a stabilirsi in
Palestina molte congregazioni religiose che si occupavano delle scuole,
degli ospedali e degli ospizi. L'arrivo di molti occidentali lasciò un
segno visibile tutt'oggi nella città.
Nel
1859 i francescani acquistarono "Siyar al-Ghanam", il Campo
dei Pastori, dove a seguito di scavi archeologici furono rinvenuti resti
di costruzioni di epoca bizantina.
Dopo la sconfitta dell'Impero Ottomano nella Prima Guerra Mondiale, nel
1922 la Palestina fu sottoposta al protettorato della Gran Bretagna su
base di accordi internazionali.
XX
secolo -
Betlemme è stata amministrata dal mandato britannico dal 1920
fino al 1948. Nell'Assemblea generale delle Nazioni unite del 1947 per
la partizione della Palestina, Betlemme è stata inclusa nell'enclave
internazionale speciale di Gerusalemme per essere amministrato dalle
Nazioni Unite.
La
Giordania ha annesso la città durante la Guerra arabo-israeliana del
1948. Molti rifugiati della zona furono catturati dalle forze israeliane
nel 1947-48; essi erano fuggiti nella zona di Betlemme, soprattutto per
stabilirsi in quello che divenne il campo profughi ufficiale di Gazanel
Dheisheh. L'afflusso di rifugiati ha significativamente trasformato la
maggioranza cristiana di Betlemme in una musulmana.
La
Giordania ha mantenuto il controllo della città fino alla Guerra dei
sei giorni nel 1967, quando fu occupato da Israele, insieme al resto
della Cisgiordania. Il 21 dicembre 1995, le truppe israeliane si
ritirarono da Betlemme, e tre giorni più tardi la città passò sotto
la completa gestione e il controllo militare dell'Autorità Nazionale
Palestinese in conformità con l'accordo ad interim sulla Cisgiordania e
la Striscia di Gaza nel 1995.
Seconda
Intifada -
Durante la Seconda Intifada, che iniziò nel 2000-01, le
infrastrutture e l'industria turistica di Betlemme furono gravemente
danneggiate. Nel 2002 le Forze di Difesa Israeliane (IDF) lanciarono
un'importante offensiva, chiamata Operazione Scudo Difensivo.
Durante
questa operazione, l'IDF assediò la Basilica della Natività, dove
circa 200 Palestinesi, incluso un gruppo di militanti, avevano cercato
riparo dall'avanzata dell'IDF nella città. L'assediò durò 39 giorni e
9 militanti e il campanaro della basilica vennero uccisi. L'attacco si
concluse con un compromesso, in base al quale 13 militanti ricercati
sarebbero stati esiliati in varie nazioni europee e in Mauritania. Il
Papa Giovanni Paolo II condannò le azioni dell'esercito israeliano,
descrivendole come "intollerabili" e il ministro degli Esteri
britannico le classificò come "totalmente inaccettabili".
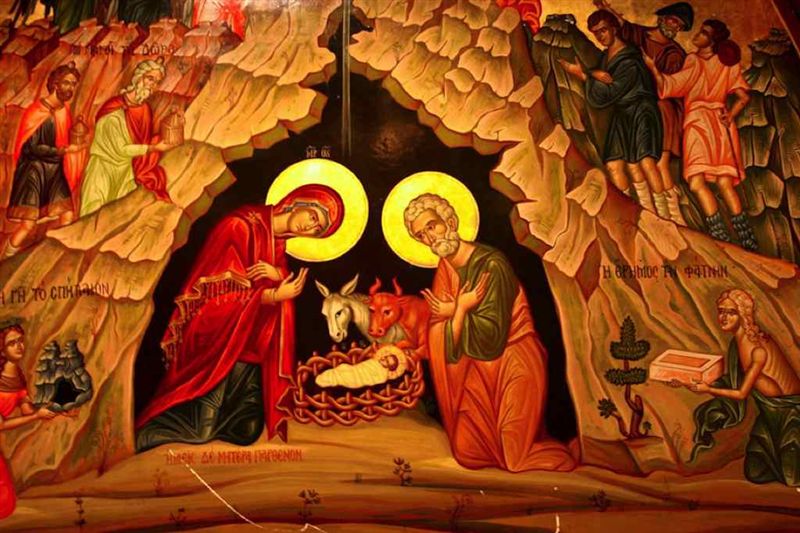
La
data di nascita di Gesù - E’
ormai pensiero comune degli storici e degli studiosi che l’anno di
nascita di Gesù Cristo non sia stato correttamente calcolato. Si parla
di un errore fatto dal monaco Dionigi il piccolo che, tra V-VI sec., fu
incaricato da Roma di proseguire la compilazione della tavola
cronologica per il calcolo delle data della Pasqua, preparata al tempo
del vescovo Cirillo. Il monaco prese come punto di partenza la data
dell’incarnazione del Signore.
Lo sbaglio di Dionigi stette nel fatto che il monaco calcolò la nascita
di Gesù dopo la morte di Erode, ovvero 4 o 6 anni dopo la data in cui
sarebbe veramente avvenuta, che corrisponderebbe all'anno 748 dopo la
fondazione di Roma. Ma Giuseppe Flavio testimonia che la morte di Erode
I il Grande avvenne dopo 37 anni del suo regno e, considerando che salì
al trono nel 40 a.C., l’anno della sua morte sarebbe da far coincidere
con il 4 a.C.
Lo conferma un altro evento astronomico, che il cronista ricorda prima
della morte del monarca, e cioè quello di un’eclissi lunare che
sarebbe avvenuta tra l’11 e il 12 aprile del 4 a.C. Per cui, se la
data di morte di Erode è da assegnare al 4 a.C., Gesù non può essere
nato oltre questo anno.
Per
quanto riguarda il mese e il giorno della nascita, invece, molti aspetti
portano a una loro veridicità. L'analisi parte da due fonti: il Vangelo
di Luca e il calendario solare rinvenuto a Qumran. Luca dice che
l’Angelo Gabriele annunciò a Zaccaria che Elisabetta era incinta,
mentre “esercitava sacerdotalmente nel turno del suo ordine” (Lc 1,
8). E' stato possibile calcolare le 24 classi in cui erano divise le
famiglie sacerdotali e risalire all’ottava classe di Abia, alla quale
apparteneva il sacerdote Zaccaria. Egli svolse servizio presso il tempio
dall’8° al 14° giorno del terzo mese e dal 24° al 30° giorno
dell’ottavo mese. Quest’ultima data corrisponde alla fine di
settembre, nove mesi prima del 24 giugno, ossia della data di Nascita
del Battista.
Così,
anche l’annuncio alla Vergine Maria “nel sesto mese” (Lc 1, 28)
dal concepimento di Elisabetta, corrisponderebbe al 25 marzo. Di
conseguenza si può considerare storica anche la data di nascita di Gesù,
il 25 dicembre.
Nonostante
questo è pensiero comune che la tradizione della Chiesa abbia stabilito
la data della solennità della nascita di Gesù in corrispondenza della
festività pagana del Dies natalis solis invicti. Questa cadeva
il 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno. Probabilmente le due
festività furono fatte coincidere per sostituire il culto pagano e
divulgare velocemente quello cristiano. Ma è anche evidente che una
festa così centrale non poté essere stabilita solo per motivi di
sincretismo ma che doveva avere alla base delle solide radici storiche.
E’ anche vero che il passaggio dalla festività pagana a quella
cristiana fu molto facile, perché la tradizione biblica parla del
Messia come di un sole e di una luce: “verrà a visitarci dall’alto
un sole che sorge” (Lc 1, 78).
Basilica
della Natività

Percorrendo
la via della Stella, come fecero i Magi d'Oriente e a loro volta i
pellegrini, verso il Luogo santo della Natività di Gesù, in
lontananza, prima di arrivare al piazzale dell'attuale basilica, si
scorge l'incanto di un Luogo che da secoli richiama milioni di
visitatori venuti da tutto il mondo per adorarlo.
Giungendo
presso il piazzale lastricato antistante la basilica, si apre la visione
del santuario della Natività. A prima vista non è facile comprendere
la struttura architettonica del complesso basilicale, che è passato
attraverso secoli di storia e di trasformazioni. L’edificio risale al
VI sec. ed è opera degli architetti dell’imperatore bizantino
Giustiniano, che volle ricostruire la basilica del IV sec. distrutta
dopo la rivolta dei Samaritani, come è testimoniato da Eutachio,
patriarca di Alessandria nel 876.
Osservando
la facciata è possibile distinguere alcune delle parti che
costituiscono il complesso della basilica e gli edifici annessi.
L'aspetto di fortezza è la conseguenza dall'esigenza, manifestatasi nei
secoli, di rendere sicura la struttura e le abitazioni dei religiosi che
custodivano la basilica. Guardando la facciata, le mura sulla destra
recintano il monastero armeno e quello greco, mentre a sinistra si
trovano le costruzioni moderne del Casa Nova e del Convento francescano
di epoca crociata.
Il
piazzale - In epoca costantiniana il piazzale attuale era parte
dell’atrio della basilica e si presentava come uno spazio aperto e
ampio. Questo è stato confermato dagli scavi che hanno riportato alla
luce il perimetro della basilica del IV sec. Davanti all'ingresso sono
state ritrovate delle cisterne di cui si possono riconoscere, sul
lastricato, le bocche di apertura: vi si raccoglieva l'acqua piovana che
veniva usata per i riti e per la vita quotidiana dei monasteri.
Attualmente
il piazzale è circondato da un muro perimetrale collegato al monastero
armeno, che si trova nella sommità del lato a sud-ovest. Il muro che si
estendeva al lato ovest del piazzale finiva con un grande portale, che
serviva da ingresso e delimitava la zona degli edifici sacri dal termine
del villaggio. La presenza della porta ormai distrutta è testimoniata
dai resti delle fondamenta e dai disegni di Bernardino d'Amico (XVI
sec.) e del Mayr (XVIII sec.).

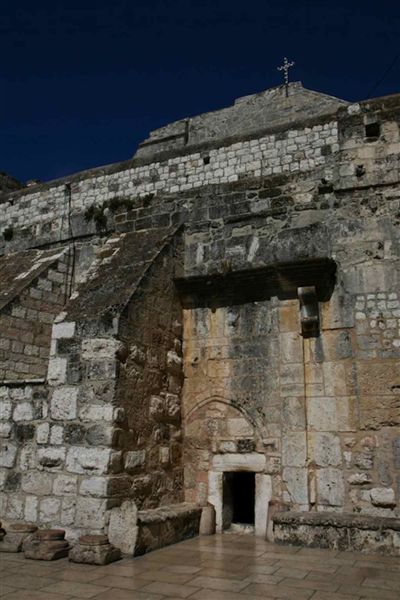
La
facciata - La facciata, la cui composizione si presenta poco chiara
a causa delle continue modifiche, appartiene alla struttura di epoca
giustinianea. L’attenta osservazione consente di scorgere tre porte
d'ingresso, che sono state nel tempo tamponate da muratura. La facciata
bizantina si doveva presentare maestosa e imponente con tre portali
d’accesso alle rispettive navate.
Diversamente
dall’edificio costantiniano, la facciata bizantina, preceduta dal
nartece, fu spostata in avanti dello spazio di un intercolumnio. La
piccola porta d'ingresso è il risultato delle riduzioni che nel tempo
furono apportate: si riconosce facilmente la grande porta centrale, di
età bizantina, con architrave orizzontale e con pietre disposte in
diagonale.
Con la
venuta dei crociati la porta venne ridimensionata nello stile proprio
dei cavalieri occidentali, per motivi di difesa del Luogo santo. Ne è
testimonianza visibile il resto dell'arco a sesto acuto che si individua
nella muratura.
In
epoca Ottomana le dimensioni del portale furono ridotte ulteriormente
creando l'attuale porta d’ingresso, realizzata per impedire l'accesso
a coloro che volevano dissacrare il luogo di culto. Questo, in qualche
modo, fa riflettere sulle alterne fasi della cristianità a Betlemme:
periodi in cui la libertà di culto garantiva il riconoscimento della
fede cristiana e altri in cui le persecuzioni e le intolleranze
rendevano difficile la vita dei cristiani locali.
Le
altre due porte bizantine, ormai coperte dai muri perimetrali della
basilica e dai contrafforti posti in facciata in epoca crociata,
permettono di intuire la maestosità e la bellezza della basilica
bizantina e lo stupore che alla prima vista doveva suscitare su coloro
che giungevano in pellegrinaggio.

Entrando
dalla piccola porta si può accedere alla zona definita tecnicamente
nartece, realizzato in età bizantina. Il nartece, nella tradizione
cristiana antica, era l’area che aveva funzione di ingresso agli spazi
sacri, destinata ai catecumeni che in alcuni momenti delle celebrazioni
non potevano entrare nella basilica. In epoca costantiniana non esisteva
il nartece, ma un atrio che svolgeva una funzione simile, strutturato in
maniera più ampia e aperta.
I
campanili crociati - I due campanili costruiti in epoca crociata
furono menzionati per la prima volta nell'itinerario di G. di
Maundeville nel 1322 e vennero costruiti sicuramente in epoca crociata.
Posti alle estremità del nartece, corrispondono oggi all'ingresso del
convento armeno e alla cappella del convento francescano di Sant'Elena.
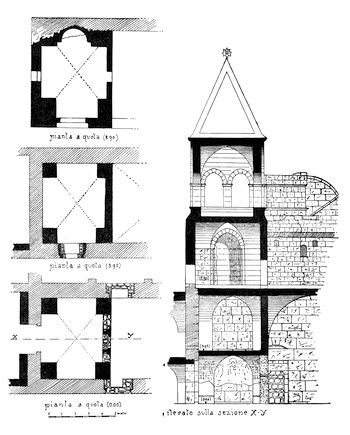 Avevano
sia funzione di campanile che di torre di guardia a controllo del
territorio. L'epoca di costruzione delle due strutture è confermata
dagli spazi rimasti intatti ai piani inferiori, che sono caratterizzati
da elementi architettonici crociati, come le arcate a sesto acuto. Avevano
sia funzione di campanile che di torre di guardia a controllo del
territorio. L'epoca di costruzione delle due strutture è confermata
dagli spazi rimasti intatti ai piani inferiori, che sono caratterizzati
da elementi architettonici crociati, come le arcate a sesto acuto.
Il
pellegrino Bernardino di Nali (XV sec.) li descrisse, nelle sue memorie,
come delle strutture molto eleganti. E’ impossibile pensare che vi
fossero appese delle campane perchè, come ricorda p. Felix Faber
(1480-83), i Saraceni non permettevano ai cristiani di avere campane. I
campanili che si vedono oggi sono costruzioni successive facenti parte
dei monasteri greco-ortodosso e armeno-ortodosso.
Il
narcete - L’attuale ingresso è modificato rispetto allo spazio
originale ed è molto ridotto. Il pavimento è quello originale del VI
sec., ma le pareti, coperte da intonaco, non restituiscono la loro
bellezza originaria, perché l’intera basilica doveva essere rivestita
di lastre di marmo bianco con venature.
Si
suppone, sulla base degli studi di architettura bizantina, che il
nartece fosse decorato non solo da marmo, ma anche arricchito con
mosaici. Dopo i restauri, che saranno effettuati a breve, e con la
rimozione degli intonaci, potrebbero tornare alla luce le decorazioni
musive parietali. Lo spazio del nartece giustinianeo è diviso in
quattro zone.
In
epoca crociata le aree alle due estremità opposte erano il piano
inferiore dei campanili, torri che si alzavano su quattro piani.
Questi
due spazi, caratterizzati da archi tipicamente crociati, sono ora
adibiti uno a portineria del monastero armeno, l'altro a Cappella di
Sant'Elena, proprietà dei frati francescani. Un quarto spazio, alla
sinistra della porta d’ingresso, è utilizzato dai militari che
presidiano e sorvegliano la basilica fin dall'epoca dei turchi.
Nell'ingresso
del monastero armeno le pareti sono state ripulite e restituite
all’originale stato: sono evidenti i fori nelle pietre della muratura,
utili all’ancoraggio dei marmi di rivestimento.
Il
portale - Tornando al nartece, è interessante mettere in risalto il
portale di legno antico che ha più di 700 anni di storia, voluto dal re
Armeno Hetum, figlio di Costantino, nel 1227, come si legge
nell'iscrizione scolpita in lingua araba e armena. Questo a
testimonianza delle buone relazione tra i Latini e la chiesa Armena.
Il
portale di fattura finissima, ma mal conservato a causa dell'usura del
tempo e della poca cura, presenta una decorazione floreale tipica dello
stile armeno. Ora non è totalmente visibile perché coperto da
impalcature, poste dal governo palestinese, a sostegno delle travi del
tetto, seriamente compromesse a livello statico. L'intonaco sulle pareti
del nartece non aiuta a comprendere la dimensione delle porte laterali,
visibili solo dall'interno della basilica dove la muratura è stata
scrostata dell’intonaco.
La zona
descritta è un passaggio obbligatorio per tutti i pellegrini che
vogliono accedere alla basilica dal piazzale e rappresenta una zona
comune alle tre Comunità. Per questo motivo risultano molto complessi
gli interventi di manutenzione che sarebbero necessari per il
consolidamento della struttura.


Interno
- Al suo interno la basilica ha conservato tutti gli elementi
architettonici del VI sec. L'imperatore bizantino al momento della
visione del progetto non approvò le scelte fatte dall’architetto, e
lo accusò di aver sperperato i fondi, condannandolo alla decapitazione.
Nonostante l’insoddisfazione dell’imperatore, la struttura ha
dimostrato di essere ben solida, arrivando intatta fino a oggi.
Il
pavimento, in epoca costantiniana era completamente rivestito di mosaico
finemente lavorato, com’è stato accertato dagli scavi del governo
inglese nel 1932. I mosaici finemente lavorati presentano decorazioni
geometriche e floreali. Tra questi si può mettere in evidenza il
mosaico conservato a sinistra del presbiterio, dove sollevando la botola
in legno, si può osservare il monogramma ΙΧΘΥΣ, dal greco pesce,
che gli antichi utilizzavano per indicare il nome di Cristo. Oggi il
pavimento è ricoperto da un semplice lastricato in pietra grezza,
mentre in epoca bizantina era realizzato con lastre di marmo bianche con
venature particolarmente accentuate, di cui ne rimane un esempio nella
zona del transetto nord.
Il
pavimento costantiniano andava leggermente in salita rispetto
all'attuale, che si trova a circa un metro di altezza sopra il livello
originario. Lo spazio interno, diviso da colonne in cinque navate, è
scuro e poco illuminato. Nel VI sec. la basilica doveva essere
totalmente ricoperta di marmo: restano le traccie dai buchi trovati
nelle mura ripulite dall'intonaco, e che servivano per fissare i marmi
alle pareti.

Il
colonnato, che oggi finisce all’altezza della zona absidale, doveva
proseguire creando un deambulatorio intorno alla Grotta della Natività.
Questo tipo di struttura architettonica è stata usata in diversi Luoghi
santi, specialemnte per i Martyria, perché secondo la tradizione il
pellegrino, girando ripetutamente intorno al luogo, poteva acquisirne le
grazie. Le colonne e i capitelli, di pietra rossa betlemita, sono quelle
originali di epoca bizantina, opera di artigiani locali.
I
capitelli, di fattura raffinata, erano dipinti in colore azzurro. Sulle
colonne sono rappresentate delle immagini di santi orientali e
occidentali, religiosi e laici. Anche gli architravi sono di questa
epoca, ma le decorazioni risalgono al periodo crociato e manifestano la
somiglianza con quelle coeve del Santo Sepolcro.
Le
alte pareti della navata centrale presentano decorazioni musive di
grande pregio, databili al XII sec., opera di maestri orientali. I
mosaici sono divisi in tre registri e rappresentano, partendo dal basso:
la genealogia di Gesù, i concili e i sinodi locali e infine, in alto,
una processione di angeli. Una testimonianza greca del IX sec. dice che
in precedenza esistevano altre decorazioni musive risalenti al periodo
bizantino. Tra queste è ricordata particolarmente la rappresentazione
dei Magi che arrivano a Betlemme ad adorare Gesù, che decorava la
facciata. E’ singolare la vicenda dei soldati persiani che invasero la
città nel 614 d.C. e che, intimoriti dalla visione del mosaico, si
dissuasero dal saccheggiare la basilica, che rimase incolume. Leggende
diffuse posteriormente raccontano l'episodio con elementi miracolosi,
come nel caso del pellegrino Jean Boucher.
I
transetti che ancora conservano l'originale pavimentazione in marmo di
epoca bizantina, sono oggi decorati da icone e arredi sacri della
tradizione Greca-ortodossa (transetto destro) e Armena (transetto
sinistro). Anche questa parte della basilica conserva decorazioni musive
di scene evangeliche abilmente realizzate.

I
mosaici pavimentali - Il pavimento della prima
basilica costantiniana era totalmente ricoperto da un tappeto musivo.
Questo è noto grazie agli scavi che tra 1932-1934 furono eseguiti dal
governo inglese. Il pavimento del IV sec. saliva in direzione della zona
absidale, con un dislivello che variava tra i 75 cm e i 31 cm. In epoca
bizantina, a seguito della variazione delle dimensioni della pianta
della basilica, la pavimentazione fu coperta da un rivestimento di
lastre di marmo bianco venato. Attraverso le botole aperte nel pavimento
è possibile, ancora oggi, godere della visione degli antichi mosaici.
La
fattura è veramente minuziosa e raffinata, soprattutto nella navata
centrale. E’ stato calcolato l’impiego di 200 tessere ogni 10 cm2 di
superficie, quando mediamente, nei comuni mosaici, la densità di
tasselli è di 100 ogni 10 cm2. Il dato aiuta a comprendere la preziosità
di queste decorazioni, dove la maggiore densità di tasselli permetteva
di elaborare immagini raffinate e di riprodurre maggiori sfumature di
colore. Il risultato è quello di una decorazione musiva molto
dettagliata, rappresentativa dell’importanza del Luogo santo.
Questi
mosaici, che ricoprivano la navata centrale e l'abside, raffigurano
elementi geometrici e decorativi (svastiche, tondi, cornici con nastri
intrecciati). Più rari gli elementi vegetali, come foglie di acanto e
viti.
Eccezionale è la rappresentazione di un gallo, nel transetto nord.
L’assenza di figure animate è in rispetto della tradizione Medio
Orientale che non usava figure animali o umane.
Un
elemento molto interessante della decorazione musiva, è conservato
nell'angolo sinistro della navata centrale dove, aprendo la botola di
legno, si può vedere un monogramma con le lettere ΙΧΘΥΣ. Il segno
usato nell'antichità per indicare il nome di Cristo, letteralmente
significa “pesce”: questo è l'unico simbolo certo di cristianità
del luogo. Un uso simile dell'acronimo veniva fatto in epoca classica
all’ingresso delle case patrizie romane, assieme alla rappresentazione
dei busti dei proprietari. Per questo è stato ipotizzato che il simbolo
segnasse il punto dell'antico ingresso alla zona sacra e alla "casa
di Gesù".
Lo
studio degli scavi inglesi ha portato all'ipotesi che l’accesso alla
zona presbiteriale della basilica costantiniana avvenisse attraverso una
scala che partiva precisamente dal punto in cui si trova il mosaico.
Secondo padre Bagatti lo scalino usato per accedere alla zona
presbiteriale fu sfondato per realizzare un’entrata diretta alla
grotta.

Il
colonnato della navata centrale - La
decorazione delle colonne, rimasta inosservata fino al 1891 quando padre
Germer-Durant la studiò, rappresenta uno degli elementi più
interessanti della decorazione interna. E' difficile riconoscere una
continuità e un’organicità del progetto iconografico.
La
tecnica utilizzata è quella dell'encausto, tecnica pittorica che
imprime i pigmenti mescolati a cera con l’effetto del calore. Sia le
mani degli artisti che il periodo di produzione sono diversi, per cui si
pensa che i lavori venissero richiesti da singoli committenti a pittori
diversi. E’ sicuro che tutte le immagini risalgano all’epoca
crociata, epoca di passaggio di divisione tra la Chiesa d’Oriente e la
Chiesa d’Occidente. Questo è confermato anche dalla presenza di Santi
sia della tradizione occidente che di quella orientale (si veda la
photogallery).
I
riquadri, tutti posti sulle colonne della navata centrale e della prima
fila di colonne a sud, sono contornati da una striscia di colore rosso o
biancastro, mentre le figure dei Santi spiccano su sfondo turchino. Ogni
santo ha il proprio nome scritto in un cartiglio in alto o posto tra le
mani. La funzione di queste immagini venne descritta dal pellegrino
Arculfo che testimoniò l’usanza di celebrare delle messe in prossimità
delle colonne nel giorno del Santo. Per gli ecclesiastici del tempo, le
colonne dipinte servivano a richiamare metaforicamente la presenza di
quei particolari Santi nel luogo.
E’
pensiero diffuso, oggi come allora, che i Santi rappresentino coloro che
sorreggono il peso della Chiesa: le immagini dei Santi sulle colonne
trasmettono con forza e semplicità questo concetto a tutti i fedeli che
visitano la basilica. Possiamo definire queste pitture “affreschi”
con finalità votive, perché è molto probabile che servissero come
attestazione di un pellegrinaggio portato a termine. Inoltre i
committenti avevano chiaro che le pitture avrebbero contribuito
all’abbellimento della chiesa.
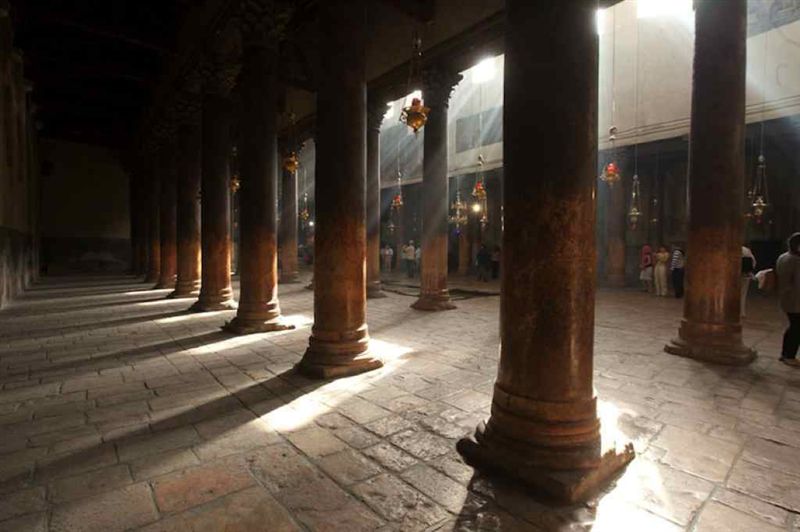
I
mosaici parietali - La navata centrale si
presenta particolarmente scura a causa della mancata manutenzione che
negli anni ha compromesso lo stato del Santuario. Resta comunque
affascinante l'effetto dei mosaici con i fondi dorati e le argentee
incrostazioni di madreperla che un tempo ricoprivano tutte le pareti
della basilica. Le decorazioni parietali, sicuramente di epoca crociata,
disposte su fasce diverse, sono in parte ricoperte da intonaco.
L’ultima
relazione dei sopralluoghi relativi il restauro della basilica ha
evidenziato che le tessere dei mosaici sono state posate inclinate verso
il basso, per far risaltare la bellezza del mosaico osservato da diversi
metri più in basso. In questo modo il pellegrino che entra nella
basilica riceve un forte impatto visivo, anche se sfavorevolmente
condizionato dal cattivo stato di conservazione dei mosaici.
La
testimonianza più diretta e precisa della decorazione è quella del
padre Quaresmi che nelle Elucidatio Terrae Sanctae (1626)
descrisse con minuzia di particolare tutti i mosaici parietali.
Al
primo livello, sul lato destro, sono rappresentati San Giuseppe e gli
antenati di Cristo secondo il Vangelo di San Matteo, le cui iscrizioni
sono in latino. Simmetricamente, secondo la testimonianza del Quaresmi,
nel lato sinistro doveva essere rappresentata la genealogia secondo il
Vangelo di Luca. Nella seconda teoria, intervallati da fasci di foglie
d’acanto, sono rappresentati i sette Concili ecumenici, i quattro
Concili Provinciali e i due Sinodi Locali.
Ogni
concilio è rappresentato da un edificio sacro e spiegato con l'aiuto di
un cartiglio in cui si esplicita la decisione presa in quella occasione.
Nel livello più alto delle teorie troviamo la raffigurazione di Angeli
in processione, diretti verso la Grotta della Natività, con fattezze
femminili e vestiti di tuniche bianche. Ai piedi di uno di questi Angeli
è stata rinvenuta la firma del mosaicista “Basil” di probabile
origine siriana.
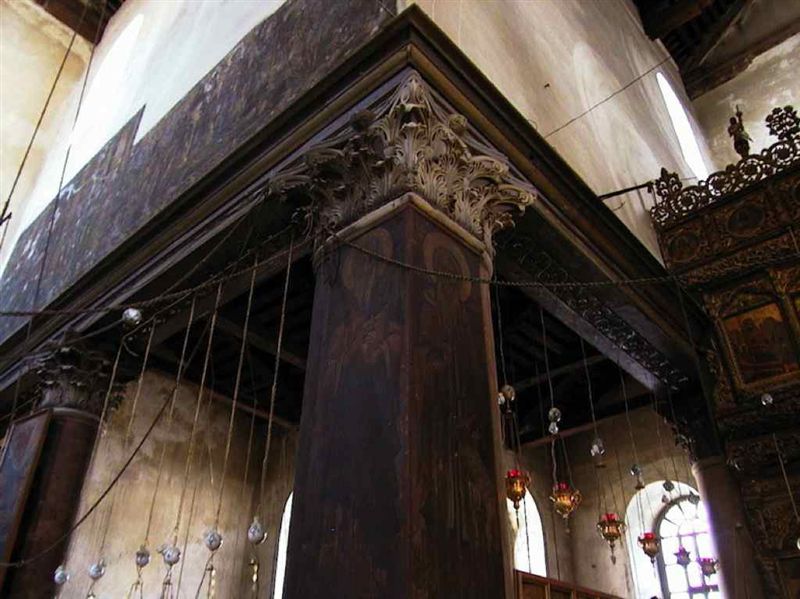
Nella
crociera della basilica, oggi si possono ancora osservare scene desunte
dai Vangeli canoni: l'incredulità di Tommaso, che sembra quella meglio
conservata, l'Ascensione e la Trasfigurazione a nord; l'entrata di Gesù
a Gerualemme a sud.
Nel catino dell’abside principale, secondo la testimonianza del
Quaresmi, doveva essere rappresentata la figura della Vergine con il
Bambino e nell'arco absidale l'Annunciazione di Maria, tra i profeti
Abramo e Davide.
Sulle
mura sottostanti si succedevano scene della vita della Madonna, tratte
dagli scritti apocrifi.
In
contro facciata, sopra il portale d’ingresso, era rappresentato
l'Albero di Iesse con Gesù e i profeti. Il mosaico è ora coperto
dall’intonaco bianco. Il pellegrino Focas nel 1168, dice di aver visto
nella chiesa l'immagine del suo imperatore bizantino, Costantino
Porfirogenito: questo precisa che anche dopo lo scisma del 1154, quando
la basilica era sotto il controllo dei Crociati, esistevano strette
relazioni tra le Chiese d'Oriente e d'Occidente.
Un’iscrizione,
fatta nell’abside principale, menziona insieme i nomi di Manuele
Comneno e Manrico di Gerusalemme, perciò i mosaici devono essere stati
realizzati prima del 1169, nelle ultime decadi della presenza crociata
in Palestina che termina nel 1187. I committenti sono sia il re crociato
di Gerusalemme che l’imperatore bizantino: un esempio di
collaborazione che è praticamente unico nella storia e che esalta
l’importanza che aveva al tempo il Santuario.
Gli
ultimi studi effettuati dopo i rilievi per i restauri, hanno sollevato
una nuova questione relativa all’origine delle maestranze impiegate
nei mosaici. L’ipotesi punta l’attenzione sulla possibilità che
siano stati degli artisti locali a lavorare al progetto decorativo, come
avveniva normalmente, per motivi di praticità. Le firme dei mosaicisti,
Efram e Basil, nomi di sicura origine siriana, sono un buon indicatore
per l’attribuzione delle maestranze. E’ anche possibile ipotizzare
che siano intervenuti dei maestri o dei progettisti greci, ma è anche
chiaro che chi ha elaborato queste decorazioni conosceva bene i grandi
monumenti della Terra Santa, realizzati da artisti provenienti da
occidente.
Per
esempio, nella fascia decorativa della navata che separa i Concili dalle
grandi figure degli angeli in alto, dove sono le finestre, c’è una
stretta fascia decorativa in cui compare una maschera animale tipica
dell’arte romanica europea. Quindi, nei mosaici di Betlemme si
riscontra questo rapporto stretto tra arte bizantina e arte occidentale,
armonizzate insieme.
Le
ultime ricerche affermano che, dal punto di vista musivo, nella basilica
è contenuta la più grande esperienza artistica di epoca crociata, che
si produsse nell’incontro tra arte bizantina e crociata. I mosaici
presentano così il “volto” Ecumenico, che la basilica della Natività
di Gesù è ancora oggi per coloro che la visitano: il punto di unione
tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente.

Presbiterio
- L'iconostasi greca posta sul presbiterio risale al 1764. Questa area
sovrastante la Grotta, nella primitiva basilica bizantina era di forma
ottagonale, come è stato rilevato dagli scavi del 1932-1934.
Secondo
le indagini e le ricostruzioni, nel IV sec. dalle scalinate che
seguivano il perimetro ottagonale delle mura perimetrali si poteva
accedere al presbiterio. In questa zona della basilica all'interno del
perimetro dell'ottagono, sotto l'attuale pavimento, sono state rinvenute
decorazioni a mosaico simili a quelle della navata centrale, ma molto più
ricco con raffigurazioni animali e vegetali e con elementi geometrici.
La
zona sacra descritta è quella che subì più trasformazioni in epoca
giustinianea. Tutta l’area absidale fu ampliata in tre direzioni con
l’aggiunta di tre ampie absidi in forma di croce.
Il
baldacchino fu sostenuto da un vero e proprio presbiterio di forma
lunare collocato al centro dell’area, in modo da far circolare
liberamente i pellegrini intorno al Luogo santo. In questa occasione
venne trasformato l’ingresso alla grotta e furono create due entrate.
Segue.....
 Pag.
2
Pag.
2
Fonte: http://www.betlemme.custodia.org/
|