|
Grotta
della natività e Pozzo
dei Magi
L'ingresso
è oggi posto lateralmente
al luogo della nascita di
Gesù, ma si ipotizza che
nel IV sec. fosse
collocato davanti, nella
zona presbiteriale. Le
piccole facciate dei due
ingressi laterali
risalgono al tempo dei
crociati.
Scendendo
la scala posta sulla
destra dell'iconostasi si
entra dentro la Grotta
della Natività. Qui lo
spazio è molto stretto e
angusto e le mura,
originariamente
irregolari, formano un
perimetro quasi
rettangolare.


Le
pareti naturali della
grotta abbellite in epoca
costantiniana, furono
ricoperte di marmo in
epoca bizantina. S’iniziò
a venerare l'altare della
Natività solo quando in
epoca bizantina fu creato
questo spazio in ricordo
del luogo preciso della
nascita di Gesù.
L’attuale
struttura è ormai
totalmente modificata da
quella descritta dal
pellegrino Focas e
dall'Abate Daniele nel XII
sec.
Due
colonne in pietra rossa e
l'iscrizione «Gloria in
excelsis Deo et in terra
pax hominibus» sovrastano
l'altare, sopra al quale
sono rappresentati la
Vergine e il Bambino in
fasce, la scena del
lavacro e quella della
venuta dei pastori. Sotto
l'altare è posta la
stella con l'iscrizione
latina: «Hic de Virgine
Maria Iesus Christus natus
est» in ricordo del luogo
preciso della Natività.

A
destra dell'altare sta il
luogo dove Maria pose Gesù
dentro la mangiatoia,
detto anche "del
Presepio". In questo
punto della Grotta il
pavimento è più basso e
il vano è costituito da
colonne simili a quelle
bizantine della navata
centrale della basilica e
da resti di due colonne
crociate. Di fronte al
Presepio c'è un piccolo
altare dedicato ai Magi,
dove i latini celebrano la
Santa Messa.
 La
struttura del presepio non
è originale ma è il
risultato di ritocchi
derivati dalla continua
usura del tempo e del
passaggio dei pellegrini. La
struttura del presepio non
è originale ma è il
risultato di ritocchi
derivati dalla continua
usura del tempo e del
passaggio dei pellegrini.
Dopo l'incendio del 1869
le pareti della Grotta
furono ricoperte di
amianto per prevenire gli
incendi, donato dal
Presidente della
Repubblica Francese, il
Maresciallo MacMahon, nel
1874. Al disotto del
rivestimento sono ancora
visibili i marmi crociati
originari; mentre al di
sopra si possono vedere
dei dipinti su tavola.
Il
“pozzo detto dei
Magi”, che in epoca
antica attirava la
curiosità di molti
pellegrini, è posto a
destra dell'altre della
Natività. La tradizione
tramandata che nella
cisterna si riflesse la
luce della stella che
indicava ai Magi il luogo
esatto della nascita del
Messia.
Come
raccontano diversi
testimoni, la luce della
stella rimase impressa nel
pozzo: “… e sul lato
settentrionale della
grotta ci è un pozzo
senza fondo, e
nell’acqua del pozzo si
vede la stella che fu
compagna dei Magi”
(Epifanio monaco, sec. XI
d.C.).
Grotta
di San Giuseppe
Seguendo
il percorso della
Processione Quotidiana,
uscendo dalla Grotta della
Natività attraverso il
cunicolo costruito dai
francescani per garantire
un passaggio diretto al
Luogo santo, si accede
alla Grotta di San
Giuseppe. Questa,
rivisitata in stile
moderno dall'architetto
Farina, doveva essere
l’antro più vicino al
Luogo della Natività.
Uscendo
dal cunicolo si trova
sulla destra l'altrare di
S. Giuseppe. Frontalmente
sono conservate le
fondazioni di un muro
costantiniano e un arco
pre-costantiniano che
attestano come già tra
I-II sec. il luogo fosse
usato come sepolcreto
“ad sanctos”. Infatti,
l'abitudine di seppellire
i morti vicino ai Luoghi
santi era usanza comune,
anche in occidente, per
esempio a Roma.
Uscendo
dalla zona sotterranea per
entrare nella Chiesa di
Santa Caterina, è
possibile attraversare le
mura di appoggio delle tre
successive ricostruzioni
dell'abside, una di epoca
costantiniana e due
diverse di età bizantina,
una delle quali risulta un
tentativo progettuale non
realizzato.

Grotta
degli innocenti
Mantenendo
le spalle all'altare di S.
Giuseppe si apre, alla
destra, la Grotta degli
Innocenti, dove sono
visibili tre arcosoli
sotto i quali erano
conservati dai due ai
cinque sepolcreti.
Qui
viene fatta memoria della
Strage degli Innocenti
provocata da Erode il
Grande poco dopo la
nascita di Gesù. Nei
primi secoli, la memoria
degli Innocenti era
ricordata nella grotta
vicina, che doveva essere
una fossa comune in cui
furono rinvenute molte
ossa di cadaveri.

Grotta
di San Girolamo
Nella
grotta di passaggio tra la
Grotta di San Giuseppe e
quella di San Girolamo,
troviamo due altari: uno
è dedicato alle sante
Paola ed Eustochio, madre
e figlia seguaci di
Girolamo, e l’altro ai
santi Girolamo ed Eusebio,
teologi e Padri della
Chiesa.
Nel
muro a destra del primo
altare sono collocati tre
sepolcri, disposti come
era nello stile delle
sepolture romane nelle
campagne laziali. Questo
aspetto potrebbe dare
credito all'idea che
fossero presenti a
Betlemme dei fedeli delle
comunità latine, che
mantennero l'abitudine di
seppellire come nell’uso
romano delle catacombe,
dove i corpi venivano
deposti in nicchie
all’interno della
parete.
Dall'ultima
grotta, intitolata a San
Girolamo per la sua
assidua frequentazione
orante di questo complesso
di grotte, è possibile
accedere direttamente al
Chiostro crociato
attraverso delle scale
interne.
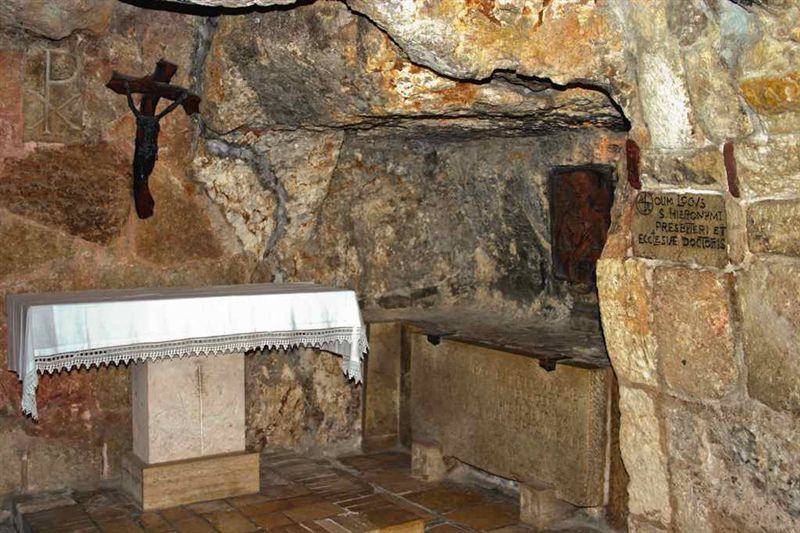
Costruzioni
intorno alla basilica
Il
complesso monumentale
degli edifici sacri, di
cui la basilica della
Natività è il cuore,
copre un'area di circa 12
mila m2 , e comprende,
oltre alla basilica, i
conventi latino (Nord),
greco (Sud-Est), armeno
(Sud-Ovest) e la chiesa
cattolica di S. Caterina
di Alessandria con il
chiostro di S. Girolamo.
La
Chiesa di Santa
Caterina è
accessibile per tre vie:
tramite il transetto nord
della Basilica della
Natività, attraverso le
grotte sotterranee,
passando per il Chiostro
di San Girolamo. La
Chiesa, che appartiene al
complesso del convento
crociato, ha subito
notevoli trasformazioni
negli anni, ultima tra
tutte quella fatta in
occasione del giubileo
dell’anno 2000.

Il
luogo dedicato a Santa
Caterina d'Alessandria già
dal 1347, inizialmente era
solo una piccola
cappellina interna al
Convento francescano, che
corrisponde oggi allo
spazio dell'altare
dedicato a Santa Caterina.
L'antica struttura
descritta dalle piante di
Bernardino Amico, è ora
modificata definitivamente
e lo spazio è stato
ingrandito nel tempo.
L'attuale
edificio sacro è molto
spazioso e luminoso,
costituito da tre navate
con abside sopraelevato in
cui è posto il coro dei
frati. Nell'abside è
rappresentata la scena
della Natività su
vetrata, fatta in epoca
moderna, risalente alle
modifiche dell’anno
2000. In fondo alla navata
di destra è posto
l'altare dedicato a Santa
Caterina; ancora dallo
stesso lato, in uno spazio
che rientra, troviamo
l'altare della Vergine con
la statua del bambin Gesù,
risalente al XVIII sec,
usata durante le
celebrazioni delle
solennità natalizie a
Betlemme.
Meritano
una nota particolare gli
archi crociati ancora
conservati all’ingresso
della chiesa, ormai
inglobati nella struttura,
che facevano parte del
chiostro detto anche di
San Girolamo. In questo
spazio è conservato il
basso rilievo donato dal
Papa in occasione del
Giubileo del 2000.


Il
Chiostro di San
Girolamo, chiamato così
per l'accesso diretto alla
grotta dedicata al Santo,
fu restaurato
dall’architetto Antonio
Barluzzi nel 1947. Per
l’occasione l'architetto
aiutò p. Bagatti nei
rilevamenti archeologici
delle grotte sottostanti.
Per restaurare il chiostro
fu necessario inserire
colonne sostitutive per il
sostegno della struttura.
 Questo
inserimento fu fatto nel
rispetto della
conservazione della
struttura: un chiaro
esempio sono i capitelli
moderni, semplici e
lineari, che si alternano
a quelli crociati più
ricchi nelle decorazioni. Questo
inserimento fu fatto nel
rispetto della
conservazione della
struttura: un chiaro
esempio sono i capitelli
moderni, semplici e
lineari, che si alternano
a quelli crociati più
ricchi nelle decorazioni.
Entrando
dal Chiostro si accede
alla cappella di S. Elena,
ricavata nella base del
campanile crociato, con
affreschi del XII sec,
poco conservati ma
stilisticamente molto
interessanti.
Lungo
il chiostro, sulla destra,
è visibile una porta
d’accesso alla basilica
usata dai Latini per gli
ingressi ufficiali del
Papa, perché il diritto
di ingresso dalla porta
principale è dato solo al
Custode di Terra Santa e
ai Patriarchi.
Sul
lato opposto sta
l'ingresso al Convento
francescano, ampliato
rispetto a quello crociato
di cui restano la sala
d'ingresso con archi a
sesto acuto, le mura
perimetrali con l'accesso
al lato nord al convento,
il deposito e le cisterne,
alcune anche di epoche più
antiche.
Attraverso
i sotterranei del convento
è possibile accedere al
luogo che la tradizione
attribuisce al Lavacro di
Gesù.

Entrando
nel Chiostro di San
Girolamo e dirigendosi
verso la Basilica, è
possibile accedere tramite
una piccola porta alla Cappella
comunemente chiamata di Sant’Elena.
In
periodo crociato il
nartece giustinianeo fu
suddiviso e uno di questi
luoghi fu adibito a
cappella. Questa presenta
elementi
dell’architettura
crociata e affreschi
medievali di pregevole
qualità, risalenti al
XIII sec. secondo lo
studioso P. Vincent, oggi
in cattivo stato di
conservazione.
Nell’abside è
rappresentato Cristo in
trono tra la Vergine e
Giovanni evangelista.
Nell’arcata
è raffigurato
un’interessante
medaglione con
l’etimasia, tema
iconografico bizantino,
che rappresenta un trono
vuoto pronto per
l’arrivo del Cristo
durante il Giudizio
Universale. Nelle altre
pareti sono rappresentate
immagini di Santi.

Convento
francescano
Il
Convento fu costruite
sopra i resti delle grotte
dei primi monaci che
s’insediarono vicino
alla Grotta della Natività
e del primo convento
crociato dei canonici
Agostiniani.
La
struttura essenziale del
convento resta quella
crociata, anche se
ampliata e modificata.
Segni chiari
dell'architettura crociata
sono rimasti ancora
nell'ampio salone di
ingresso del Convento, ma
anche negli spazi
sotterranei. E' possibile
ancora accedere all'antico
spazio di deposito
crociato e attraverso
l'area destinata oggi agli
ascensori è possibile
individuare l'antica
cisterna crociata.
 La
facciata e l'accesso al
Convento crociato erano
disposti nel lato nord
dell'edificio e cioè
lungo l'attuale spazio
dedicato a parcheggio
Conventuale e ingresso al
Casa Nova. La
facciata e l'accesso al
Convento crociato erano
disposti nel lato nord
dell'edificio e cioè
lungo l'attuale spazio
dedicato a parcheggio
Conventuale e ingresso al
Casa Nova.
Il
luogo detto del «Lavacro
di Gesù» è
accessibile solo dal
convento. Il sito, carico
d’interesse storico e
archeologico, non è stato
ancora adeguatamente
studiato. E’ certo però
che la roccia, in questo
luogo, non ha subito
trasformazioni, mantenendo
le stesse caratteristiche
del tempo in cui la Sacra
Famiglia sostò a
Betlemme.
Questo
aspetto di grande
suggestione introduce alla
grotta circolare, al
centro della quale è
scavata una vasca rotonda,
ricordata dalla tradizione
come luogo del primo bagno
di Gesù.
La scena del lavacro non
manca mai nelle icone
orientali e nelle
rappresentazioni antiche
della Natività. Lo spazio
venne riscoperto da un
intraprendente sacrestano
alla fine del XIX sec.
La
sacralità del luogo è
tramandata da alcuni
antichi come Arculfo (De
locis sanctis, 670 d.C.,
Lib. II, cap. 3), che
racconta di essersi lavato
il viso per devozione. Il
sito deve essere ancora
studiato, ma è possibile
ipotizzare che venisse
usato fin dall'antichità.
La
struttura del convento che
ospita i francescani è
ancora quella di epoca
crociata. Diversi spazi
del convento realizzati
nel medioevo sono ancora
visibili, come la Sala
crociata, oggi adibita
a cappella per i
pellegrini, un tempo usata
come magazzino.
Accanto
a questa sala sono
conservate antiche
cisterne di grandi
dimensioni, che
raccoglievano l'acqua
della stagione invernale
per il fabbisogno annuale.
Il
tetto della basilica
A
differenza di numerose
chiese orientali la
copertura del tetto non
era a volta ma a travatura
coperta, come viene
descritto da Ludovico de
Rochechouart prima dei
restauri nel 1461: “Nel
tetto v’è una struttura
lignea costruita in
antichi tempi. Questa di
giorno in giorno va in
rovina soprattutto nel
coro. I Saraceni non
vogliono permettere né di
edificare, né di
riparare, così è un
miracolo del Piccolo che
ivi è nato se resta
ancora”.
Il
tetto della Basilica della
Natività subì un
notevole rifacimento nel
1479 per volontà
dell’allora guardiano
Giovanni Tomacelli. Il
legname, pagato da Filippo
il Buono di Borgogna venne
trasportato dalle navi
veneziane, mentre il
piombo per la copertura fu
regalato dal re Edoardo IV
d’Inghilterra. Un
successivo rifacimento a
opera dei Greci venne
effettuato nel 1671; in
questa occasione fu
sostituito il legno di
cedro con quello di pino
come testimoniato dal
padre Nau.
L’enorme
impiego di materiali e
risorse economiche
produsse il felice
risultato di un tetto che
dura fino ad oggi, anche
se fortemente deteriorato,
degrado che provoca
infiltrazioni d'acqua alle
decorazioni musive
parietali. In particolare
la struttura in piombo,
che in estate raggiunge
temperature altissime, si
modifica con il calore
causando gli spostamenti
della struttura che
provocano le
infiltrazioni. Proponiamo
ai visitatori una
interessante visione aerea
della basilica, dal tetto
da Chiesa di Santa
Caterina che permette di
godere della costruzione
triabsidale del Santuario,
e aiuta a comprendere i
cambiamenti del perimetro
dell’edificio avvenuti
nei diversi secoli.
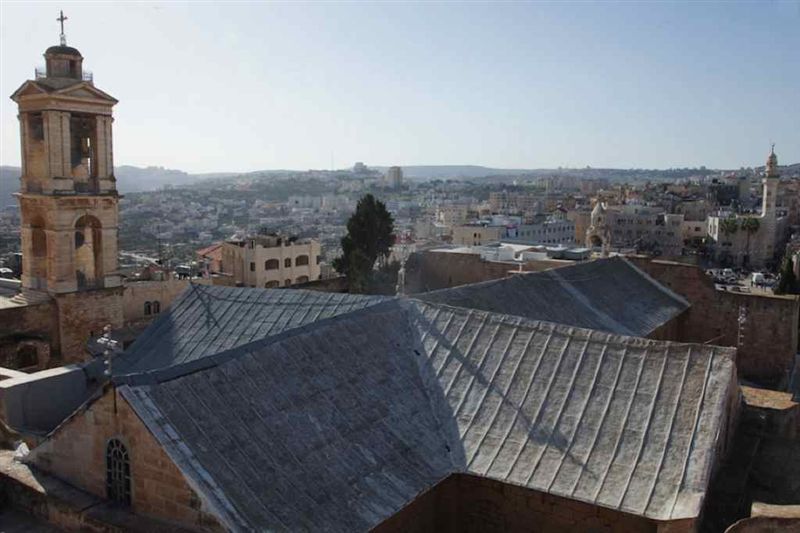
Il
tesoro di Betlemme
Il
tesoro di Betlemme è oggi
conservato presso il Museo
Archeologico dello Studium
Biblicum Franciscanum. Il
tesoro è composto da una
serie di oggetti in bronzo
e argento che
appartenevano alla
Basilica della Natività
in epoca crociata. Questi
furono casualmente
ritrovati in due diversi
momenti, nel 1863 durante
i lavori di restauro
presso la cucina del
convento francescano e nel
1906 durante lo scavo
della fondazione del nuovo
ospizio per i pellegrini.
Il
"tesoro" venne
nascosto con molta cura e
per cause oggi sconosciute
ma che dovevano servire a
proteggerlo da eventuali
saccheggi. È possibile
che questo avvenne dopo il
divieto del 1452 di
Muhammad II, che proibiva
ai cristiani l’uso di
campane. Il tesoro è
composto da:
-
Un
Pastorale smaltato;
-
Tre
Candelieri anch’essi
smaltati e due in
argento con
iscrizioni;
-
Un
Carillon composto da
13 campane;
-
Canne
di Organo di varie
dimensioni;
-
Infine
una croce armena in
metallo rinvenute
negli scavi del
1962-64 da p.
Bellarmino Bagatti.
Inoltre,
sono conservati sempre
all’interno del Museo
della Flagellazione, altri
oggetti d’arte,
ugualmente appartenuti
alla basilica della
Natività.
Nel
1863 durante i lavori per
il restauro della cucina
del Convento francescano e
gli scavi per la
fondazione dell’ospizio
del 1906, vennero
ritrovate tredici campane
assieme a numerose canne
di organo. Questo
ritrovamento fu di
notevole interesse.
Storicamente dobbiamo
ricordare che le fonti
testimoniano che 1187 entrò
in vigore il divieto per i
cristiani di fare uso di
campane. Un simile
provvedimento fu ripetuto
nel 1452 per disposizione
di Muhammad II. E'
plausibile pensare che gli
il Carillon fu rimossi a
seguito di questo decreto
e che in seguito fu deciso
di sotterrare il tutto
nelle vicinanze del
convento.

Le
dodici campane possono
essere distinte in due
serie che costituivano
differenti concerti. La
prima comprende sette
campane di dimensioni più
grandi, ciascuna delle
quali corrispondente a un
suono della scala
diatonica: do, re, mi, fa,
sol, la, si. Nella seconda
serie, quattro delle più
piccole, recano come
decorazione una croce a
rilievo con bracci uguali,
e dall’altra parte una
letterea: C. A. E. D.,
forse corrispondente alle
note do, re, mi, fa. La
quinta, ancora di
dimensioni ridotte, porta
un’iscrizione in lettere
gotiche: +VOX DOMINI
(+Voce di Dio), motivo
ampiamente attestato nel
XIII secolo.
Dodici
di queste sono simili per
la forma stretta e alta e
largamente svasata alla
basa. La tredicesima,
modellata a mano, a
differenza delle altre, è
una campana bassa (timpani
o marmitta), senza
battente.
Le
anse della campana sono
modellate come dei draghi
alati e dava il tono di
fa.
Gli studi si sono
concentrati sul problema
dell’utilizzo di questi
oggetti. Si è discusso se
fossero parte di un
orologio o se fosse stata
una campana cinese. Ma
confrontandolo con altri
esemplari, tra cui uno
recentemente trovato negli
scavi dell’abbazia di
san Samuele a Nabi Samwil,
si è pensato che si
trattasse di un Carillon,
che veniva suonato insieme
all’organo. Il
collegamento era garantito
da battagli ai quali erano
legate delle corde che
potevano essere mosse dal
musicista stesso.
In
base alla data attestata
per la piccola campana al
XIII secolo, si suppone
che esse siano state
prodotte tra XII e XIII
sec. e che, come il
pastorale e i candelabri,
furono portate
dall’Europa sotto
Innocenzo IV dal vescovo
Godefrido de’ Perfetti.
I
bacilli di Betlemme che
recano all’interno le
storie di San Tommaso,
furono fatte probabilmente
per uso liturgico come
acquamanili.
Le
storie incise a bulino,
sono racchiuse tra le due
iscrizioni in lettere
gotiche, superiore e
inferiore. Esemplari
provenienti dalle stessa
bottega sono esposti al
museo del Louvre e al
British. L’epoca di
datazione è riferibile al
XII sec.
I
bacilli di Betlemme che
recano all’interno le
storie di San Tommaso,
furono fatte probabilmente
per uso liturgico come
acquamanili.
Le
storie incise a bulino,
sono racchiuse tra le due
iscrizioni in lettere
gotiche, superiore e
inferiore. Esemplari
provenienti dalle stessa
bottega sono esposti al
museo del Louvre e al
British. L’epoca di
datazione è riferibile al
XII sec.

Segue.....
Pag.
1 
 Pag.
3
Pag.
3
Fonte:
http://www.betlemme.custodia.org/
|