|
Il castello
di Schönbrunn
e gli edifici annessi, insieme
all'ampio parco, è ritenuto
uno dei maggiori monumenti
della civiltà austriaca,
grazie alla sua lunga e
movimentata storia. L'intero
complesso, dichiarato
monumento nazionale, del quale
fanno parte il castello, il
parco con le sue numerose
costruzioni, le fontane e le
statue nonché il giardino
zoologico, il più antico del
mondo, è entrato a far parte
nel 1996 del patrimonio
culturale dell'umanità
dell'UNESCO.
La storia di Schönbrunn e degli
edifici che lo precedettero
risale al Medioevo. L'intera
tenuta veniva definita
"Katterburg" sin
dagli inizi del Trecento, ed
apparteneva ai domini feudali
del convento di
Klosterneuburg. Nei secoli
seguenti passò a vari
affittuari, fra cui alcuni
prestigiosi, come il
borgomastro di Vienna Hermann
Bayer nel 1548, che fece
ampliare la costruzione
trasformandola in una dimora
signorile.
Nel 1569 la tenuta e la residenza
divennero di proprietà degli
Asburgo grazie a Massimiliano
II con un contratto di vendita
che comprendeva un edificio,
un mulino, una stalla, un
parco e un frutteto. Era così
posta la prima pietra per una
residenza di rappresentanza
nonché per il parco e il
giardino zoologico.
L'interesse di Massimiliano fu rivolto principalmente alla
trasformazione del giardino
zoologico, che era destinato
soprattutto alla selvaggina e
al patrimonio avicolo locale.
Nella fagianaia
"Fasangarten" si
allevavano però anche
gallinacei esotici, come i
pavoni e i tacchini.
Dopo la morte improvvisa di
Massimiliano II nel 1576
la Katterburg
passò a Rodolfo II, che
stanziò esclusivamente i
fondi che servivano alla
manutenzione. L'imperatore
Mattia sfruttò la tenuta come
riserva di caccia. La leggenda
vuole che durante una battuta
di caccia nel 1612 scoprisse
la "bella fonte"
("schöner
Brunnen"), dalla quale
derivò il nome di Schönbrunn.

Anche il suo successore Ferdinando II
e la consorte di questi
Eleonora di Gonzaga, entrambi
appassionati cacciatori,
scelsero Schönbrunn come
luogo di soggiorno durante le
battute di caccia. Dopo la
morte di Ferdinando nel 1637
la tenuta divenne la residenza
vedovile di Eleonora, la
quale, amante dell'arte, vi
condusse un'animata vita di
società per la quale aveva
bisogno di una cornice
architettonica di
rappresentanza. Per questo
intorno al 1642 ella fece
costruire un castelletto,
cambiandone il nome da
Katterburg a Schönbrunn, la
cui prima menzione in
documenti ufficiali risale
proprio a quell'anno.
Nel 1683 il castello e il giardino
zoologico di Schönbrunn
furono preda delle
devastazioni per l'assedio di
Vienna da parte dei Turchi.
L'imperatore Leopoldo I, che
ne entrò in possesso nel
1686, prese la decisione di
affidare Schönbrunn all'erede
al trono Giuseppe, e di
costruire per questi un
edificio di rappresentanza.
Quando ben presto, grazie alla
mediazione degli ambienti
aristocratici, l'architetto
Johann Bernhard Fischer von
Erlach, che si era formato a
Roma, giunse alla corte
imperiale, nel 1688 egli
disegnò il cosiddetto
"progetto Schönbrunn
I" per l'imperatore, con
il quale intendeva dar prova
del proprio talento
architettonico e risvegliare
l'interesse del sovrano. Nel
1689 Fischer fu quindi
nominato precettore di
architettura dell'erede al
trono, e si affermò ben
presto come il più richiesto
architetto della corte e della
nobiltà. Nel 1693 Leopoldo I
lo incaricò di eseguire i
progetti concreti per la
costruzione di un castello di
caccia, eretto nel
1696 in
parte ancora sulle fondamenta
del castelletto distrutto dai
Turchi.
Nella primavera del 1700 era
terminata la costruzione del
tratto centrale del castello,
ormai abitabile. Il progetto
di ampliamento con
l'edificazione delle ali
laterali si arenò nel 1701 in
seguito alle difficoltà
finanziarie causate dalle
guerre spagnole di
successione, mentre i lavori
ancora necessari si bloccarono
del tutto alla morte
improvvisa di Giuseppe.
Fischer von Erlach era
responsabile non soltanto
della progettazione del
castello, ma presiedeva anche
i lavori che sorvegliava di
persona. Proprio a questo
grande incarico eminentemente
rappresentativo si deve
probabilmente anche il
conferimento del predicato
nobiliare "von
Erlach", che gli fu
concesso dall'imperatore
Leopoldo.

Il castello incompiuto servì in
seguito come residenza
vedovile di Guglielmina
Amalia. Nel
1728 l'imperatore Carlo VI
entrò in possesso di Schönbrunn,
dov'egli tuttavia si recava
soltanto per la caccia ai
fagiani. Infine egli donò il
complesso alla figlia Maria
Teresa, che come testimoniano
le fonti nutriva già da
sempre una predilezione per il
castello e il giardino. Il
regno di Maria Teresa fu per
Schönbrunn un'epoca di grande
sfarzo, e il castello divenne
il centro della vita politica
e di corte. Sotto la sua
influenza personale e sotto la
direzione dell'architetto
Nikolaus Pacassi, l'ex
castello di caccia di Giuseppe
I fu trasformato ed ampliato
sino a divenire una residenza.
Nell'inverno del 1742/43
ebbero inizio i primi lavori
di costruzione nel castello
incompiuto, che culminarono in
seguito in un progetto di
rifacimento di ampio respiro
al quale il complesso deve in
gran parte l'aspetto odierno.
La prima fase, dal 1743 al
1749, fu già dominata da
Nikolaus Pacassi, che grazie
al suo talento soprattutto
pratico fu promosso primo
architetto e quindi nel 1749
architetto di corte. Dapprima
si iniziò a costruire i
locali destinati alle udienze
e ad abitazione nell'ala
orientale per la futura coppia
imperiale, che ne prese
possesso nel 1746.
Un anno prima si era svolta la
cerimonia di consacrazione
nella cappella del castello,
che pur nella nuova
sistemazione conservava la
struttura e articolazione
spaziale voluta da Fischer von
Erlach.
Durante i lavori di rifacimento
dell'ala orientale furono
creati anche i due cortili
interni e fu costruita la
cosiddetta scala della
cappella, che consentiva di
accedere al piano nobile.
I lavori seguenti, nel 1746,
compresero la demolizione
della scalinata centrale
all'aperto di Fischer von
Erlach sul lato del cortile
d'onore, per creare al piano
terra del risalto centrale un
ampio passaggio coperto e al
piano nobile sovrastante
la Piccola
e Grande Galleria.
Contemporaneamente fu
edificato il cosiddetto
Scalone azzurro nell'ala
occidentale come accesso di
rappresentanza al piano
nobile, senza però
distruggere l'articolazione
delle pareti della sala da
pranzo, voluta all'epoca da
Fischer von Erlach, con il
soffitto affrescato da
Sebastiano Ricci nel 1702/03.
Poiché la famiglia imperiale
si era fatta più numerosa, già
nel 1747 nell'ala orientale si
rese necessario un nuovo
intervento, inserendo un piano
ammezzato fra il piano nobile
e il piano superiore,
destinato ad alloggiare i
figli dell'imperatrice e la
loro corte.

Le due gallerie al centro del
castello offrivano spazio per
i grandi ricevimenti, mentre
la Piccola Galleria
era adibita a salone per le
feste di famiglia in cerchia
più intima. Mancavano ancora
in questo primo rifacimento la
ricca decorazione di stucchi e
gli affreschi del soffitto nei
due saloni delle feste. Alla
Grande Galleria, in occasioni
private, si poteva accedere
anche direttamente attraverso
il nuovo scalone del cortile
d'onore, dalle passatoie
arcuate. Nelle occasioni
ufficiali i visitatori
dovevano invece seguire
l'intero percorso come voleva
la tradizione del "fare
anticamera"', dallo
scalone azzurro alle sale
delle udienze dell'imperatore
e consorte, come prevedeva il
cerimoniale di corte.
Fra gli ulteriori rifacimenti di
quell'epoca si annoverano
anche le arcate di
collegamento lungo il cortile
d'onore con le ali laterali,
definite "ali dei
cavalieri" nelle quali
alloggiava il personale di
corte di rango superiore.
Adiacenti ad esse furono
costruiti ampi fabbricati di
servizio in direzione di
Meidling (fra l'altro
l'Orangerie) e Hietzing.
Questi fabbricati si erano
resi urgentemente necessari,
poiché l'utilizzazione del
castello come residenza della
famiglia imperiale e la
presenza dell'intera corte che
ciò comportava richiedeva il
necessario approvvigionamento.
Dopo tutto Schönbrunn doveva
dare vitto e alloggio ad oltre
1500 persone. Per esplicito
desiderio di Maria Teresa nel
tratto del cortile nord fu
costruito anche un teatro del
castello, inaugurato
solennemente nel 1747. Come
cantanti ed attori vi si
esibivano fra l'altro anche i
numerosi figli
dell'imperatrice, mentre Maria
Teresa in persona dava prova
del suo talento canoro.
Ben presto dopo il 1750 Maria Teresa
si vide costretta a
intraprendere nuovamente un
ampliamento del castello, la
cui progettazione ed
esecuzione nel 1753 - 1763 fu
affidata esclusivamente a
Pacassi. La famiglia imperiale
era rallegrata quasi da una
nascita l'anno, e per
sopperire al fabbisogno di
stanze si rese necessario
l'inserimento di una piano
intermedio anche nell'ala
occidentale.
Grazie a questo intervento la
simmetria esterna
dell'edificio fu ripristinata
e si poté quindi procedere ad
ultimare le facciate. I lavori
della seconda fase di
rifacimenti non si limitarono
all'ampliamento spaziale e
agli esterni, ma si
concentrarono anche sulla
decorazione dei saloni di
rappresentanza.
Le due gallerie in quanto saloni
delle feste furono dotate di
un soffitto a volta, che fu
decorato di magnifici stucchi
ed affreschi che ne fanno la
maggiore testimonianza del
rococò in una reggia
imperiale. Gli affreschi
furono realizzati da Gregorio
Guglielmi fra il 1755 ed il
1761, mentre nel 1761/62
Albert Bolla eseguì gli
stucchi.

Anche le sale prospicienti il
giardino furono decorate in
gran parte in stile rococò,
con forme estremamente
manierate, le cosiddette
rocaille, inserendo specchi e
dipinti fissati al muro oppure
ricorrendo alle cosiddette
"cineserie",
all'epoca di gran moda.
Dopo la morte improvvisa
dell'imperatore Francesco
Stefano I nel 1765, che
addolorò profondamente Maria
Teresa, si ebbe una nuova fase
di rifacimenti. La vedova fece
adibire varie sale nell'ala
orientale del castello a
memoriale del marito, senza
badare a spese nel decorarle
con preziosi pannelli di lacca
cinese e pregiatissime
pannellature di legno tuttora
conservate. Al pianterreno
Maria Teresa fece decorare fra
il 1769 ed il 1777 le
cosiddette stanze Bergl, in
cui abitò sino alla morte
durante i caldi mesi estivi,
di pitture paesaggistiche
esotiche.
Dopo la morte di Maria Teresa il
castello di Schönbrunn restò
disabitato e fu riutilizzato
come residenza estiva soltanto
ai primi dell'Ottocento, sotto
l'imperatore Francesco II. A
quell'epoca risalgono anche le
due occupazioni di Vienna da
parte di Napoleone, nel 1805 e
nel 1809, durante le quali
l'imperatore francese alloggiò
fra l'altro nelle stanze
destinate a memoriale di
Francesco Stefano I, nell'ala
orientale.
In occasione del Congresso di Vienna
nel 1814/15 ci si rese conto
che a Schönbrunn erano
necessari urgenti rifacimenti.
Nel corso di tali lavori
Francesco II fece eseguire fra
il 1817 e il 1819 anche una
trasformazione della facciata
secondo i progetti
dell'architetto di corte
Johann Aman, che comportò
cambiamenti decisivi. Aman
asportò la ricca decorazione
rococò della facciata di
Pacassi e conferì al castello
il suo aspetto attuale,
nell'ormai classico
"giallo Schönbrunn",
con una facciata sobria,
ridotta a pochi elementi
decorativi.
Nel 1830 Francesco Giuseppe nacque
nell'ala orientale del
castello, abitata dai suoi
genitori Francesco Carlo e
Sofia. Educato dalla madre sin
dai primi anni di vita al
futuro ruolo di erede al
trono, Francesco Giuseppe
trascorse i mesi estivi
dell'infanzia e giovinezza a
Schönbrunn. Con la sua ascesa
al trono nel 1848 il castello
avrebbe vissuto una nuova
epoca di splendore, poiché
l'imperatore scelse Schönbrunn
come sua residenza preferita,
in cui trascorse gran parte
della vita. Da giovane
imperatore Francesco Giuseppe
andò a vivere nelle stanze
dell'ala occidentale che
affacciavano sul cortile
d'onore, dov'egli abitò fino
alla morte, avvenuta il 21
novembre del 1916. Mentre le
sale di rappresentanza
rimasero quasi identiche, gli
appartamenti privati
dell'imperatore ricevettero
nuovi arredi. I mobili che si
sono conservati fino ad oggi,
mostrano nel loro carattere
sobrio e borghese una
peculiarità del carattere di
Francesco Giuseppe.
In occasione delle imminenti nozze
con Elisabetta, duchessa di
Baviera, nel 1854, già
durante l'inverno si ebbero
gli interventi di rifacimento
per la futura imperatrice
nell'ala occidentale che dava
sui giardini privati di
Hietzing. Anche l'appartamento
di Elisabetta comprendeva
varie stanze, al centro delle
quali si trovava il salotto
dell'imperatrice, in cui ella
teneva udienza. I locali
adiacenti verso nord, come
la Camera
da letto comune,
la Camera
della toeletta e il Gabinetto
della scala erano le stanze
private di Elisabetta e furono
arredate con pesanti mobili di
palissandro. Il cosiddetto
Gabinetto della scala le
serviva da studio. Qui nel
1862 Elisabetta fece inserire
una scala a chiocciola che le
consentiva di accedere
direttamente ai locali a
pianterreno. Le sale del
pianterreno sottostanti
l'appartamento furono arredate
un anno dopo come autentiche
"camere private" che
davano sul giardino, come più
tardi a Gödöllö, con un
grande salotto e probabilmente
la palestra che era di
prammatica. Le pareti furono
rivestite e i mobili
tappezzati del suo colore
preferito, il violetto.

Al pianterreno del castello furono
arredati anche gli
appartamenti dei figli di
Elisabetta e Francesco
Giuseppe. Per la figlia
maggiore, Gisella, erano state
allestite le stanze adiacenti
a quelle dell'imperatrice,
mentre per Rodolfo fu arredato
nel 1867 il cosiddetto
"appartamento del
principe ereditario", che
dava verso Meidling.
In tutto il pianterreno
nell'intervento di arredamento
per la famiglia di Francesco
Giuseppe si conservarono quasi
tutte le decorazioni di
stucchi dei soffitti,
dell'epoca di Maria Teresa, le
pannellature di legno in
bianco e oro e i paesaggi
dipinti alle pareti. Gli
stucchi di altissimo pregio
artistico alle pareti e ai
soffitti di queste stanze
testimoniano dell'alto livello
raggiunto dall'artigianato
artistico all'epoca di Maria
Teresa.
In occasione dell'imminente
esposizione universale nel
1873 a
Vienna, dal
1869 in
poi si ebbero ampi interventi
di restauro rispettando le
antiche decorazioni rococò
del Settecento, che furono
integrate o ripristinate in
neo-rococò come espressione
dello stile imperiale. I
lavori si concentrarono sulle
due gallerie e sulle stanze
nell'ala orientale, destinate
ad appartamenti per gli
ospiti. In queste sale le
pareti furono rivestite a
nuovo o di parati delle
collezioni imperiali o di
damasco ananas rosso, come si
vede tuttora.
Nel corso di questi lavori si
intervenne nella Piccola
galleria applicando sulla
scagliola, della metà del
Settecento, una monocromia
nella tecnica del bianco
lustrato, riccamente decorata
con composizioni di agrafi,
trofei ed armi.
Le
sale e le stanze del castello
di
Schönbrunn
|
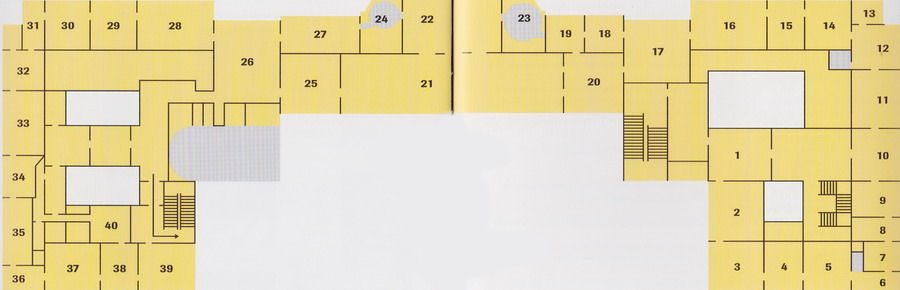
|
-
La
Stanza della Guardia
-
La
Stanza del biliardo
-
La
Stanza di noce
-
Lo
Studio di Francesco
Giuseppe
-
La
Camera da letto e
camera mortuaria di
Francesco
Giuseppe
-
Il
Gabinetto
occidentale a
terrazza
-
Il
Gabinetto della
scala
-
La
Camera della
toeletta
-
La
Camera da letto
comune di Elisabetta
e Francesco Giuseppe
-
Il
Salotto
dell'imperatrice
-
La
Stanza di Maria
Antonietta
-
La
Stanza dei bambini
-
Il
Gabinetto della
prima colazione
-
Il
Salone giallo
-
La
Stanza del balcone
-
La
Stanza degli specchi
-
La
Stanza grande di
Rosa
-
La
prima Stanza piccola
di Rosa
-
La
seconda Stanza
piccola di Rosa
-
La
Stanza delle
lanterne
|
-
La
Grande Galleria
-
La
Piccola Galleria
-
Il
Gabinetto cinese
rotondo
-
Il
Gabinetto cinese
ovale
-
La
Stanza del carosello
-
La
Sala delle cerimonie
-
La
Stanza dei cavalli
-
Il
Salone cinese
azzurro
-
La
Stanza Vieux-Laque
-
La
Stanza di Napoleone
-
La
Stanza delle
porcellane
-
La
Stanza del milione
-
Il
Salone degli arazzi
-
Lo
Studio
dell'arciduchessa
Sofia
-
Il
Salone rosso
-
Il
Gabinetto a terrazza
-
La
Camera ricca
-
Lo
Studio di Francesco
-
Il
Salone di Francesco
Carlo
-
La
Stanza della caccia
|
Ala
Occidentale
In cima allo Scalone azzurro, dietro
un'imponente porta, ha inizio
la romantica visita degli
appartamenti imperiali, un
affascinante percorso
attraverso i secoli. Le sale
del castello di Schönbrunn
furono non soltanto teatro di
innumerevoli festeggiamenti e
residenza della dinastia
asburgica, ma furono anche il
luogo in cui operarono celebri
artisti e artigiani delle più
svariate epoche stilistiche.
Nell'ex
castello di caccia di Giuseppe
I lo Scalone azzurro
fungeva da sala da pranzo e fu
trasformato intorno al 1745 da
Nikolaus Pacassi in scalone di
rappresentanza, intervento
necessario per il castello di
residenza e di famiglia della
sovrana asburgica Maria
Teresa. I rifacimenti non
intaccarono l'affresco del
soffitto, eseguito nel
1701/1702 dal pittore italiano
Sebastiano Ricci, che descrive
la glorificazione dell'erede
al trono Giuseppe, ritratto
come eroe di guerra ed uomo
virtuoso. Il nome dello
scalone deriva dalla
tinteggiatura azzurro chiaro
delle pareti, che risale
all'epoca di Maria Teresa.

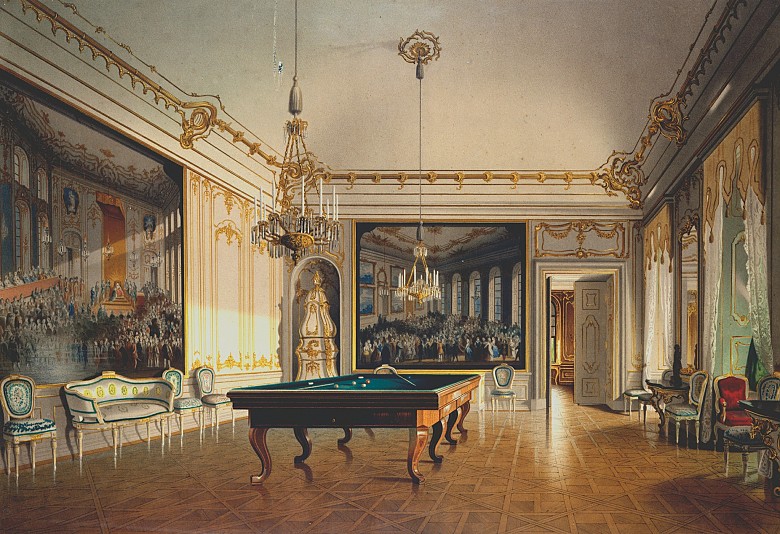
La
Stanza del biliardo
apre la sequela delle sale da
udienza e delle camere private
di Francesco Giuseppe,
penultimo imperatore
asburgico. Gli arredi del suo
appartamento testimoniano il
mondo del sovrano e raccontano
come si svolgesse la sua vita
privata e lavorativa nel
castello: ad esempio il tavolo
da biliardo, gioco all'epoca
assai apprezzato a corte,
menzionato per la prima volta
in questa sala nel 1837.
Varie volte la settimana l'imperatore Francesco Giuseppe
riceveva i membri del suo
governo e le maggiori cariche
militari. Mentre i ministri, i
generali e gli ufficiali
aspettavano in questa sala, si
dilettavano al tavolo da
biliardo di epoca Biedermeier.
I
dipinti al centro la cerimonia
di conferimento dell'Ordine di
Maria Teresa nel 1758, a
sinistra il banchetto nella
Grande Galleria e a destra la
partecipazione di Francesco
Giuseppe al convivio nel parco
in occasione del centenario
della fondazione dell'Ordine),
ritraggono eventi memorabili
della storia asburgica.
La
Stanza di noce fungeva
da sala delle udienze per
Francesco Giuseppe, e deve il
suo nome ai preziosi pannelli
in legno di noce che ne
rivestono le pareti e
risalgono al 1765, quando
l'ala occidentale, dopo la
morte improvvisa di Francesco
Stefano I, fu arredata per
Giuseppe II, reggente insieme
a Maria Teresa. I pannelli
sono incorniciati di listelli
dorati ed adorni di rocaille
anch'esse dorate. Di questa
notevole decorazione rococò
fanno parte anche le consolle
dorate e riccamente intagliate
e il lampadario intagliato di
legno, a quarantotto bracci.
Un secolo dopo furono
realizzati nello stile del
neorococò gli arredi della
Sala delle udienze per
Francesco Giuseppe.
Qui
l'imperatore Francesco
Giuseppe teneva le numerose
udienze con i suoi ministri, i
funzionari di corte e i capi
di governo. Il lunedì
e il giovedì persino ogni
suddito dell'impero che ne
facesse richiesta era ammesso
alle udienze dell'imperatore.
Fu grazie alle udienze che
Francesco Giuseppe divenne un
eccezionale fisionomista,
attitudine che serbò fino ad
età avanzata.

Lo
Studio di Francesco
Giuseppe contrasta
in maniera
eclatante con la Stanza di
noce, che aveva
funzioni di rappresentanza.
Gli arredi sobri nello stile
dello storicismo, nel gusto
tradizionale borghese degli
anni 1860/70, erano consoni
alla natura parsimoniosa
dell'imperatore. Instancabile,
Francesco Giuseppe, che amava
definirsi il primo funzionario
del suo stato, lavorava allo
scrittoio nel vano della
finestra, di solito vestito
del suo "bonjourl"
grigio lupo.
La
giornata lavorativa del
sovrano aveva inizio alle 5
del mattino, e tutte le
pratiche venivano sbrigate con
il medesimo zelo, sia
quelle importanti che quelle
minori, a testimonianza del
suo accentuato amore per
l'ordine che si spingeva fino
alla pedanteria. Mentre
lavorava l'imperatore prendeva
dei pasti frugali che si
faceva servire allo scrittoio,
tra i pacchi di pratiche
sbrigate e quelle non evase.
I due ritratti di grande formato
raffigurano Francesco Giuseppe
all'età di 33 anni e
l'imperatrice Elisabetta,
divenuta un mito e
universalmente nota con il
soprannome di Sisi, entrata
nella leggenda assai prima dei
film nei quali il suo ruolo fu
interpretato da Romy
Schneider. A corroborare il
mito, quando l'imperatrice era
ancora viva, furono la sua
intelligenza, lo spirito
indomito, l'eccentricità e la
straordinaria avvenenza.
Incompresa a corte, Elisabetta
soffriva di depressioni, che
si acuirono dopo il tragico
suicidio a Mayerling del
figlio Rodolfo.

La
Camera da letto e camera
mortuaria di Francesco
Giuseppe fu arredata nel
1868 con gli stessi mobili
imbottiti dello studio, e
sarebbe rimasta quasi identica
per i cinquant'anni seguenti,
fino alla morte
dell'imperatore. Nel corso di
quel mezzo secolo tuttavia vi
si aggiunsero numerose
fonografie e dipinti di membri
della famiglia, figli e
nipoti, nonché
gli oggetti ricordo.
Di
questi fa parte anche il
paravento, adorno di tanti
quadretti di pellegrinaggi
portati in ricordo da
Katharina Schratt, l'amica del
cuore dell'imperatore. Fu
proprio Elisabetta a creare il
contatto fra la celebre
attrice viennese e Francesco
Giuseppe, e a incoraggiarlo
sempre più, perché preferiva
sapere l'imperatore in fidata
compagnia durante le sue
continue assenze. Gli arredi
della camera da letto
dall'aspetto così poco
imperiale, il letto di ferro,
l'inginocchiatoio e il lavabo
di marmo, con gli accessori
dell'epoca, testimoniano della
parsimonia e della semplicità
dell'imperatore, che si alzava
già alle quattro del mattino.
Dopo
aver fatto le abluzioni
mattutine con l'acqua fredda,
Francesco Giuseppe era solito
recitare le preghiere del
mattino, da cattolico
osservante qual era. Nel letto
di ferro spartano l'imperatore
si spense all'età di 86 anni
il 21 novembre del 1916, in
piena Prima guerra mondiale.
Il dipinto di Franz Matsch lo
ritrae 24 ore dopo la morte.
All'uscita della camera è
collocato nel vano della porta
il gabinetto, che fu
installato nel 1899 per
Francesco Giuseppe.


Il
Gabinetto occidentale della
terrazza conduce
all'appartamento
dell'imperatrice Elisabetta.
Vi è
esposto un dipinto del pittore
francese Pierre Benevaux, che
ritrae le figlie minori di
Maria Teresa: Maria
Antonietta, futura regina di
Francia, e Maria Giuseppa.
Per
Sisi, come Elisabetta veniva
affettuosamente chiamata in
famiglia, la vita da
imperatrice in Austria ebbe
inizio in un certo senso
proprio a Schönbrunn. Dopo il
suo arrivo a Vienna, il 22
aprile del 1854, ella
trascorse la prima notte a Schönbrunn,
mentre il giorno seguente si
ebbe l'ingresso solenne nella
città,
residenza imperiale.
 Il
Gabinetto della scala fungeva
da studio di Elisabetta, che
qui curava la sua fitta
corrispondenza, scriveva i
suoi diari e componeva
liriche. Dopo la prima crisi
coniugale, nel
1859, Elisabetta si
rifugiò a Madeira
e per un anno non fece più
ritorno alla corte di
Vienna; al suo ritorno
soggiornò frequentemente a
Schönbrunn. Il
Gabinetto della scala fungeva
da studio di Elisabetta, che
qui curava la sua fitta
corrispondenza, scriveva i
suoi diari e componeva
liriche. Dopo la prima crisi
coniugale, nel
1859, Elisabetta si
rifugiò a Madeira
e per un anno non fece più
ritorno alla corte di
Vienna; al suo ritorno
soggiornò frequentemente a
Schönbrunn.
Nel
suo studio fu costruita una
scala a chiocciola, che oggi
non esiste più,
che conduceva alle stanze
private di Elisabetta al
pianterreno, per lei allestite
a quell'epoca. Di qui
l'imperatrice, che amava la
libertà e rifiutava il rigido
cerimoniale di corte, poteva
uscire quando voleva dal
castello, inosservata agli
occhi di portieri e guardie.
Queste camere, che oggi non esistono
più, non erano arredate
secondo le norme vigenti a
corte, ma secondo il gusto
dell'imperatrice, erano
tappezzate di parati viola ed
ammobiliate con oggetti di
proprietà di Elisabetta.
Inoltre l'appartamento sul giardino
disponeva di una palestra con
camerino per i massaggi e di
un "luogo di decenza
elegante, inodore,
all'inglese": una
toilette.
Poiché l'imperatrice,
estremamente schiva di
carattere, amava fare
frequenti passeggiate nel
parco del castello,
l'appartamento sul giardino le
consentiva di uscire quando
voleva e di rientrare senza
essere osservata dai portieri
e dalla guardia.
La
Camera della toeletta
dell'imperatrice Elisabetta
non poteva mancare in alcun
appartamento di Elisabetta,
poiché
la giornata dell'imperatrice
era scandita dalle cure
estetiche e dallo sport per
conservare una figura
asciutta. L'imperatrice
austriaca era ritenuta una
delle donne più belle del
mondo, fama alla quale avevano
contribuito in maniera
decisiva soprattutto i
ritratti di Franz Xaver
Winterhalter. Ricette speciali
di bellezza, la ginnastica
quotidiana e le diete
servivano a mantenere snella
la sua figura, cosa che
Elisabetta sottolineava
ulteriormente indossando abiti
attillati.
Varie
ore erano dedicate ogni giorno
alla cura della magnifica
chioma, che le sfiorava le
caviglie e che ella amava far
acconciare a forma di corona
intrecciata. Fu cosi che la
parrucchiera Franziska
Feifalik divenne una delle sue
più intime confidenti, e se
la situazione lo consentiva la
parrucchiera spesso fungeva
persino da controfigura
dell'imperatrice, che
rifuggiva dal contatto con il
pubblico.
Fu
Elisabetta stessa a creare il
mito della propria bellezza
eterna. Una volta compiuti i
trent'anni non si fece mai più
ritrarre, e quando si trovava
in pubblico nascondeva il viso
dietro un ventaglio.


La
Camera da letto comune di
Elisabetta e Francesco
Giuseppe fu rivestita nel
1854, l'anno delle nozze, di
tessuti bianchi e blu e
arredata con pesanti mobili di
palissandro, che probabilmente
poco rispondevano al gusto
della stravagante imperatrice.
La camera da letto fu
utilizzata dalla coppia
soltanto nei primi anni di
matrimonio; ben presto
all'imperatore ne venne negato
l'accesso, oppure Elisabetta
s'intratteneva soltanto nelle
sue camere private, a
pianterreno.
Nonostante
Elisabetta gli opponesse
questi rifiuti e l'avesse
tante volte respinto,
Francesco Giuseppe esaudiva
ogni desiderio della sua amata
Sisi, che ben presto imparò
ad usare il potere della
propria bellezza. Fu così che
dagli anni Settanta
dell'Ottocento in poi le fu
possibile condurre vita
autonoma e dedicarsi a lunghi
viaggi, mentre Francesco
Giuseppe divenne sempre più
solitario a causa della sua
assenza.
Adorata
da Francesco Giuseppe anche
dopo la morte, Elisabetta fu
assassinata il 10 settembre
1898 dall'anarchico italiano
Luigi Lucheni a Ginevra.
La
cosiddetta Stanza di Maria
Antonietta, dai pannelli
in bianco ed oro e i
candelabri da parete di vetro
boemo, fungeva all'epoca di
Elisabetta da sala da pranzo
per la famiglia.
La tavola è imbandita per la famiglia con porcellane
viennesi, argenterie da tavola
viennesi della ditta
Mayerhofer & Klinkosch e
bicchieri di cristallo con
sfaccettatura a forma di
prisma della ditta Lobmeyr.
Quando vi pranzava la famiglia
imperiale in cerchia
ristretta, il cerimoniale era
meno rigido che nei banchetti
di corte. L'imperatore stesso
decideva la disposizione dei
posti a tavola ed era concesso
anche chiacchierare da un lato
all'altro della tavola, mentre
nei banchetti di corte ci si
poteva intrattenere soltanto
con il commensale seduto
accanto, bisbigliando.
Nelle occasioni ufficiali si servivano piatti della cucina
francese, mentre nei pranzi di
famiglia si apprezzava la
cucina viennese e le ricette
semplici come Wiener Schnitzel
(una sorta di cotoletta alla
milanese), gulasch, arrosto
alle cipolle, brioche o
Kaiserschmarren (frittatine
con uva passa).
I fiori per le decorazioni a
centrotavola erano forniti
dall'amministrazione dei
giardini di corte di Schönbrunn.
Oltre alle azalee e ai
giacinti per le decorazioni più
preziose si utilizzavano le
orchidee. Nel 1900 nelle serre
del castello crescevano 25.000
orchidee di 1500 varietà,
all'epoca la maggiore raccolta
d'Europa. Il dipinto al centro
ritrae l'imperatrice
Elisabetta ai tempi delle
nozze d'argento, adorna di
rubini e diamanti.
La stanza deve il nome ad un
arazzo che raffigura Maria
Antonietta con i figli. Era un
dono di Napoleone III a
Francesco Giuseppe, ed è
proprietà privata della
famiglia.

Nel
Salotto dell'imperatrice
l'atmosfera è
dominata dai pannelli
bianco-dorati, dalle
tappezzerie di seta chiara e
dai sontuosi arredi nello
stile del neorococò.
L'orologio collocato dinanzi
allo specchio presenta una
particolarità: grazie al
quadrante con le lancette a
rovescio montato sul retro, si
può leggere l'ora anche allo
specchio.
Particolarmente
interessanti sono i dipinti
che adornano il salone. Il
ritratto di Maria Antonietta
in costume da caccia alla moda
dell'epoca è opera di Joseph
Kranzinger,
mentre gli altri dipinti a
pastello vengono attribuiti al
pittore ginevrino Jean-ÈtienneLiotard,
per il quale Maria Teresa
nutriva una particolare
predilezione. Ritraggono
l'erede al trono Giuseppe
all'età di undici anni ed
alcune delle sue sorelle.
Il
salotto faceva parte
dell'appartamento
dell'imperatrice Elisabetta,
cui era collegato mediante lo
scalone azzurro e l'anticamera
dell'imperatrice. Negli anni
Sessanta dell'Ottocento
Elisabetta soggiornò
prevalentemente a Vienna e
grazie alla sua costante
presenza riuscì ad esercitare
influenza crescente
sull'imperatore in materia
politica. E fu in fondo
proprio Elisabetta a favorire
il compromesso con l'Ungheria:
l'unica volta in cui esercitò
il suo ruolo di imperatrice.
 La
cosiddetta Stanza dei
bambini è
adorna dei ritratti di varie
figlie di Maria Teresa. La
cosiddetta Stanza dei
bambini è
adorna dei ritratti di varie
figlie di Maria Teresa.
I
dipinti, che risalgono al 1765
circa, ritraggono la figlia
maggiore Maria Anna,
appassionata di scienze
naturali, in un abito con il
corpetto blu; vestita di pizzo
con il fiocco rosso Maria
Cristina, la figlia preferita
di Maria Teresa, che fu
l'unica a poter sposare l'uomo
che aveva scelto, il duca di
Sassonia-Teschen; Maria
Elisabetta, un tempo così
graziosa, in abito dorato
adorno di rose di stoffa
variopinta, rimase talmente
sfigurata dal vaiolo e in
seguito dal gozzo, da venir
soprannominata in famiglia
"Liesl con il
gozzo"; Maria Amalia, in
abito di velluto rosso con le
maniche di pizzo bianco, andò
sposa al duca di
Borbone-Parma, che aveva
cinque anni meno di lei; Maria
Carolina, che regge tra le
mani un ritratto del padre che
lei stessa aveva eseguito, andò
sposa a Ferdinando, re di
Napoli e di Sicilia, ed oppose
poi veemente resistenza a
Napoleone.
Maria
Antonietta, in abito azzurro
con pizzi bianchi, lasciò la
corte viennese all'età di
quindici anni per andare in
sposa al Delfino francese e
risiedere a Versailles come
futura regina di Francia.
Sulla
sinistra s'intravede la camera
da bagno che fu installata per
l'ultima imperatrice
austriaca, Zita, nel 1917.
Il
Gabinetto della prima
colazione è
adorno di medaglioni fiorati
incorniciati. Questi lavori
d'applicazione montati in
cornice di rocaille furono
eseguiti da Elisabetta
Cristina, la madre di Maria
Teresa.
Per
intere generazioni fu
consuetudine della famiglia
asburgica che i figli
svolgessero attività
artistiche e seguissero una
formazione artigiana. Maria
Teresa e Francesco Stefano I
promossero anch'essi le
attività artistiche dei loro
figli, che parteciparono
attivamente anche alla
decorazione di varie sale di Schönbrunn.
 Il
Salone giallo, situato
sul lato del castello che da
verso il parco, è
arredato con mobili originali
dell'epoca di Maria Teresa. Il
Salone giallo, situato
sul lato del castello che da
verso il parco, è
arredato con mobili originali
dell'epoca di Maria Teresa.
Definita
già intorno alla metà del
Settecento "stanza gialla
fiammingheggiante", solo
di recente la sala è stata
ripristinata nella sua forma
originale grazie al rinnovo
della doratura dei mobili,
datati intorno al 1770, e al
rivestimento con una stoffa di
stile adatto.
A
questo insieme di arredi
tipici dello stile dell'epoca
di Maria Teresa si aggiunge il
secretaire Luigi XVI
realizzato dal celebre
ebanista Adam Weisweiler, uno
scrittoio da donna che giunse
a Vienna come unico oggetto
ricordo della regina di
Francia Maria Antonietta, che
fu ghigliottinata nel 1793.
Notevoli
sono inoltre in questa sala i
numerosi ritratti a pastello
di bambini borghesi del
pittore ginevrino Liotard, che
furono acquistati
personalmente da Maria Teresa:
questi ritratti di fanciulli
contrastano fortemente con i
tipici ritratti di corte dei
figli dell'imperatrice.
Nella
Stanza
del
Balcone
sono
esposti i ritratti dei figli
di Maria Teresa, eseguiti dal
pittore di corte Martin van
Meytens. Fra essi vediamo Maria Elisabetta, che veniva considerata
la più avvenente fra le
figlie di Maria Teresa ed era
ritenuta quindi un ottimo
partito. Tuttavia ella non fu
risparmiata dal temuto vaiolo
nero, e sopravvisse alla
malattia ma il suo volto
rimase sfigurato dalle
cicatrici e non poté più
pertanto essere maritata.
L'unica alternativa per l'arciduchessa fu andarsene in
convento, il che tuttavia non
equivaleva necessariamente ad
una punizione, visto che le
figlie degli imperatori, in
qualità di badesse dei propri
conventi, risiedevano in
appartamenti degni del loro
rango e potevano liberamente
coltivare i propri interessi.
Particolare
attenzione merita il quadro a
grande formato, datato
1751/1752, che ritrae gli
arciduchi Giuseppe, Carlo
Giuseppe e Pietro Leopoldo,
che già
in tenera età furono nominati
condottieri di reggimenti.
Il
principe ereditario Giuseppe
undicenne, raffigurato al
centro, è
ritratto come comandante di un
reggimento di dragoni, benché
in un'uniforme adeguata al
cerimoniale tradizionale di
corte. Carlo Giuseppe (a
destra) è ritratto
nell'uniforme del suo
reggimento ungherese di
fanteria, e Leopoldo (a
sinistra) come piccolo
corazziere.


La
Stanza degli specchi
(dal 1762 in poi detta anche
Salone degli specchi), dalla
magnifica decorazione
bianco-dorata e dagli specchi
di cristallo, è
una tipica sala di
rappresentanza dell'epoca di
Maria Teresa. Le pareti e il
soffitto sono adorni di
rocaille dorate, fra cui sono
montati grandi specchi
incorniciati da girandole di
bronzo: la decorazione rococò
risale al 1755 circa e faceva
da cornice ad udienze e
piccole cerimonie.
Fu
qui
probabilmente
che
il
13 ottobre 1762
l'imperatrice ricevette anche
Leopold Mozart con i suoi
figli, Anna, di undici anni, e
Wolfang, che ne aveva sei. Il
piccolo Wolfgang si esibì
al cospetto di Maria Teresa al
clavicembalo,
"saltandole poi in
grembo, abbracciandola e
sbaciucchiandola per
bene", come raccontava il
padre orgoglioso.
Ala
centrale
L'insieme
delle tre Stanze di Rosa,
realizzate nel 1763/1764
unendo insieme una camera
grande e due piccole, deve il
nome al pittore Joseph Rosa,
che eseguì
su incarico di Maria Teresa 15
paesaggi di grande formato,
montati nei pannelli murali.
Il
primo dipinto a sinistra nella
Stanza grande di Rosa mostra
la residenza originaria della
dinastia, la Fortezza detta
Habichtsburg, in seguito
Habsburg (Asburgo), come
rovina idealizzata, situata
nella legione dell'Aargau in
Svizzera. Questo quadro stava
probabilmente a sottolineare
anche l'interesse di Maria
Teresa per la storia della
dinastia asburgica. Gli altri
dipinti mostrano paesaggi
fluviali e montani idealizzati
con figure accessorie di
contadini, nonché greggi di
capre e pecore al riposo, e
creano un contrasto con la
tipica decorazione rococò in
bianco ed oro.
Nella
Stanza grande di Rosa fra gli
stucchi dorati e le rocaille
manierate sono incastonati
vari strumenti musicali,
un'allusione al fatto che
probabilmente la stanza veniva
usata anche come sala della
musica. Qui si trova il
ritratto di Maria Teresa
regina d'Ungheria, di Martin
van Meytens.
Dalla
seconda Stanza piccola di Rosa
si vede la cosiddetta scala di
Kaunitz, che consentiva al
conte Kaunitz, cancelliere di
stato ed uno dei più
intimi consiglieri di Maria
Teresa che risiedeva al piano
superiore, di avere accesso
diretto al piano nobile.


Nella
Stanza delle lanterne,
i cui rivestimenti di marmo
delle porte risalgono
all'epoca di Giuseppe I, prima
dell'elettrificazione del
castello i servitori sostavano
con le lanterne per indicare
la strada nell'oscurità,
in caso di necessità, ai
sovrani e alla corte.
Lunga
43 metri e larga quasi 10, la Grande
Galleria rappresentava a
cornice ideale per le
cerimonie di corte. Vi si
tenevano balli, ricevimenti in
grande stile e banchetti.
Maria Teresa adorava
festeggiare soprattutto gli
onomastici dei familiari. Le
cerimonie prevedevano di
solito, oltre ad un ballo,
spettacoli teatrali e di danza
in cui si esibivano i figli
dell'imperatrice. Nella vita
normale a corte l'enorme sala
fungeva da anticamera ai
visitatori ammessi all'udienza
presso i sovrani nell'ala
orientale.
Con
l'avvento della Repubblica,
proclamata nel 1918, la
Grande Galleria seguendo la
tradizione ha continuato a
fungere da cornice a
ricevimenti e concerti. Nel
1961 vi si svolse il
leggendario incontro fra il
presidente americano J.F.
Kennedy e il capo di stato
russo Nikita Kruscev.
Gli
stucchi in bianco ed oro, i
grandi specchi di cristallo e
la volta affrescata della
Grande Galleria creano
un'opera d'arte totale: uno
dei più grandiosi esempi di
salone delle feste rococò
nell'architettura delle regge
europee, realizzato intorno al
1760 da Nikolaus Pacassi
coadiuvato dal pittore
Gregorio Guglielmi e dallo
stuccatore Albert Bolla. Fra i
pilastri che delimitano archi
a tutto sesto la sala si apre
verso il cortile d'onore, e
sul lato opposto verso la
Piccola Galleria, attraverso
arcate inframmezzate da
specchi montati in oro. La
magnifica decorazione di
stucchi dorati pare quasi far
dileguare il confine fra le pareti
e il soffitto, mentre le
ghirlande dorate di fiori e i
modiglioni sospesi creano il
trait d'union con le volte
affrescate del soffitto,
collegate da trofei e motivi
araldici a tutto tondo.
Gli
affreschi della volta, opera
del pittore italiano
Guglielmi, sono raffigurazioni
allegoriche che alludono
chiaramente alla situazione
politica, militare ed
economica dell'epoca.
L'affresco centrale datato
1760, nonostante la
contemporanea guerra con la
Prussia, mostra il benessere
della monarchia sotto Maria
Teresa, che troneggia al
centro con Francesco Stefano
I, circondata dalle
personificazioni delle virtù
Prudentia, Fortitudo e
Justitia. Intorno a questo
gruppo si raccolgono le
allegorie dei territori della
corona asburgica con le loro
ricchezze, e fra essi
Mercurio, il dio del
commercio, che collega il
divino al terreno.
L'affresco
ad ovest, realizzato l'anno
dopo, mostra un'allegoria
della pace e raffigura la
prosperità
delle terre della corona, resa
possibile da Concordia, allo
zenit dell'affresco,
circondata da Abundantia e
Pax. L'affresco ad est, che
raffigura un'allegoria
militare, fu distrutto dai
bombardamenti nell'aprile del
1945, nelle ultime giornate
della Seconda guerra mondiale,
e fu sostituito da una copia
nel 1947/1948. Al centro
dell'affresco compare su un
cavallo bianco il dio della
guerra Marte, e sotto di esso
Minerva, la dea dell'arte
della guerra. Quest' ultima
troneggia inoltre librandosi
come patrona al di sopra di
una lezione nell'Accademia
militare di Maria Teresa,
descritta con grande efficacia
pittorica. Infine vi sono
raffigurate la fanteria, la
cavalleria e l'artiglieria.
L'illuminazione originale
della sala, con innumerevoli
candele di cera che
rischiaravano la Grande
Galleria nel riverbero della
monocromia nella tecnica del
bianco, fu sostituita nel 1901
da ben 1104 lampadine.

La
Piccola Galleria fu
arredata contemporaneamente
alla Grande Galleria e serviva
ai tempi di Maria Teresa per
le feste in cerchia familiare
ristretta. Durante i restauri
avvenuti intorno al 1870 la
scagliola originaria
bianco-rosata delle pareti,
dell'epoca di Maria Teresa, fu
eliminata e sostituita dalla
monocromia nella tecnica del
bianco lustrato e vi fu
apposta una esuberante
decorazione di stucchi in
bianco ed oro in stile
neorococò.
L'affresco
del soffitto, anch'esso di
Gregorio Guglielmi, non fu
intaccato da tali rifacimenti.
Anche questo affresco
raffigura un'allegoria, la
glorificazione del saggio e
mite governo della casa
d'Asburgo in Austria.
Al
centro si staglia Aeternitas,
caratterizzata dalla ruota
dell'eternità, che regge la
corona arciducale sopra ad una
gru bianca retta da
Chronos.
 Ai
suoi piedi il dio della guerra
Marte occupa la posizione
centrale. Protetta dal suo
mantello vediamo la lupa con i
gemelli, e lo stendardo con
S.P.Q.R. che allude
all'origine romana dell'impero
e quindi a Francesco Stefano
I, imperatore del Sacro Romano
impero della nazione
germanica. Ai
suoi piedi il dio della guerra
Marte occupa la posizione
centrale. Protetta dal suo
mantello vediamo la lupa con i
gemelli, e lo stendardo con
S.P.Q.R. che allude
all'origine romana dell'impero
e quindi a Francesco Stefano
I, imperatore del Sacro Romano
impero della nazione
germanica.
Come
personificazione del Sacro
Romano impero sul lato breve a
destra è
raffigurato un vecchio, il
capo cinto d'alloro, con la
corona imperiale, lo scettro,
il globo imperiale, la
bandiera e il toson d'oro, cui
un genio alato mostra la
pietra filosofale. Sul lato
opposto si allude alla mitezza
e giustizia di Maria Teresa:
vediamo Clementia come
personificazione della
mitezza, con le fiamme sulla
fronte, che indica
l'iscrizione "Regnum me
comite (eri)t (iust)um"
(Il mio regno sia giusto),
mentre di fronte a lei
troneggia Justitia,
caratterizzata dalla bilancia
e la spada.
La
Piccola Galleria si apre sul
grande parterre del parco e
verso la Gloriette, sulla
sommità dell'altura di Schönbrunn.
Sui
lati della Piccola Galleria si
trovano i Gabinetti cinesi,
a sinistra quello ovale, a
destra quello rotondo, due
stanze dal carattere
squisitamente intimo che Maria
Teresa amava adoperare come
salottini, ad esempio per
giocare a carte. Prima che vi
venissero applicate le
cineserie, il gabinetto
rotondo veniva usato anche
come saletta delle conferenze,
in cui si svolgeva la
cosiddetta "Table de
Conspiration", la tavola
delle cospirazioni: erano
conferenze segrete i cui
partecipanti venivano
rifocillati grazie ad un
montavivande che saliva dalla
sala inferiore al pianterreno,
senza essere disturbati o
spiati dai servitori.
Intorno
al 1760 i due gabinetti
vennero adornati di preziose
cineserie, e sono una
testimonianza della passione
ed ammirazione per i lavori in
lacca dell'Estremo Oriente, le
tappezzerie di seta e le
porcellane cinesi e
giapponesi, sempre più
diffuse nelle regge europee a
partire dai primi del
Settecento.
Anche
Maria Teresa amava queste
cineserie, che comparvero in
varie sale di Schönbrunn. I
gabinetti cinesi sono adorni
di un'intelaiatura di legno
bianco con rocaille riccamente
dorate. Fra gli specchi sono
montati pannelli cinesi di
lacca di varie misure e forme,
su cui sono dipinti paesaggi,
fiori e uccelli. Dalle loro
cornici dorate sporgono
piccole consolle su cui
poggiano statuine e vasi di
porcellana bianca e blu.
Notevoli
sono anche i lampadari rococò
dorati a fuoco della stessa
epoca, con boccioli e
piattelli di smalto, nonché i
preziosi pavimenti ad intarsio
di vari legni esotici e
locali, dal complesso disegno.


La
Stanza del carosello
fungeva da sala d'attesa prima
delle udienze di Maria Teresa
e del consorte Francesco
Stefano I di Lorena. La stanza
prende il nome da uno dei
dipinti che l'adornano, il
Carosello di dame, organizzato
nel 1743 nella Cavallerizza
d'inverno della Hofburg per
celebrare la ritirata di
Francesi e Bavaresi dalla
Boemia, che dopo la morte del
padre Carlo VI incalzavano
Maria Teresa.
La
giovane sovrana è
ritratta su un cavallo bianco
nell'atto di condurre la
quadriglia a cavallo, seguita
da altre quadriglie in
carrozzette
a
conchiglia intarsiate
e argentate, una delle quali è
conservata nel Museo delle
carrozze.
Il
dipinto che ritrae il
conferimento dell'Ordine di
Santo Stefano documenta un
altro evento significativo del
regno di Maria Teresa. I due
ritratti, quello di Carlo VI e
di Giuseppe II fanciulli, li
raffigurano con indosso i
sontuosi abiti di corte
spagnoli.
L'adiacente
Sala delle cerimonie
fungeva non soltanto da
seconda anticamera per
Francesco Stefano I ma anche
da salone delle feste per
cerimonie di famiglia come
battesimi, compleanni e
onomastici, matrimoni del
personale di corte
aristocratico e banchetti di
corte.
 Degli
arredi che risalgono intorno
al 1760 fa parte anche la
magnifica decorazione a
rocaille, ulteriormente
esaltata dagli ornamenti
plastici della volta. La
decorazione di stucchi dorati
sulle pareti intelaiate di
bianco è
opera di Albert Bolla, come
nella Grande Galleria; ricorda
l'antico nome di "Sala
delle battaglie" la
decorazione della volta, che
presenta giavellotti, trofei,
bandiere ed altri strumenti di
guerra, che alludono al potere
della monarchia. Degli
arredi che risalgono intorno
al 1760 fa parte anche la
magnifica decorazione a
rocaille, ulteriormente
esaltata dagli ornamenti
plastici della volta. La
decorazione di stucchi dorati
sulle pareti intelaiate di
bianco è
opera di Albert Bolla, come
nella Grande Galleria; ricorda
l'antico nome di "Sala
delle battaglie" la
decorazione della volta, che
presenta giavellotti, trofei,
bandiere ed altri strumenti di
guerra, che alludono al potere
della monarchia.
La
Sala delle cerimonie si
distingue soprattutto per i
dipinti monumentali
commissionati da Maria Teresa.
Il ciclo pittorico raffigura
un evento politico-sociale
nonché familiare, ossia le
nozze fra l'erede al trono
Giuseppe ed Isabella di Parma,
della casa reale francese dei
Borbone, avvenute nel 1760.
Anche
questo matrimonio, come la
maggior parte degli altri
combinati per i suoi figli, fu
un'abile mossa politica di
Maria Teresa, per alleare la
Francia all'Austria. Il
dipinto più
grande della serie ritrae
l'ingresso a Vienna della
principessa di Parma, il 5
ottobre 1760, con la Hofburg
sullo sfondo.
L'enorme
spiazzo immaginario davanti
agli edifici della Hofburg
ospita 94 carrozze a sei
cavalli. Il corteo si chiude
con la carrozza dorata
dell'ambasciatore della sposa,
il principe di Liechtenstein,
e la carrozza blu e argento
della sposa, scortata dalle
guardie svizzere imperiali in
uniformi nere e gialle. Gli
altri dipinti del ciclo
raffigurano le nozze nella
chiesa degli Agostiniani, il
banchetto nuziale nella grande
Anticamera della Hofburg, la
cena e la serenata nella Sala
della ridotta. A pranzo la
mensa a ferro di cavallo era
stata imbandita nella Hofburg
con un nuovo servizio d'oro: a
capotavola siedono Francesco
Stefano I e Maria Teresa, ai
loro lati gli sposi e quindi
la famiglia imperiale.
L'orchestra
in primo piano offre
l'accompagnamento musicale per
il banchetto, servito da alti
aristocratici nell'abito di
corte spagnolo. Per il
banchetto serale nella Sala
della ridotta la mensa dei
dolci è
stata imbandita in porcellana.
La parte interna della tavola
a ferro di cavallo è decorata
da un centrotavola allungato
con un giardino fatto di
zucchero colorato e numerose
figure. Pochi giorni dopo si
svolse nella Sala della
ridotta anche la serenata, cui
la famiglia imperiale
assistette seduta in prima
fila.
 Ciò
che colpisce in questi
dipinti, oltre al formato, è
la fedeltà ai dettagli negli
edifici, nei personaggi e
negli abiti, fino ad arrivare
ai servizi da tavola. Mentre
la bottega di van Meytens era
impegnata nella realizzazione
di questi dipinti, che durò
vari anni, nell'ultimo quadro
qui descritto fu aggiunto
Mozart bambino nella fila di
spettatori, poiché la sua
leggendaria esibizione al
cospetto della famiglia
imperiale a Schönbrunn
aveva fatto scalpore. E'
inserito in questo ciclo di
dipinti il ritratto forse più
celebre di Maria Teresa,
raffigurata come "prima
donna d'Europa" con
indosso un abito di pizzi
brabantini al tombolo. Ciò
che colpisce in questi
dipinti, oltre al formato, è
la fedeltà ai dettagli negli
edifici, nei personaggi e
negli abiti, fino ad arrivare
ai servizi da tavola. Mentre
la bottega di van Meytens era
impegnata nella realizzazione
di questi dipinti, che durò
vari anni, nell'ultimo quadro
qui descritto fu aggiunto
Mozart bambino nella fila di
spettatori, poiché la sua
leggendaria esibizione al
cospetto della famiglia
imperiale a Schönbrunn
aveva fatto scalpore. E'
inserito in questo ciclo di
dipinti il ritratto forse più
celebre di Maria Teresa,
raffigurata come "prima
donna d'Europa" con
indosso un abito di pizzi
brabantini al tombolo.
Dalla
Sala delle Cerimonie si vede
la Stanza dei cavalli,
dov'è
apparecchiata la cosiddetta
"tavola del
maresciallo" secondo un
modello del 1852: era una
tavola solennemente imbandita
per le cariche supreme di
corte e gli alti ufficiali
quando non era presente
l'imperatore.
La
stanza prende il nome dai
quadri equestri che vi sono
esposti, risalenti all'epoca
della vedova dell'imperatore
Guglielmina Amalia, e che
furono riutilizzati in altra
collocazione con i nuovi
arredi del 1760 circa.
Questo
ensemble unico, cui si
aggiunge il dipinto in grande
formato di una caccia
ad inseguimento di Giuseppe I
presso Marchegg, testimonia di
quanto fosse centrale il ruolo
dei cavalli nella società
di corte.
I
destrieri nobili ed eleganti,
allevati nelle scuderie di
corte, erano considerati
l'espressione di uno stile di
vita raffinato e di una corte
altamente rappresentativa.
Ala
Orientale
Con
il Salone cinese azzurro
avevano inizio un tempo le
stanze private di Francesco
Stefano I. In origine
rivestite soltanto di pannelli
di noce, le pareti vennero
tappezzate nel 1806 di
preziosi parati di carta di
riso cinesi.
I
parati, che risalgono alla metà
del Settecento, furono
probabilmente già
acquistati da Maria Teresa,
che era appassionata di cineserie,
e poi messi da parte, per cui
fu soltanto sotto l'imperatore
Francesco II/I che trovarono
la loro definitiva
utilizzazione in cinque stanze
del castello di Schönbrunn.
 I
parati si sono tuttavia conservati
nel Salone cinese azzurro:
sono realizzati in carta di
riso e presentano motivi
floreali su uno sfondo chiaro.
Nelle strisce verticali si alternano
un campo ovale ed uno
rettangolare, con scene
disegnate su sfondo azzurro,
dipinto con il prezioso
colorante azzurrite. I
parati si sono tuttavia conservati
nel Salone cinese azzurro:
sono realizzati in carta di
riso e presentano motivi
floreali su uno sfondo chiaro.
Nelle strisce verticali si alternano
un campo ovale ed uno
rettangolare, con scene
disegnate su sfondo azzurro,
dipinto con il prezioso
colorante azzurrite.
Le
scene eseguite in inchiostro
nero e color bronzo dovevano
far conoscere all'osservatore
europeo quattro ambiti
tematici importanti per il
mondo cinese: l'allevamento
del baco e la produzione della
seta, la coltivazione del
riso, la fabbricazione delle
pregiate porcellane e la
coltivazione del te.
I
quadretti sono incorniciati da
spalliere di fiori e bambù
e sovrastati da cesti ricolmi
di fiori intorno a cui
svolazzano uccelli, farfalle
ed insetti.
Notevoli
sono anche i tavoli, con
lastre di marmo nero in cui
sono inseriti preziosi lavori
ad intarsio in pietra dura.
In
questa stanza si svolsero le
trattative con l'ultimo
imperatore, Carlo, che
condussero infine, l'11
novembre 1918, alla sua
rinuncia agli affari di stato.
Il giorno seguente fu
proclamata la repubblica, il
che mise fine anche alla
storia di Schönbrunn
come residenza imperiale.
Alla
morte improvvisa dell'amato
consorte Francesco Stefano I,
la Stanza Vieux-Laque fu
trasformata da Maria Teresa in
sala commemorativa. La
decorazione con i preziosi e
costosi pannelli neri di lacca
provenienti dalle manifatture
imperiali di Pechino, fu
probabilmente creata secondo
un progetto dell'architetto
Isidor Canevale. Concepiti in
origine come paraventi per il
mercato europeo, questi
pannelli di lacca furono
tagliati e montati
nell'intelaiatura di noce.
 Le
pareti e le porte, coronate da
sovrapporte, sono composte da
fasce verticali con cornici
riccamente intagliate e
dorate, mentre sui pannelli di
lacca che vi sono montati sono
dipinte scene di genere,
paesaggi e raffigurazioni di
fiori ed uccelli. Nello stile
delle cornici già si
preannuncia il passaggio dal
rococò al primo classicismo. Le
pareti e le porte, coronate da
sovrapporte, sono composte da
fasce verticali con cornici
riccamente intagliate e
dorate, mentre sui pannelli di
lacca che vi sono montati sono
dipinte scene di genere,
paesaggi e raffigurazioni di
fiori ed uccelli. Nello stile
delle cornici già si
preannuncia il passaggio dal
rococò al primo classicismo.
Particolare
attenzione
meritano i ritratti
commissionati da Maria Teresa
per questa sala commemorativa.
Il ritratto postumo di
Francesco Stefano I è opera
di Pompeo
Batoni, ch eseguì anche il
duplice ritratto di Giuseppe
II e del fratello Leopoldo,
realizzato a Roma nel 1769,
quando i due fratelli vi
soggiornavano per l'elezione
del Papa.
Davanti
a Giuseppe, sul tavolo, c'è
il testo dell'"Esprit des
lois" di Montesquieu, una
delle principali opere
dell'Illuminismo, ai cui
principi s'ispirava l'operato
del giovane imperatore. Il
terzo dipinto di Anton von
Maron ritrae la consorte di
Leopoldo, Maria Ludovica di
Spagna, con la numerosa
figliolanza. Il ritratto di
piccolo formato raffigura
Maria Teresa in lutto.
Dopo
la morte del marito,
l'imperatrice non avrebbe mai
più deposto le vesti
vedovili. Di sublime qualità
è anche il pavimento, che si
distingue non soltanto per i
legni pregiati e la
particolarità degli
ornamenti, ma anche per le
varie sfumature e gli effetti
ottici che ne risultano.
La
Stanza di Napoleone fu
utilizzata come camera da
letto da Napoleone Bonaparte
negli anni 1805 e 1809.
Egli aveva occupato per due
volte Vienna, scegliendo
entrambe le volte Schönbrunn
come quartier generale. Le nozze con Maria Luisa, la figlia dell'imperatore
Francesco II/I, avvenute nel
1810, dovevano sigillare la
pace fra i due sovrani. Da
quelle nozze nacque un figlio
maschio, passato alla storia
con il nome di duca di
Reichstadt.
Dopo che Napoleone, sconfitto, ebbe abdicato, Maria Luisa
portò il piccolo che
all'epoca aveva due anni a
Vienna, dove crebbe alla corte
del nonno Francesco I al
sicuro e protetto dal mondo
esterno. Era il nipotino
preferito dell'imperatore, con
cui condivideva a passione per
la botanica. Il ritratto lo
raffigura bambino nelle vesti
di giardiniere nel parco del
castello di Laxenburg.
Il giovane duca morì nel 1832 di tubercolosi, in questa
stanza, a soli 21 anni. La sua
maschera mortuaria e
l'allodola capelluta che fu il
suo animale domestico
prediletto, ricordano ancora
oggi l'unico figlio legittimo
di Napoleone Bonaparte.


La
Stanza delle porcellane,
arredata nel 1763/1764 secondo
un progetto dell'artista
francese Jean Pillement,
attivo alla corte di Vienna,
serviva a Maria Teresa come
studio e stanza da gioco.
L'intelaiatura di legno
intagliato dipinta in bianco e
azzurro, a imitazione della
porcellana, ne riveste
interamente le pareti sino al
soffitto.
I
pannelli murali sono scanditi
da ghirlande di fiori e frutta
che s'innalzano da una
ringhiera e vengono trattenuti
da ombrellini cinesi. Nei
pannelli sono montati 213
disegni a inchiostro di china
azzurro con scene di genere
cinesi, eseguiti da Francesco
Stefano I e dai suoi figli.
Fanno parte della decorazione
anche quattro medaglioni in
cornice ritratto di Maria
Cristina e del consorte
Alberto di Sassonia-Teschen,
di Isabella di Parma, prima
moglie del principe ereditano
Giuseppe, e dell'imperatore
stesso.
La
cosiddetta Stanza del
milione è
così chiamata per i pannelli
murali di una pregiata qualità
esotica di legno di rosa,
detto "feketin" o
anche "vicatin". La
decorazione era stata in
origine realizzata per il
palazzo del Belvedere, e nel
1766, per ordine di Maria
Teresa, fu trasportata a Schönbrunn.
 Nei
pannelli di
legno pregiato, la cui
superficie crea un disegno di
straordinario pregio estetico,
sono incastonate miniature
indo-persiane del Seicento,
montate in delicate cornici
dorate a rocaille. Per
adattarle alle forme delle
cornici, le
miniature furono tagliate da
membri della famiglia
imperiale e composte a
formare nuovi quadri in una
sorta di collage. Nei
pannelli di
legno pregiato, la cui
superficie crea un disegno di
straordinario pregio estetico,
sono incastonate miniature
indo-persiane del Seicento,
montate in delicate cornici
dorate a rocaille. Per
adattarle alle forme delle
cornici, le
miniature furono tagliate da
membri della famiglia
imperiale e composte a
formare nuovi quadri in una
sorta di collage.
Le
cesure che necessariamente ne
risultano furono integrate da
raffigurazioni del cielo o
paesaggi. Il collage di un
unico cartiglio è
composto talvolta da ben 27
pezzi.
Le
miniature raffigurano scene di
vita del regno indiano dei
gran mogol dell'India del XVI
e XVII sec. La sequela di 61
fogli era stata scritta in
origine per la corte dei mogol
e decorata di quadri che
descrivono in unità
straordinariamente compiuta la
vita privata e di corte di
questi principi indiani di
origine persiana.
Durante
la Seconda guerra mondiale i
pannelli della Stanza del
milione furono smontati e
messi in salvo nelle saline di
Altaussee, per sottrarli al
pericolo incombente ed
evitarne la distruzione. Per
rispettare i criteri di
conservazione, nel 1980 si è
deciso di sostituire alle
miniature, altamente sensibili
alla luce, delle stampe
facsimile di alto pregio e di
custodire gli originali nel
deposito dei manoscritti della
Biblioteca Nazionale
austriaca.
Dalla
Stanza del milione s'intravede
il Gabinetto delle
miniature, con numerosi
quadretti in parte firmati
opera dei figli e del marito
di Maria Teresa. La tavola
della prima colazione è
imbandita di porcellane
dell'Ottocento provenienti dalle
manifatture Thun-Klöslerle e
realizzate pel la corte di
Praga dell'imperatore
Ferdinando II, che nel 1948
aveva abdicato a favore di
Francesco Giuseppe.


La
sala definita Salone degli
arazzi fece parte dal 1837
al 1873 dell'appartamento dei
genitori di Francesco
Giuseppe; Francesco Carlo,
fratello dell'imperatore
Ferdinando I, e la moglie
Sofia, utilizzavano come
salotto questa stanza dagli
arredi semplici e borghesi,
nello stile del Biedermeier.
Nel
1873 a questi arredi furono
sostituiti degli arazzi di
Bruxelles del Settecento:
scene di mercato e portuali,
realizzate secondo progetti di
David Teniers il giovane e
giunte a Vienna nel 1850 dal
palazzo reale di Ofen
(Budapest).
Contemporaneamente
vi si aggiunsero le notevoli
poltrone, anch'esse rivestite
di arazzi che raffigurano i
dodici mesi e i segni
zodiacali.
Il
cosiddetto Studio
dell'arciduchessa Sofia fu
arredato per l'ambiziosa madre
di Francesco Giuseppe. Sofia
perseguì
energicamente e con successo
l'obiettivo che si era
prefissa, ossia portare suo
figlio sul trono asburgico.
Era non soltanto la suocera ma
anche la zia dell'imperatrice
Elisabetta, eppure le due
donne ebbero per tutta la vita
un rapporto conflittuale e
difficile.
Gli
interni neorococò, tipici
dell'epoca di Francesco
Giuseppe, sono adorni di
numerosi ritratti di famiglia
e souvenir. Di quelli che un
tempo furono gli arredi della
camera si conserva soltanto il
secretaire da donna con
elaborati intarsi di
madreperla, che testimonia
dell'eccezionale qualità
artigiana degli ebanisti della
corte viennese ancora
nell'Ottocento.


Nel
Salone rosso, un tempo
biblioteca di Maria Teresa,
sono esposti vari ritratti di
imperatori Asburgo, ad
iniziare con Leopoldo II, che
succedette al fratello
Giuseppe II (1765-1790) per un
breve periodo di regno
(1790-1792). Accanto a lui
vediamo il figlio Francesco,
che dal 1792 era l'ultimo
imperatore del Sacro Romano
Impero col nome di Francesco
II. Nel 1806 egli si vide
costretto a sciogliere il
Sacro Romano Impero a causa
delle guerre napoleoniche. Già
due anni prima aveva elevato
le Terre della corona
asburgica alla dignità
d'Impero d'Austria. Così
Francesco II, ultimo
imperatore del Sacro Romano
Impero della Nazione
Germanica, divenne Francesco
I, primo imperatore d'Austria.
Francesco
II/I (1792-1835) diede in
sposa la sua prima figlia
Maria Luisa a Napoleone, e la
secondogenita Leopoldina, di
cui è
esposto sul cavalletto un
ritratto, all'imperatore del
Brasile. Leopoldina ebbe un
ruolo determinante nel
movimento indipendentista del
Brasile, dove tuttora viene
celebrata come eroina
nazionale.
Gli
altri ritratti raffigurano
l'imperatore Francesco I
(1835-1848) e la consorte
Maria Anna. Ferdinando era il
primogenito di Francesco II/I,
e dovette per questo
succedergli al trono, benché
gravemente malato sin dalla
tenera infanzia. Nel 1848 egli
abdicò in favore del nipote
Francesco Giuseppe, e si ritirò
con la moglie a vivere a
Praga. Quando nel 1875 si
spense a Praga senza aver
avuto figli, nominò Francesco
Giuseppe erede universale
unico del suo immenso
patrimonio privato. Da quel
momento in poi
Francesco
Giuseppe
fu
sufficientemente facoltoso
per poter finanziare senza
problemi i desideri
stravaganti e costosi della
moglie Elisabetta.



Il
Gabinetto a terrazza,
detto anche gabinetto fiorato
a partire dal 1775 viene detto anche Gabinetto dei fiori per le pareti
affrescate di ghirlande di
fiori. Si affaccia sul lato
del Cortile d'onore e
consentiva ai membri della
famiglia imperiale di accedere
ad una terrazza al di sopra
delle arcate che delimitano il
Cortile d'onore. Il soffitto
è decorato di dipinti
pregevoli. Il trompe l'œil
eseguito da Johann Zagelmann
intorno al 1770 mostra un
cielo popolato di putti nel
colorismo tenue tipico del
rococò.
 La
cosiddetta Camera ricca
era un tempo la camera da
letto dei genitori, e in essa
nel 1830 nacque Francesco
Giuseppe. I parati originali
di carta, in parte
ancora
visibili,
con
le
foglie stampate,
risalgono all'epoca in cui vi
abitarono Francesco Carlo e
Sofia, genitori di Francesco
Giuseppe. La
cosiddetta Camera ricca
era un tempo la camera da
letto dei genitori, e in essa
nel 1830 nacque Francesco
Giuseppe. I parati originali
di carta, in parte
ancora
visibili,
con
le
foglie stampate,
risalgono all'epoca in cui vi
abitarono Francesco Carlo e
Sofia, genitori di Francesco
Giuseppe.
Oggi
vi è
esposto l'unico letto di
parata della corte di Vienna
che si sia conservato. Questo
letto sontuoso, costosissimo,
fu commissionato già nel 1723
per la camera da letto
imperiale dei genitori di
Maria Teresa, l'imperatore
Carlo VI ed Elisabetta
Cristina, per la Favorita,
altra residenza degli Asburgo
a Vienna e fu ultimato
soltanto nel 1737. In seguito
divenne di proprietà di Maria
Teresa e fu esposto a scopi di
rappresentanza al piano nobile
dell'ala leopoldina della
Hofburg di Vienna, dove nel
1740 si trasferirono Maria
Teresa e suo marito Francesco Stefano.
In
quanto letto di parata non
faceva parte del mobilio di
uso comune, ma veniva
utilizzato come oggetto con
funzioni cerimoniali, ad
esempio per il battesimo del
principe ereditario Giuseppe
nel 1741. Gli arredi di questa
sontuosa camera da letto
consistono tuttora del letto
di parata con il baldacchino,
la coperta, i pannelli murali
in tessuto e i tendaggi, tutti
in velluto rosso con preziosi
ricami in oro e argento.
Per
garantire al massimo la
conservazione di questi
preziosi tessuti, il letto di
parata viene presentato in
vetrina insieme ai ritratti a
pastello della coppia
imperiale.
Nello
Studio di Francesco Carlo,
che un tempo apparteneva
all'appartamento del padre di
Francesco Giuseppe, i dipinti
ci riportano un'ultima volta
all'epoca di Maria Teresa. Il
celebre ritratto di famiglia
datato 1754, della bottega di
van Meytens, mostra
l'imperatore Francesco Stefano
I e Maria Teresa con undici
dei loro sedici figli:
Ferdinando Carlo, nato nel
giugno del 1754, nel lettino,
il tredicenne Giuseppe nelle
vestì
di corte rosso ed oro, che si
rivolge verso la madre vestita
di raso azzurro, Francesco
Stefano nel tradizionale abito
di corte spagnolo, circondato
dalle figlie maggiori. Inoltre
vi sono esposti anche i
ritratti delle dame che ebbero
un ruolo importante nella vita
di Maria Teresa, a sinistra
accanto alla porta la sorella
Maria Anna, morta in età
giovanile, accanto la madre
Elisabetta Cristina, un tempo
celebre per la sua avvenenza,
e la contessa Fuchs, ex
istitutrice e fidata
confidente, l'unica non
appartenente alla casa
d'Asburgo ad essere sepolta
nella cripta imperiale.
Sul
lato opposto i dipinti
di piccolo formato ci danno
un'idea della produzione
artistica dei figli di Maria
Teresa. Fra l'altro vi è
immortalata la scena della
famiglia imperiale che
festeggia san Niccolò e
Giuseppe II al capezzale della
puerpera, la sua amata
consorte Isabella".


La
Stanza della caccia
conclude la visita del
castello al primo piano, e
allude fra l'altro all'antica
funzione di Schönbrunn
come castello dì caccia. Il
dipinto "Pernici davanti
a Schönbrunn"
di Johann Georg Hamilton
mostra sullo sfondo il
castello così come fu
costruito da Fischer von
Erlach.
Cappella
del castello
- La cappella a pianterreno
consacrata a santa Maria
Maddalena fa parte del primo
castello costruito da Fischer
von Erlach, e non ha subito
cambiamenti di rilievo. Nel
1728 ne erano stati comunque
non soltanto terminati i
lavori di costruzione, ma
ultimati persino gli arredi
(probabilmente su progetto di
Andrea Pozzo). Dopo il 1740
Maria Teresa fece spostare il
portale della cappella,
trasformando e accrescendo il
numero degli oratori e dei
matronei, cui si poteva
accedere dalla Sala delle
cerimonie.
Fino al 1744 furono anche rinnovati gli interni.
L'imperatrice fece montare sul
soffitto i dipinti di Daniel
Gran e sostituì alla pala
d'altare di Joh. Michael
Rothmayr (La visione di santa
Maria Maddalena, oggi nella
chiesa degli Agostiniani), un
dipinto di Paul Tröger (Le
nozze di Maria). Per questo
dipinto Georg Raphael Donner
progettò l'altare di marmo e
creò un rilievo per il
tabernacolo, mentre il suo
allievo Franz Kohl realizzò
un nuovo dossale e la cornice.
L'arcivescovo di Vienna, conte
Sigismondo Kollonitsch,
consacrò la cappella.
Il
pianterreno
Al
pianterreno del castello sul
lato prospiciente il parco,
fra il 1769 ed il 1777 Maria
Teresa commissionò
l'esecuzione di paesaggi
esotici nelle cosiddette
Stanze Bergl; lei stessa
risiedeva nell'appartamento
Goess, che si trovava a
sinistra del vestibolo, mentre
le altre stanze erano
disposizione dei figli che
abitavano ancora a corte.
Maria
Teresa diede incarico di
decorare le stanze del proprio
appartamento al pittore boemo
Johann Wenzel Bergl, mentre
quelle dei suoi figli furono
affidate anche al pittore
Martin Steinrucker.
Le
stanze sono caratterizzate
soprattutto da paesaggi
esotici, una pittura
illusionistica che si
proponeva di fondere gli
interni alla natura che li
circondava.
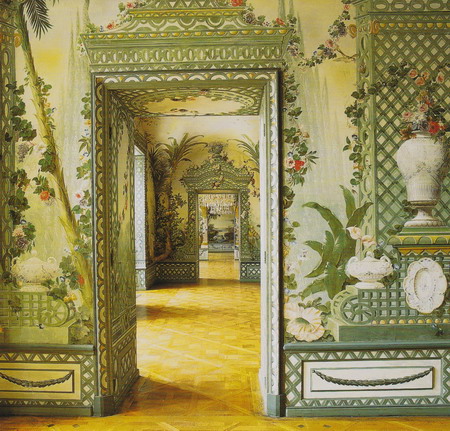 L'Appartamento
Goess e l'Appartamento del
principe ereditario L'Appartamento
Goess e l'Appartamento del
principe ereditario
L'appartamento
Goess, in cui abitò
Maria Teresa, è un complesso
di quattro stanze unitarie dal
punto di vista funzionale ed
artistico, le cui pitture
vanno dal paesaggio esotico
vergine al giardino barocco
costruito, progettato al
tavolo da disegno.
Nelle
prime due sale fra la
vegetazione tropicale
svolazzano uccelli acquatici,
e la natura pacifica è
lussureggiante e rigogliosa ma
si avverte anche la caducità
dei frutti, disposti
artisticamente.
I
particolari spaziali sono
sottolineati soltanto da
portali dipinti, mentre il
soffitto e le pareti si
dileguano fra la vegetazione
che si arrampica in alto.
Nella
terza stanza si arriva al
giardino barocco come
espressione del dominio sulla
natura, cui alludevano già i
drappeggi di seta, il pavone e
i cesti di frutta nella
seconda sala.
L'ultima
stanza è infine un padiglione
dipinto, con una filigrana in
legno come in un vero
giardino. Nell'appartamento
del principe ereditario,
situato lungo la facciata che
dà sui giardini privati
Meidlinger Kammergarten
(Giardini del principe
ereditario), le pitture
raffigurano invece paesaggi
austriaci, cui si integrano
tuttavia gli elementi
scenografici esotici classici.
L'Appartamento
di Gisella e "Vivere Schönbrunn"
L'Appartamento
di Gisella, situato lungo la
facciata sud-occidentale del
castello che da sul parco,
comprende tre stanze dalle
pareti dipinte di paesaggi
esotici, eseguite dai pittori
Bergl e Steinrucker, la
cosiddetta "stanza rococò",
con ariose architetture a
trompe l'oeil, ed altre due
camere in bianco ed oro, in
stile rococò. L'intera
sequela di stanze sulla
facciata occidentale verso il
parco è oggi aperta al
pubblico ed ospita il museo
per i bambini, "Vivere Schönbrunn".
Nei paesaggi illusionistici
nelle cosiddette Stanze Bergl
i motivi esotici delle pitture
sono integrati da scorci
naturalistici reali. In
entrambe le stanze i paesaggi
sono caratterizzati da un
colorismo chiaro: nell'una
predominano tuttavia la flora
e la fauna esotica, nell'altra
invece la raffigurazione
prospettica di città
orientali con moschee e
palazzi, impreziosite
da rovine classiche e
monumenti sul limite anteriore
del dipinto.
Alle
stanze con le pitture
paesistiche è
anteposta una sala ovale nella
quale all'epoca di Maria
Teresa, prima del 1760, veniva
apparecchiata la cosiddetta
"tavola della
cospirazione", che poi
mediante un argano a manovella
veniva sollevata al piano
nobile, nell'attuale Gabinetto
cinese rotondo. Le camere
adiacenti alle Stanze Bergl
ospitano oggi uno spazio
dedicato alla partecipazione
attiva di bambini e adulti,
che possono qui fare
l'esperienza autentica della
vita quotidiana alla corte
imperiale, e comprendere così
la storia del castello e dei
suoi abitanti.
Una
cornice particolare offre la
cosiddetta "stanza rococò",
con la suddivisione spaziale
trompe l'oeil fatta di porte
dipinte e nicchie adorne di
vasi di fiori, e
caratterizzata soprattutto dal
colorismo sfumato tipico del
rococò.

Maggio
2015
 Pag.
2
Pag.
2
|