|
Per la sua lunga storia e le alterne
vicende che
l’accompagnarono, il parco
imperiale di Schönbrunn è
ritenuto uno dei maggiori
monumenti dell’Austria.
Dichiarato monumento
nazionale, l’intero
complesso formato dal castello
con tutti gli edifici annessi,
il parco con i suoi vari
elementi architettonici, le
fontane e le statue nonché il
giardino zoologico, il più
antico del mondo che si sia
conservato, è stato
dichiarato patrimonio
culturale dell’umanità
dall’UNESCO alla fine del
1996.
Il castello e il parco
costituiscono un’unità e
sono in vario modo correlati
l’uno l’altro, così come
voleva la concezione barocca
del castello dei sovrani,
secondo cui l’architettura e
la natura dovevano
compenetrarsi a vicenda.
L’assetto barocco del
giardino è rimasto
praticamente immutato nel
corso del tempo, sin
dall’ultimo decennio di vita
di Maria Teresa, ed è tuttora
fortemente caratteristico del
parco di Schönbrunn.
Nel 1569 la tenuta e la residenza divennero di proprietà
degli Asburgo grazie a
Massimiliano II. L’interesse
dell’imperatore del Sacro
romano impero della nazione
germanica era rivolto
preminentemente alla
costruzione di un serraglio,
per poter soddisfare, oltre al
proprio collezionismo, anche
la passione della caccia
condivisa da tutto il casato
asburgico. Il nuovo
parco voluto da Massimiliano
era quindi destinato non solo
all’allevamento della
selvaggina e del patrimonio
avicolo locale, ma offriva
anche spazio ai gallinacei
esotici, come tacchini e
pavoni, che non potevano
mancare nel parco di un
sovrano.
Il parco recintato della Katterburg fu distrutto ne 1605
dalle truppe ungheresi. Una
volta rimediato ai danni
più gravi, la tenuta fu
sfruttata in seguito
dall’imperatore Mattia
soltanto come riserva di
caccia. La leggenda vuole che
durante una battuta di caccia
nel 1612 egli scoprisse la
“bella fonte” (“schöner
Brunnen”), dalla quale derivò
alcuni decenni più tardi il
nome definitivo Schönbrunn.
Anche il suo successore
Ferdinando II e la consorte di
questi Eleonora di Gonzaga,
entrambi appassionati
cacciatori, scelsero Schönbrunn
come luogo di soggiorno
durante le battute di caccia.
Dopo la morte di Ferdinando
nel 1637 la tenuta
divenne residenza vedovile, e
cinque anni dopo vi fu fatto
costruire un castelletto di
rappresentanza, che da allora
in poi porta il nome Schönbrunn,
menzionato per la prima volta
in documenti ufficiali nel
1642.

Oltre al castello, Eleonora di
Gonzaga, appassionata d’arte
alla stregua dell’omonima
nipote e consorte
dell’imperatore Ferdinando
III, che risedette anch’ella
a Schönbrunn da vedova,
commissionò grandi lavori in
giardino, per poterlo usare
per l’animata vita di società.
Nella seconda metà del
Seicento nel “famose parco
di Scheenbrunn“ si tennero
fra l’altro vari spettacoli
teatrali, cui partecipò come
compositore ed attore
anche l’imperatore Leopoldo
I.
L’assedio di Vienna da parte dei
Turchi, nel 1683, mise
amaramente fine alla vita
culturale. Anche il castello e
il parco di Schönbrunn furono
preda delle devastazioni degli
ottomani.
L’imperatore Leopoldo I, che
ne entrò in possesso nel
1686, prese la decisione
di affidare Schönbrunn
all’erede al trono
Giuseppe, e di costruire per
questi un edificio di
rappresentanza. Quando ben
presto, grazie alla mediazione
degli ambienti aristocratici,
l’architetto Johann Bernhard
Fischer von Erlach, che si era
formato a Roma, giunse alla
corte imperiale, oltre ad un
primo progetto utopico egli
creò un progetto realizzabile
di un castello di caccia, la
cui costruzione ebbe inizio
nel 1696 e che quattro
anni dopo era già abitabile.
Non fu però possibile
ultimarne la costruzione a
causa dei disagi finanziari
sotto il regno di Giuseppe,
dovuti alla guerra di
successione spagnola.
Nel 1695 Jean Trehet, allievo del
grande maestro francese
dell’arte dei giardini André
Le Notre, iniziò a disegnare
il parco. Lungo l’asse
centrale del parco del
castello, Trehet tracciò il
parterre centrale, accentuato
da una vasca a stella e
fiancheggiato da boschetti
laterali. Il parco barocco,
che già all’epoca
probabilmente conteneva
l’immancabile labirinto ed
un aranceto a struttura
circolare, era scandito da
ampi viali.
Alla morte di Giuseppe I nel 1771, il
castello incompiuto di caccia
di Schönbrunn divenne la
residenza vedovile
dell’imperatrice Guglielmina
Amalia. Nel 1728
l’imperatore Carlo VI entrò
in possesso di Schönbrunn,
dov’egli tuttavia si recava
soltanto di rado per la caccia
ai fagiani. Infine egli donò
il complesso alla figlia Maria
Teresa, che nutriva già da
sempre una predilezione per il
castello e i giardini
circostanti. Il regno di Maria
Teresa, iniziato nel 1740 alla
morte improvvisa di Carlo VI,
fu per Schönbrunn un‘epoca
di grande splendore, e il
castello divenne il centro
della vita politica e di
corte. Sotto la direzione
dell’architetto Nikolaus
Pacassi, fra il 1743 ed il
1763 l’ex castello di caccia
fu trasformato, ampliato e
dotato di arredi di estremo
pregio sino a divenire una
sontuosa residenza di stile
rococò.
Mentre i rifacimenti del castello e i
suoi arredi si devono a Maria
Teresa, il consorte
dell’imperatrice, Francesco
Stefano I di Lorena, insieme
alla sua cerchia di artisti
lorenesi, si dedicò alla
realizzazione del parco, che
fu ampliato e articolato da un
nuovo sistema di viali a
stella, collegati visivamente
e da diversi vialetti. I
grandi viali diagonali
s’incontrano al centro del
castello con l’asse centrale
dominante. Il parco barocco di
Schönbrunn aveva funzioni di
rappresentanza per il sovrano,
per cui era concepito come
prosecuzione all’esterno dei
saloni di rappresentanza.
Di fronte alla facciata del castello
prospiciente il giardino, il
parterre occupava
l’estensione maggiore, con
le sue aiuole dal disegno
rigidamente simmetrico. Il
contorno delle aiuole era
tracciato in fine legno di
bosso su pietrine colorate o
sabbia, e da questi ornamenti,
di solito ispirati ai ricami,
derivava il nome di
"broderieparterre",
aiuole merlettate.
Lateralmente crescevano
boschetti, orlati di siepi ed
alberi tosati secondo rigide
forme geometriche e provvisti
di spiazzi e vani nascosti.
Nel 1753 l’imperatore
Francesco Stefano I,
appassionato di scienze
naturali, fece tracciare nella
parte occidentale del parco,
in direzione di Hietzing, un
giardino botanico olandese. Un
anno prima era stato fondato
il serraglio di Schönbrunn.
Mentre il castello e il
giardino intorno al 1770 erano
quasi ultimati, la collina di
Schönbrunn nel prolungamento
del grande parterre continuava
a presentarsi come una radura
nel bosco priva di ornamenti.
Dopo che l’architetto di
corte Johann Ferdinand
Hetzendorf von Hohenberg ebbe
realizzato elaborati progetti,
Maria Teresa, vedova dal 1765,
si decise a malincuore a
favore di una versione
semplificata del nuovo assetto
del parco.
Ai piedi della collina di Schönbrunn
sarebbe sorta
la Fontana di Nettuno e sulla
sommità dell’altura la
Gloriette. La collina stessa,
al posto di un complesso
sistema di terrazzamenti,
sarebbe stata accessibile
mediante semplici sentieri a
zig-zag.
Al nuovo assetto della collina
di Schönbrunn si
accompagnò anche quello del
Grande Parterre, che prevedeva
fra l’altro la collocazione,
nelle siepi che lo
delimitavano lateralmente, di
statue mitologiche, eseguite
nel 1777 da Johann
Wilhelm Beyer e dalla sua
bottega. Allo stesso tempo
furono costruiti anche vari
elementi architettonici nel
parco, fa cui
la Rovina romana,
la Fontana dell’obelisco, la
Bella Fonte e presumibilmente
anche la Piccola Gloriette. I
lavori si conclusero nel 1780,
ultimo anno di vita di Maria
Teresa. Già un anno prima il
parco, ad eccezione del
Giardino privato, era stato
aperto al pubblico.
 Nell’Ottocento il “Giardino
olandese”, che a partire
1753 da Francesco Stefano I
aveva fatto tracciare per la
sua raccolta di piante, fu
trasformato in un parco
all’inglese. Su
quest’area fu costruita fra
il 1880 ed il 1882 la
grande Serra delle palme,
edificio monumentale di vetro,
e fu tracciato il relativo
giardino. Poco lontano da
questa, nel 1904 fu costruito
l’ultimo edificio voluto
dalla casa imperiale,
la Serra
della meridiana, anch’essa
destinata ad ospitare piante
esotiche. Nell’Ottocento il “Giardino
olandese”, che a partire
1753 da Francesco Stefano I
aveva fatto tracciare per la
sua raccolta di piante, fu
trasformato in un parco
all’inglese. Su
quest’area fu costruita fra
il 1880 ed il 1882 la
grande Serra delle palme,
edificio monumentale di vetro,
e fu tracciato il relativo
giardino. Poco lontano da
questa, nel 1904 fu costruito
l’ultimo edificio voluto
dalla casa imperiale,
la Serra
della meridiana, anch’essa
destinata ad ospitare piante
esotiche.
Labirinto Classico
- Tracciato fra il 1698 ed
il 1740, il labirinto di Schönbrunn
consisteva di quattro sezioni
di diversa forma con un
padiglione centrale
presumibilmente sopraelevato,
dal quale si abbracciava con
lo sguardo l'intero percorso.
Nel Settecento il labirinto fu
gradualmente abbandonato,
finché nel 1892 anche le
ultime siepi che restavano
furono tagliate.
Nell'autunno del 1998 nel
parco del castello di Schönbrunn
è stato tracciato un nuovo
labirinto della superficie
complessiva di
1.715 m2
, rispettando il più
possibile il modello storico.
Al centro si trova una
piattaforma panoramica.
Grande parterre - Come
prescrivevano i principi
dell'arte barocca dei
giardini, il parco aveva
funzioni di rappresentanza per
il sovrano, per cui, in
stretto riferimento
all'architettura del castello,
era concepito come
prosecuzione all'esterno dei
saloni di rappresentanza: la
"spina dorsale" del
giardino era formata come
nell'impianto del castello
dall'asse centrale, la cui
simmetria era determinata
dagli assi ortogonali e
diagonali. Di fronte alla
facciata del castello
prospiciente il giardino, il
parterre raggiungeva la sua
massima estensione con le
aiuole dalla rigida simmetria.
Il contorno delle aiuole era
tracciato in fine legno di
bosso su pietrine colorate o
sabbia, e da questi ornamenti,
di solito ispirati ai ricami,
prendevano il nome di
"broderieparterre",
aiuole ricamate. Lateralmente
crescevano i boschetti, orlati
di siepi ed alberi tosati
secondo rigide forme
geometriche e provvisti di
spiazzi e vani nascosti.
Fontana di Nettuno
- Ai piedi del pendio, al
termine del grande parterre,
sorge
la Fontana
di Nettuno, che faceva parte
dell’assetto generale del
parco voluto da Maria Teresa
negli anni Settanta del
Settecento. Nel 1776 si iniziò
a scavare la vasca. I lavori
durarono quattro anni, e la
fontana fu ultimata prima
della morte
dell’imperatrice. Il
progetto fu molto
probabilmente opera di Johann
Ferdinand Hetzendorf von
Hohenberg, mentre il gruppo
scultoreo di marmo di Vipiteno
fu eseguito da Wilhelm Beyer.
Il parapetto rientrante verso
il pendio, provvisto di una
balaustra ornata di vasi, crea
la parete posteriore
dell’enorme vasca.
Al centro s’inarca in avanti un basamento semiovale sul
quale si erge un paesaggio
frastagliato popolato da
Nettuno, dio del mare, con il
suo seguito. Il parapetto e il
basamento sono scanditi da
lastre di rivestimento: sul
basamento esse recano
mascheroni, mentre i sostegni
verticali sono ornati di
ghirlande di fiori. Al centro
del gruppo scultoreo vediamo
Nettuno, che brandisce il
tridente, trasportato su una
carrozza a forma di conchiglia
al di sopra di una grotta
aperta nella roccia.
Alla sua sinistra si trova una ninfa, alla destra invece è
inginocchiata la dea del mare,
Tetide, che implora Nettuno di
favorire il viaggio per mare
di suo figlio Achille, partito
alla conquista di Troia. Ai
piedi della grotta si
affollano i tritoni, creature
per metà pesce e per metà
uomo in grado di seminare
angoscia e terrore fra gli
uomini e gli animali, che
fanno parte del seguito di
Nettuno. Sono raffigurati con
trombe a forma di conchiglia
e guidano gli ippocampi con
cui Nettuno cavalca per i
mari. Il viaggio per mare di
Nettuno che domina
l’elemento dell’acqua,
motivo ricorrente dell’arte
fra Cinquecento e Settecento,
simboleggiava il sovrano che
sa guidare le forze del suo
stato. Al gruppo di Nettuno,
in origine a sé stante, fu
aggiunto nell’Ottocento uno
sfondo di verzura.

Piccola Gloriette
- Al centro di un pendio boschivo e nei pressi dell’attuale
porta di Maria Teresa, sorge
la Piccola Gloriette
, un padiglione a forma di
torre a due piani,
probabilmente costruito
intorno al 1775 da Isidor
Canevale. L’edificio
ottagonale, provvisto di
balconi con scala annessa,
fungeva presumibilmente da
padiglione panoramico.
L’interno è decorato da
ridenti pitture
architettoniche in stile rococò:
dal parapetto al piano
superiore si apre lo sguardo
verso un cielo dipinto.
Rovina
romana
- Denominata anticamente “Rovina di Cartagine”,
la Rovina
romana sorge ai piedi
dell’altura boschiva di Schönbrunn.
Progettata da Johann Ferdinand
Hetzendorf von Hohenberg, fu
costruita nel 1778 e
perfettamente inserita nella
natura circostante: era
concepita come una scenografia
romantica da giardino,
sull’ispirazione di analoghi
ruderi costruiti già prima
della metà del Settecento in
Inghilterra, ma che soltanto
alcuni decenni più tardi
trovarono ampia diffusione.
Hohenberg concepì
la Rovina
romana a Schönbrunn come
un edificio nuovo in tutte le
sue parti, che si ispirava al
modello romano dell’antico
tempio di Vespasiano e Tito, i
cui ruderi erano il soggetto
di un’incisione del 1756 di
Giovanni Battista Piranesi.
Diversamente da quanto accadde per la Gloriette, tutti gli
elementi architettonici, dalle
colonne ai rilievi, furono
costruiti ex novo sotto la
direzione dell’architetto di
corte, come di recente si
è potuto dimostrare. Le
decorazioni in pietra furono
eseguite dagli scultori Beyer,
Henrici e Franz Zächerle.
Soltanto per le pietre
sapientemente collocate a
scopi decorativi intorno alla
Rovina furono utilizzati
frammenti architettonici
provenienti dal castello di
Neugebäude.

L’insieme è formato da un bacino rettangolare chiuso da
un possente arco a tutto sesto
e da ali laterali di mura, che
crea l’impressione di un
palazzo dell’età classica
che sprofonda nel terreno. In
posizione centrale c’è
l’arco a tutto sesto con un
frammento di architrave e
fregio decorato secondo un
modello romano, con
rilievi che raffigurano
vari oggetti sacrificali. Le
mura aggettanti ad angolo
retto presentano, oltre al
rilievo architettonico, una
decorazione di sculture e
busti classicheggianti.
Nello stagno antistante il rudere c’è il gruppo
scultoreo delle due divinità
fluviali Danubio ed Enns,
opera di Wilhelm Beyer. La
radura nel bosco, che sale
alle spalle dell’arco a
tutto sesto centrale, era
anticamente terrazzata, ad
emulare una cascata. Le
terrazze portavano alla statua
di Ercole ritratto nell’atto
di lottare con Cerbero, il
cane a tre teste che stava a
guardia dell’inferno e
personificava i vizi, mentre
già poggia sull’Idra
sconfitta dalla testa di
serpente.
La definizione di Rovina di
Cartagine, diffusa
all’epoca della costruzione,
fa presumere che oltre alla
valenza romantica voluta
dall’architetto, si alluda
qui alla vittoria di Roma
su Cartagine. Dal momento che
gli Asburgo detennero per
secoli e secoli la dignità di
imperatori del Sacro romano
impero della nazione
germanica, e si
consideravano pertanto i
legittimi successori
dell’antico impero romano,
in questo edificio doveva
venire ad espressione anche la
loro rivendicazione dinastica.
Giardino del principe ereditario
- Il Giardino del principe
ereditario fa parte dei
Giardini di corte di Meidling,
e corre proprio lungo la
facciata est del castello. Fu
così battezzato intorno al
1870, quando al pianterreno fu
arredato l’appartamento del
principe ereditario Rodolfo.
Le quattro aiuole del parterre
sono delimitate da una
bordura, e al centro cresce un
vecchio tasso.
Nei mesi estivi vi si conservano, al
riparo dal vento, alcuni
pregevoli esemplari della
preziosa raccolta di agrumi
dell’Ente federale dei
giardini “Bundesgärten”.
La sezione adiacente del giardino
detta “Am Keller“
(ossia “sulla cantina”),
una delle zone più antiche
del parco di Schönbrunn, fu
tracciata proprio al di sopra
della cantina delle
cucine di corte, costruita
intorno al 1700.
Al centro del parterre a
“broderie” diviso in tre
parti, con un elaborato
disegno a ricamo, si trova una
vasca ottogonale. Questa parte
del giardino è delimitata da
un pergolato a ferro di
cavallo con cinque padiglioni
di grata, uno dei quali è una
terrazza panoramica.

Bella
fonte
- Collocata nell’angolo di un sentiero fra le siepi, la
prima fontana, costruita dal
giardiniere di corte
Stekhoven, fu sostituita nel
1771 da quella eseguita
dall’architetto di corte
Isidor Canevale.
Il parapetto a forma di
padiglione quadrato si apre
sia sul retro che sul davanti
in un arco a tutto sesto.
Nell’arco posteriore è
collocata la statua della
ninfa Egeria, opera di Wilhelm
Beyer, sopra la vasca. Egeria
regge sul braccio un’anfora
dalla quale sgorga l’acqua
sorgiva, un tempo tanto
apprezzata alla corte di
Vienna, per riversarsi quindi
nella vasca.
La facciata dell’edificio a
tempietto è ricoperta da un
motivo che ricorda le
stalattiti, allo stesso modo
del frontone triangolare e
della cupola piatta, coronata
da vasi, mentre
l’architrave è decorata di
conchiglie. Anche
all’interno le pareti
presentano la stessa
decorazione a concrezioni
calcaree, mentre gli angoli
sono decorati di fasci di
canne e il soffitto di
ghirlande di fiori.
In una delle pareti è incastonata
una lapide con la
lettera “M” coronata, a
ricordo dell’imperatore
Mattia, che avrebbe scoperto
la Bella Fonte
(Schöner Brunnen).
Fontana
dell'obelisco
- Anch’essa collocata ai piedi della collina di Schönbrunn,
la Fontana
dell’obelisco crea un colpo
d’occhio al limitare del
viale diagonale orientale, e
insieme alla Gloriette
ed alla Menagerie costituisce
una delle attrazioni
principali dell’asse del
parco.
 Come gli altri elementi architettonici del parco,
anche questa fontana fu
costruita da Johann Ferdinand
Hetzendorf von Hohenberg
e secondo l’iscrizione sullo
zoccolo dell’obelisco fu
collocata nel 1777.
Benedict Henrici ne realizzò
le sculture, in parte secondo
progetti di Wilhelm Beyer. Come gli altri elementi architettonici del parco,
anche questa fontana fu
costruita da Johann Ferdinand
Hetzendorf von Hohenberg
e secondo l’iscrizione sullo
zoccolo dell’obelisco fu
collocata nel 1777.
Benedict Henrici ne realizzò
le sculture, in parte secondo
progetti di Wilhelm Beyer.
La fontana è formata da una
vasca circondata da un
parapetto, con una balaustra
guarnita di vasi, appoggiato
contro la scarpata
retrostante. Al centro della
parete si apre una grotta
aggettante sulla vasca, che è
popolata di divinità fluviali
e coronata da un obelisco.
La grotta è scandita da tre vasche, dalle quali
l’acqua si riversa fino alla
vasca della fontana
fuoriuscendo dalla bocca di un
mascherone centrale e dai vasi
delle divinità fluviali.
L’obelisco, sorretto da quattro
tartarughe come simbolo della
stabilità, doveva narrare con
i suoi geroglifici la storia
della dinastia asburgica. Ma i
geroglifici sono frutto
d’invenzione, poiché la
decifrazione di questa
scrittura risale al 1822. Fra
la grotta e il muro una
duplice scala sale verso una
piattaforma dalla quale,
guardando attraverso una
piccola cavità nella grotta,
si ammira il panorama del
viale.
In quanto simboli cosmici, già
secondo gli antichi egizi gli
obelischi erano in
collegamento con il culto del
sole. Coronati da un disco
d’oro come simbolo del sole,
gli obelischi
simboleggiano il percorso dei
raggi del sole fino alla
terra, mentre i quattro angoli
indicano i punti cardinali.
Nell’iconografia barocca
l’obelisco era il simbolo
della stabilità del sovrano e
della solidità del suo
governo. L’aquila sul
disco solare, l’unico essere
che potesse avvicinarsi al
sole senza patir danno,
simboleggia il sovrano, che
media fra il cielo e la terra. La
Fontana
dell’obelisco di Schönbrunn
serviva inoltre probabilmente
a simboleggiare la
rivendicazione inconfutabile e
permanente del regno da parte
del casato asburgico.
Fontana
dell'angelo
-
La
Fontana
dell'angelo
risale probabilmente all'epoca
in cui il parco fu dotato di
sculture, intorno al
1777. In
una descrizione del 1784 si
legge: "... si giunge ad
uno spiazzo, su un lato del
quale si trova un traliccio
verde, con un grande portale e
sei nicchie che ospitano dei
posti a sedere.
Nel
grande portale c'è una grande
vasca d'acqua color rosa
screziato di bianco; al di
sopra due fanciulli siedono su
una balena dalla quale l'acqua
scorre nella vasca." Il
suddetto reticolato fu
sostituito nel 1820/30
dall'attuale ringhiera di
ferro. L'interessante vasca a
forma di conchiglia, in
origine proveniente dal
castello rinascimentale di
Neugebäude nel sobborgo
viennese di Simmering, si
trova oggi nel foyer del
castello. La fontana ha oggi
una nuova vasca a forma di
conchiglia di marmo rosa.


Fontana
rotonda
- Nei due punti d'intersezione dei viali a stella, ad est e
ad ovest del Grande parterre,
si apre uno spiazzo rotondo al
centro di ciascuno dei quali
è collocata una fontana con
la statua di una naiade. Nella
mitologia classica le naiadi,
divinità delle acque e delle
sorgenti, erano al seguito di
Nettuno. I due gruppi
scultorei furono realizzati da
Beyer. Nella Fontana rotonda
(Rundbassin), che dà sul lato
di Meidling, la naiade è
raffigurata nell'atto di
giocare con un uccello
acquatico.
Colombaia
- Costruita nel 1750/1776,
la Colombaia
è una voliera alta e rotonda
di rete di filo di ferro,
chiusa da un tetto di rame a
cupola coronato da un pomello.
Alla costruzione rotonda,
leggera ed ariosa, furono
addossate quattro nicchie in
muratura per offrire un
giaciglio agli uccelli.
L'insieme di viali che
circonda
la Colombaia
fu tracciato intorno al
1760 in
percorsi a raggio e ad anello,
detti "carosello"
nella tradizione di Schönbrunn.

La Gloriette
con la terrazza panoramica
- Già Fischer von Erlach
aveva previsto un belvedere,
costruito sulla sommità della
collina di Schönbrunn, che
creasse il degno coronamento
del parco barocco. Soltanto
quando fu realizzato
l’assetto del parco voluto
da Johann Ferdinand Hetzendorf
von Hohenberg, fu finalmente
eretto il complesso.
La Gloriette
, edificio a colonnato del
primo classicismo, fu
costruita sulla sommità
dell’altura nel 1775 secondo
un progetto dell’architetto
von Hohenberg.
Il corpo dell’edificio è costituito da un elemento
centrale a forma di arco di
trionfo con ariose ali ad
arcate a tutto sesto. Il corpo
centrale, che fu munito
di vetrate nell’ultimo anno
di vita di Maria Teresa, è
coronato da una possente
aquila imperiale che poggia
sul globo terrestre,
circondata da trofei d’armi.
Il tetto piano è cinto da una
balaustra e già ai primi
dell’Ottocento fungeva da
terrazza panoramica. Tuttora
vi si può accedere tramite
una scalinata.

Giardino botanico
- Nel
1753 l
'imperatore Francesco I
Stefano, consorte di Maria
Teresa appassionato di scienze
naturali, acquistò dal comune
di Hietzing un terreno
abbandonato ricoperto di
siepi, sul quale fece
tracciare il "giardino
olandese". Il giardino,
che si trovava al posto
dell'attuale Grande serra
delle palme, seguiva un
assetto geometrico ed era
suddiviso in tre sezioni,
ciascuna a sua volta suddivisa
in quattro, con una fontana al
centro. La parte
settentrionale era dedicata
alla floricoltura, quella
centrale in cui si coltivava
anche frutta a spalliera
fungeva da orto, e quella
meridionale da frutteto.
Inoltre sul lato nord sorse anche una grande serra. Sotto
gli imperatori Giuseppe II e
Francesco III l'antico
"Giardino botanico
olandese" fu ampliato con
l'acquisto di nuovi terreni.
In questa nuova sezione
sorsero alcune nuove serre e
un cosiddetto
"arboretum" a scopi
di studio, in cui crescevano
alberi esotici americani
coltivati su terreno sabbioso,
piantati in file regolari e
ciascuno con una targhetta.
Risalgono ad esempio a
quell'epoca i quattro possenti
platani nei pressi della
"Grande serra delle
palme".
Un catalogo che riportava tutte le piante coltivate nel
"Giardino botanico
olandese", del 1799,
comprendeva 4000 piante di
quasi 800 specie.
A partire dal 1828 il
"Giardino botanico
olandese", dopo la sua
trasformazione in un giardino
paesaggistico su modello
inglese, venne chiamato anche
"Giardino delle piante di
corte". L'attuale
"Giardino botanico"
comprende i terreni acquistati
sotto Giuseppe II e Francesco
II. Per maggiori informazioni
sul parco e sulle sue piante
nonché sulla Serra delle
palme.

Dal serraglio al giardino
zoologico - Alla fine
dell’Ottocento
l’aspetto e la finalità del
serraglio di Schönbrunn si
trasformarono, e il serraglio
barocco divenne un giardino
zoologico. Le mura tra le
gabbie furono abbattute
intorno al 1880 e sostituite
da sbarre, per “poter vedere
meglio e più comodamente gli
animali esposti”. Dopo il
1900 l’area del giardino
zoologico fu ampliata verso
est fino alla Fontana di
Nettuno, là dove si trovava
l’ex fagianaia, per poter
ospitare il gran numero di
animali, che nel 1914
raggiunsero il record storico
di 3470 capi.
Giardino zoologico
- La fondazione del serraglio
di Schönbrunn si deve a
Francesco Stefano I. Come
nella realizzazione del
Giardino botanico di Schönbrunn,
anche in questo caso fu
decisivo soprattutto
l’interesse del sovrano per
le scienze naturali. Secondo
un progetto del 1751 del suo
architetto di corte Nicolas
Jadot, l’imperatore fece
costruire un giardino
zoologico che prevedeva
tredici gabbie disposte a
raggiera intorno ad un
padiglione centrale. Le gabbie
furono ultimate già nel 1752,
il padiglione centrale
soltanto nel 1759.
Le gabbie per gli animali, ciascuna
provvista di una fontana,
erano separate da alte mura e
rinchiuse, sul lato che dava
verso il padiglione, da sbarre
di ferro fra i pilastri
coronati da vasi e sculture di
animali. Sul retro di ciascuna
gabbia c’era, visibile
dall’esterno, una
“loggia”, una sorta di
casetta che fungeva da
giaciglio notturno agli
animali.
In un settore più a valle,
verso ovest, sorge un edificio
a due piani che funge da
abitazione per il guardiano
degli animali, e uno
stagno con annesso edificio
per gli uccelli acquatici.
Il padiglione centrale ad un
piano, in cui di quando in
quando l’imperatore faceva
prima colazione, crea il colpo
d’occhio lungo il grande
asse diagonale che parte dal
centro del castello e lo
congiunge con il padiglione.
Il padiglione sorge su un
basamento ottagonale e vi
si può accedere mediante
quattro scalinate. I
risalti piatti sui quattro
lati del corpo dell’edificio
presentano porte dall’arco a
tutto sesto con frontone
ornato di figure,
inframmezzate dalle aperture
delle finestre con archi a
sesti ribassati. Il
tetto a campana è coronato
tutt’intorno da una
balaustra.
Gli interni, in origine dipinti di
verde, furono decorati poco
dopo il 1765, su incarico di
Maria Teresa, con ricchi
pannelli di legno ornati di
rocaille, specchi e quadri di
animali ed uccelli rari, per
farne un memoriale
dell’imperatore defunto.
 E’ accertato che i dipinti
sono opera di Johann Michael
Purgau e mostrano “i
ritratti di gran numero degli
animali presenti in questo
serraglio fin dalla sua
fondazione“. I dodici quadri
raffigurano animali rarissimi
che a quell’epoca non erano
ancora presenti nel serraglio
imperiale, benché fossero
ambiti oggetti da
collezionismo.
E’ accertato che i dipinti
sono opera di Johann Michael
Purgau e mostrano “i
ritratti di gran numero degli
animali presenti in questo
serraglio fin dalla sua
fondazione“. I dodici quadri
raffigurano animali rarissimi
che a quell’epoca non erano
ancora presenti nel serraglio
imperiale, benché fossero
ambiti oggetti da
collezionismo.
La cupola appiattita dell’interno
è decorata da un affresco di
Josef Ignaz Mildorfer che
mostra scene delle Metamorfosi
di Ovidio. Oltre ad un
baccanale, incentrato intorno
alla coppia di amanti Bacco ed
Arianna, vi sono raffigurati
vari episodi in cui degli
esseri umani vengono
trasformati in animali.
Il nucleo originario della raccolta
di animali di Schönbrunn era
formato dalle collezioni
dell’ex castello di Neugebäude
e del serraglio del Belvedere,
che ad eccezione degli animali
feroci erano stati trasferiti
nel nuovo giardino zoologico.
In seguito il numero di
animali esotici si accrebbe
grazie ad acquisti e
donazioni. Un notevole
allargamento della collezione
botanica e zoologica si ebbe
grazie alle spedizioni nelle
Indie occidentali, finanziate
da Francesco Stefano I.
Quando nel 1779 il parco fu aperto al
pubblico, fu possibile anche
visitare il giardino
zoologico. Anche
Giuseppe II s’impegnò per
il serraglio, che negli anni
ottanta del Settecento si
accrebbe nuovamente grazie a
nuove spedizioni. Alcuni
animali però morivano perché
non si disponeva di conoscenze
su come allevarli e curarli.
Nel corso dell’Ottocento arrivarono
nuovi animali, le gabbie
esistenti vennero trasformate
e nuove gabbie vennero
costruite. Fra le attrazioni
dello zoo c’erano elefanti,
cammelli, canguri ed altri
animali esotici.
Particolare scalpore fece l’arrivo
della prima giraffa viva, che
giunse a Schönbrunn nel 1828,
dono del viceré d’Egitto. I
viennesi entusiasti
accorrevano in massa nel
giardino zoologico “per
poter finalmente soddisfare la
loro enorme curiosità
osservando quella rara
creatura”.
L’arrivo della giraffa
influenzò la moda e la vita
di società. Erano in voga gli
abiti, gli accessori e le
acconciature “à la
giraffe“, e in una festa nel
locale “Zur blauen
Traube“, nel quartiere di
Penzing, l’ospite d’onore
fu il guardino della giraffa,
originario di Alessandria
d’Egitto. Nonostante
le attente cure, la giraffa
morì appena dieci mesi dopo,
e si dovettero attendere 23
anni prima che il giardino
zoologico potesse rallegrarsi
dell’arrivo di una nuova
giraffa.
 Serra
delle
palme
- La Serra
delle
palme sorge al posto dell'ex
Giardino olandese, e fu
costruita nel 1881/82 secondo
un progetto di Franz Xaver
Segenschmid. Lunga
113 metri
, è formata da un padiglione
centrale alto
28 metri
e da due padiglioni laterali
di tre metri più bassi. Serra
delle
palme
- La Serra
delle
palme sorge al posto dell'ex
Giardino olandese, e fu
costruita nel 1881/82 secondo
un progetto di Franz Xaver
Segenschmid. Lunga
113 metri
, è formata da un padiglione
centrale alto
28 metri
e da due padiglioni laterali
di tre metri più bassi.
Collegati
da corridoi a forma di tunnel,
i tre padiglioni creano tre
diverse zone climatiche: una
serra fredda a nord, una
"temperata" nel
padiglione centrale, e una
serra tropicale a sud. Le
varie temperature vengono
raggiunte mediante un
riscaldamento a vapore che
consente di presentare specie
rare della flora di tutti i
continenti.
Nel realizzare l'imponente costruzione in ferro, ispirata
al tardo storicismo, ci si
giovò della tecnologia allora
all'avanguardia, operando
scelte formali consone ai
materiali adoperati.
Le linee concave e convesse dei padiglioni laterali e di
quello centrale creano un
effetto di armonia delle
proporzioni e conferiscono
visibile leggerezza
all'edificio metallico,
nonostante le eccezionali
dimensioni.
Le lastre di vetro sono inserite fra l'ossatura della
struttura metallica esterna, e
combaciano come una membrana
con le curvature delle travi
di ferro. La Serra
delle palme di Schönbrunn è
l'ultima e la più grande del
suo genere sul continente
europeo.
Fontana
a
stella
- La Fontana
a
stella (Sternbassin) si
trovava anticamente al centro
del Grande parterre. Nel corso
delle trasformazioni del
Grande parterre volute da
Hohenberg, nel 1772 la vasca
fu trasportata nel sito
attuale, lungo l'asse
occidentale diagonale del
giardino. Allo stesso tempo fu
costruita
la Fontana rotonda che le fa
da pendant, al centro dei
viali a stella sul lato est.
I
gruppi scultorei delle naiadi,
che in entrambe le fontane
sono realizzati in marmo di
Vipiteno, furono scolpiti
contemporaneamente alla
Fontana di Nettuno, fra il
1770 ed il 1780. Nella
mitologia classica le naiadi,
divinità delle acque e delle
sorgenti, erano al seguito di
Nettuno. La delimitazione
degli spiazzi in cui sorgono
la Fontana rotonda e quella a
stella è marcata da otto
grandi vasi di marmo,
realizzati da Johann Baptist
Hagenauer fra il 1772 e il
1780.


Giardino del deserto - Quando
l’imperatore Francesco
Giuseppe I commissionò la
costruzione di una serra
secondo i progetti
dell’architetto Alfons
Custodis, pensava
esclusivamente ad un posto per
conservare la sua immensa
“Nuova collezione
olandese”, di estremo valore
dal punto di vista botanico,
formata soprattutto da piante
provenienti da Australia e
Sudafrica.
La serra ultimata nel 1904
nello stile della fin de siècle,
con una struttura in ferro che
già anticipa a livello
formale lo Jugendstil, era
pertanto concepita per
ospitare quelle piante
difficili da coltivare e non
adatte a svernare
nell’Europa centrale, grazie
alla sua parete posteriore
murata a nord, alla parete
vetrata che dava verso sud ed
alla semplice vetratura.
Poco meno di cent’anni dopo, in occasione del restauro e
consolidamento della
struttura, resosi necessario,
l’Ente dei giardini ha
deciso di presentare in
questa serra al pubblico
interessato gli esemplari più
belli e di maggior
pregio della collezione di
piante succulente (cactus ed
altre piante dai tessuti
acquiferi, resistenti ai climi
aridi), fino a questo momento
non aperta al pubblico.
Per rendere l’esposizione il più interessante e varia
possibile, in collaborazione
con il Giardino zoologico
verranno presentati tre
diversi habitat aridi
(Madagascar, deserti del mondo
antico e del mondo nuovo), con
una selezione della fauna e
della flora autoctona di
quelle regioni. A prescindere
dall’esperienza avvincente
che offre, l’esposizione si
propone di mostrare le
interessantissime e svariate
strategie di sopravvivenza
degli abitanti, terrestri e
sotterranei, di questi habitat
così inclementi.

Orangerie
- Già la vedova
dell'imperatore Giuseppe I,
Guglielmina Amalia, fece
tracciare un aranceto, e per
far svernare melangoli e
aranci diede ordine di
costruire una serra. Francesco
Stefano I commissionò intorno
al 1754 l
'Orangerie a Nicola Pacassi,
che seguì presumibilmente un
progetto di Nicolas Jadot.
Lunga
189 metri
e larga dieci, l'Orangerie di
Schönbrunn viene considerata
accanto a quella di Versailles
la maggiore aranciera di epoca
barocca. Sulla facciata sud,
gli archi grandi e piccoli a
tutto sesto si alternano alle
lesene adorne di bugne
rustiche e mascheroni.
L'interno è scandito da
soffitti a volte, il
riscaldamento a pannelli
radianti creava le condizioni
climatiche adeguate.
L'Orangerie non serviva però
soltanto per far svernare gli
agrumi e le piante da vaso, ma
anche come giardino d'inverno
fiorito per i festeggiamenti
della casa imperiale. Giuseppe
II amava le feste con le
tavole riccamente imbandite
nell'Orangerie, traboccante di
fiori e agrumi illuminati, e
in occasione di una festa
nell'inverno del 1786 Mozart
diresse proprio qui il suo
singspiel
"L'impresario". Il
retro dell'Orangerie è
tuttora destinato alla sua
funzione originaria, mentre
nella parte anteriore,
ristrutturata, si tengono i
"concerti al castello di
Schönbrunn".

Museo delle carrozze
- Nel 1922 il nucleo dell'ex
"parco vetture"
della corte di Vienna, che
comprendeva carrozze da
cerimonia, carrozze ufficiali,
slitte e portantine della
"K.u.K.
Hofwagenburg" fu
trasferito dalle stalle di
corte della Hofburg di Vienna
a Schönbrunn, e allestito
nella ex cavallerizza
d'inverno, riadattata per
l'occasione.
Fa parte di questa celebre e
straordinaria collezione anche
la carrozza imperiale che fu
costruita probabilmente per
l'incoronazione di Giuseppe II
nel 1764, e che a partire da
quel momento fu utilizzata per
diverse incoronazioni regali e
imperiali degli Asburgo.
La carrozza da cerimonia, riccamente
adorna di intagli in legno
dorato e pitture di Franz
Xaver Wagenschön, veniva
trainata da otto cavalli
bianchi, ma poiché aveva un
peso complessivo di oltre
4000 kg
poteva avanzare soltanto a
passo d'uomo. Per poter essere
trasportata, la carrozza da
cerimonia veniva smontata,
trasportata di solito per via
d'acqua e rimontata sul posto.
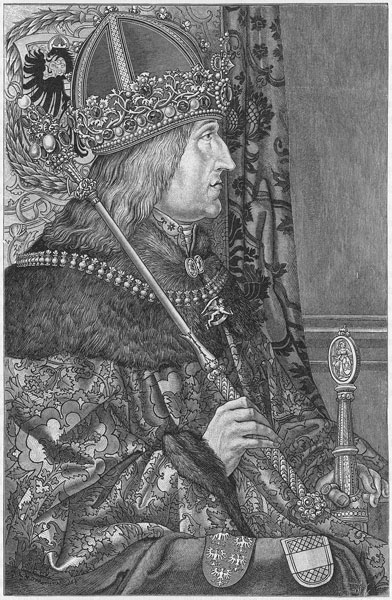 Gli
Asburgo - La nascita di un
impero universale Gli
Asburgo - La nascita di un
impero universale
La dinastia discendeva da una
stirpe di conti alemanni
dell’Aargau (nell’attuale
Svizzera). Dopo che Rodolfo I
d’Asburgo nel 1273 fu eletto
re del Sacro Romano Impero
della Nazione germanica, egli
infeudò nel 1282 i suoi due
figli degli ex ducati dei
Babenberg di Austria e Stiria.
In quella data ebbe inizio il
regno asburgico in Austria,
durato oltre 630 anni, che va
dalla fine del Duecento alla
fine della Prima guerra
mondiale, nel 1918.
Grazie ad una politica
energica ed intelligente, nel
corso dei secoli i piccoli
possedimenti nella regione
danubiana e in Stiria
divennero un impero universale
che si allargava dall’Europa
centro-orientale all’America
meridionale.
Federico III (1415/1452-1493) fu il primo Asburgo ad essere incoronato
dal Papa a Roma imperatore del
Sacro Romano Impero. Da quel
momento in poi, sino allo
scioglimento dell’Impero
(con una sola interruzione nel
1741-1745) la dignità
imperiale fu appannaggio degli
Asburgo. Per le terre che
rappresentavano l’origine
dell’Austria Federico
legalizzò il titolo di
“arciduca”, che gli
Asburgo usarono sino alla fine
della monarchia.
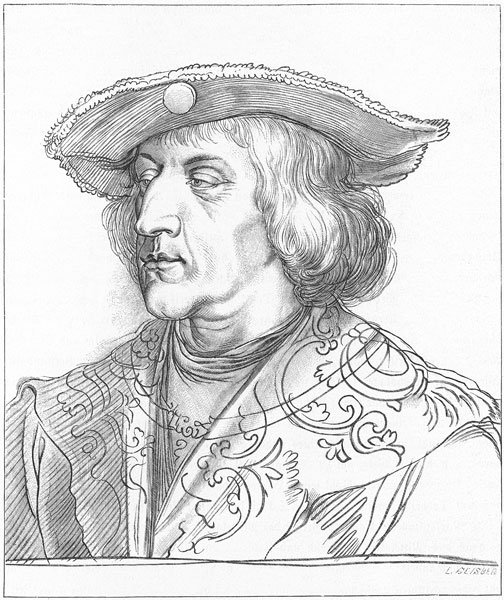 Federico preferì come residenza la città di Wiener
Neustadt, mentre nei suoi
soggiorni nella Burg di Vienna
abitava nello Schweizertrakt,
dove fece costruire anche la
cappella di corte, nella quale
tuttora la messa della
domenica è accompagnata dai
Piccoli cantori di Vienna. Federico preferì come residenza la città di Wiener
Neustadt, mentre nei suoi
soggiorni nella Burg di Vienna
abitava nello Schweizertrakt,
dove fece costruire anche la
cappella di corte, nella quale
tuttora la messa della
domenica è accompagnata dai
Piccoli cantori di Vienna.
Massimiliano I (1459/1493-1519) fu il vero e proprio fondatore della
politica matrimoniale
asburgica: “Bella gerant
alii, tu felix Austria
nube”. Massimiliano, detto
“l’ultimo dei
cavalieri”, sposò nel 1477
Maria di Borgogna, erede del
ricco ducato di Borgogna cui
appartenevano anche i Paesi
Bassi.
Il figlio Filippo detto “il Bello” sposò
Giovanna “
la Pazza
”, erede di Castiglia ed
Aragona, per cui anche
la Spagna
e le sue ricche colonie
sudamericane entrarono a far
parte dell’impero asburgico.
Il nipote Ferdinando convolò
infine a nozze con Anna, erede
dei regni di Boemia e
Ungheria. In questo modo nel
giro di tre generazioni,
grazie ad un’abile politica
matrimoniale, nacque
l’impero universale degli
Asburgo “sul quale non
tramontava mai il sole”.
Carlo V (1500/1519-1558) dedicò il suo regno innanzitutto alla
lotta contro
la Riforma. Per
poter meglio amministrare i
suoi domini eterogenei, egli
suddivise le terre asburgiche
e le funzioni ad esse
correlate fra sé stesso ed il
fratello Ferdinando, e fondò
così una linea austriaca ed
una spagnola degli Asburgo, le
cui residenze erano Vienna e
Madrid.
Il Seicento fu caratterizzato
dalle lotte per respingere gli
Ottomani. Sotto Leopoldo
I (1640/1658-1705) nel
1683 i Turchi misero per la
seconda volta Vienna sotto
assedio, conclusosi con la
vittoria delle truppe
imperiali e la disfatta del
pericolo turco. Leopoldo fece
ampliare
la Hofburg
e costruì il Leopoldinischer
Trakt che a lui deve il nome
(di fronte agli appartamenti
imperiali), che oggi ospita
gli uffici del Presidente
federale austriaco.
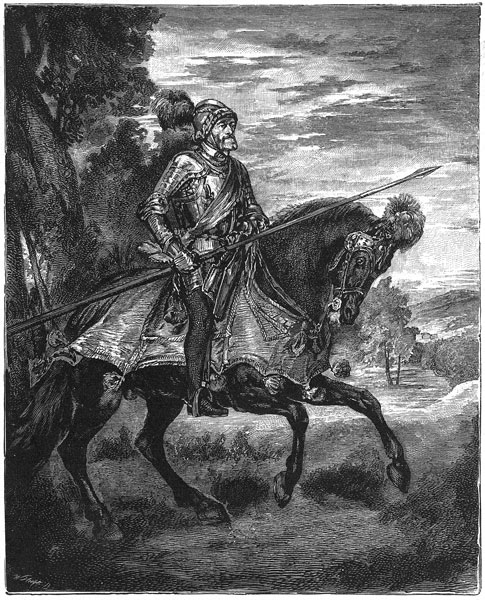


Ai primi del Settecento con le
Guerre di successione di
Spagna gli Asburgo cedettero
ai Borbone di Francia i loro
possedimenti spagnoli. Carlo
VI (1658/1711-1740), che
era cresciuto in Spagna, fece
ritorno a Vienna nelle vesti
di imperatore e fece ampliare
la Hofburg
con sfarzo barocco. Oltre alla
Biblioteca nazionale e al
Maneggio d’inverno, patria
dei cavalli Lipizzani della
Scuola spagnola di
equitazione, durante il suo
regno fu costruito anche il
Reichskanzleitrakt, nel quale
oggi si trova parte degli
appartamenti imperiali.
 Figlia
dell'imperatore Carlo VI, Maria
Teresa (1717-1780) si
assicurò i diritti al trono
grazie alla legge sancita dal
padre e nota come
"prammatica
sanzione" (1713), che
stabiliva la successione
nell'eredità dei territori
asburgici anche in linea
femminile. Sposatasi nel 1736
con Francesco di Lorena, Maria
Teresa assunse nel 1740 il
governo dei paesi ereditari
(Austria, Ungheria e Boemia). Figlia
dell'imperatore Carlo VI, Maria
Teresa (1717-1780) si
assicurò i diritti al trono
grazie alla legge sancita dal
padre e nota come
"prammatica
sanzione" (1713), che
stabiliva la successione
nell'eredità dei territori
asburgici anche in linea
femminile. Sposatasi nel 1736
con Francesco di Lorena, Maria
Teresa assunse nel 1740 il
governo dei paesi ereditari
(Austria, Ungheria e Boemia).
 Impegnata
dapprima nella guerra di
Successione e nella guerra dei
Sette anni, l'imperatrice si
dedicò a partire dagli anni
sessanta del secolo a una
decisa politica interna,
conforme alle concezioni del
dispotismo illuminato. Perseguì
il rafforzamento dello Stato
e, parallelamente, il
miglioramento delle condizioni
di vita dei propri sudditi,
fondando tra l'altro una vasta
rete di scuole pubbliche e
popolari. Impegnata
dapprima nella guerra di
Successione e nella guerra dei
Sette anni, l'imperatrice si
dedicò a partire dagli anni
sessanta del secolo a una
decisa politica interna,
conforme alle concezioni del
dispotismo illuminato. Perseguì
il rafforzamento dello Stato
e, parallelamente, il
miglioramento delle condizioni
di vita dei propri sudditi,
fondando tra l'altro una vasta
rete di scuole pubbliche e
popolari.
Sotto
la sua direzione, che si
avvalse della collaborazione
dell'abile primo ministro
Kaunitz, l'Austria si trasformò
da Stato feudale a Stato
burocratico-centralizzato, nel
quale alla borghesia erano
affidate importanti funzioni
di amministrazione e in cui
erano ridimensionati i
tradizionali privilegi
dell'aristocrazia.
Il
figlio Giuseppe II (coreggente
e imperatore) le subentrò
gradualmente nel governo,
avviando una politica di
riforme assai più radicale di
quella materna.
Sotto
il patronato di Maria Teresa
riscossero grande fortuna due
artisti italiani: il pittore
romano Gregorio Guglielmi
(1714-1773), che lavorò a Schönbrunn
e all'università di Vienna, e
i
l poeta e librettista Pietro
Metastasio (1698-1782);
questi, chiamato da Carlo VI
in Austria a rivestire
l'incarico di poeta cesareo,
scrisse i testi di numerosi
melodrammi e diffuse negli
ambienti della corte asburgica
la cultura dell'Arcadia
romana, intessuta di temi
bucolici derivati dalla
tradizione classica.
 Ai
primi dell’Ottocento Francesco
II (1768-1835), in
reazione all’incoronazione
di Napoleone ad imperatore dei
francesi nel 1804, proclamò
l’impero ereditario
austriaco e fu quindi il primo
imperatore austriaco con il
nome di Francesco I.
Nel
1806, in
seguito alle vittorie
napoleoniche, egli dichiarò
infine disciolto il Sacro
Romano Impero, che cessò
dunque di esistere dopo oltre
mille anni come regno
sovranazionale della
cristianità. Ai
primi dell’Ottocento Francesco
II (1768-1835), in
reazione all’incoronazione
di Napoleone ad imperatore dei
francesi nel 1804, proclamò
l’impero ereditario
austriaco e fu quindi il primo
imperatore austriaco con il
nome di Francesco I.
Nel
1806, in
seguito alle vittorie
napoleoniche, egli dichiarò
infine disciolto il Sacro
Romano Impero, che cessò
dunque di esistere dopo oltre
mille anni come regno
sovranazionale della
cristianità.
Sotto
il suo successore
Ferdinando il Buono
(1793-1875), che soffriva di
epilessia, il cancelliere di
stato Metternich costruì un
sistema repressivo, basato
sullo spionaggio e sulla
censura. Eppure proprio
quell’epoca, detta
Biedermeier, fu una delle più
fiorenti della storia della
civiltà austriaca.
Francesco
Giuseppe I (1830/1848-1916) nacque nel 1830 nel castello di
Schönbrunn. A diciott’anni
egli successe allo zio sul
trono austriaco, dopo che
Ferdinando I dovette abdicare
in seguito alla rivoluzione
nel 1848, e dopo la rinuncia
al trono del padre arciduca
Carlo.
 Con i suoi 56 milioni di abitanti, nel corso dei
secoli l’impero era divenuto
una monarchia plurinazionale
nella quale convivevano sotto
un’unica corona le
nazionalità più svariate,
fra cui tedeschi, ungheresi,
cechi, rumeni, sloveni e
italiani. Con i suoi 56 milioni di abitanti, nel corso dei
secoli l’impero era divenuto
una monarchia plurinazionale
nella quale convivevano sotto
un’unica corona le
nazionalità più svariate,
fra cui tedeschi, ungheresi,
cechi, rumeni, sloveni e
italiani.
I primi anni di governo di Francesco Giuseppe furono
caratterizzati dalle sconfitte
militari, con la perdita dei
possedimenti italiani del
Lombardo Veneto, e dopo la
battaglia di Sadowa contro
la Prussia
anche della supremazia nella
Confederazione germanica.
Francesco Giuseppe proseguì la politica
conservatrice dei suoi
predecessori e fu confrontato
soprattutto con l’insorgere
del conflitto tra le
nazionalità nella monarchia
plurinazionale. Nel 1867 si
ebbe il “compromesso” con
l’Ungheria, da cui nacque la
duplice monarchia
austro-ungarica e che concesse
ampia autonomia ai magiari.
Quello stesso anno
l’imperatore fu infine
incoronato re d’Ungheria.
Sotto Francesco
Giuseppe furono costruiti
la Neue Hofburg
sulla Heldenplatz e il
Michaelertrakt, che diedero
alla Hofburg il suo aspetto
attuale.
Nel
1854 egli sposò la cugina
sedicenne, la principessa
Elisabetta di Baviera, detta
in famiglia Sisi. L’imperatrice
Elisabetta (1837-1898)
divenne una donna avvenente ed
estrosa, adorata dal marito
per tutta la vita. La coppia
ebbe quattro figli: la
primogenita, Sofia, morì alla
tenera età di due anni, le
figlie Gisella (1856-1932) e
Maria Valeria (1868-1924) si
sposarono ed ebbero numerosi
discendenti.
 L’unico
figlio maschio, il principe
ereditario Rodolfo, nato
nel 1858, si suicidò nel 1889
all’età di trent’anni
insieme all’amante, la
baronessa diciassettenne Mary
Vetsera, nel castello di
caccia di Mayerling. L’unico
figlio maschio, il principe
ereditario Rodolfo, nato
nel 1858, si suicidò nel 1889
all’età di trent’anni
insieme all’amante, la
baronessa diciassettenne Mary
Vetsera, nel castello di
caccia di Mayerling.
Dalle
sue nozze con Stefania del
Belgio nacque una figlia,
Elisabetta detta Erzsi, che
dopo il divorzio dal principe
Windisch-Graetz aderì al
Partito socialdemocratico,
sposò il socialista Adolf
Petznek e passò alla storia
come “l’arciduchessa
rossa”.
La
fine della monarchia
- Dopo il tragico suicidio del
principe ereditario Rodolfo
Francesco Ferdinando
(1863-1914), nipote
dell’imperatore, fu nominato
erede al trono della monarchia
austro-ungarica. Ma
anch’egli finì
tragicamente, assassinato nel
giugno del 1914 insieme alla
moglie Sofia a Sarajevo,
attentato che fu la scintilla
dello scoppio della Prima
guerra mondiale.
Francesco
Giuseppe si spense durante la
guerra nel novembre del 1916,
all’età di 86 anni, dopo 68
anni di regno. Gli successe il
pronipote Carlo I (1887-1922)
ultimo imperatore austriaco.
La fine della Prima guerra
mondiale significò anche la
fine della monarchia
austro-ungarica.
L’11
novembre 1918 fu proclamata la
prima repubblica austriaca,
dopo la rinuncia di Carlo agli
affari del regno. Dal momento
però che egli non aveva
rinunciato al trono, dovette
andare in esilio con la
famiglia. Nel 1922 morì
all’età di 35 anni
nell’isola portoghese di
Madeira.
La
moglie Zita (1892-1989) di
Borbone-Parma rifiutò
anch’ella per tutta la vita
di rinunciare ufficialmente al
trono e visse quindi in
esilio, gli ultimi anni in
Svizzera, dove morì nel 1989.
Le sue spoglie furono portate
a Vienna, dove fu sepolta come
ultima imperatrice d’Austria
nella cripta dei Cappuccini
dell’omonima chiesa.
Maggio
2015
Pag.
1 
|