- Duomo
di Santo Stefano (Stephansdom)
Simile
a una scogliera di corallo, il
Duomo si eleva dal mare di
case del centro città.
Esso è, fin dalla sua
costruzione, un simbolo della
storia e del destino
dell'Austria. Dal momento
della sua distruzione e
ricostruzione dopo gli orrori
della Seconda Guerra Mondiale
è divenuto anche un simbolo
della rinascita e del
consolidamento dell'Austria
come stato libero ed
indipendente. Il Duomo è
inoltre un edificio che non si
potrà mai considerare
compiuto. Perciò esso è
anche un simbolo della
limitatezza e incompiutezza di
tutto ciò che è terreno.
Proprio in questa
incompiutezza, però, consiste
il suo inimitabile splendore e
la sua bellezza quasi divina.
Come
nel caso di molte altre
chiese, anche gli inizi di
Santo Stefano sono oscuri. Non
sappiamo se al posto
dell'attuale chiesa ci fosse
un santuario pagano.
Probabilmente in questo luogo
sorgeva un cimitero romano,
ipotesi avallata dalla
presenza di pietre sepolcrali
murate nelle fondamenta del
Portale Gigante.
Gli
ultimi scavi (1996) in
questa zona hanno rafforzato
l'ipotesi che, verso est,
sotto la prima chiesa romanica
di Santo Stefano, si trovasse
già
un più piccolo santuario, una
cappella. Due edifici situati
entrambi nei pressi della
vecchia cinta muraria romana,
San Pietro al Graben e San
Ruperto, vicina al canale del
Danubio, vengono ritenuti i
templi cristiani più antichi
di Vienna. Nel sec. XII fu
intrapresa, sull'area
dell'attuale Duomo, la
costruzione di una grande
chiesa parrocchiale dipendente
da Passavia, che fu dedicata
al
patrono del
Duomo
della città
tedesca.
Verso
la metà
del sec. XII, Enrico II di
Babenberg, fondatore del
Convento degli Scozzesi,
trasferì la sua residenza a
Vienna. La leggenda narra che
il margravio Enrico avrebbe
visto in sogno un giovane
architetto con in mano il
progetto di una imponente
chiesa. Il signore vide in
questo il segno della volontà
divina e ordinò di costruire
la chiesa di Santo Stefano. La
posa della prima pietra ebbe
luogo nel 1137. La leggenda
racconta ancora che il giovane
cui fu affidata la conduzione
dell'opera
sarebbe
stato lo stesso apparso
in sogno al margravio.
Dopo
la consacrazione della nuova
chiesa, nel 1147, sarebbe
scomparso senza lasciare
tracce, ma, per la
straordinaria bellezza
dell'edificio, solo Gesù
in persona avrebbe potuto
essere il misterioso
capomastro. Così, al Duomo di
Santo Stefano ben si addicono
i versi del salmo 127:
"Se il Signore non
costruisce la casa, invano vi
faticano i costruttori"
(Salmo 127, 1).

Storia
del Duomo
La
chiesa romanica - Un
contratto di scambio del 1137
tra il margravio Leopoldo IV
Babemberg ed il vescovo
Reginmar di Passavia
(Contratto di Mautern) rese
possibile la costruzione della
prima chiesa di Santo Stefano
che allora sorgeva ancora al
di fuori delle mura cittadine,
il corso delle quali seguiva
quello
delle antiche mura
dell'accampamento romano,
approssimativamente a
nord-ovest della piazza di
Santo Stefano. Il contratto,
nel quale per la prima volta
viene nominata la parrocchia
di Vienna, fu concluso a
Mautern, sul Danubio, e
stabiliva che il margravio
consegnasse al vescovo la
chiesa parrocchiale di Vienna,
situata nelle vicinanze di
quella di San Pietro,
ottenendo in cambio una vigna
e metà
della dote parrocchiale che si
trovava nei pressi della città,
a condizione che la chiesa e
gli altri restanti luoghi di
culto più piccoli sparsi sul
territorio parrocchiale
in futuro fossero
sottomessi
al vescovo di
Vienna.
Nell'aprile
del 1147 ebbe luogo la prima
consacrazione parziale della
chiesa di Santo Stefano,
allora non ancora terminata,
in presenza del vescovo di
Passavia, Reginbert. La
costruzione era per dimensioni
troppo imponente per la Vienna
di allora, il che fa pensare
ad un gesto programmatico
dell'ispiratore: Santo Stefano
era concepita come futura sede
vescovile o, almeno, come
chiesa ducale. La prima chiesa
romanica, come anche il Duomo
attuale, era orientata verso
l'oriente del sole del 26
dicembre 1137 (sud-est). Negli
Atti degli Apostoli si
racconta che Santo Stefano,
poco prima di morire, vide i
cieli aperti. Il primo raggio
di sole che, cadendo
sull'altare maggiore, illumina
l'ambiente, è
proprio un simbolo di questi
"cieli aperti".
Di
questo primo edificio non si è
conservato quasi nulla nel
corso dei secoli;
le
poche
informazioni
in nostro
possesso provengono da scavi
archeologici e da pochi
frammenti architettonici. La
navata centrale aveva una
larghezza di circa 12 metri,
tutte e tre le navate insieme
raggiungevano circa i 23
metri. La lunghezza della
chiesa, abside inclusa, era più
o meno di 83 metri. Le uniche
parti pervenuteci del
primitivo complesso - escluse
le fondamenta subito ricoperte
dopo gli scavi del 1945 - sono
la cosiddetta "Camera
Nera" nel piano inferiore
della Torre Pagana, dove oggi
si trova una stanza adibita a
confessionale, e parti del
pianterreno della costruzione
ovest.
 La
chiesa tardoromanica - La
forma di questo edificio,
costruito tra il 1230 e il
1245, è
chiaramente riconoscibile e
ricostruibile, sebbene sia
soprattutto la parte ovest di
questa chiesa ad essere ancora
conservata. L'ambizioso
progetto di elevare Santo
Stefano a sede vescovile portò
alla demolizione della vecchia
chiesa del XII secolo e alla
sua completa ricostruzione,
eccetto il piano inferiore
delle Torri Pagane, sulle
preesistenti fondamenta. La
Cattedrale aveva un grande
coro centrale, un transetto
sporgente e la struttura
basilicale a tre navate.
Guardando la galleria ovest
con le sue colonne, con i
capitelli decorati con foglie
e animali e con i suoi
costoloni in parte profilati,
si può
dedurre la non comune
ricchezza decorativa di questa
chiesa. La
chiesa tardoromanica - La
forma di questo edificio,
costruito tra il 1230 e il
1245, è
chiaramente riconoscibile e
ricostruibile, sebbene sia
soprattutto la parte ovest di
questa chiesa ad essere ancora
conservata. L'ambizioso
progetto di elevare Santo
Stefano a sede vescovile portò
alla demolizione della vecchia
chiesa del XII secolo e alla
sua completa ricostruzione,
eccetto il piano inferiore
delle Torri Pagane, sulle
preesistenti fondamenta. La
Cattedrale aveva un grande
coro centrale, un transetto
sporgente e la struttura
basilicale a tre navate.
Guardando la galleria ovest
con le sue colonne, con i
capitelli decorati con foglie
e animali e con i suoi
costoloni in parte profilati,
si può
dedurre la non comune
ricchezza decorativa di questa
chiesa.
La
galleria ovest, compresa tra
le due Torri Pagane, fu
concepita come "galleria
ducale" come anche la
sede imperiale di Carlo Magno
ad Aquisgrana e le grandi
gallerie negli antichi duomi
imperiali tedeschi - un
ambiente a se stante, ma
orientato verso l'altare. I
piani superiori delle torri
vennero costruiti in ultimo,
sicuramente dopo l'incendio
del 1258.
L'edificio
tardoromanico, completamente
ricostruito, raggiungeva la
lunghezza di m. 70 circa ed
era limitato nella sua
larghezza dalle due torri
ovest che con i loro m. 65 di
altezza si ergevano di gran
lunga al di sopra del tetto.
La nuova chiesa fu consacrata
solennemente il 23 aprile 1263
dal vescovo Otto di Passavia.
Nel 1267, il parroco Gerhard
von Siebenbùrgen fondò la
tuttora esistente Curia, cui
è affidata l'assistenza
spirituale nel Duomo.






La
struttura gotica - Tra il
1304 e il 1340, sotto il duca
Albrecht II, fu intrapresa la
costruzione del luminoso coro
gotico a tre absidi. Il Coro
Albertino, che si ispirava al
coro gotico della chiesa
dell'abbazia cistercense di
Heiligenkreuz nel Bosco
viennese, fu consacrato il 23
aprile 1340 dal vescovo Albert
di Passavia. Poco più
tardi furono erette, sotto il
duca Rodolfo IV "il
Fondatore", le cappelle
laterali ovest a due piani,
dette anche Cappelle Ducali.
Il duca in persona pose nel
1359 la prima pietra della
costruzione di ampliamento
gotica. Per circa 100 anni
l'edificio crebbe lentamente,
ma con continuità. Il 23
marzo 1361, in presenza del
vescovo Pietro di Coirà, fu
murata nella Porta del Vescovo
la pietra di Colomanno sulla
quale, secondo la tradizione,
il santo subì il martirio.
Nello stesso anno fu
intrapresa la costruzione
delle navate. Quale preludio
alla creazione del vescovado
di Vienna nel 1469, il duca
Rodolfo IV, fondatore anche
dell'Università
di Vienna, creò nel 1365 una
Collegiata di Tutti i Santi,
indipendente da Passavia, con
sede in Santo Stefano e sala
capitolare nella galleria
ovest.
La
cima della Torre Sud, di cui
Rodolfo IV aveva posto
personalmente la prima pietra,
servendosi di un utensile
d'argento, poté
essere completata nel 1433. I
cornicioni delle navate furono
ultimati nel 1440, il tetto
ancor prima del 1474. In quel
periodo si stabilirono degli
stretti contatti tra le
corporazioni edili del Duomo
di Vienna e di Praga. Vienna
era allora una delle quattro
corporazioni principali del
regno. Tra il 1417 e il 1430
fu eretta la sacrestia
inferiore, annessa alla navata
sud. Le pareti delle navate
crebbero intorno ai muri di
epoca romanica come un guscio,
in modo da continuare a
permettere la celebrazione
degli uffici divini. Solo dopo
l'ultimazione dei muri gotici,
furono abbattuti, nel 1430, i
muri romanici. Ancor prima
della costruzione della volta
fu eseguita, a partire dal
1440, la imponente capriata di
legno di larice, capolavoro
dell'arte carpentiera gotica
per il quale
non
si
utilizzò
nemmeno
un
chiodo. Nel 1446, il
maestro Hans Puchsbaum
intraprese la costruzione
della volta della navata
centrale.
L'imperatore
Federico III, cui si deve
l'erezione di Vienna a
vescovado nel 1469, pose nel
1450 la prima pietra della
Torre Nord di cui nel 1467 si
intraprese la costruzione.
Secondo la tradizione,
l'imperatore ordinò
di utilizzare come
agglutinante per le fondamenta
della torre il vino che, per
le avverse condizioni
atmosferiche, quell'anno era
risultato piuttosto acido. Nel
1459, a Ratisbona, alla
riunione annuale delle
corporazioni edili, la
corporazione del Duomo di
Vienna fu ritenuta la più
importante dell'area sud
orientale dell'Europa
centrale. La costruzione della
torre fu interrotta agli inizi
del XVI secolo. L'ultimo
strato di mattoni porta incisa
la data del 1511. Tensioni
economiche e sociali, dovute
alle scoperte, alle guerre
contro i Turchi e ai disordini
religiosi, determinarono la
decadenza delle grandi idee
alla base dell'architettura
medievale. Nel 1578, Hans
Saphoy portò a termine la
torre con una calotta
rinascimentale. Con la nascita
dell'Umanesimo, furono creati
nel Duomo significativi
capolavori dell'artigianato
quali il pulpito (1480 circa)
o il piede di organo del
Maestro Pilgram (datato 1513),
il fonte battesimale o gli
scanni dei Consiglieri,
distrutti completamente
nell'incendio del 1945, così
come i numerosi epitaffi di
cittadini viennesi ed eruditi
dell'Università. Nel 1631,
l'imperatore Ferdinando II
elevò il vescovo di Vienna al
rango di principe (principe
vescovo).


Dopo
il trionfo della vera fede
sull'eresia, il duomo venne
rifatto in stile barocco in
due grandi fasi. Sotto il
principe vescovo Breuner, nel
1647, fu terminato dai
fratelli Pock l'altare
maggiore barocco. A questo
periodo risalgono anche i più
antichi paramenti sacerdotali
del Duomo, i rossi paramenti
di Breuner, che ancora oggi
vengono utilizzati il giorno
di S. Stefano. L'altare
maggiore è dunque una
donazione del vescovo, mentre
l'arredamento della navata fu
finanziato dai cittadini. Dal
1677 si procedette
all'ulteriore riassetto
barocco del Duomo (altari
laterali, oratorii imperiali e
organi). Durante il secondo
assedio turco, nel 1683, più
di mille palle di cannone
colpirono la Cattedrale;
alcune di esse sono ancora
oggi visibili, murate, nelle
pareti della Torre Sud e della
navata. Durante l'assedio, il
tetto venne riparalo più
volte
con
dei
tendoni allo scopo
di ingannare il nemico,
facendogli credere che la città
disponesse ancora di un
approvvigionamento
sufficiente. Il 12 settembre
1683, giorno in cui la Chiesa
celebra il Nome di Maria,
Vienna fu liberata dai Turchi,
dopo una battaglia seguita ad
una messa celebrata dal
cappellano Marco d'Aviano. A
perpetuo ricordo della
liberazione della città, nel
1711, fu fusa con il bronzo
dei cannoni turchi requisiti,
la "Pummerin", la
grande campana situata nella
torre sud, uno dei simboli
della città. Sul finire del
XVII secolo trovarono posto
nel Duomo due immagini
miracolose: nel 1693 fu
trasportata in festosa
processione nel Duomo la
tavola di "Maria nel
sole" e nel 1697 l'icona
di "Maria Pócs".
Con
l'elevazione di Vienna ad
arcidiocesi, nel 1722, Santo
Stefano divenne chiesa
metropolitana.
Una
statistica del 1732, curata
dal sacrestano Johann Wachter,
consente di farsi un'idea
della vita liturgica in Santo
Stefano in epoca barocca.
In base a tale
statistica, giornalmente vi si
celebrarono in media 150 messe
e almeno un pontificale, nel
corso dell'anno vi furono
recitati 1095 Rosari ed almeno
129.000 fedeli si accostarono
alla Confessione.
Nello
stesso anno fu chiuso il
cimitero di Santo Stefano, che
circondava il Duomo, e, nel
1755, l'imperatrice Maria
Teresa fece ampliare e
decorare di nuovo la Cripta
Ducale sotto l'altare
maggiore, nella quale sono
sepolti il duca Rodolfo IV ed
alcuni dei primi Asburgo. Le
inumazioni nelle catacombe del
Duomo furono proibite nel 1782
dall'imperatore Giuseppe II.
In quello stesso anno papa Pio
VI fece visita all'imperatore
allo scopo di indurlo a
rivedere la sua politica
religiosa e celebrò
nel Duomo la messa solenne di
Pasqua. In quell'occasione
egli donò all'allora
arcivescovo di Vienna, il
cardinale Migazzi, che resse
l'arcidiocesi per 46 anni,
paramenti di grande valore
conservati ancora oggi nella
Camera dei Paramenti.
 Le
costruzioni adiacenti al Duomo
andarono a mano a mano
scomparendo: già
nel 1699 era stata rimossa la
Casa delle Reliquie che, in
seguito al disprezzo per le
reliquie causato dalla
Riforma, aveva perso ogni
significato; prima del 1792
sparirono anche gli edifici
riservati a cantori, ministri
ecclesiastici e prestamisti,
di modo che
l'imperatore Francesco II,
quando fece il suo ingresso a
Vienna, poté
ammirare per la prima volta la
vista ovest della Cattedrale.
Durante le Guerre Napoleoniche
(1809), nelle quali si arrivò
a combattere anche nel Duomo,
vennero danneggiate diverse
opere d'arte ivi conservate. Le
costruzioni adiacenti al Duomo
andarono a mano a mano
scomparendo: già
nel 1699 era stata rimossa la
Casa delle Reliquie che, in
seguito al disprezzo per le
reliquie causato dalla
Riforma, aveva perso ogni
significato; prima del 1792
sparirono anche gli edifici
riservati a cantori, ministri
ecclesiastici e prestamisti,
di modo che
l'imperatore Francesco II,
quando fece il suo ingresso a
Vienna, poté
ammirare per la prima volta la
vista ovest della Cattedrale.
Durante le Guerre Napoleoniche
(1809), nelle quali si arrivò
a combattere anche nel Duomo,
vennero danneggiate diverse
opere d'arte ivi conservate.
Nel
XIX secolo, il rinato
interesse per il passato
richiamò
l'attenzione sul cattivo stato
di conservazione in cui si
trovava la Cattedrale dopo
secoli di incuria.
L'architetto Friedrich von
Schmidt, combattuto tra il
desiderio di conservare la
purezza di stile e quello di
preservare la sostanza, alla
fine riassunse il risultato
nella bella immagine della
chiesa di Santo Stefano come
di un libro che si poteva
sfogliare, ma in cui non si
poteva scrivere nulla. Solo
poche suppellettili in stile
neogotico trovarono allora
posto nel Duomo.
Nel
corso del restauro, in
occasione del quale, nel 1853,
vennero completati anche i
frontoni delle navate (fino a
quel momento era stato
terminato solo il cosiddetto
"Frontone di
Federico" sulla Porta dei
Cantori, gli altri erano solo
dipinti), si arrivò
tra il 1838 e il 1860 alla
demolizione e alla
ricostruzione della guglia
della Torre Sud. Tra il 1859 e
il 1887 si dotò la Cattedrale
di pitture su vetro in stile
neogotico, che poi sarebbero
state
distrutte
completamente nel 1945.
Nel 1900 le reliquie medievali
furono trasferite dall'attuale
sala capitolare nella cappella
di S. Valentino (cappella
doppia superiore nord nella
parte ovest). Agli inizi di
questo secolo si intrapresero
gli interventi di restauro
della facciata occidentale e
del Portale Gigante.
Sebbene
il Duomo avesse sopportato due
assedi turchi e le guerre
napoleoniche, tuttavia sul
finire della Seconda Guerra
Mondiale fu distrutto quasi
per metà.
All'inizio della guerra i suoi
tesori più importanti, ovvero
il Portale Gigante, il pulpito
e la tomba di Federico, furono
murati e sfuggirono quindi
alla distruzione operata
dall'incendio dell'11 e 12
aprile 1945. Nella catastrofe
le fiamme propagatesi dagli
edifici intorno al Duomo
distrussero le capriate
gotiche, gli scanni dei
Consiglieri di epoca
tardogotica situati nella
Navata Centrale, il monumento
alla liberazione dai Turchi,
le vetriate, la Grande Croce
di Wimpassing, la Croce dello
jubé, eccetto le braccia e il
capo di Gesù crocifisso, gli
oratorii imperiali, il grande
organo, l'organo del Coro e la
maggior parte delle campane,
"Pummerin" compresa.
Nell'insieme andò così
perduto un 45% del Duomo. Si
deve alla volontà del
cardinale Theodor Innitzer, in
quel tempo arcivescovo della
città, e del Prof.
Karl
Holey,
architetto Duomo,
come anche alla collaborazione
disinteressata ed effettiva
dei viennesi, delle varie
regioni dell'Austria e di
molti finanziatori stranieri,
che Santo Stefano non sia
diventato un monumento
commemorativo ed ammonitore
contro la guerra, ma, anzi,
con la sua ricostruzione, sia
assurto a simbolo della
resurrezione dell'Austria.
Finalmente,
il 19 novembre 1948, fu
celebrata la prima messa nella
navata centrale ricostruita.
L'inaugurazione solenne della
restaurata cattedrale ebbe
luogo il 26 aprile 1952 in
presenza del cardinale
Innitzer. Quello stesso giorno
la nuova Pummerin, fusa con i
resti della vecchia campana,
fece il suo ingresso trionfale
a Vienna. Nel 1957 essa fu
definitivamente posta nella
Torre Nord.
Per
consentire una degna sepoltura
ai vescovi di Vienna, nel 1953
si edificò
nelle catacombe la Cripta
Episcopale. Nel 1956 si
procedette ad un restauro
della Cripta Ducale e alla
costruzione della chiesa
inferiore, di un
lapidario e della Cripta dei
Canonici. Nel 1960, il
cardinale di Colonia, Frings,
consacrò
il nuovo organo e, nel 1972,
fu collocata la nuova vetrata
ovest, fabbricata in Tiralo.
Nel corso delle sue visite
pastorali, nel 1983 e nel
1988, papa Giovanni Paolo II
visitò anche il Duomo. Nel
1989, per adeguarsi alle nuove
esigenze liturgiche fissate
dal Concilio Vaticano II, si
procedette ad un riassetto
della zona dell'altare
maggiore, al termine del quale
fu consacrato un nuovo altare.
Nel
1991, in occasione del
seicentocinquantesimo
anniversario della
consacrazione del Coro
Albertino, il Duomo fu dotato
di un nuovo organo che fu
posto nel Coro degli Apostoli.
Qualche anno più
tardi (1997), in occasione
degli ottocentocinquanta anni
della consacrazione
dell'antica chiesa romanica,
fu riaperto, dopo lunghi
lavori di restauro, il Portale
Gigante e, contemporaneamente,
si riadattò la galleria ovest
per destinarla a spazio
espositivo.
Simbolismo
All'uomo
illuminato del XX secolo
risulta piuttosto difficile
comprendere il messaggio
spirituale del Duomo. I
doccioni dall'espressione
scimmiesca posti all'esterno
del Duomo dovrebbero
allontanare i demoni. Anche
l'utilizzazione di materiale
da costruzione romano dovrebbe
essere intesa in questo senso.
Riutilizzando e consacrando
parti di edifici pagani, si
toglieva loro il potere. Cosi
ancora oggi si trova nell'arco
interno destro del Portale
Gigante una lapide funeraria
romana dalle lettere quasi
cancellate e, nascosta dietro
la nicchia del portico, dove
si trova la figura del
grifone, fu scoperta nel 1996
la cosiddetta
"Guardona", effigie
di donna proveniente da
un'altra pietra tombale
romana.
 In
una nicchia con una grata
situata presso la Porta del
Vescovo si trovavano i
cosiddetti
"Tartari", divinità
pagane. Un'iscrizione
conservata ancora oggi mette
in guardia contro la
venerazione di questi idoli e
invita a mantenersi fedeli
alla fede cristiana. Sotto gli
orologi delle Torri Pagane
sono rappresentati
plasticamente, a sinistra, un
fallo e, a destra, una vulva.
Forse costituiscono un indizio
della presenza di un tempio
pagano della fertilità sul
luogo dell'attuale chiesa. Il
potere delle divinità pagane
era stato ormai sconfitto,
ciononostante la presenza
delle suddette
rappresentazioni testimonia
la continuità
di culto in questi luoghi:
Santo Stefano è da sempre
suolo sacro. Ne sono un chiaro
indizio proprio i recenti
scavi nell'area del Portale
Gigante, che hanno portato
alla luce
numerose sepolture. In
una nicchia con una grata
situata presso la Porta del
Vescovo si trovavano i
cosiddetti
"Tartari", divinità
pagane. Un'iscrizione
conservata ancora oggi mette
in guardia contro la
venerazione di questi idoli e
invita a mantenersi fedeli
alla fede cristiana. Sotto gli
orologi delle Torri Pagane
sono rappresentati
plasticamente, a sinistra, un
fallo e, a destra, una vulva.
Forse costituiscono un indizio
della presenza di un tempio
pagano della fertilità sul
luogo dell'attuale chiesa. Il
potere delle divinità pagane
era stato ormai sconfitto,
ciononostante la presenza
delle suddette
rappresentazioni testimonia
la continuità
di culto in questi luoghi:
Santo Stefano è da sempre
suolo sacro. Ne sono un chiaro
indizio proprio i recenti
scavi nell'area del Portale
Gigante, che hanno portato
alla luce
numerose sepolture.
Il
percorso iconografico: il
Portale Gigante con la sua
ricca simbologia ci parla, se
lo contempliamo in possesso di
alcune informazioni previe e
ci abbandoniamo alle sue
suggestioni. Chi ne varca la
soglia, calpesta suolo sacro,
entra in un santuario. Ci si
deve immaginare l'interno
medievale molto più oscuro:
le vetrate e gli altari di
epoca gotica gli avrebbero
conferito un'atmosfera più
solenne. Nel coro centrale è
interessante pensare che sotto
i nostri piedi si trovano le
catacombe, luogo di sepoltura
di quei cristiani che hanno già
compiuto il loro cammino. La
vista dell'altare maggiore ci
indica la direzione da
seguire. Nella pala
dell'altare contempliamo la
visione di Stefano morente: i
cieli aperti.
Volgendo
quindi lo sguardo verso
l'alto, riconosciamo, a circa
metà altezza dei pilastri, i
santi che ci vengono quasi
incontro come messaggeri
dell'Aldilà. Rappresentano
quei cristiani che han già
raggiunto la pienezza: la
Chiesa dei santi. Infine lo
sguardo incontra le volte con
le loro nervature di pietra
che s'intrecciano e la
peculiare decorazione che ne
deriva: simbolo dell'infinito,
dell'Uno, del trascendente,
che nessuna immagine può
rappresentare.
In
questo senso è
anche interessante il ricco
simbolismo numerico del Duomo.
Non è casuale che le vetrate
delle navate laterali, il
luogo riservato ai credenti,
siano quattro e quelle del
coro, il luogo in cui si
celebra il mistero della
Messa, siano tre. Non sono
solo ragioni estetiche a
motivare la presenza nella
parte superiore della
Torre Sud di dodici
pinnacoli intorno ad una
guglia centrale: essi
simboleggiano i dodici
Apostoli intorno al Maestro.
La balaustrata del pulpito è
costituita da motivi trilobati
e quadrilobati che formano una
ruota. I motivi quadrilobati
sembrano svolgersi verso il
basso, mentre i motivi
trilobati verso l'alto.
Il
numero uno simboleggia il Dio
Uno, ma anche il Cristo. Tre
Persone costituiscono la
Trinità,
quattro sono gli Evangelisti.
Il numero quattro è anche un
numero "terrestre"
che allude ai quattro elementi
(terra, aria, fuoco ed acqua),
alle quattro stagioni, ai
quattro temperamenti e ai
quattro punti cardinali. Il
numero sette, somma dei due
precedenti numeri, è un
numero sacro, rappresenta la
perfezione; basti pensare ai
sette sacramenti della Chiesa
cattolica, ai sette diaconi
della Chiesa primitiva, uno
dei quali fu Santo Stefano, o
ai sette sigilli del libro
dell'Apocalisse.
E
sulla base dei numeri tre e
quattro si possono calcolare
in modo quasi preciso le
proporzioni del Duomo: il tre
seguito dal sette da il numero
37. 37 moltiplicato per tre da
111 ovvero l'unità,
ed infatti il Duomo ha una
larghezza di 111 piedi (un
piede = cm. 32). La lunghezza
del Duomo è di 333 piedi,
ovvero 111 moltiplicato per
tre. Lo stesso numero
moltiplicato per quattro da
444, cioè
l'altezza della Torre Sud. Ed
infine 343 gradini, ovvero
7x7x7, conducono alla camera
della Torre Sud.
Per
concludere, un accenno alle
dimensioni dell'attuale
Cattedrale: la lunghezza è
di m.107,2, la larghezza dei
tre cori di m. 34,2, l'altezza
del coro centrale di m. 22,4.
La navata centrale e le
laterali misurano rispettivamente
m. 28 e m. 22,4 di altezza.
L'altezza massima del tetto
del coro è
di m. 46,7, mentre quello
della navata centrale
raggiunge i m.59,9. La Torre
Sud misura m. 136,4 e la Torre
Nord con la cupola m. 60,6.
Esterno
del Duomo

IL
TETTO - Al tetto
compete la funzione estetica
di dare unità
alle diverse parti della
Cattedrale, facciata
occidentale, cappelle a due
piani, navate e coro, ed allo
stesso tempo di fare da
raccordo tra il corpo
dell'edificio e la Torre Sud.
Simile a un duomo sul Duomo,
il tetto si erge con m. 37,85
al di sopra della navata e m.
25,30 sul Coro, per una
lunghezza di m.110. Ha una
campata di m. 35 ed una
pendenza di 64 gradi, 80 nei
punti di massima pendenza. In
questo modo, l'alta velocità
di deflusso delle acque
piovane fa sì che il tetto si
mantenga pulito. Il tetto è,
dunque, un capolavoro della
tecnica, ottenuto con 605
tonnellate di acciaio. Esso
sostituisce, sin dall'incendio
del 1945, l'armatura gotica,
costituita da quasi 3000
tronchi d'albero. I tronchi
avrebbero occupato un bosco di
km 1,5, corrispondente più o
meno alla superficie
dell'ottavo distretto
di Vienna
(Josefstadt).
La
peculiarità
del tetto è rappresentata
dalle 230.000 tegole policrome
smaltate. Ogni tegola pesa kg.
2,5, è fissata con due chiodi
di rame ai falsi puntoni del
tetto ed è posta nella malta.
Il motivo zigzagato sul tetto
delle navi, interrotto da una
fascia decorata a rombi, è
ottenuto dalla combinazione di
dieci colori diversi. Sul lato
sud del tetto del Coro
Albertino sono visibili,
inoltre, lo stemma della casa
imperiale d'Austria, con la
data del 1831, ed il
monogramma F.l. (Francesco I);
sul lato nord, le insegne
della città di Vienna e della
Seconda Repubblica, con la
data del 1950. Le tegole
smaltate provengono - come
quelle di epoca gotica - da
Postorna, nella Repubblica
Ceca.
LA
TORRE SUD - Le statue
di Rodolfo il Fondatore,
situate presso la Porta dei
Cantori e la Porta del
Vescovo, documentano, grazie
al modello di chiesa a due
torri che reggono fra le mani,
che originariamente erano
previste per S. Stefano due
torri di uguale altezza, come
nel caso delle Torri Pagane. È
un dato di fatto che, al
contrario di quanto avvenuto
per altre chiese, si
intraprese la costruzione
della Torre Nord solo dopo
aver completato la Torre Sud.
Le fondamenta della torre più
alta, quella che,
soprannominata affettuosamente
"Steffi", ovvero
"Stefanino",
costituisce il simbolo della
città, sono relativamente
poco profonde, ovvero solo m.
3,5 circa, a testimonianza
della eccezionale statica
dell'edificio.
 La tradizione narra che fosse
proprio il duca Rodolfo IV a
porre la prima pietra di
questa chiesa il 7 aprile
1359. La parte inferiore, con
l'annessa cappella di S.
Caterina (battistero),
fu completata nel 1369
ed il primo piano nel 1404.
Poiché
non furono rispettati i
disegni originari, nel 1409 si
arrivò alla demolizione
parziale dell'edificio
costruito fino a quel momento,
ma già quello stesso anno
furono ripresi i lavori su
progetto di Peter von
Prachatitz e con il
finanziamento della borghesia
cittadina. Nel 1416 poterono
essere collocate le campane al
secondo piano della torre e,
il 10 ottobre 1433, Hans von
Prachatitz pose la croce a due
bracci sulla punta della
torre. Il campanile di S.
Stefano veniva cosi ad essere
il più alto d'Europa dopo
quello di Strasbugo.
La tradizione narra che fosse
proprio il duca Rodolfo IV a
porre la prima pietra di
questa chiesa il 7 aprile
1359. La parte inferiore, con
l'annessa cappella di S.
Caterina (battistero),
fu completata nel 1369
ed il primo piano nel 1404.
Poiché
non furono rispettati i
disegni originari, nel 1409 si
arrivò alla demolizione
parziale dell'edificio
costruito fino a quel momento,
ma già quello stesso anno
furono ripresi i lavori su
progetto di Peter von
Prachatitz e con il
finanziamento della borghesia
cittadina. Nel 1416 poterono
essere collocate le campane al
secondo piano della torre e,
il 10 ottobre 1433, Hans von
Prachatitz pose la croce a due
bracci sulla punta della
torre. Il campanile di S.
Stefano veniva cosi ad essere
il più alto d'Europa dopo
quello di Strasbugo.
L'unitarietà
dell'effetto ottico che esso
offre, basato sul principio
della torre piramidale che si
assottiglia procedendo verso
la sommità, testimonia la
genialità del suo architetto
e costruttore.
La base del campanile è
un quadrato che a poco a poco
diviene un ottagono.
Originariamente
al di sopra del coronamento
triangolare era previsto il
piano superiore ottagonale;
ma, intorno al 1400, una
modificazione radicale del
progetto aggiunse ancora,
sopra il coronamento, un piano
che ospita una cella
campanaria quadrangolare.
Da
questo ottagono, dal quale si
eleva la guglia del campanile,
si staccano le torri d'angolo,
in modo tale che ben dodici
pinnacoli circondano la
guglia. Poiché
il campanile è attiguo al
Coro degli Apostoli, i
pinnacoli suggeriscono un
programma iconografico
significativo: i dodici
Apostoli.
La
guglia del campanile (simbolo
di Gesù
Cristo) è divisa in tre parti
(simbolo della Trinità). Da
una piccola base scolpita, di
forma ottogonale, si eleva il
fiorone quadripartito con il
suo capitello. L'aquila
bicipite con una croce a due
bracci su cui è inciso il
motto dell'imperatore
Francesco Giuseppe I "Virìbus
Unitis" corona lo Steffi.
Dal
XV secolo alla Seconda Guerra
Mondiale, la stanza dei
campanari, situata a 82 metri
d'altezza, servì ai
vigili del fuoco come
punto di osservazione. Durante
l'assedio turco, essa ebbe
un'importanza strategica
particolare. Il grande
orologio, che già
nel 1417 si trovava sulla
Torre Sud, fu rimosso solo
durante i lavori di restauro
del 1860/61. La nuova torre,
rinnovata dal 1862 al 1864, è
da allora priva di orologio.
Una
targa commemorativa (1997),
situata nel contrafforte
orientale, vicino alla Porta
della Campana dei Quarti,
ricorda il capitano Gerhard
Klinkicht che, nell'aprile del
1945, si oppose all'ordine di
distruggere il campanile di S.
Stefano.
LA
TORRE NORD - Il 13
agosto 1450, l'imperatore
Federico III pose la prima
pietra della Torre Nord,
soprannominata "Torre
dell'Aquila" per la
figura che la corona.
Architetto dell'Opera del
Duomo era allora Hans
Puchbaum. Un'antica tradizione
riferisce che, su ordine
dell'imperatore, per spegnere
la calce, fu utilizzato il
vino. A causa della
maturazione prematura
dell'uva, infatti, il vino
aveva sviluppato un'acidità
talmente elevata che lo si
voleva gettar via. La calce,
però, con l'aggiunta di vino,
diventa particolarmente
resistente e quindi adatta
alle costruzioni. Affinché le
fondamenta potessero
stabilizzarsi, si interruppero
i lavori per 17 anni, finché,
il 2 giugno 1467, in
occasione di una cerimonia, il
vescovo di Passavia non pose
su di esse la prima
pietra.
I
progetti conservati
documentano che, nella costruzione
della torre, ci si orientò
per lo più alla già compiuta
Torre Sud. Nel 1511, la Torre
Nord raggiunse l'altezza
attuale; i lavori di
completamento previsti non
furono più ripresi. Nel 1578,
Hans Saphoy edificò la
calotta rinascimentale che
accoglie elementi gotici ed
ospita la
grande campana,
la "Pummerin". Il
sogno di terminare la torre,
ricorrente nei sec. XVII e
XIX, non fu mai realizzato.
 
LE FIGURE ALL'ESTERNO DEL DUOMO - All'esterno
del Duomo si trovano numerose
figure, per lo più
copie del secolo
scorso, i cui originali sono
conservati nel Museo di Storia
della Cit là. Le statue
rappresentano santi e avi del
duca Rodolfo IV. Rimandiamo
qui soprattutto alla figura di
S. Stefano (1460 circa) della
Torre Sud. Essa era parte
della decorazione originaria
che sii trova al di sopra del
primo piano, plesso il
cosiddetto "Banchetto di
Starhemberg". Da questa
posizione, infatti, il conte
Ruggero di Starhemberg,
difensore della città del
secondo assedio turco,
osservava, nel 1683, i
movimenti dell'esercito
nemico.
Dal
pulpito di Giovanni di
Cnpisliano (sec.
XV), vicino all'ingresso
delle catacombe, il
santo predicò su ordine
dell'imperatore
Federico
III. Non è
stato chiarito se il
semplice pulpito gotico
in origine si trovasse
all'esterno, nell'allora
cimitero di S.
Stefano,
o
se invece
fosse l'antico
pulpito del Duomo. Su di esso
i francescani,
nel 1738,
fecero sistemare una
apoteosi barocca del loro
santo, morto nel 1456 durante una campagna contro i Turchi.
I
PORTALI DELLE TORRI - La
"Porta della Campana
dei Quarti",
sotto la Torre Sud, e
la "Porta
dell'Aquila",
sotto la Torre Nord, sono, in
confronto alle entrate dei
principi, piuttosto semplici.
Oltre alle figure delle
colonnine, che rappresentano
gli Evangelisti (ingresso alla
Navata degli Apostoli), e a un
angelo nella volta del
portico, non sono conservate
nella Porta della Campana dei
Quarti altre figure
originarie. La disposizione
dei baldacchini lascia invece
supporre la progettazione di
un programma figurativo più
complesso.
Nei
baldacchini delle arcate
esterne, si trovano oggi
figure neogotiche del soc.
XIX, alcune di esse copie. Gli
originali
si trovano nel Museo di Storia
della Città.
Nel pilastro centrale interno
dell'ingresso, si osserva una
statua di Maria con il Bambino
Gesù (1420 circa). Le pareti
del portico della Porta
dell'Aquila sono finemente
traforate e, a parte una
statua di Maria del sec. XVII
(ingresso alla Navata di
Nostra Signora), non
presentano elementi
figurativi.
LA
PORTA DEI CANTORI - L'opera
d'arte gotica più significativa è
costituita dalla "Porta
dei Cantori", ingresso
laterale del Duomo, situato a
sud ovest, anticamente adibito
al passaggio dei cantori. Già
la chiesa romanica presentava
un ingresso nello stesso
punto. Nel 1440, a protezione
del magnifico timpano, venne
costruito un portico che ha
permesso la conservazione del
portale con il suo ricco
programma figurativo. Nel sec.
XIX, un restauro effettuato
per ripristinare la leggibilità
della pietra comportò la
perdita della policromia.
Particolarmente
suggestiva è l'elaborazione plastica
della fascia inferiore del
timpano con scene tratte dalla
vita dell'apostolo Paolo
(ingresso alla Navata degli
Apostoli). Fu infatti ai piedi
di Paolo che i carnefici
posero le vesti di Stefano
dopo l'esecuzione. La sua
figura è quindi
indissolubilmente legata alla
biografia del patrono della
chiesa.
A
sinistra, è rappresentata la cavalcata di Saulo verso
Damasco, al centro, la caduta
di Saulo e, infine, la sua
conversione. La serie di scene
è incorniciata da particolari
composizioni architettoniche.
La fascia superiore del
timpano, infine, rappresenta
il battesimo e il martirio
dell'Apostolo delle Genti.
Gli
apostoli nella strombatura
furono scolpiti, a due a due,
da diversi artisti.
Significativa
è anche la rappresentazione del fondatore della
chiesa, Rodolfo IV, e della
sua sposa Caterina,
rispettivamente nella parte
inferiore destra e sinistra
della strombatura, ciascuno
con il proprio stemma. I due
personaggi sono rappresentati
in piedi, come nell'atto di
entrare in chiesa, rivolti
appena l'uno verso l'altro.
Rodolfo regge nella mano
destra il modello stilizzato
di S. Stefano, Caterina uno
scettro.
Nel
portico troviamo figure di S.
Paolo, di Cristo con il globo
terrestre, come anche figure
neogotiche (1893) dei santi
Rodolfo, Francesco ed
Elisabetta di Turingia.

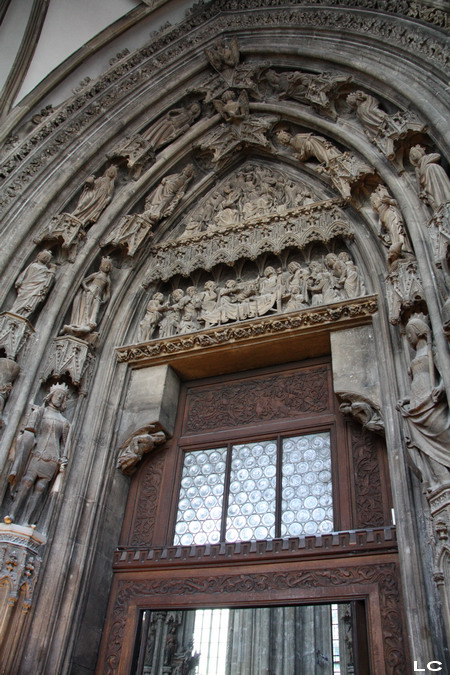
LA
PORTA DEL VESCOVO -
Questo portale (1360 circa),
attraverso il quale una volta
il vescovo faceva il suo
ingresso in chiesa, riprende
per costruzione e struttura la
Porta dei Cantori, situata di
fronte. Nel timpano, nella
fascia inferiore, è rappresentata la
Dormizione di Maria. La madre
di Dio si trova su una
lettiera, davanti alla quale
sono poste delle lampade. Al
capezzale e ai piedi del letto
sono rannicchiate le prefiche.
Dietro il capo di Maria
morente, si trova suo figlio
Gesù, con la destra sollevata
in atto benedicente. Nella
mano sinistra sorregge l'anima
incoronata dì sua madre. Gli
apostoli dolenti accompagnano
la scena con diversi servizi
liturgici: S. Pietro recita
preghiere da un libro, un
altro tiene pronta
l'acquasantiera, un altro
ancora il turibolo.
Nella
fascia superiore del timpano i
riconosce l'Incoronazione di
Maria: Cristo, seduto in trono
con sua madre, incorona Maria:
"Sii fedele fino alla
morte e ti darò la corona della vita". Angeli ed arpie,, esseri con corpi di
uccello e teste di angelo,
sorreggono il drappeggio che
copre il trono. Tutt'intorno,
a completare la scena, degli
angeli accompagnano l'evento
con la musica.
Negli
archivolti sono scolpite
figure di sante (ingresso alla
Navata di Nostra Signora),
mentre nella strombatura si
trovano di nuovo Rodolfo IV (a
sinistra) e Caterina (a
destra). I loto stemmi sono
rappresentali qui in
modo
quasi aneddotico: Rodolfo
regge uno scettro e, nella
mano destra coperta da un
drappo, il modello della
chiesa.
Nel
portico si può osservare una graziosa rappresentazione
dell'Annunciazione.

IL
PORTALE GIGANTE - Il
Portale Gigante, eretto tra il
1230 e il 1250, fu
trasformato, in occasione
della visita dell'imperatore
Federico II, in un imponente
portale molto lavorato.
Abbiamo notizia dell'esistenza
del portale anteriore solo
grazie agli scavi
archeologici. Il portale
maggiore di S. Stefano
appartiene con tutta la
fabbrica occidentale al
patrimonio costitutivo più
antico e significativo della
Cattedrale. Il suo nome ha
origine - come quello delle
Torri Pagane - da una
tradizione locale.
Probabilmente si deve alla
presenza di un osso di mammuth
che vi era appeso o alla
radice "risen"
dell'antico alto tedesco, con
il significato di "tirare
dentro, entrare". Il nome
"Torri Pagane" si
riferisce invece alla forma
delle torri stesse, che
ricorda dei minareti, sebbene
il termine "pagano"
possa anche alludere alla loro
notevole antichità.
Il
Portale Gigante subì varie trasformazioni e
rimaneggiamenti soprattutto
per quanto riguarda le
colonne, la distruzione; delle
decorazioni degli
stipiti
(forse in seguito ad un
incendio del 1258), il
trasferimento di alcuni
rilievi, come anche la
collocazione, avvenuta in
epoca posteriore, di entrambe
le figure nell'intradosso
all'imboccatura dell'arco
ogivale gotico ed il
rifacimento della figura di
Cristo nel timpano.
Il
timpano presenta al centro la
rappresentazione del Cristo
Pantocratore, signore della
terra, in trono
sull'arcobaleno, mentre
solleva la destra benedicente
e nella sinistra tiene il
libro della vita. Un'aureola
con la croce gli circonda il
capo. Nel nimbo si osservano
quattro stelle, opera però di mano più tarda; la superficie rimanente
della lunetta è completata da
piante in germoglio. Viticci e
grappoli d'uva, simboli
eucaristici, si trovano anche
sugli stipiti della porta. La
porta diventa così simbolo
della "porta coeli".
Entrando nel Duomo
attraverso
di essa, lo sguardo cade
immediatamente sul dipinto
dell'altare maggiore che
mostra la lapidazione di
Stefano e l'apertura dei cieli
con Cristo alla destra del
Padre. Il fedele, attraverso
la porta, viene introdotto
nella vastità del Duomo che altro non vorrebbe se non condurre
a Cristo.
Sette
colonne sostengono da ogni
lato il portale. Gli stipiti,
nella cui parte superiore sono
scolpite teste di animali,
corrispondono ai diversi
livelli del portale. Le
colonne, in parte incassate,
costituiscono con i loro
capitelli la base della zona
superiore. Piante e boccioli
animano questo spazio; tra di
essi si riconoscono volti
umani, visi dall'espressione
grottesca e teste di animali.
La zona a rilievo soprastante
i capitelli caliciformi
mostra, nella strombatura
sinistra anteriore, presso la
porta, una scimmia
accovacciata, il demonio
nell'atto di mettere un cappio
al collo di un uomo, e due
aquile, delle quali quella
dalle penne lisce simboleggia
la beatitudine eterna, l'altra
con il piumaggio ruvido è simbolo di dannazione.
Un leone corre verso le
aquile; lo seguono sirene
alate e due draghi intrecciati
l'uno con l'altro. Nella
strombatura destra si vedono
due cani, di esecuzione
posteriore, con un'unica testa
e legati con viticci. I
rilievi successivi presentano
una volpe che trascina
per i capelli un uomo
sdraiato.
Tra un leone ed una scimmia,
un uomo ne afferra un altro
per il copricapo appuntito,
mentre solleva l'ascia per
colpire. Segue un piccolo
demonio, quindi un uomo con le
mani alzate che precede draghi
intrecciati tra loro. Il corpo
di un animale dalla testa
umana e una sirena danzante
tra due teste concludono
questa serie di rilievi.
Nella
strombatura sinistra è
rappresentato l'inferno, in
quella destra il mondo degli
uomini, alla mercé dei
demoni. Nella parte superiore
segue ora la rappresentazione
del mondo del sublime, il
mondo dei santi: al di sopra
delle colonne troneggiano gli
Apostoli con nelle mani libri
e pergamene con lo sguardo
rivolto verso l'alto - quanto
più essi sono vicini al
centro, tanto più guardano
con concentrazione il Cristo. A sinistra si riconosce S. Pietro con la
chiave, a destra S. Paolo. Gli
Apostoli, al pari delle
colonne che li sorreggono,
diventano simbolicamente
colonne della fede e testimoni
del Giudizio Universale.
Quattordici santi, ovvero due
volte sette, sono qui
rappresentati: si tratta degli
Apostoll con l'aggiunta dei
due evangelisti, Luca e Marco,
che non vengono annoverati fra
i Dodici. Questa
interpretazione è suffragata
dal fatto che dieci delle
figure hanno in mano dei
libri, mentre quattro di esse
rotoli di pergamena.

Il
portico gotico rese necessarie
modifiche decisive e risale
allo stesso periodo della
finestra gotica, aperta
intorno al 1440 al posto di un
rosone romanico. Le due figure
nell'intradosso interno
rappresentano, a sinistra, un
uomo con la piccozza, a
destra, un uomo accovacciato;
si potrebbe trattare di uno
scalpellino e del costruttore.
È interessante notare che
la piegatura del ginocchio
sinistro del Cristo fu
scalpellata via. Alla base di
ciò possiamo vedere
probabilmente un antico
cerimoniale di ammissione ad
una corporazione edile
medievale. In questo modo le
due piccole statue, maestro e
garzone, renderebbero omaggio
"all'architetto del
mondo".
Il
portico, che nel XV secolo fu
abbassato e modificato per la
costruzione della finestra ad
ovest e nel quale è introdotto il portale, mostra nella zona superiore un grifone nell'atto
di colpire un animale, a
destra Sansone che spalanca le
fauci di un leone dopo averlo
immobilizzato con un
ginocchio, a sinistra, su un
trono, un giudice con le gambe
accavallate, popolarmente
detto "l'Estrattore di
spine", e una figura di
S. Stefano, trasferita qui in
epoca posteriore (copia del
1997). La rappresentazione del
giudice e i due leoni che lo
fiancheggiano indicano che in
questo portale si doveva
amministrare la giustizia.
Il
23 marzo 1997, la porta, dopo
necessari interventi di
restauro durati oltre un anno,
è stata solennemente riaperta dal cardinale
arcivescovo Christoph Schònborn.
I lavori di restauro hanno
messo a nudo anche resti degli
strati di pittura medievale
del portale. Scavi
archeologici in
questa
aerea hanno riportato alla
luce, oltre a molti reperti
funerari, anche tratti di muri
di precedenti edifici finora
sconosciuti: un portico
rettangolare e le fondazioni
di un portale di epoca
precedente. Poiché nel Medioevo le sepolture si trovavano solo
intorno alle chiese, si può
dedurre dalla presenza
ininterrotta di tombe sotto
questo portale più antico,
l'esistenza di una chiesa di
epoca precedente situata più
ad est.
Percorso
iconografico
- L'ingresso
del Portale Gigante, fino al
1952 aperto solo per le grandi
solennità, guida il fedele verso Cristo, così come fanno
gli Apostoli. Una volta
all'interno dell'edificio, si
ripete lo stesso schema
iconografico: i santi sulle
colonne fanno quasi ala e
conducono verso l'altare
maggiore, simbolo di Gesù
Cristo.
Interno
del Duomo

LA
NAVATA CENTRALE - L'interno
non segue lo schema classico
di una cattedrale gotica, ma
si presenta con l'interno a
tre navate tipico di una
chiesa parrocchiale.
L'edificio è orientato chiaramente verso il coro. Ogni navata
si riferisce ad un tema
iconografico preciso, come
testimoniano in particolare i
santi sui pilastri: la Navata
Centrale con l'altare maggiore
fa riferimento a Gesù Cristo,
ma anche a S. Stefano e a
tutti i santi; la navata
laterale posta a sud, agli
Apostoli e quella a nord, alla
Madre di Dio. In questo
contesto, si osservi che il
coro centrale presenta una
leggera curva verso nord; non
è stato chiarito se questo
fenomeno si possa spiegare con
l'orientamento ad est o se
celi propositi iconografici:
il capo chino del Redentore
sulla croce.
L'altare
maggiore fu costruito dai
fratelli Johann Jakob e Tobias
Pock, di Costanza, su
commissione del principe
vescovo Philipp Friedrich
conte Breuner, e fu consacrato
il 19 maggio 1647. Per quanto
riguarda la concezione, esso
appartiene al tipo "Porta
Coeli", poiché,
nella sua struttura, ricorda
un portale. La pala d'altare
è opera di Tobias Pock:
rappresenta la lapidazione di
S. Stefano davanti alle mura
di Gerusalemme e su di lui i
cieli
aperti
con Cristo seduto alla destra
del Padre. Nella parte anteriore
sinistra del dipinto, la
rappresentazione del giovane
con un cane e con lo sguardo
quasi proteso verso l'esterno
è ritenuta l'autoritratto
dell'artista Tobias Pock.
L'altare
maggiore di S. Stefano
costituisce il primo e più
significativo esempio di
altare del primo barocco a
Vienna. Svariati gradini
conducono all'imponente mensa
dell'altare sul quale dal
1989, anno dell'ultima
risistemazione dell'altare
(rimozione del tabernacolo),
si trovano sette candelieri
dorati barocchi: una allusione
ai primi sette diaconi della
Chiesa. Lo zoccolo, le colonne
isolate, la travatura e il
frontone sono eseguiti in
marmo nero polacco sul quale
ben risaltano i due stemmi
sullo zoccolo e i mezzi
pilastri in marmo grigio della
Stiria. I restanti elementi
decorativi e figurativi sono
realizzati in marmo bianco
tirolese.
La
pala d'altare, alta 15 metri,
fu dipinta su peltro (fuso da
Gian Giorgio Diepolt di
Costanza) per timore che una
tela non resistesse, viste le
dimensioni
del dipinto. Essa è fiancheggiata dalle
statue di S. Sebastiano e del
margravio Leopoldo IIII,
patrono dell'Austria, a
sinistra, e da quelle del martire
S. Floriano,
altro
santo
austriaco, e di S. Rocco, a
destra. S. Sebastiano e S.
Rocco sono venerati quali
protettori dalla peste e,
proprio a ricordo delle
epidemie, hanno trovato posto
sull'altare maggiore. Nella
parte superiore, accanto a due
grandi angeli, si trovano due
vescovi di incerta
identificazione. Potrebbe
trattarsi di Quirino e
Severino o di Bonifacio e
Ruperto. Il dipinto
rettangolare rappresenta
Maria, Regina degli Apostoli e
dei Santi. A coronamento
dell'altare si trova infine
una statua dell'Immacolata. Il
giorno precedente la
consacrazione dell'altare
maggiore, il principe vescovo
Breuner consacrò
la grande colonna mariana
davanti alla chiesa "Am
Hof". In quell'occasione,
l'imperatore Ferdinando III
fece al vescovo la solenne
promessa di proclamare
l'Immacolata Concezione
patrona dell'arciducato
d'Austria.


Gli
stalli barocchi del coro, che ospitava il capitolo
furono realizzati tra il 1639
e il 1648, sotto il vescovo
Breuner, da Mattia Hàckl su
progetto Johann Jakob Pock. La
parte posteriore è articolata
da colonnine che incorniciano
conchiglie nelle quali sono
sistemati i busti di papa
Paolo II e dell'imperatore
Federico MI, fondatori della
diocesi di Vienna, oltre a
quelli dei vescovi della città.
La loro identificazione è
possibile grazie ai
sottostanti cartigli araldici
e alle sigle poste al di
sopra
dei busti. Dopo la Seconda
Guerra Mondiale, al coro fu
aggiunta una fila di stalli da
ciascun lato.
Delle
originarie vetrate gotiche
sono giunte a noi attraverso i
secoli solo le tre inserite
nelle finestre del coro. La
vetrata della Crocifissione
era posta in origine nella
finestra centrale,
probabilmente come
continuazione iconografica del
perduto altare maggiore
gotico. Nel 1901 la vetrata
venne trasferita nella
finestra destra. Nella zona
sottostante è
rappresentata la lapidazione
di S. Stefano, patrono del
Duomo, nella parte superiore,
la Crocifissione.
Gli
altari a pilasti e gli altari
laterali - La pala
d'altare originaria, dipinta
da Martino Altomonte,
rappresentava S. Giovanni
Nepomuceno, santo nazionale
della Boemia. Fu l'unica ad
andare distrutta nell'incendio
del Duomo e fu sostituita da
un'opera di soggetto simile
del cosiddetto Schmidt di
Krems, prestito dell'abbazia
di Melk. Poiché l'Abbazia richiese indietro la pala, fu eseguita
una copia dell'Estasi di S.
Giovanni Nepomuceno, quella
che attualmente orna l'altare
che funge da credenza. A
sinistra e a destra si trovano
le statue di S. Giovanni
Battista e di S. Giovanni Evangelista.
L'altare
fu portato a compimento nel
1723.
L'altare
di S. Carlo Borromeo,
terminato nel 1728, era
originariamente ornato da una
pala di Michaele Rottmayr
(oggi conservata nel Museo del
Duomo). Nel 1783, questa venne
sostituita con una pala di
Wolfgang Kòpp,
eseguita con la tecnica a scagliola,
che rappresenta l'arrivo in
Cielo del giovane cardinale
milanese, intercessore contro
la peste. Il dipinto è
fiancheggiato, a sinistra e a
destra rispettivamente, dalle
sculture di S. Pietro e S.
Giacomo il Giovane.
Le
immagini superiori di entrambi
gli altari mostrano degli
angeli nella gloria celeste.
L'altare
con l'immagine miracolosa di
"Maria nel sole"
- L'altare
di Nostra Signora, adibito
alla comunione, come fa
pensare la presenza
tutt'intorno di una
cancellata, ospita la
miracolosa immagine tardo
gotica (risalente agli anni
tra il 1470 e il 1480) di
"Maria nel sole",
qui trasferita il 18 ottobre
1693. Il dipinto rappresenta
Maria in piedi sulla falce di
luna con Gesù Bambino in braccio. Sopra la testa della Madre
di Dio, due angeli sorreggono
la corona degli Asburgo. Ai
suoi piedi, da entrambi i
lati, sono inginocchiati i
membri di una non meglio
identificata famiglia di
donatori. Il dipinto è opera
di un artista anonimo
presumibilmente della scuola
di Martin Schongauer e
ricorda, quanto a confezione e
a stile, l'opera di Hans
Siebenbùrger, artista attivo
a Vienna nel tardo sec. XV.
Il
progetto dell'altare risale a
Mathias Steinl. Accanto ai due
angeli posti sui lati, si
trovano le statue dei santi
Simone e Giuda Taddeo che
ricordano l'altare anteriore.
Nella parte superiore è
rappresentato Dio Padre, chino
verso il dipinto, con lo
Spirito Santo. Le due figure
laterali rappresentano S.
Giovanni Battista (sinistra) e
S. Benedetto (destra).


L'altare
di S. Giuseppe - Analogamente all'altare di Nostra Signora,
anche l'altare di S. Giuseppe
fu concepito come
altare
per la comunione. La
sua erezione risale al 1700
circa e il progetto è
attribuito anch'esso a Mathias
Steinl.
La pala d'altare di
Anton
Schoonjans è dipinta
su metallo e rappresenta il
giovane S. Giuseppe nell'atto
di presentare al fedele il Bambino
Gesù per
l'adorazione (vi è apposta la
data del 1699).
Accanto agli angeli in
preghiera sono
rappresentati gli evangelisti
Matteo e Marco e nella parte
superiore
Luca
e
Giovanni. Molto
ben riuscita, da un
punto di vista iconografico,
è
l'Annunciazione collocata
al di sopra della pala.
L'altare di Santa Cecilia
- La
pala di questo altare,
coronata da un rilievo
araldico, mostra S. Caterina
inginocchiata su delle nuvole.
Accinto a lei sono S. Cecilia,
patrona della musica, e S.
Lucia. Sopra di loro si libra
un grosso angelo circondato di
putti che tiene tra le mani la
corona del martirio. Le statue
rappresentano S. Giovanni
Evangelista e un santo con la
barba senza attributi. Il
dipinto nella parte superiore
mostra la Madonna con il
Bambino, con lo sguardo chino
verso i santi della pala
sottostante. L'altare termina
con una figura di S.
Elisabetta di Turingia posta
su un piedistallo. Sul gradino
si legge una iscrizione che
ricorda la donazione
dell'altare da parte di
Nikolaus Wilhelm Becker,
barone di Walhorn.
L'altare
di S. Gennaro -
La
pala di Martino Altomonte
rappresenta la Gloria di S.
Gennaro sulla città di Napoli. Degli angeli sorreggono il pastorale,
la palma (simbolo del
martirio) e le ampolle con il
sangue del santo. San Gennaro
è infatti noto soprattutto
per il miracolo dello
scioglimento del sangue che si
ripete dal 1389 a scadenze
regolari. Il dipinto è
fiancheggiato dalle statue di
S. Giovanni Nepomuceno e di S.
Nicola. Nella parte superiore
troviamo la rappresonlaziono
del martirio di S. Vito,
patrono
dell'altare anteriore. Delle
due sante è
identificabile solo S. Maria
Maddalena, a sinistra. I
rilievi sul basamento
riproducono l'arresto di S.
Gennaro e l'ammansimento dei
leoni.

Il
pulpito, che studi
recenti non attribuiscono più
ad Anton Pilgram, risale al
tardo sec. XV (al più tardi
1480) ed è costituito da tre
blocchi di pietra arenaria le
cui giunture sono
riconoscibili ad occhio nudo.
La tribuna del pulpito si
eleva dalla base d'appoggio
come un fiore stilizzato, dal
quale spuntano, petali
immaginari, i quattro Padri
della Chiesa. La base è
costituita da sei graziose
colonnine con rappresentazioni
dei santi; la colonna
portante, più grande e posta
al centro, simbolizza la
domenica, giorno in cui dal
pulpito si predicava.
Le
figure di poco più grandi
rappresentano, insieme con le
statue poste tra i Padri della
Chiesa, i Dodici. Le restanti
mostrano santi molto venerati
e patroni di vari uffici. I
busti dei quattro Dottori
della Chiesa, dai lineamenti
molto simili, che guardano
fuori da un balcone chiuso
gotico, simboleggiano anche i
quattro temperamenti e,
insieme con il "Guardone",
le quattro età dell'uomo. Da
destra a sinistra: S. Ambrogio
con mitra e libro simboleggia
il temperamento sanguigno; S.
Geronimo,
con cappello cardinalizio e
libro,
è rappresentato come vecchio collerico; S.
Gregorio, con tiara, libro e
lente d'ingrandimento, è
visto come lo scettico
flemmatico e di mezza età; da
ultimo S. Agostino, con mitra,
libro e calamaio, rappresenta
il giovane melancolico,
assorto nei suoi pensieri.
Come
già osservato, tre blocchi di arenaria costituiscono
il pulpito, mentre i quattro
Dottori della Chiesa ornano la
tribuna. Tre per quattro è
uguale a dodici: sia
l'insegnamento dei Padri della
Chiesa che l'omelia del
sacerdote dal pulpito si
basano sui dodici Apostoli
che, infatti, assumono la
funzione portante nel
basamento del pulpito.

La
balaustrata si compone
di quattro ruote con motivi
trilobati e quadrilobati. Le
une simboleggiano la Trinità, le altre sono simbolo
delle cose terrene, delle
stagioni, dei punti cardinali
e dei temperamenti. Il
predicatore, mentre sale la
scala del pulpito, deve
lasciar dietro di sé tutto ciò
che è terreno e peccaminoso;
quanto c'è di divino, invece,
deve portarlo con sé e, colmo
di esso, annunciare la parola
di Dio. Strani animali,
serpenti, anfibi e rane
popolano il corrimano della
ringhiera. Così viene
rappresentata la lotta tra il
Bene e il Male: le rane, che
si trattengono nei pantani ed
evitano la luce del sole,
simboleggiano insieme con i
serpenti il Male.
Le
lucertole e gli anfibi, che
invece escono al sole, sono
simbolo del Bene. Si riconosce
chiaramente infatti come rane
e anfibi si mordano a vicenda.
La lotta sembra incerta, non
si sa chi ne uscirà
vittorioso; ma, affinché
nessuno degli animali cattivi
raggiunga il predicatore, è
posto alla fine del corrimano
un cagnolino con l'incarico di
impedire che qualche ospite
indesiderato arrivi su.
L'ingresso al pulpito è
costituito da una porta con un
motivo trilobato e statuette
neogotiche delle tre Virtù
teologali: Fede, Speranza e
Carità. L'attuale corona del
fonte battesimale funse fino
alla Seconda Guerra Mondiale
da baldacchino del pulpito
che, in questo modo, ricordava
la forma di un turibolo.


Nel
cosiddetto
"Guardone"
ritroviamo le sembianze
dell'anonimo maestro del
pulpito, proveniente
probabilmente dal circolo di
un certo Niclaes Gerhaert van
Leyden. Squadra e compasso lo
accreditano quale architetto,
l'abbigliamento ed i capelli
lunghi quale libero cittadino.
Il
pulpito venne più volte restaurato, così per esempio nel 1652 e
agli inizi del sec. XIX. In
quell'occasione esso fu
verniciato completamente on
colore ad olio grigio. Poiché
il pilastro del pulpito
cedette leggermente, nel 1870
fu puntellato e
successivamente, tra il 1878 e
il 1880, si procedette ad un
restauro radicale: venne
smontato e portato via e fu
liberato dalla cappa di colore
ad olio, cosa che determinò
però la perdita dell'antica
pittura conservata sotto. Una
volta integrate e restaurate
idealmente alcune parti, il
pulpito fu ricomposto. Una
iscrizione sotto il
"Guardone" ricorda
questi interventi di restauro.
Il
pulpito di S. Stefano fu
sempre luogo di controversie e
dispute. Così,
ad esempio, al
tempo
della
Riforma,
il 12 gennaio 1522, il vescovo
Georg von Slaktonia lasciò il pulpito al predicatore protestante Paulus
Speratus, che da lì tenne ai
religiosi di Vienna lì
riuniti una fervente predica
contro la vita monastica,
invitandoli ad abbandonare il
convento. E da qui predicò S.
Pietro Canisio (1597), primo
gesuita tedesco e predicatore
di S. Stefano.
Nel
nostro secolo, il cardinale
Theodor Innitzer tenne da qui
il 7 ottobre 1938, nel corso
delle celebrazioni per la
Madonna del Rosario, la sua
famosa predica ai giovani,
nella quale li invitava alla
fedeltà
a Cristo e alla sua Chiesa:
"Solo uno è il vostro
duce, Gesù Cristo!".
Queste coraggiose parole
ebbero come conseguenza
l'assalto al palazzo vescovile
della gioventù hitleriana.

L'altare
di S. Giovanni Battista -
La
pala di Michael Rottmayr
(1788) raffigura l'imposizione
del nome a S. Giovanni
Battista da parte del padre
Zaccaria. Al centro siede S.
Elisabetta che tiene il
fanciullo tra le braccia e lo
porge all'osservatore. Nella
metà sinistra del dipinto, è rappresentata la
Madonna incinta. Dietro di lei
si riconosce S. Giuseppe.
Anche
del progetto e dell'esecuzione
di questo altare
particolarmente affascinante,
che si appoggia artisticamente
al pilastro gotico, si assume
la responsabilità Mathias Steinl. Al di sopra della pala, è
rappresentata l'Immacolata,
affiancata da due sante.
L'altare è coronato da una
raffigurazione della Trinità.
È anche interessante la
presenza di due figure che
dall'altare si volgono verso
la navata: a sinistra, S.
Francesco e, a destra, la
statua molto venerata di S.
Antonio da Padova.
La
galleria ovest e le cappelle
laterali doppie
- Sotto
Rodolfo il Fondatore, furono
aggiunte alla navata romanica
ancora esistente le doppie
cappelle a sinistra e a destra
delle Torri Pagane. Le due
cappelle superiori erano
raggiungibili dalla galleria
occidentale. L'antica galleria
ducale fu destinata dal duca
Rodolfo a sede del Capitolo di
Ognissanti da lui fondato.
L'apertura del grande
finestrone gotico divenne
necessaria solo con la
costruzione a volta della
navata gotica (dal 1446).
In
corrispondenza delle Torri
Pagane si trovano, nella
galleria ovest, volte a
crociera tardo-romaniche e
rosoni con ruote a raggi e
intrecci che costituivano le
originarie finestre della
navata romanica. Nel lato nord
si riconosce un affresco
romanico raffigurante Cristo
nella mandorla, a destra
Maria, a sinistra Giovanni il
Battista. A sinistra, al di
sotto della
scena,
si distingue una figura
femminile con un bimbo in
braccio cui accenna una mano
che fuoriesce dalle nuvole.
Tra le numerose
interpretazioni di questa
scena, la più corrente la ritiene la rappresentazione di una
investitura medievale.
L'affresco viene anche inteso
come allusione al fatto che
qui si trovava l'antica
galleria ducale dei Babenberg.
I piccoli appoggi gotici, che
sorreggono i positivi degli
organi, costituivano in un
primo tempo basi di appoggio
di altari.
La
cappella superiore nord,
chiamata cappella di S.
Valentino, fu terminata
nel 1440 e racchiude dagli
inizi del secolo il tesoro
delle reliquie del Duomo, cui
aveva dato inizio il duca
Rodolfo.
Un
altare delle reliquie
neogotico, opera di Ludwig Lìnzinger,
racchiude
le
reliquie di vari santi oltre
al reliquiario con le teste
dei Santi Cosma e Damiano.
Armadi a muro barocchi
intarsiati e piramidi d'altare
contengono reliquiari e
mostranze con varie reliquie.
Al centro della cappella è situato un sarcofago con
le ossa di S. Valentino. I
pochi oggetti di venerazione
di epoca medievale
pervenutici, come la preziosa
custodia con una scheggia
della Santa Croce, sono
conservati ed esposti nel
Museo Diocesano e del Duomo
dal 1933.

La
cappella di S. Bartolomeo
(cappella superiore sud),
chiamata anche Cappella Reale
o Ducale, racchiudeva una
volta nelle sue finestre le
cosiddette "vetrate degli
Asburgo", una specie di
genealogia della dinastia,
oggi conservate nel Museo di
Storia della Città.
Degne di nota sono anche le
due chiavi di volta (S.
Michele con la bilancia per
pesare le anime e S. Michele
che uccide il drago).
Il
Principe Eugenio di Savoia è sepolto nella tomba al
centro della cappella della
Santa Croce (cappella
inferiore settentrionale,
altrimenti detta cappella
Morandus, Tirna, Liechtenstein
o Savoia). La parete
dell'altare è ornata da un
crocifisso tardogotico con
capelli naturali; l'affresco
che lo circonda fu eseguito da
Johann Ender nel 1853. Il
monumento funebre per il
principe Eugenio di Savoia (t
1736), generale dell'esercito
imperiale nella guerra contro
i turchi, fu fatto erigere da
sua zia, Maria Teresa Felicita
di Savoia, nel 1752. Il
monumento, collocato nel muro,
è costituito da un sarcofago
e da una piramide decorata con
sculture
di Joseph Wurschbauer. Nello
stesso anno furono rinnovati
anche la mensa dell'altare e
l'imponente tabernacolo
barocco; già
nel 1731 erano stati
realizzati l'altare della
croce e la grande cancellata
barocca di ingresso. Nelle
statue neogotiche dei pilastri
si riconoscono, a cominciare
dalla destra dell'ingresso, i
santi Francesco di Paola,
Giovanni Battista, Elisabetta
di Turingia, Francesco e
Leopoldo; mentre, a sinistra
dell'altare, i santi Stefano,
Severino, Teresa di Avila,
Giuseppe e Luigi.
La
cappella inferiore sud, la
cappella del Duomo riservata
all'adorazione, è denominata cappella di S. Eligio. Essa è
adornata da interessanti
chiavi
di
volta del sec. XIV (Ecce Homo,
Maria con il Bambino) e
dall'unico altare gotico a
portelli del Duomo a noi
pervenuto. L'altare di S.
Valentino, donazione del
vescovo di Chimsee, Ludwig
Ebner, fu eseguito
originariamente per la
cappella omonima. Nel pannello
centrale è inserita la figura del
santo vescovo Valentino tra
quelle di S. Odilia e S.
Orsola. I portelli aperti
presentano, a sinistra, San
Leodegario, a destra, S.
Erasmo. All'esterno dei
portelli si vedono S. Barbara,
a sinistra, e S. Elisabetta, a
destra. Le ali fisse esterne
mostrano, a sinistra, S.
Caterina, a destra, S. Rocco.
Nella parte superiore
dell'altare è posta la
statuetta di un Ecce Homo
(copia). Sul lato sinistro
della cappella, sulla base di
una colonna, c'è una scultura
policroma di Maria con
il Bambino (1330 circa), qui
trasferita dall'antico
convento della Himmelpfortgasse
e perciò detta anche
la "Himmelpfòrtnerin", ovvero la
"Portiera del Gelo".
Le
figure dei pilastri
raffigurano, a partire da
destra, i seguenti santi: una
santa non identificata (1360
circa), Ludmilla (1360 circa),
un santo vescovo con calice
(1365 circa), Biagio (1890),
la "Portiera del
Gelo" con Eligio (1890);
a sinistra dell'altare,
Remigio (1890), Leonardo
(1890), un abate santo con
pietra e pastorale (1365),
Afra (1360) e Maria con Gesù
Bambino (1365).
Nell'altare
di questa cappella ogni
giorno, dalle 6.00 alle 22.00,
è esposto il Santissimo
per la venerazione
.
Navata
di Nostra Signora
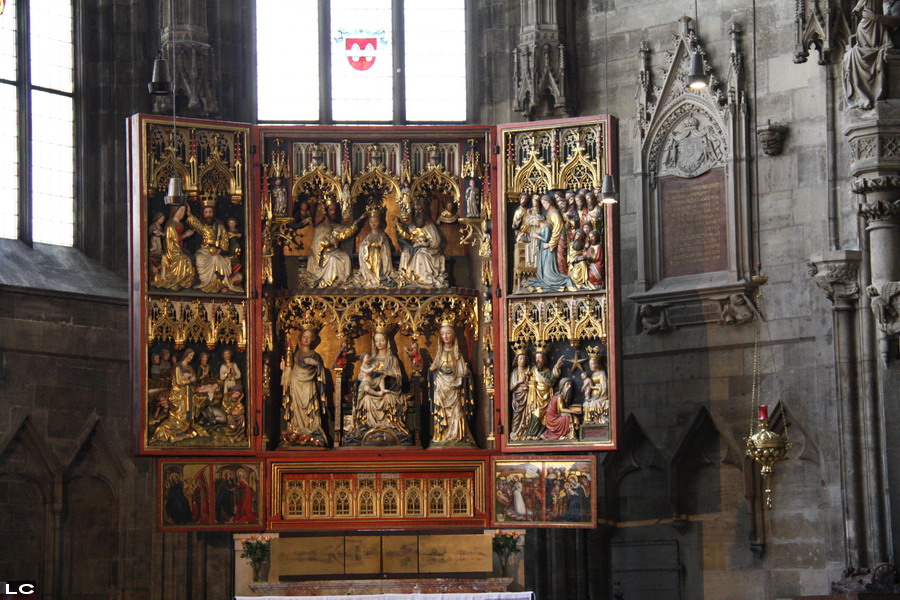
L'altare
di Wiener Neustadt, databile
nel 1447 grazie all'iscrizione
sulla predella, fu costruito
utilizzando antichi frammenti
per il monastero cistercense
di S. Bernardo a Wiener
Neustadt. Nel 1883 arrivò
a S. Stefano, dove fu
collocato dapprima nel lato
sud del Coro degli Apostoli,
poi, nel 1952, nel Coro di
Nostra Signora. L'altare
ospita il tabernacolo
principale del Duomo. È
considerato una donazione
dell'imperatore
Federico
III,
poiché sulla predella si trova il suo motto
"AEIOU". Queste
cinque lettere vengono
interpretate in modo
differente, ma la decifrazione
di esse è, a dire il vero,
alquanto discutibile.
Si
tratta di un altare
trasformabile a quattro
portelli, evoluzione
dell'armadio delle reliquie.
Aprendo i portelli della
predella, appaiono piccole finestre gotiche traforate, dietro le quali un
tempo venivano conservate
delle reliquie. Esse venivano
esposte ai fedeli solo in
occasione delle feste
solenni; nei giorni feriali
e le domeniche ordinarie le
reliquie - che costituivano il
patrimonio più prezioso di un
monastero - venivano poste al
sicuro chiudendo le finestre.
I portelli aperti della
predella mostrano scene dalla
vita di Maria: a sinistra,
l'Annunciazione e
la Visitazione;
a destra, la
Nativita e l'Adorazione dei
Magi. I
portelli chiusi rappresentano scene
dalla
Passione: a
sinistra,
Gesù sul
Monte degli Ulivi e la
Crocifissione; a destra, la
Flagellazione e la Coronazione
di spine.
Quando
i grandi portelli sono chiusi
(lato dei giorni feriali), è
possibile vedere
raffigurazioni di santi su
fondo scuro, disposti su
quattro file; a portelli semi
aperti (la domenica) si vedono
parimenti dei santi, ma su
fondo dorato. In complesso
sono visibili 72 santi, tra i
quali alcuni Apostoli, i santi
Floriano e Cristoforo, o,
accanto a santi dell'ordine
benedettino o a S. Stefano,
anche santi piuttosto
sconosciuti, come il
leggendario S. Morando,
venerato dagli Asburgo come
loro presunto antenato.
Poiché la severa regola dei cistercensi per lungo tempo
permise la rappresentazione
plastica solo del Crocifisso
e di Maria, troviamo
rappresentato sull'altare
aperto un ciclo mariano. Al
centro, Maria, la nuova Eva, seduta in trono con il
Bambino in braccio; alla sua
sinistra, S. Barbara con la
torre e, alla sua destra, S.
Caterina con la spada. Sopra
questa scena, l'Incoronazione
di Maria.
Nel
portello sinistro, sono
riconoscibili, nella parte
inferiore, la Natività, in quella superiore, un'altra Incoronazione di
Maria. Nel portello destro, è
visibile l'Adorazione dei
Magi. È interessante
osservare che tra i Magi non
vi è nessun moro. In questa
scena è rappresentato
l'omaggio delle stagioni della
vita al loro Redentore. Il re
sbarbato, a sinistra,
raffigura la giovinezza, il
secondo l'età adulta, il
terzo, inginocchiato, la
vecchiaia. Nel riquadro
superiore è rappresentata la
Dormizione di Maria,
circondata dagli Apostoli. Il
prediletto Giovanni sostiene
la Madre di Dio morente,
mentre Gesù accoglie l'anima
incoronata di Maria.
Attualmente
l'altare viene chiuso a metà
durante l'Avvento e la
Quaresima, completamente nella
Settimana Santa


Il
cenotafio del duca Rodolfo IV e della sua sposa Caterina
(1360 circa) ci è pervenuto
purtroppo in un pessimo stato
di conservazione. Anticamente
nei baldacchini della galleria
erano rappresentati eruditi e
monaci - riferimento ai meriti
di Rodolfo nella fondazione
dell'università. Le figure di
Rodolfo e Caterina, eseguite
in arenaria, erano adornate di
pietre preziose.
Originariamente il monumento sepolcrale era situato
nel Coro Centrale, vicino
all'entrata alla sua tomba. In
occasione delle celebrazioni
funebri per l'imperatore
Federico III, nel 1493, fu
trasferito nel lato destro del
Coro di Nostra Signora. Dopo
la guerra fu spostato alla
parete sinistra del Coro di
Nostra Signora. Solo da poco
ha ripreso posto alla destra
dell'altare di Wiener
Neustadt.
L'altare
dei Santi Pietro e Paolo -
L'unico
altare ligneo del Duomo è anche l'altare della
corporazione degli scalpellini
e risale al 1677. Sopra una
mensa gotica si eleva la
struttura in legno
marmorizzata, simile per
concezione all'altare
maggiore. Ai lati della pala
di Tobias Pock, che mostra la
glorificazione dei due
principi degli Apostoli, sono
le figure di due santi
monarchi: a destra,
l'imperatore Enrico e, a
sinistra, il margravio
Leopoldo. Il dipinto superiore
mostra i Santi
Quattro
Coronati ai piedi di Maria.
Statue di S. Sebastiano e S.
Rocco, invocati contro la
peste, sono collocate a
sinistra e a destra.
L'altare
di S. Francesco -
La
pala d'altare, spostata
all'indietro per raggiungere
un effetto spaziale, è opera di Michael Rottmayr e raffigura la
Stigmatizzazione di S.
Francesco d'Assisi. Ai lati i
santi Virgilio e Cassiano.
Il dipinto superiore mostra S. Orsola, patrona
dell'altare anteriore, con le
compagne; ai lati, S. Giacomo
Apostolo e S. Matteo
Evangelista.
Il disegno dell'altare è attribuito a Mathias
Steinl.
Il
piede monumentale dell'organo
-
Come
pendant al "Baldacchino
di Fùchsel" situato di
fronte, Anton Pilgram creò il
cosiddetto piede dell'organo.
L'imperatore Massimiliano I
appoggiò il progetto di
Pilgram.
Il maestro rappresentò sé
stesso affacciato ad una
finestra. I suoi tratti
somatici tradiscono
insicurezza e onere della
responsabilità, in quanto,
come architetto del Duomo, non
era particolarmente amato dai
suoi collaboratori. Compasso e
squadra lo identificano quale
architetto; il suo
abbigliamento, con cappello
dottorale e talare, è invece
quello di un erudito.
L'iscrizione sotto il
ritratto porta la data del
1513 e accredita Pilgram con
il titolo accademico di
"Magister".
Sopra,
nella galleria, doveva
trovarsi il primo organo del
Duomo; di fronte vi era lo
spazio destinato ai cantori.
L'altare
di S. Francesco Saverio -
La
pala d'altare (1690) raffigura
S. Francesco Saverio che
predica ai mori. Le altre
figure rappresentano i santi
Nicola e Guglielmo.
Nel
dipinto superiore, si ammira
l'Incoronazione di Maria ad
opera della Trinità;
ai lati le sante Barbara e
Caterina. Una statua di S.
Elena con la croce corona
l'altare. Nel gradino si trova
una iscrizione
che commemora la donazione
dell'altare da parte del
barone Nikolaus Wilhelm Becker
(1690).


L'altare
del Sacro Cuore di Gesù - Come
il Duomo di Ratisbona, anche
il Duomo di S. Stefano
possiede tre preziosi altari
gotici con baldacchino dei
quali quello soprannominato
"Baldacchino di
Puchheim" (1434), dal
nome della donatrice
Elisabetta di Puchheim, è il più antico ed anche il più bello. L'opera
è attribuita al maestro Hans
Puchbaum. Sull'altare si trova
una immagine molto venerata
del Sacro Cuore di Gesù del
sec. XVIII.
La
cappella di S. Barbara
- Uno
degli ambienti più semplici del duomo è
costituito dalla sala di
preghiera e meditazione: la
cappella di S. Barbara,
situata nella base della Torre
dell'Aquila. In questa
cappella tardogotica, con
chiavi di volta pendenti molto
significative (scudi), furono
rimosse le ultime tracce della
guerra solo nel 1986.
Nel
1983 fu portata qui dalla
chiesa parrocchiale di
Schonkirchen una croce
tardogotica a grandezza
naturale. Ai piedi del
crocifisso fu racchiusa una
capsula contenente ceneri
provenienti
dal
crematorio del campo di
concentramento di Auschwitz,
consegnata dal cardinale
Franciszek Macharski
all'allora Arcivescovo di
Vienna, cardinale Franz Kònig, in occasione della celebrazione
dei Vespri per
la Giornata
Cattolica, il 10
settembre 1983, alla presenza
di papa Giovanni Paolo II.
Per
i finestroni tardogotici della
cappella erano previste
vetrate di Marc Chagall sul
tema dell'immagine divina nel
Vecchio e Nuovo Testamento. La
morte dell'artista impedì purtroppo la realizzazione del progetto.

 Navata
degli Apostoli Navata
degli Apostoli
Alla
parete occidentale dello
spazio situato sotto la Torre
Nord, si trova il busto
originale di un Ecce Homo di
epoca gotica, chiamato il
"Cristo del mal di
denti".
Originariamente si trovava
nella parte anteriore esterna
del Coro Centrale, ma nel 1960
venne sostituito in quel luogo
da una copia. Il nome si deve
ad una leggenda: degli
ubriachi, di ritorno da un
giro delle osterie,
attraversarono il cimitero di
S. Stefano e si fecero beffe
dell'espressione sofferente
del Cristo, chiamandolo
"Il Cristo che ha il mal
di denti" . Gli legarono
un fazzoletto e si presero
gioco di lui. Quella notte,
però, essi vennero colpiti da un forte dolore di
denti che fu alleviato solo
quando essi andarono in
pellegrinaggio alla statua del
"Cristo del mal di
denti" per chiedere
perdono.
Il
monumento sepolcrale
dell'imperatore Federico III
-
L'imperatore
Federico III, nato ad
Innsbruck nel 1425, fu una
persona pia che non amava né
la guerra né la caccia, ma
piuttosto la botanica,
l'alchimia e l'astrologia. Si
dice che fosse di nobile
aspetto e che fosse tenace e
parsimonioso. Nel corso della
sua vita, che fu per quei
tempi molto lunga, tuttavia
non gli vennero risparmiate
guerre, dissidi e intrighi.
Nel 1452 sposò Eleonora di
Portogallo e da questa unione
nacque il futuro imperatore
Massimiliano.
L'imperatore
Federico III edificò con
grande magnificenza le sue
residenze di Linz, Graz e
Wiener Neustadt. Nel 1469
ottenne dal Papa la creazione
del vescovado di Vienna. Oltre
a fondare numerosi monasteri e
chiese, conseguì nel 1485 la
canonizzazione di Leopoldo III
Babenberg. Poco dopo essere
stato sottoposto
all'amputazione di un arto
inferiore, mori, il 18 agosto
1493, per le conseguenze di un
colpo apoplettico. I suoi
successi furono dovuti non da
ultimo al fatto che visse più
a lungo di tutti i suoi
nemici.
Tra
il 1463 e il 1467,
l'imperatore Federico III
riusci ad assicurarsi per il
suo monumento funebre lo
scultore più importante dell'epoca,
Niclaes Gerhaert van Leyden,
attivo a Strasburgo. Al
maestro in persona si devono
il progetto del monumento e il
coperchio della tomba, del
peso di circa otto tonnellate.
È eseguito in
marmo
proveniente dalla cava di
Adnet, nei pressi di Hallein.
Il
maestro Niclaes morì a Wiener Neustadt nel 1473. Nel 1479, la lastra
fu trasferita a Wiener
Neustadt per ragioni di
sicurezza, poiché Vienna era
allora occupata dalle truppe
del re d'Ungheria Mattia
Corvinio. Essa fu di nuovo
riportata a Vienna nel 1493,
ancor prima della morte
dell'imperatore. Max Valmet
esegui infine, su incarico
dell'imperatore Massimiliano,
le lastre con i rilievi,
mentre Michael Tichter di
Salisburgo, la balaustrata con
le sue 54 figure.
Il
monumento sepolcrale è costruito su tre
livelli: su una infrastruttura
ricoperta di animali di ogni
genere poggia una balaustrata
che circonda il sarcofago vero
e proprio. Nella base della
balaustrata si trovano le
raffigurazioni dei Dodici,
nella parte anteriore ovest,
al centro,
la
figura
di Cristo in veste di giudice.
Sul lato est dei gradini
conducono alla balaustra che è praticabile. Vicino alla scala si trova la
rappresentazione del Cristo
Risorto, con ai lati due
angeli con gli strumenti della
passione. Gli archi della
balaustra sono decorati con
figure di santi, tra cui anche
una di S. Leopoldo.

I
rilievi sulle pareti del
monumento simbolizzano le
fondazioni religiose
dell'imperatore: nel lato
anteriore (est) il monastero
francescano di S. Leonardo,
nei pressi di Graz (1463); sul
lato sud, a sinistra la
fondazione del convento
eremitico dei Paolani, al
centro la fondazione del
vescovado di Ljubljana (1461),
e sul lato destro la
fondazione del monastero
domenicano di S. Pietro a
Wiener Neustadt (1444); nel
lato est (posteriore) la
fondazione del monastero
cistercense di S. Bernardo a
Wiener Neustadt (1444); nel
lato nord, a sinistra Commenda
dell'Ordine cavalieresco di S.
Giorgio nel castello di Wiener
Neustadt (approvata dal Papa
nel 1469), al centro
l'istituzione del vescovado e
della collegiata di Wiener
Neustadt e, sul lato destro,
il monastero dei canonici di
S. Ulrico, situato anch'esso a
Wiener Neustadt. Sulle pareti
del sarcofago è da notare anche la raffigurazione di diversi
principi elettori che
testimoniano l'elevazione
dell'Austria a Arciducato -
nel
1453 l'imperatore Federico
confermò
il "privilegium
maius" del duca Rodolfo
IV.
Sul
bordo superiore, vescovi e
monaci in preghiera piangono
la morte del monarca. Le
pareti della tomba sono
completate dagli scudi dei
possedimenti imperiali. La
lastra di copertura del
sarcofago mostra la figura
sdraiata dell'imperatore con
la veste dell'incoronazione -
Federico fu l'ultimo
imperatore ad essere
incoronato dal Papa. I tratti
del viso sono identici a
quelli del ritratto
dell'imperatore anziano.
 A
destra del monarca si
riconoscono lo stemma
dell'ordine cavalieresco di S.
Giorgio, lo stemma imperiale
con l'aquila bicipite e lo
scudo austriaco con la fascia,
sostenuto da un leone con
l'elmo che con la sua zampa
destra afferra la spada
imperiale. Ai piedi
dell'imperatore si riconosce
lo stemma degli Asburgo, alla
sua sinistra lo stemma della
Lombardia e lo scudo con le
cinque aquile dell'antica
Austria con il cappello
arciducale, sopra il quale
un'aquila con la corona
sorregge una lascia con le
lettere AEIOU e lo stemma
della Stiria. A
destra del monarca si
riconoscono lo stemma
dell'ordine cavalieresco di S.
Giorgio, lo stemma imperiale
con l'aquila bicipite e lo
scudo austriaco con la fascia,
sostenuto da un leone con
l'elmo che con la sua zampa
destra afferra la spada
imperiale. Ai piedi
dell'imperatore si riconosce
lo stemma degli Asburgo, alla
sua sinistra lo stemma della
Lombardia e lo scudo con le
cinque aquile dell'antica
Austria con il cappello
arciducale, sopra il quale
un'aquila con la corona
sorregge una lascia con le
lettere AEIOU e lo stemma
della Stiria.
È interessante il messaggio
iconografico del monumento: il
basamento del sarcofago è
popolato da ogni sorta di
figure grottesche, creature
fiabesche, animali e teschi.
Essi simboleggiano
il peccato
nella
vita
dell.imperatore. I rilievi
sulle pareti
del monumento testimoniano
invece le buone azioni
dell'imperatore. Infine, nella
cornice superiore del
sarcofago,
monaci,
sacerdoti
e
vescovi delle sue
fondazioni pregano per la
salvezza eterna del monarca.
Salendo
i gradini situati sul lato
est, è possibile raggiungere la balaustrata. La
raffigurazione del
Risorto domina la
parete est, angeli sorreggono
gli strumenti della passione.
È possibile salire nella
gloria dei Cieli solo
attraverso la Passione e la
Resurrezione di Cristo. Lo
stesso imperatore volge lo
sguardo ad oriente. Sembra
alzarsi dalla sua tomba,
rivolto verso il sole
nascente, simbolo di Cristo.
Al di sopra del capo
dell'imperatore, la rappresentazione
di S. Cristoforo fa
riferimento alla profonda fede
del pio signore: S. Cristoforo
era consideralo il protettore
dalla morte improvvisa,
imprevista. Guardando la sua
immagine la mattina presto, si
era salvaguardati da un
decesso imprevisto.
Ai
nostri giorni, una
esplorazione con la sonda ha
confermalo che l'imperatore
Federico III è veramente sepolto a S. Stefano, nel più grande
ed importante monumento
funebre imperiale medievale al
nord delle Alpi.
La
croce dello jubè - Sulla
parete sud del Coro degli
Apostoli è stata fissata dal 1952
la cosiddetta "Croce
dello jubé", monumento
ai caduti della Seconda Guerra
Mondiale. Fino al 1945 si
trovava sopra il cancello
rinascimentale a mo' di croce
sull'arco trionfale. Durante
l'incendio del Duomo, la
figura del Cristo, eccetto la
testa e le mani, andò
completamente distrutta e fu
poi rifatta liberamente. La
croce è incorniciata da sei
rilievi della Passione (1515
-1520) che un tempo, prima di
essere trasferiti qui nel
1952, erano situati sul lato
esterno della sala capitolare,
al di sopra degli affreschi.
Il
nuovo organo del Duomo -
Il nuovo organo,
fabbricato nel 1991 dalla
ditta austriaca Rieger,
dopo quasi quindici anni di
discussioni e progetti, ha
trovato finalmente la sua
sistemazione nella Navata
degli Apostoli: la scelta è stata fatta in vista della funzione liturgica
dell'organo, così come anche
per ragioni architettoniche.
Lo strumento ha 55 registri su quattro tastiere. Si
tratta di un organo
principale, molto compatto,
sobrio nella posizione di un
organo di coro. Possono
esservi eseguiti con le
migliori condizioni anche
brani da concerto, persino con
accompagnamento
dell'orchestra. La forma
esterna non si adatta
all'architettura gotica, ma
piuttosto alla decorazione
interna del Duomo,
principalmente barocca.

La
Madonna dei
servi - La
leggenda narra che una serva
accusata di furto accorresse a
questa statua di Maria a
chiederle protezione e che, in
seguito a ciò,
fosse provata la sua
innocenza. Il nome, però, si
spiega piuttosto con il fatto
che questa statua (eseguita
intorno al 1320 o, secondo
altre ricerche, già nel 1280
circa) originariamente si
trovava sull'antico altare
dedicato a Maria nel Coro di
Nostra Signora, dove un tempo
veniva celebrata la messa
mattutina, frequentata per lo
più dal personale di
servizio.
La
figura della Madonna, unita
delicatamente a Gesù Bambino
per mezzo del velo, è
considerata per la sua
eleganza una delle più belle
statue mariane dell'epoca.
Dell'originaria policromia
sono riconoscibili solo pochi
resti, poiché il fumo delle
numerose candele di sego,
accese davanti ad essa per
devozione, con il passare del
tempo l'ha annerita. Ancora
oggi la Madonna dei servi è
una delle immagini più
venerate del Duomo.
 Altari
laterali Altari
laterali
L'altare
di S. Leopoldo -
Vicino
all'ingresso della Sacrestia
Inferiore, sotto il
"Baldacchino
Fuchsel" (fu donato nel
1448 da Agnes Fuchsel), nel
luogo originariamente
destinato ai cantori, è posto l'altare neogotico (1903) del santo
margravio Leopoldo. La
plastica figura del santo
tiene nelle mani lo scudo
dell'Austria inferiore
("scudo delle
allodole") e il modello
di una chiesa. Nella predella
si trovano i busti dei santi
Colomanno e Severino. Le
raffigurazioni sono opera
dello scultore viennese Ludwig
Schadler, mentre le parti
ornamentali furono eseguite
dallo scultore Ludwig
Linzinger di Linz. Nel muro, a
destra dell'altare, è
visibile il foro d'entrata
della pallottola di un fucile
e la data 1848. Entrambi
ricordano la rivoluzione del
1848, durante la quale si
verificarono scontri anche nel
Duomo.
L'altare
della Trinità
- Il
disegno dell'ultimo altare
eretto nel sec. XVIII (1740)
si deve probabilmente a Georg
Raphael Donner. La pala
d'altare di Michelangelo
Unterberger (1751) rappresenta
la SS. Trinità.
La pala è affiancata da due
arcangeli. Nella parte
superiore, tra due angeli in
adorazione, si vede un libro
con le parole: "In tres
unum sunt".
L'architettura dell'altare si
deve a Mathias Langwitter,
mentre l'opera scultorea a
Balthasar Moli. Tra questo
altare e l'altare di S.
Sebastiano sono posti gli
stalli di un coro barocco con
un oratorio.
L'altare
di S. Sebastiano -
La
pala d'altare (inizi del sec.
XVIII), eseguita da un artista
anonimo, raffigura il martirio
del martire romano Sebastiano.
Sull'arco a sesto ribassato
della parte superiore,
incorniciato da teste di
cherubini, si
ergono le figure di due
vescovi santi non
identificati.
L'altare
con l'immagine miracolosa di
Maria Pòcs - Sull'altare
tardogotico con baldacchino
situato a sud ovest
("Baldacchino di
Oexl"), è posta l'icona molto
venerata di Maria Pócs. Il 1
dicembre 1697 essa fu
collocata al di sopra del
tabernacolo dell'altare
maggiore per la venerazione e
vi rimase fino al 1945, anno
del trasferimento nella sede
attuale.
L'immagine
deriva il nome dalla località di provenienza, Pócs
(Ungheria settentrionale),
diocesi di Eger, dove fu
dipinta nel 1676 da Stephan
Pap.
Dopo l'esposizione nella
chiesa del villaggio, nel
1696, essa cominciò a versare lacrime. Finalmente la fama di questa
immagine miracolosa raggiunse
la corte imperiale di Vienna.
Su sollecitazione di Padre
Marco d'Aviano, l'imperatore
Leopoldo I, persona di
profonda fede, fece
trasportare l'icona a Vienna
perché fosse conservata nella
sua residenza. Dopo che essa,
su richiesta dei cittadini, fu
esposta per l'adorazione in
varie chiese, trovò infine il
suo luogo di culto definitivo
nel Duomo.
La vittoria decisiva del principe Eugenio sui
Turchi, nella battaglia
di Zenta dell'11 settembre
1697, fu attribuita da Abraham
a Sancta Clara all'immagine
miracolosa. In seguito a ciò
gli Asburgo elessero l'icona a
"palladium" del loro
impero.
In
occasione del trasferimento
dell'icona nel Duomo,
l'imperatrice Eleonora fece
dono di una sfarzosa cornice
che, probabilmente con
allusione alla rosa nella mano
di Gesù Bambino, è chiamata "cornice della Rosa
Mistica". Nel 1776 la
cornice fu sostituita da
quella attuale in argento, più
semplice e coronata da un
baldacchino. L'imperatrice
Eleonora, nella stessa
occasione, donò anche dei
magnifici paramenti per
cerimonie solenni, che portano
il suo nome e che vengono
utilizzati ogni anno per la
festa dell'Immacolata, l'8
dicembre.
La
cappella di S. Caterina o del
Battistero
- La
cappella di S. Caterina, oggi
battistero, è
una cappella gotica con un
piccolo coro addossato che si
trova ai piedi della Torre
Sud. La scelta di S. Caterina,
patrona degli eruditi e
dell'Università, si deve a
Rodolfo IV, fondatore dell'Università
di Vienna,
probabilmente
perché nell'immediata vicinanza, nell'attuale Casa
della Curia, era ospitata la
scuola media, precorritrice
dell'università.
Le significative chiavi di volta raffigurano il
Volto di Cristo, l'Agnello di
Dio e S. Caterina con spada e
ruota.
Oggi
questa piccola cappella è ornata da un altare
neogotico con una statua
gotica della santa (anni tra
il 1420 e il 1430).

A sinistra dell'ingresso, sulla
parete, si trova una statua
dell'Addolorata; a destra una
statua di S. Giovanni
Evangelista (1895).
Gioiello
della cappella è comunque il fonte
battesimale del 15° secolo.
Fu realizzato in marmo
di Salisburgo
da
un artista ignoto nel
1481, come risulta da
un'iscrizione sul bordo della
vasca. In origine si trovava
nella Navata Centrale davanti
alla cancellata della
Comunione e solo nel sec. XVII
fu trasferita nella cappella
di S. Caterina.
Al
piede del fonte si trovano,
come fondamento e base della
Rivelazione, della Fede e del
Battesimo, i quattro Evangelisti:
Matteo, Marco, Luca e
Giovanni, con
in
mano i rispettivi
attributi
e
rotoli o libri. Il
fonte
battesimale, che
sporge notevolmente oltre il
piede ottogonale, mostra in
quattordici nicchie piatte
Cristo
"Salvator
mundi", i dodici Apostoli
e S.
Stefano. Sul
bordo tagliato
obliquamente si leggono
le parole in
latino
dell'ultimo capitolo
del Vangelo di Marco:
Poi disse loro:
"Andate
per tutto il mondo,
predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi
crederà
e sarà battezzato sarà
salvo; chi non crederà,
sarà condannato".
Dalla
Seconda Guerra Mondiale, il
coronamento ettagonale del
fonte, in precedenza posto
come baldacchino
sul pulpito
del Duomo, è tornato al suo posto.
Nella
forma evoca
una
guglia gotica, è
coronato da una
rappresentazione
del
Battesimo di
Cristo e mostra su sette
riquadri, come su un
palcoscenico girevole, le
rappresentazioni molto
realistiche dei sette
sacramenti. Esse sono
incassate su sfondi traforati
e
non
sono
strettamente separate
tra loro. Sopra le
singole scene
si librano
angeli che accompagnano
l'amministrazione di ogni
sacramento con un simbolo
particolare: sul Battesimo un
angelo suona pieno di gioia il
tamburo; sulla Cresima ci sono
degli angeli in
preghiera;
sull'Eucarestia essi sorreggono
un calice; sulla
Penitenza
un angelo sorregge
un libro aperto;
sulla Ordinazione sacerdotale
e il Matrimonio
un angelo accompagna
la scena con
la musica; al
di sopra
dell'infermo,
l'angelo innalza una croce.
Sulla
parete ovest davanti alla
cappella, sono stati collocati
nel 1947 resti del monumento
alla liberazione dai Turchi
(1894), in stile neobarocco.
Esso celebra la liberazione
della città dal pericolo turco nel
1683 ed è opera di Hedmund
von Hellmer, uno degli
scultori viennesi allora più
noti. Il testo latino della
targa fu scritto da Franz
Jachym, Arcivescovo
coadiutore, quello tedesco fu
una libera traduzione della
scrittrice austriaca Paula von
Preradovic (autrice del testo
dell'inno austriaco).


Santi
dei pilastri
I
santi dei pilastri di una
cattedrale, come il Duomo di
S. Stefano, raccontavano
all'uomo medievale, che in
genere non sapeva leggere,
della vita e della morte di
Gesù e dei santi in un modo
semplice
e
accurato, ma sempre
profondamente religioso. In
questo modo i pilastri, ben
oltre la loro pura funzione
architettonica, si caricano di
valore simbolico e segnano per
così dire un "sentiero
di raccoglimento" verso
l'altare maggiore del Duomo.
Probabilmente l'idea di
elevare i pilastri a veicolo
di un programma simbolico
insolitamente ricco risale già
al duca Rodolfo IV. Anche
l'imperatore Federico III
dovette avere un'influenza
decisiva su tale programma. La
decorazione figurativa della
navata fu realizzata
contemporaneamente alle volte:
già nell'edificare le pareti
della navata, si tenne conto
delle statue, per la maggior
parte disposte in gruppi di
tre, progettando colonnine e
baldacchini.
Sebbene
il programma iconografico
sembra che non fosse stabilito
nei dettagli, è possibile tuttavia identificare alcuni dei
luoghi destinati previamente a
una figura. Mentre il
programma iconografico dei tre
cori era stato fissato, nelle
tre navate, invece, statue di
santi, scene dalle Sacre
Scritture e dalla vita di Gesù
sono disposte in modo
apparentemente arbitrario. Le
numerose repliche di santi
particolarmente popolari si
spiegano con le elargizioni,
fatte soprattutto dalla
borghesia, e sono anche un
chiaro riferimento alla
consacrazione del tempio a
Tutti i Santi. Alcune
delle figure di pietra o di
argilla si richiamano a
reliquie, altari e cappelle
della chiesa.
È
interessante sapere che
nel Duomo si trovano 96
rappresentazioni di Maria,
nell'insieme quasi una
completa narrazione della sua
vita: si tratta di statue di
legno o di pietra, dipinti, raffigurazioni individuali o
scene di gruppo su monumenti
funebri.


Duomo,
luogo di sepoltura
Le
catacombe di S. Stefano
- Le
cripte sotterranee di S.
Stefano vennero chiamate dai
viennesi con il nome di
"catacombe".
L'intero complesso di corridoi
e celle sotterranee è articolato in una parte più antica, sotto il
Duomo, ed una più recente,
situata a nord est del Duomo,
sotto la piazza. Il centro
delle catacombe è costituito
dalla Cripta Ducale, in cui,
sotto l'altare maggiore, è
posto il sarcofago di Rodolfo
IV.
Il duca Rodolfo il Fondatore fece costruire questa
tomba di famiglia per sé ed i
suoi
discendenti;
l'imperatrice Maria Teresa la
fece ampliare e restaurare
negli anni 1754/55. Oggi vi si
trovano 15 feretri, al centro
dei quali, in posizione più elevata, è posto il sarcofago di Rodolfo IV.
Nella parte anteriore
dell'ambiente ovale, sono
posti un rilievo gotico con
cimieri e due scudi dell'epoca
del duca Rodolfo, come anche
lo stemma del tempo di Maria
Teresa con l'aquila del Sacro
Romano Impero. Nelle nicchie
laterali sono conservate dal
1957 più di 70 urne
contenenti gli intestini degli
Asburgo.
Sotto
il Coro degli Apostoli si
costruì nel 1953 una cripta per
i vescovi e gli arcivescovi di
Vienna con
un
rilievo di Cristo Risorto,
opera di Josef Troyer: 14
vescovi hanno trovato qui il
loro sepolcro, la maggior
parte di essi dopo la
riesumazione in occasione del
restauro del Duomo.
Sotto
il coro centrale, nel 1952, è stato organizzato un
lapidario, in cui vengono
conservati sia frammenti di
opere d'arte del Duomo andate
distrutte, sia originali di
sculture sostituite in situ da
copie.
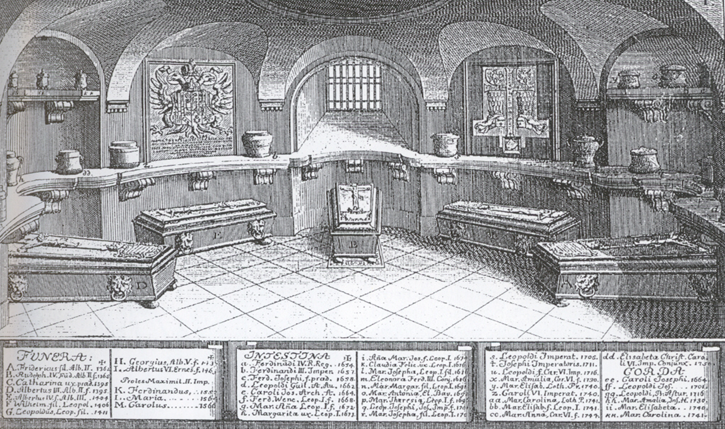 Sotto
l'incrocio della volta, si
trova il semplice vano della
chiesa inferiore (adattato nel
1957). Degno di nota è il bell'altare
dell'artista tirolese Josef
Troyer, un crocifisso ligneo
barocco (1730 circa) e una
figura classicista di Maria,
proveniente dalla cappella del
seminario di Hollabrunn. Sotto
l'incrocio della volta, si
trova il semplice vano della
chiesa inferiore (adattato nel
1957). Degno di nota è il bell'altare
dell'artista tirolese Josef
Troyer, un crocifisso ligneo
barocco (1730 circa) e una
figura classicista di Maria,
proveniente dalla cappella del
seminario di Hollabrunn.
Sotto
il Coro di Nostra Signora
trovano sepoltura i canonici
di S. Stefano.
La
parte nuova delle catacombe
(1744), immediatamente
attigua, era divenuta ormai
necessaria, poiché gli antichi locali sotto
la chiesa non erano più
sufficienti ad ospitare le
sepolture. Con la chiusura del
cimitero di S. Stefano, che
circondava la chiesa, fu
previsto un maggior numero di
sepolture all'interno delle
catacombe.
A questo
scopo, alla metà
del
XVIII secolo, furono collegate
al
sistema
delle catacombe le cantine
degli edifici circostanti. In
circa 30 anni vi trovarono
sepoltura quasi 11000 persone,
tra cui anche i grandi
architetti Johann Bernhard
Fischer von Erlach e Lukas von
Hildebrandt.
Attraverso
una scala si giunge di nuovo
all'aperto, vicino alla
cappella della Santa Croce
(1752). Davanti a questa
croce, il 6 dicembre 1791, fu
benedetta, tra molte altre,
anche la salma di Wolfgang
Amadeus Mozart.
Nel
1783, infine, l'imperatore
Giuseppe II proibì
di seppellire i morti nelle
chiese e nelle cripte.
Negli
anni seguenti, le catacombe
furono quasi inaccessibili;
nel 1872/73, il cardinale
Rauscher le fece sanare e fece
murare i resti dei cadaveri.
Come
documentato chiaramente dallo
ricerche archeologiche
effettuale nel corso del
restauro
del Portale Gigante, fin dalla
fondazione della chiesa
esisteva un cimitero. Solo nel
1732 esso venne chiuso e
pietre tombali e lampade
furono trasferite sui muri
della chiesa. Ancora oggi
testimoniano che per molti
secoli tanti fedeli hanno
trovato l'ultima dimora sotto
la protezione di S. Stefano.
Oltre
alle tombe del duca Rodolfo IV
e dell'imperatore Federico
III, importanti da un punto di
vista artistico, sono conservati nel
Duomo circa 200
epitaffi.
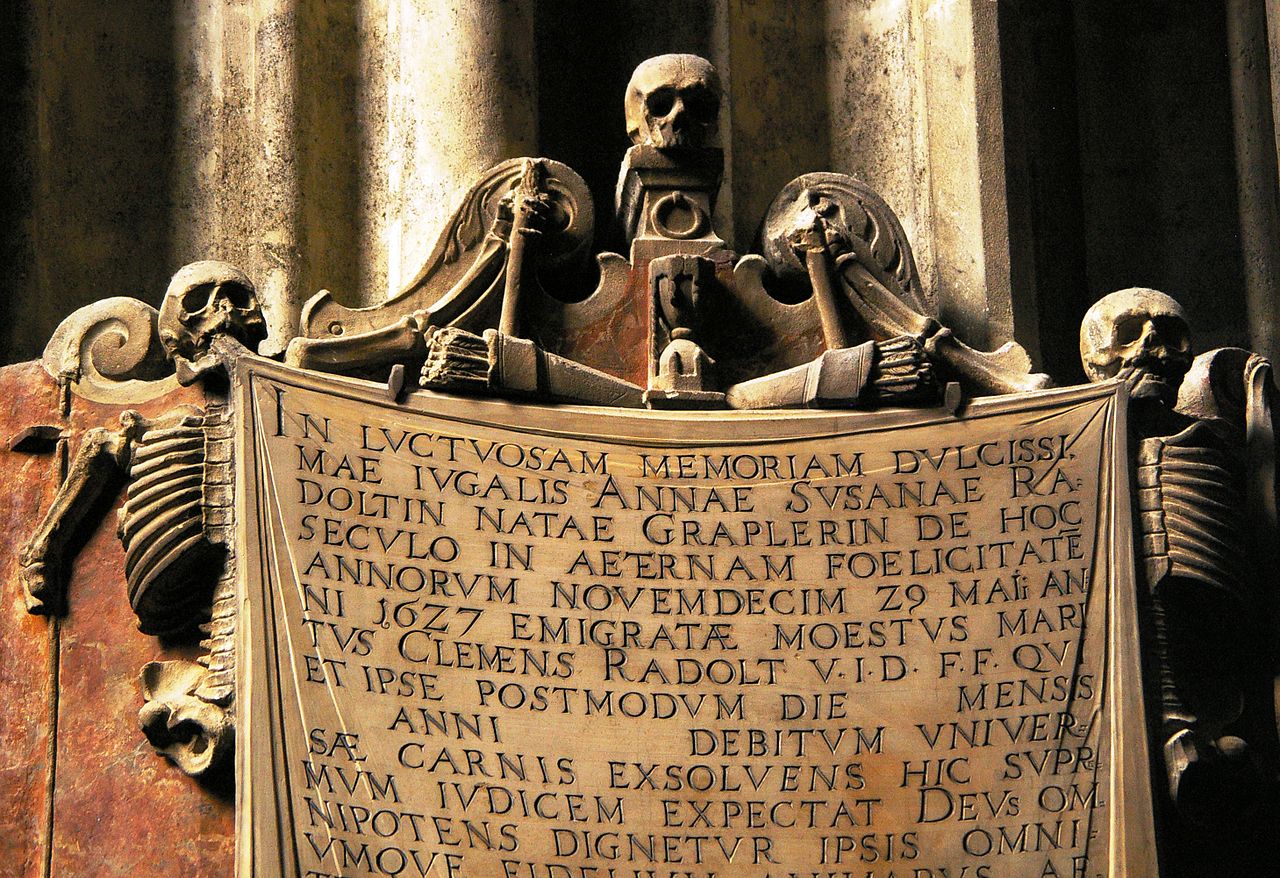
All'esterno
del Duomo si trovano molti
monumenti sepolcrali che
abbracciano un arco di tempo
compreso tra il 1440 e il
1704. La maggior parte di essi
sono stati collocati sui muri
della chiesa dopo la chiusura
dell'antico cimitero.
Nella
parte frontale del pilastro
nord-ovest della Torre Nord,
si trova una copia (1912)
dell'epitaffio composto per il
poeta umanista Conrad Celtis
(t 1508). L'originale fu posto
all'interno del Duomo, a
destra dell'ingresso
principale, presso l'ingresso
al confessionale. Rappresenta
il defunto in veste di
erudito, con le braccia
appoggiate su dei libri. Sotto
l'iscrizione sepolcrale, in
una semplice cornice
architettonica, si trova una
corona d'alloro con la croce e
le lettere "VIVO".
L'
"Orto del Getsemani di
Lackner", datato 1502, è
posto nella parte sud della
Coro degli Apostoli, insieme
con una lampada funeraria
gotica che presenta una
decorazione a rami. Esso
mostra Gesù e i suoi
discepoli sul Monte degli
Ulivi; significativi sono in
particolare i ricchi dettagli
paesaggistici. Il commerciante
Lienhart Lackner fece eseguire
questo capolavoro gotico con
l'affascinante figura di S.
Stefano in ricordo della
consorte Barbara.
Immediatamente a sinistra, il
cognato Hans Straub donò l'epitaffio che da lui
prese nome e che rappresenta
plasticamente
il commiato di Gesù da
sua madre. Egli, circondalo
dagli
Apostoli,
tende la mano
alla madre
afflitta, mentre
la
sostiene quasi con
tenerezza. La scena è
incorniciata da medaglioni che
raffigurano i Sette Dolori di
Maria. Artisticamente rilevante
è anche la cornice
rinascimentale che conferisce
all'epitaffio una particolare
eleganza.
 A
sinistra, vicino al portico
dei Cantori, si trova in alto,
con una copertura a mo' di
cappella, la tomba (1360) del
poeta e trovatore Neidhart von
Reuental, "consigliere
divertente" alla corte di
Otto l'Allegro. La lastra di
copertura mostra la figura
distesa del defunto. Sono
conservati anche resti dei
rilievi. Fu gravemente
mutilato nel corso delle
Guerre Napoleoniche (1809).
Una targa commemorativa e la
luce di una lampada
cimiteriale gotica nella
parete sud della cappella di
S. Eligio ricordano colui che
diede impulso alla
ricostruzione di S. Stefano,
il parroco del duomo, Karl
Raphael Dorr (t 1964). A
sinistra, vicino al portico
dei Cantori, si trova in alto,
con una copertura a mo' di
cappella, la tomba (1360) del
poeta e trovatore Neidhart von
Reuental, "consigliere
divertente" alla corte di
Otto l'Allegro. La lastra di
copertura mostra la figura
distesa del defunto. Sono
conservati anche resti dei
rilievi. Fu gravemente
mutilato nel corso delle
Guerre Napoleoniche (1809).
Una targa commemorativa e la
luce di una lampada
cimiteriale gotica nella
parete sud della cappella di
S. Eligio ricordano colui che
diede impulso alla
ricostruzione di S. Stefano,
il parroco del duomo, Karl
Raphael Dorr (t 1964).
All'interno
della chiesa, andarono
perduti, in seguito
all'incendio del 1945,
numerosi epitaffi sulle pareti
e sul pavimento della chiesa.
Di quelli a noi pervenuti, se
ne devono menzionare alcuni. A
sinistra del cancello della
cappella della Santa Croce, si
trova il monumento funebre di
Johannes Cuspinian, delle sue
due consorti e dei suoi otto
figli. Egli fu un importante
medico, poeta, narratore e
diplomatico al servizio
dell'imperatore Massimiliano e
mori nel 1529.
Tra
gli altari di S. Francesco e
di S. Francesco Saverio, sulla
parete nord, è posto l'epitaffio per il vescovo Johann Fabri
(t
1541). Il vescovo viennese vi è raffigurato già avanti
negli anni. Ogni domenica
predicava, dopo i Vespri, dal
pulpito del Duomo e, in
ottemperanza ai suoi desideri,
trovò l'ultima dimora presso
l'ingresso al pulpito.
Nel Coro di Nostra Signora,
si trova una serie di
monumenti sepolcrali di
vescovi della diocesi di
Vienna. Di particolare effetto
è la pietra tombale del primo
vescovo che resse
effettivamente la diocesi,
Georg von Slatkonia (t 1522).
Essa rappresenta il vescovo
con tutte le sue insegne e i
suoi stemmi, sorretti da
putti, in una bella cornice
architettonica. Uno dei pochi
monumenti sepolcrali barocchi
è quello del principe
arcivescovo Joseph conte
Tautson (t 1757). La grande
struttura è decorata da un
sarcofago, da un obelisco e da
un medaglione contenente un
ritratto, con due putti
dolenti.
Nel
lato sud della cappella di S.
Caterina è situato il monumento al
primo principe vescovo di
Vienna, Anton Wolfrath,
anteriormente abate del duomo
di Krems e di Wilhering (t
1639). Esso raffigura, in un
medaglione, il ritratto a
mezzo busto del vescovo in una
cornice architettonica.
Campane
del Duomo
Le
campane del duomo di S.
Stefano sono distribuite su
tre torri campanarie: la Torre
Sud, la Torre Nord e la Torre
Pagana nord.
Nella
Torre Nord si trova il
campanone, la seconda campana
più
grande dell'Europa
occidentale, chiamata per i
suoi rintocchi profondi la
"Pummerin". Essa ha
preso il posto dell'antica
"Pummerin", del peso
di 22.500 kg, fusa nel 1711
con il bronzo dei cannoni
turchi, e andata distrutta nel
grande incendio del 1945. La
nuova campana, realizzata
nella fonderia di campane di
Sankt Florian nell'Austria
superiore, pesa 21.383 kg, ha
un diametro di 23 cm ed
un'altezza di 294 cm, corona
compresa. Nel punto di
maggiore spessore raggiunge i
23 cm. È decorata con sei
teste di turco nei bracci
della corona e con tre rilievi
che rappresentano la
Madonna, una
scena
dell'assedio
turco del 1683 e l'incendio
del Duomo del 1945.
L'iscrizione latina del
rilievo dei turchi, tradotta,
dice: "Fui fusa con il
bottino dei Turchi, quando la
città dissanguata esultò dopo
la valorosa vittoria sulla
potenza nemica. 1711 ".
La
seconda iscrizione, relativa
all'incendio del Duomo,
contiene le seguenti parole:
"Mi spaccai nelle fiamme
dell'incendio. Precipitai
dalla torre devastata, mentre
la città gemeva per la guerra e
l'angoscia". L'iscrizione
commemorativa recita:
"Ripristinata sotto il
cardinale Theodor Innitzer,
con l'impegno di Heinrich
CleiBner, dal maestro Karl
Ceisz; consacrato alla Regina
dell'Austria, affinché per
sua intercessione regni la
pace nella libertà. 1951
" Al di sopra di tale
iscrizione si trova lo stemma
della Repubblica austriaca; al
di sotto di essa, una
combinazione di vari stemmi.
Il campanone venne fuso il 5
novembre 1951, fu consacrato
solennemente il 26 aprile 1952
dal cardinale Innitzer e
infine issato sulla Torre Nord
nell'ottobre del 1957. I suoi
rintocchi risuonano almeno
dieci volte l'anno, nelle
seguenti occasioni: la notte
di Capodanno, la notte di
Pasqua, la domenica di Pasqua,
la domenica dì Pentecoste, il
giorno del Corpus Domini, il
giorno dell'Assunzione, per
Tutti i Santi, la notte di
Natale, a S. Stefano, per il
Te Deum di fine anno e in occasione
della morte
dell'arcivescovo.
 Le
campane a festa di S. Stefano
(11
campane)
si trovano nella Torre Sud.
Vennero fuse tutte nel 1960 ad
opera della ditta Pfunder di
Vienna, furono consacrate il 2
ottobre e risonarono per la
prima volta il 1 novembre 1960
in occasione del
pontificale. Le
campane a festa di S. Stefano
(11
campane)
si trovano nella Torre Sud.
Vennero fuse tutte nel 1960 ad
opera della ditta Pfunder di
Vienna, furono consacrate il 2
ottobre e risonarono per la
prima volta il 1 novembre 1960
in occasione del
pontificale.
La
campana di S. Stefano,
soprannominata la
"Halbpummehn", ha un peso di 5.700 kg e viene suonata solo per
celebrazioni particolarmente
solenni. Le altre dieci
campane danno voce allo
scampanio domenicale e
festivo.
Poiché la Torre Pagana nord fu risparmiata
dall'incendio, sono pervenute
fino a noi le campane
originali. La campana più
grande dal peso di 1.670 kg è
chiamata "Feuerin"
(da Feuer, fuoco). Essa venne
fusa nel 1859 e fu suonata in
occasione di un incendio.
Attualmente viene utilizzata
in particolari occasioni ai
Vespri.
La
quarta campana per dimensioni,
soprannominata la
"Kantnerin" (da
Kantor, cantore), chiamava un
tempo i cantori in chiesa e,
durante la settimana, sonava per
la benedizione. Pesa
1.306
kg e la sua fusione risale al
1772.
Nello
stesso anno venne fusa anche
la "Fehringerin",
dal peso di 643 kg, suonata
per la messa solenne
domenicale.
Un
tempo, per comunicare alle
birrerie vicine al Duomo che
era giunta l'ora di chiusura,
risonava la "Bicrin
gerin" (da Bier, birra),
anch'essa fusa nel 1772.
Kantnerin,
Fehringerin e Bieringerin
costituiscono lo scampanio
al Vespri della
domenica e degli
altri giorni festivi.
Ancora
nella Torre Pagana si trovano
la vecchia "Armen-Seelenn-Glocke"
("campana delle Anime del
Purgatorio"), risalente
al 1772, e la cosiddetta
"Churpótsch", dello stesso
anno.
Il nome di quest'ultima si
deve probabilmente a una
donazione del clero
della curia in
onore della immagine
miracolosa di Maria Pòcs.
Nella parte superiore della
Torre Sud si trovano inoltre
le due campane che segnano le
ore, la "Primglocke"
(campana che segna i quarti) e
la "Schlag-glocke"
(da schlagen, battere, sonare.
Segna le ore), entrambe del
XIV
secolo
Sacrestie
La
"sacrestia
superiore", in origine
pendant alla Sala Capitolare,
che era
un
ambiente con volta a crociera
e con chiavi di volta
ornamentali a sud dell'altare
maggiore, fu ampliata nel sec.
XVII e ristrutturata nel 1718.
A questo periodo risalgono
anche gli arredi. Gli
affreschi, opera di Martino
Altomonte, rappresentano scene
della vita di S. Stefano.
Degno di nota è
anche un lavabo barocco in
marmo che contiene nell'alzata
un rilievo con il Battesimo di
Gesù.
La
"sacrestia
inferiore", situata nel
lato sud della navata, fu
costruita al posto di una
sacrestia gotica. La prima
stanza è
arricchita di preziosi stucchi
di Giovanni Antonio Tencala;
iI dipinto sul soffitto, opera
di Martino Altomonte, ha come
soggetto il "Sacrificio
di Elia" ed è
incorniciato da ritratti a
mezzo busto di diversi
profeti,
eseguiti
in
stucco.
Entrando
nella sala, a sinistra, si
trova un grande crocifisso
gotico di legno (1420 circa)
che in origine forse si
trovava nell'arco di trionfo
della Cattedrale. Le due
statue alle estremità
della parete del crocifisso
(originariamente destinate
alla cappella della Santa
Croce) rappresentano Maria e
Giovanni e sono firmate
dall'artista, Franz Xaver
Messerschmidt (1768). Nella
parete di fronte si trova una
rappresentazione plastica di
Mosé con le Tavole della
Legge.
La
seconda stanza, la sacrestia
del vescovo e dei canonici,
possiede anch'essa preziosi
stucchi e affreschi di Martino
Altomonte. L'elaborazione
figurativa è centrata da un punto di vista iconografico sul
Nuovo Testamento. L'affresco
sul soffitto (1730 circa)
mostra la consegna delle
chiavi a Pietro. I piccoli
medaglioni sul soffitto
mostrano i quattro Evangelisti
e l'Annunciazione. Sulla porta
d'ingresso si trova ancora la
rappresentazione plastica
della "Ecclesia".
Degni di menzione sono anche
l'originale mobilia intarsiata
della sacrestia
e
due
lavabi il cui disegno risale
probabilmente a Georg Raphael
Donner. I rilievi furono
eseguiti da Georg Hillebrand.
Tesoro
di Santo Stefano
Poiché la sacrestia inferiore di S. Stefano fu
risparmiata dalla distruzione
durante l'incendio, ci sono
stati conservati una serie di
preziosi paramenti e oggetti
liturgici tuttora in uso
secondo una tradizione non
scritta. Di particolare
rilievo sono i piccoli e i
grandi paramenti di Breuner. I
piccoli furono modificati nel
1647 utilizzando una stoffa più
antica (1500 circa); i grandi,
tra i più importanti del
primo Barocco, sono
perfettamente conservati. Nel
Tesoro si trovano anche
scarpe, calze e guanti
pontificali, oggi non più in
uso, e i manipoli. I grandi
paramenti di Breuner sono in
raso di seta con ricami in oro
e vengono indossati ogni anno
il 26 dicembre.
Altri
paramenti, quelli
dell'imperatrice Eleonora
(1697), sono arricchiti da una
magnifica decorazione floreale
variopinta e da figure
ricamate; essi vengono
utilizzati per la messa
solenne della festa dell'8
dicembre.
In
occasione della sua visita
all'imperatore Giuseppe II,
Papa Pio VI donò al Duomo numerose pianete, tra cui quella bianca
(1740) ogni anno viene
indossata dall'arcivescovo la
domenica
di
Pasqua. Degna di
nota è anche
la Pianeta
di
Maria (1780 circa) con
una ricca decorazione floreale
e ricami figurativi.
Tra
le numerose opere d'arte,
alcune delle quali concesse in
prestito al palazzo
arcivescovile e al Museo
Diocesano e del Duomo, è
da ricordare soprattutto il
ritratto di Rodolfo IV il
Fondatore. È considerato il
più antico ritratto
conservato del duca e
rappresenta Rodolfo in un
inconsueto proflilo di tre
quarti con una corona che non
gli appartiene.
È ancora da
menzionare l'originario tabernacolo
dell'altare
maggiore (1640 circa),
un'opera del primo Barocco
realizzata a Palermo, e una
preziosa croce gotica (sec.
XIV),
usata
nel Duomo durante
le celebrazioni liturgiche
della Settimana Santa.
Nel Museo di Storia della Città, a Karlsplalz, si trovano
accanto alle
statue originale
della Torre Sud, alle vetrate
ducali e ai disegni (la più
grande collezione del mondo di
progetti di epoca gotica),
anche resti dell'altare del
Cristo Morto.

31
Maggio 2015
Pag.
2 
 Pag.
4
Pag.
4
|