|
Età
repubblicana
La Repubblica
romana (Res publica
Romana) fu il sistema di governo della
città di Roma nel
periodo compreso tra il 509
a.C. e
il 27
a.C.,
quando l'Urbe fu governata da
un'oligarchia repubblicana. Essa nacque a seguito di contrasti interni che portarono alla fine della
supremazia della componente etrusca sulla città e
al parallelo decadere delle istituzioni
monarchiche. La sua fine viene invece convenzionalmente fatta coincidere, circa mezzo
millennio dopo, con la fine di
un lungo periodo di guerre
civili che segnò de
facto (benché
formalmente non avvenne in
forma istituzionale) la fine
della forma di governo
repubblicana, a favore di
quella del Principato.
Quella
della Repubblica rappresentò
una fase lunga, complessa e
decisiva della storia
romana:
costituì un periodo di enormi
trasformazioni per Roma, che
da piccola città
stato quale
era alla fine del VI
secolo a.C. divenne,
alla vigilia della fondazione
dell'Impero,
la capitale di
un vasto e complesso Stato,
formato da una miriade di
popoli e civiltà differenti,
avviato a segnare in modo
decisivo la storia dell'Occidente e
del Mediterraneo.
In
questo periodo si inquadrano
la maggior
parte delle grandi conquiste
romane nel Mediterraneo e
in Europa,
soprattutto tra il III e
il II
secolo a.C.;
il I
secolo a.C. fu
invece, come detto, devastato
dai conflitti intestini dovuti
ai mutamenti sociali, ma fu
anche il secolo di maggiore
fioritura letteraria e
culturale, frutto
dell'incontro con la cultura ellenistica e
riferimento
"classico" per i
secoli successivi.
Riguardo
la forma di governo, lo
storici greco Polibio affermerà
che quello della repubblica
romana è il migliore esempio
di Costituzione
mista,
poiché rappresenta la
perfetta unione tra la monarchia,
incarnata dai Consoli,
l'oligarchia,
incarnata
dal Senato,
e la democrazia,
incarnata dalle Assemblee
romane,
i famosi comizi.
 Civiltà
romana repubblicana - Nella
società repubblicana i più
alti comandi, come quello
dell'esercito e il potere
giudiziario,
che in età
regia erano
prerogativa del re,
in epoca repubblicana, tranne
che in poche occasioni, furono
assegnati a due consoli,
mentre per quanto riguarda
l'ambito religioso,
prerogative regie furono
attribuite al pontifex
maximus.
Con la progressiva crescita di
complessità dello Stato
romano si rese necessaria
l'istituzione di altre cariche
(edili, censori, questori,
tribuni
della plebe)
che andarono a costituire le magistrature. Civiltà
romana repubblicana - Nella
società repubblicana i più
alti comandi, come quello
dell'esercito e il potere
giudiziario,
che in età
regia erano
prerogativa del re,
in epoca repubblicana, tranne
che in poche occasioni, furono
assegnati a due consoli,
mentre per quanto riguarda
l'ambito religioso,
prerogative regie furono
attribuite al pontifex
maximus.
Con la progressiva crescita di
complessità dello Stato
romano si rese necessaria
l'istituzione di altre cariche
(edili, censori, questori,
tribuni
della plebe)
che andarono a costituire le magistrature.
Per
ognuna di queste cariche
venivano osservati tre
principi: l'annualità,
ovvero l'osservanza di un
mandato di un anno (faceva
eccezione la carica di
censore, che poteva durare
fino a 18 mesi), la collegialità,
ovvero l'assegnazione dello
stesso incarico ad almeno due
uomini alla volta, ognuno dei
quali esercitava un potere di
mutuo veto sulle
azioni dell'altro, e la gratuità.
Il
secondo pilastro della
repubblica romana erano le assemblee
popolari,
che avevano diverse funzioni,
tra cui quella di eleggere i
magistrati e di votare le
leggi. La loro composizione
sociale differiva da assemblea
ad assemblea; tra queste
l'organo più importante erano
comunque i comizi
centuriati,
in cui il peso nelle votazioni
era proporzionale al censo,
secondo un meccanismo (quello
della divisione delle fasce
censitarie in centurie)
che rendeva preponderante il
peso delle famiglie patrizie.
Il
terzo fondamento politico
della repubblica era il Senato,
già presente nell'età della
monarchia. Costituito da 300
membri, capi delle famiglie
patrizie (Patres) ed ex
consoli (Consulares),
aveva la funzione di fornire
pareri e indicazioni ai
magistrati, indicazioni che
poi divennero de facto vincolanti.
Approvava inoltre le decisioni
prese dalle assemblee
popolari.
Nascita
e consolidamento (509-343 a.C)
Si
racconta che mentre Tarquinio
il Superbo stava
assediando la città
dei Rutuli di Ardea, il figlio Sesto
Tarquinio abusò
della nobile ed
onestissima Lucrezia (moglie di Lucio
Tarquinio Collatino),
che per la vergogna si suicidò. Il
marito Lucio
Tarquinio Collatino,
il padre Spurio
Lucrezio Tricipitino e
l'amico Lucio
Giunio Bruto (anch'egli
imparentato con i Tarquini),
convinsero i Romani a
ribellarsi e a rovesciare la
monarchia nel 509
a.C.,
abbandonando il re e
chiudendogli in faccia le
porte della città. La
famiglia di Lucrezia guidò,
quindi, la rivolta che
costrinse alla fuga i Tarquini,
che dovettero così
abbandonare Roma per
rifugiarsi in Etruria.
Lucio Tarquinio Collatino,
marito di Lucrezia, e Lucio
Giunio Bruto vinsero le
elezioni come primi due Consoli,
supremi magistrati della neo
Repubblica romana.
Leggenda
- La
leggenda narra che il sovrano
esule si rivolse prima agli
Etruschi di Veio e Tarquinia,
poi a quelli di Chiusi,
governati dal lucumone Porsenna,
in entrambi i casi per
chiedere un sostegno militare
esterno e poter così
rientrare a Roma. Entrambe le
sue richieste furono accolte,
ed in entrambi i casi il
conflitto che ne risultò,
alla fine, si risolse a favore
di Roma, sostenuta da aiuti
soprannaturali, come la voce
che proclamò la vittoria dei
Romani guidati da Lucio Giunio
Bruto e Publio
Valerio Publicola sugli etruschi di Veio e Tarquinia, o da singoli atti di valore dei
Romani, come quelli di Orazio
Coclite, Muzio
Scevola e Clelia,
che convinsero Porsenna a
levare l'assedio da Roma.
Contesto
storico
- Quando
i Romani riuscirono a cacciare
i Tarquini nel 509
a.C.,
furono favoriti dal fatto che
la potenza
etrusca era
ormai in pieno declino
nell'Italia meridionale. Basti
ricordare che pochi anni prima
(nel 524
a.C.),
gli Etruschi erano stati
battuti presso Cuma dalle forze greche poste sotto il comando dello stratega Aristodemo,
segnando la fine del loro
espansionismo e l'inizio del
crollo della signoria etrusca
a sud del Tevere. Ciò
condusse le genti latine a
ribellarsi, come dimostra la
successiva battaglia
di Aricia,
nella quale i Latini, soccorsi
da Aristodemo, ottennero una
decisiva vittoria per la loro
indipendenza, sconfiggendo le
forze etrusche poste sotto il
comando del figlio
di Porsenna,
Arunte. Roma approfittò della
nuova situazione venutasi a
creare.
Il
significato storico che sta
sotto l'elaborazione
leggendaria della fondazione
della repubblica riguarda due
aspetti fondamentali per la
storia militare e sociale
romana: l'emancipazione
politica
dagli Etruschi e,
soprattutto, l'esito del
contrasto tra l'istituzione
monarchica ed il ceto dei Patrizi;
questi ultimi, preoccupati
dalle iniziative politiche
popolari sostenute dai re
etruschi (come
la riforma
centuriata e
l'imposizione fiscale
"progressiva"), che
sembravano condurre ad un
sempre crescente peso della plebe,
si assicurarono con la
cacciata di Tarquinio il
Superbo il controllo politico
e sociale attraverso un
istituto oligarchico.
 Vi
è da aggiungere che vi fu
un'altra componente che favorì
la cacciata da Roma degli
Etruschi: l'alleanza con i Sabini.
Questi ultimi, scendendo dai
monti verso il Latium
vetus,
andarono ad insidiare il
fianco etrusco. Questa
collaborazione latino-sabina
è confermata - secondo il De
Francisci -
non solo in base a quanto
riferito da Livio (secondo il Vi
è da aggiungere che vi fu
un'altra componente che favorì
la cacciata da Roma degli
Etruschi: l'alleanza con i Sabini.
Questi ultimi, scendendo dai
monti verso il Latium
vetus,
andarono ad insidiare il
fianco etrusco. Questa
collaborazione latino-sabina
è confermata - secondo il De
Francisci -
non solo in base a quanto
riferito da Livio (secondo il
quale Attius
Clausus con
la gens
Claudia ed
i suoi clientes vennero
ammessi nel territorio romano)
ma anche dal fatto che Appio
Erdonio (di
chiara origine sabina) si
impadronì del Campidoglio (nel 460
a.C.).
In aggiunta a ciò, va tenuto
presente che molte delle
cariche più elevate di questi
anni vennero occupate
da gentes ssabine
come i Valerii,
i Claudii,
i Postumii e
gli Lucretii.
Il
periodo immediatamente
successivo alla cacciata dei
Tarquini fu segnato da una
crisi militare ed economica
per l'Urbe: l'espansione
territoriale guidata dai re fu
seguita da una controffensiva
dei popoli circostanti (Equi e Volsci),
che ridimensionarono i confini
di Roma, mentre
l'emarginazione dei ceti
plebei artigiani e mercantili,
che sotto la monarchia avevano
guidato la crescita economica
della città, portarono ad una
recessione economico-agricola
dominata dai grandi
proprietari terrieri.
I
primi Consoli assunsero il
ruolo del re con l'eccezione
dell'alto sacerdozio
nell'adorazione di Iuppiter
Optimus Maximus nel grande tempio sul colle Capitolino.
Per quel compito i Romani
elessero un Rex
sacrorum o
"Re delle cose
sacre". Fino alla fine
della Repubblica, l'accusa di
volersi dichiarare re, rimase
una delle più gravi accuse a
cui poteva incorrere un
personaggio potente (ancora
nel 44
a.C. gli
assassini di Giulio
Cesare sostennero
di aver agito per prevenire la
restaurazione di una monarchia
esplicita).
I
primi anni della Repubblica
(509-496 a.C)
- I
primi anni della Repubblica
furono caratterizzati dalla
necessità di stabilizzare il
nuovo ordine, difendendolo sia
da nemici interni (coloro che
venivano accusati di voler
restaurare il regime
monarchico), sia dai nemici
esterni, che, contando sulla
debolezza del nuovo regime,
provarono a recuperare la
propria indipendenza dallo
Stato romano. Nel 507
a.C. il Tempio
di Giove Ottimo Massimo,
per secoli simbolo della
potenza romana, fu dedicato al
dio da uno dei primi consoli
repubblicani, Marco
Orazio Pulvillo, quasi ad avocare al nuovo stato un tempio voluto e realizzato dagli ultimi
tre re di Roma.
In
qualche modo, la difesa del
nuovo ordine della Repubblica,
da quello appena rovesciato
della monarchia, fu un
movimento storico che a Roma
assunse caratteri di psicosi
collettiva, considerando che
lo stesso Publio
Valerio (il
futuro Publicola ovvero
amico del popolo), dovette
difendersi dall'accusa di
voler farsi re, costretto poi
ad abbattere la dimora che
stava costruendo in cima
al Velia e
promulgando una legge che
permetteva a tutti i cittadini
romani di uccidere chiunque
avesse tentato di farsi re.
Il
corpo sociale era in fermento:
all'ordine più
tradizionalista, come quello
legato alle famiglie
patrizie,
si contrapponeva il popolo
romano (la plebe),
in un movimento dialettico che
sfociò anche nella violenza e
che sarebbe emerso più
chiaramente nel decennio
successivo, con la prima
secessione della plebe del 494 a.C. È
di questo periodo
l'introduzione
nell'ordinamento romano
della provocatio
ad populum, che garantiva ad ogni cittadino che fosse stato condannato da un
magistrato alla pena capitale,
di appellarsi al popolo per
trasformare la pena
inflittagli, e la nomina di
due questori da parte del
popolo.
Dal
punto di vista militare, dopo
essersi garantita
l'indipendenza dal potente
vicino etrusco, Roma si trovò
a dover ristabilire la propria
autorità lungo i confini
settentrionali con i Sabini,
che sempre più spesso
compivano scorrerie in
territorio romano (nel 505
a.C. sull'Aniene e 504
a.C. nei
pressi di Fidene),
e verso i meridionali, dove la
colonia di Pometia fu
duramente punita per essere
passata dalla parte degli Aurunci.
Che
i Romani si sentissero
accerchiati, lo si desume dai trionfi che
furono accordati per vittorie
forse anche di modeste
dimensioni, ma ancor più
dall'istituzione della figura
del dittatore,
carica che per la prima volta
fu attribuita nel 501
a.C. a Tito
Larcio,
in previsione di una futura
guerra contro una lega di città
latine. È in queste
condizioni che si sviluppò
quella che potremmo definire
una prima forma di
"politica estera"
dello stato romano: il divide
et impera,
teso a dividere gli avversari,
grazie ad azioni diplomatiche,
per poi arrivare allo scontro
campale con un nemico
indebolito nella propria
consistenza numerica.

Roma
e i Latini (496-494 a.C )
-
Roma
era rimasta esclusa dalla lega
delle città
latine limitrofe,
forse anche in virtù
dell'influenza della
componente etrusca della città:
la ricerca di nuove terre
coltivabili e di vie di
comunicazione contrappose
presto l'Urbe agli altri
centri latini.
Un
nuovo equilibrio fu stabilito
con il Foedus
Cassianum (la
data è incerta, ma non
successiva al 493
a.C.),
un trattato di pace stipulato
tra Romani e Latini, che
rimase in vigore fino al 338
a.C.,
conseguenza dello scontro tra
le due parti, conclusosi con
la Battaglia
del lago Regillo,
di fatto l'ultimo tentativo di Tarquinio
il Superbo (e
quindi della componente
etrusca che a lui faceva
riferimento) di rientrare
nell'Urbe. Sebbene i Romani
prevalsero sul campo, con il
trattato Roma riconosceva alle
città latine la loro
autonomia ma si riservava il
Supremo Comando in caso di
guerra. L'alleanza aveva,
perciò, uno scopo prettamente
difensivo, in vista delle
incombenti minacce degli Equi,
dei Volsci e
degli Aurunci.
Vicende
politiche interne (494-487 a.C )
- Intanto
la città era teatro di
violenti conflitti tra patrizi
e plebei, conflitti che
trovavano origine nella
richiesta dei secondi di
essere rappresentati nelle
istituzioni della città
(istituzioni che, dopo la
caduta della monarchia, erano
appannaggio esclusivo dei
patrizi) e di non essere
ridotti in schiavitù, in
applicazione del Nexum,
perché debitori a seguito di
eventi bellici. In quel
frangente l'Urbe riuscì a
resistere alle forze esterne
solo ritrovando l'accordo tra
i due ordini (il dittatore Manio
Valerio Massimo promise le riforme a guerra conclusa) i quali, compatti, con rapide ed
efficaci azioni militari
riuscirono nel 494
a.C. a
respingere gli attacchi dei Sabini, Equi e Volsci.
A
guerra conclusa, poiché i
patrizi non volevano concedere
ai plebei quanto promesso,
soprattutto a causa della
forte opposizione a questa
riforma dell'ala più
oltranzista dei patrizi
guidata da Gneo
Marcio,
conosciuto come Coriolano,
questi per la prima volta
nella storia romana adottarono
come forma di lotta politica
la secessio
plebis,
ovverosia abbandonarono la
città, ritirandosi sul monte
Sacro appena fuori le mura
cittadine, rifiutandosi di
rispondere alla chiamata alle
armi dei Consoli.
La
prima secessione dei plebei si
concluse quando questi videro
accolte alcune delle loro
richieste, tra le quali la più
importante era senza dubbio
quella dell'istituzione nel 494
a.C. della
figura del tribuno
della plebe;
peraltro il ricomporsi della
frattura tra i due ordini non
comportò il ristabilirsi
della concordia interna.

Primi
scontri con Equi, Volsci ed
Ernici (493-480 a.C )
- Le
vicende di Coriolano, esiliato
da Roma a seguito delle accuse
mossegli dai tribuni,
condottiero dei Volsci contro
la sua città natale fin sotto
le mura cittadine, ritiratosi
solo grazie all'intervento
delle donne romane (488
a.C.),
sia che siano state reali, o
il frutto di una successiva
rielaborazione storica,
riportano di quale intensità
fossero le tensioni sociali
interne alla città, che si
aggiungevano a quelle esterne
connesse alla dura guerra
contro i Volsci, che
caratterizzò quel periodo.
Nel
periodo successivo, dal 487
a.C. al 480
a.C.,
Roma tornò ad essere
impegnata in una serie di
scontri con le popolazioni
vicine di Volsci, Ernici, Equi,
oltre agli Etruschi della
città di Veio, quasi tutti
dall'esito favorevole, anche
se nel 484
a.C. i
Romani subirono una pesante
sconfitta in battaglia da
parte dei Volsci davanti alle
porte di Anzio,
e la vittoria dei romani sui
vejenti
nel 480
a.C. costò
loro pesantissime perdite, tra
le quali quella del console Gneo
Manlio Cincinnato.
Oltre
ai tradizionali motivi di
rivalità, le città limitrofe
trovarono motivazioni per le
loro incursioni nell'evidente
debolezza di Roma,
attraversata in quegli anni da
feroci lotte intestine, legate
alla questione della legge
agraria, voluta dal console Spurio
Cassio Vecellino nel 486 a.C.,
che per questo fu condannato a
morte l'anno successivo per
accuse mossegli dai patrizi.
Nonostante vari episodi di
insubordinazione e renitenza
alla leva, in tutto questo
periodo, patrizi e plebei si
ricompattarono nei momenti di
maggiore pericolo, riuscendo
sempre a far fronte al
pericolo esterno.
A
questo periodo, risalgono la
consacrazione del tempio
dedicato ai Dioscuri (484
a.C.)
e l'episodio della condanna a
morte
della vestale Oppia,
sepolta viva per esser venuta
meno al voto di castità.
Nuovi
conflitti con l'etrusca Veio
-
Tra
il 483 a.C. e il 474 a.C.
Roma dovette combattere
duramente contro la città di
Veio, che dopo aver annientato
l'esercito privato della gens
Fabia nella battaglia
del Cremera del 477 a.C., era
arrivata addirittura a
costruire opere fortificate
sul Gianicolo,
appena fuori dalle mura della
città.
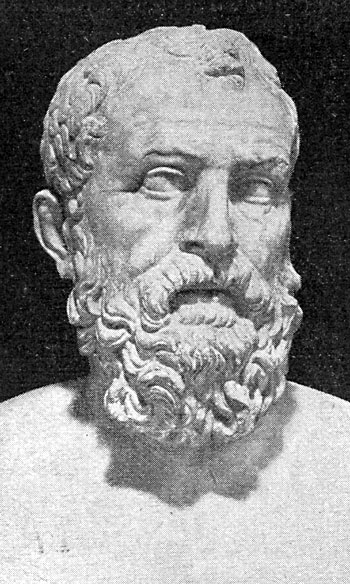 La
probabilità che un conflitto
bellico di tale portata sia
stato affidato ad una sola
gens, metterebbe in serio
dubbio la cronologia
dell'ordinamento censitario
serviano: slitterebbe quindi
di oltre un secolo l'origine
cronologica di un ordinamento
in classi di censo quale
quello di Roma sotto Servio
Tullio. Questa prima fase del
conflitto tra le due città,
si risolse con una tregua
quarantennale concessa dai
romani ai veienti nel 474
a.C. in
cambio di frumento e denaro. La
probabilità che un conflitto
bellico di tale portata sia
stato affidato ad una sola
gens, metterebbe in serio
dubbio la cronologia
dell'ordinamento censitario
serviano: slitterebbe quindi
di oltre un secolo l'origine
cronologica di un ordinamento
in classi di censo quale
quello di Roma sotto Servio
Tullio. Questa prima fase del
conflitto tra le due città,
si risolse con una tregua
quarantennale concessa dai
romani ai veienti nel 474
a.C. in
cambio di frumento e denaro.
Sia
durante lo scontro con gli
Etruschi, che nel periodo
immediatamente successivo, non
mancarono occasioni di scontro
con le popolazioni vicine dei
Volsci, degli Equi e dei
Sabini, che quando non si
risolsero con un nulla di
fatto, furono tutti favorevoli
ai romani, tranne in una
occasione, nel 471
a.C.,
quando i Volsci sconfissero
duramente i romani, anche
grazie alle divisioni
esistenti tra Patrizi e
Plebei.
Divisioni,
le cui motivazioni in parte
erano state ereditate dai
periodi precedenti (come la
legge agraria), ed in parte
erano frutto di nuove
rivendicazioni da parte dei
plebei, come quelle legate
alla Lex
Publilia Voleronis, per la quale i Tribuni dovevano essere eletti nei comizi
tributi,
cui solo i plebei avevano
diritto a partecipare.
Dopo
aver respinto l'offensiva
delle popolazioni vicine, i
Romani si videro ostacolata
l'espansione a nord dalla
ricca e fiorente città
etrusca di Veio,
che le contendeva il dominio
sul Tevere. Iniziata nel 477
a.C. (battaglia
del Cremera), la guerra si conclude nel 396
a.C. con
la distruzione
della città etrusca ad
opera di Furio
Camillo,
dopo un assedio di dieci anni.
A questo punto, l'espansione
romana nel Centro Italia era,
però, ancora ostacolata dalla
migrazione di Celti e Sanniti.
Tra
i bellicosi popoli vicini e le
tensioni interne
-
Il
periodo che corre tra il 470
a.C. e il 451
a.C.,
è caratterizzato dalle
campagne contro le popolazioni
vicine, colpevoli di
sconfinare e razziare i
territori romani o quelli
degli alleati, e le crescenti
tensioni interne, tra Plebe e
Senato, che ruotavano intorno
alla Lex
Terentilia,
con cui i tribuni provarono a
limitare i poteri dei consoli,
e quindi quello dei Patrizi,
ma che non arrivò mai ad
essere votata.
Durante
il ventennio i più strenui
oppositori esterni furono i Volsci e
gli Equi,
più abili come razziatori e
guastatori (almeno così
vengono descritti da Tito
Livio),
che come combattenti, e per
questo regolarmente sconfitti
negli scontri campali dai
romani, anche quando questi si
trovano in inferiorità
numerica. La città di Anzio viene
presa nel 469
a.C.,
e nel 462
a.C. i
Volsci subiscono ingenti
perdite ad opera dei romani.
I Sabini si
limitarono a qualche
scorribanda, mentre gli Ernici sono
riportati tra gli alleati, cui
Roma presta aiuto, quando
questi subiscono le razzie da
parte degli Equi e dei Volsci.
La città di Tusculum si
distingue per essere la più
fedele tra gli alleati dei
romani, intervenendo nella
riconquista del Campidoglio,
occupato da Appio
Erdonio.
Nel 466
a.C. viene
consacrato il tempio di Giove
Fidus sul Quirinale,
voluto da Tarquinio
il Superbo,
mentre il censimento del 465
a.C. conta
104.714 cittadini, esclusi
orfani e vedove, numero che
dovette essere sicuramente
ridimensionato dalla pestilenza che
colpì Roma nel 463
a.C. Il
decimo censimento Ab
Urbe condita del 459
a.C. comunque
conta 117.319 abitanti.
Intanto
in città le tensioni tra
Patrizi e Plebei, impegnati
nella controversia per
l'approvazione della Lex
Terentilia, che tra le altre
cose provoca l'esilio di Cesone
Quinzio,
figlio di Cincinnato,
raggiungono l'apice nel 460
a.C.,
quando i dissidi interni,
rendono possibile che Appio
Erdonio,
e i suoi seguaci, prendano il Campidoglio,
riconquistato a fatica dalle
truppe consolari di Publio
Valerio Publicola,
ucciso nei combattimenti per
riprendere la rocca.
Tra
le due fazioni cresce la
consapevolezza che la
situazione di stallo tra i due
ordini sia pericolosa per la
stabilità di Roma, per cui,
dopo aver inviato una
commissione, formata da Spurio
Postumio Albo, Aulo
Manlio e Sulpicio
Camerino,
ad Atene,
per trascrivere le leggi di Solone,
e quindi poterle studiare e
riformare le istituzioni
romane, dopo molte insistenze
da parte dei tribuni
della plebe,
patrizi e plebei concordarono
per la costituzione del primo decemvirato.
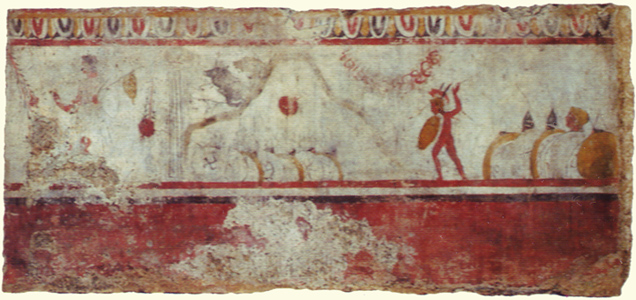 Tra
gli episodi leggendari spicca
la
prima dittatura di Cincinnato
nel 456 a.C.,
che sconfitti gli Equi
nell'ennesima battaglia del monte
Algido,
torna ai campi dopo
appena
16 giorni di dittatura. Tra
gli episodi leggendari spicca
la
prima dittatura di Cincinnato
nel 456 a.C.,
che sconfitti gli Equi
nell'ennesima battaglia del monte
Algido,
torna ai campi dopo
appena
16 giorni di dittatura.
Il
decemvirato, istituito come
comitato di saggi per il
rinnovamento della Repubblica,
compito che portò a termine
con l'emanazione delle Leggi
delle XII tavole, si sviluppò come tentativo di istituire un governo autoritario, che
escludesse i plebei da
qualsiasi magistratura e
decisione nel governo della
città. A questo tentativo i
plebei risposero con la
minaccia della secessione (in
questi eventi si inserisce la
vicenda di Verginia)
e alla fine ottennero il
ripristino di tutte le
magistrature ordinarie, nonché
l'esilio per i decemviri e la
messa in stato di accusa di Appio
Claudio e Spurio
Oppio Cornicino, i più odiati tra i decemviri.
Ristabilite
le prerogative della plebe, e
dei suoi campioni i tribuni
della plebe, la città vive
con relativa tranquillità la
dialettica tra le due classi
sociali, tanto che il breve
tentativo dei tribuni
consolari,
rimasti in carica per soli tre
mesi nel 444
a.C.,
non porta gravi conseguenze
per la stabilità interna
della città.
Nel 443
a.C. viene
istituita la carica del censore,
preposto ai censimenti,
per liberare i consoli di
un'attività che non
riuscivano a portare a
termine, se non
saltuariamente.
Il
periodo tra il 440
a.C. e
il 406
a.C. internamente
fu caratterizzato dalle
tensioni tra plebei e patrizi,
reso dall'alternanza di
consoli e tribuni consolari
alla guida della città (anche
se di fatto furono sempre
eletti patrizi alle supreme
magistrature), ed esternamente
dal rinvigorirsi delle spinte
anti-romane nelle popolazioni
vicine, che furono affrontate
dall'urbe con la nomina di un
dittatore (ben cinque nel
periodo), a significare di
come fossero considerate serie
queste minacce dai romani.
Comunque nel 420
a.C. i
plebei ottennero di poter
accedere alla carica di questore,
anche se si deve aspettare il 409
a.C.,
perché tre plebei fossero
eletti alla carica, fino a
quel momento ad appannaggio
dei patrizi.
A
nord Roma dovette fronteggiare
la pressione di Veio,
sconfitta due volte davanti
alle mura della città alleata
di Fidene,
nel 437
a.C. e nel 426
a.C. (terza
dittatura di Mamerco
Emilio Mamercino), risolvendo la crisi con la distruzione di Fidene e una tregua ventennale
con gli etruschi, mentre a sud
continua a farsi sentire la
pressione dei mai domati Volsci,
capaci di impegnare a fondo i
romani nel 423
a.C.,
malamente condotti dal console Gaio
Sempronio Atratino, che per questo fu condannato a pagare una multa di 15.000 assi.
La
supremazia dei romani sui
Volsci non fu comunque mai in
dubbio, come dimostrano le
vittorie romane ad Anzio nel 408
a.C. e
ad Anxur nel 406
a.C.,
conquistata e saccheggiata dai
romani. In questo stesso anno,
scaduta la tregua, fu
nuovamente dichiarata guerra
(la terza) alla città etrusca
di Veio.
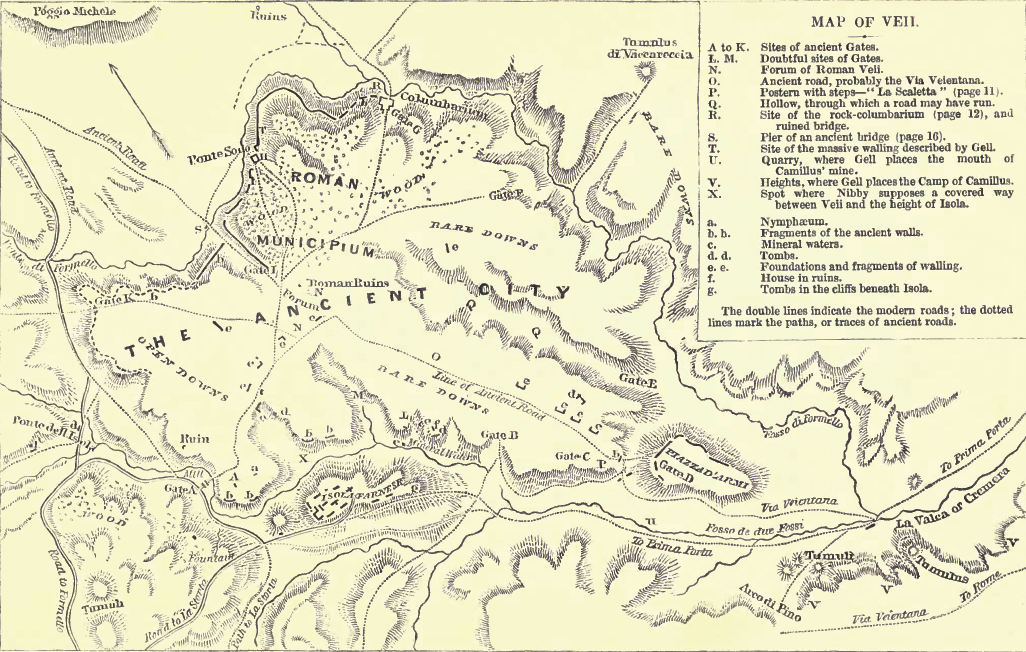
La
conquista di Veio
- Nel 405
a.C.,
iniziò il decennale assedio
di Veio,
dopo che l'anno precedente era
stata dichiarata guerra alla
potente città etrusca. Da
parte loro i Veienti non
riuscirono a trovare alleati
nelle altre città etrusche.
Il
conflitto ebbe una svolta
quando nel 403
a.C. i
romani iniziarono a costruire
fortini per controllare il
territorio veiente, e
terrapieni e macchine
d'assedio (vinea, torri e
testuggini) per stringere
l'assedio alla città. La
messa in opera di queste
opere, comportò la necessità
di mantenere i soldati in
armi, anche durante l'autunno
e l'inverno, quando
tradizionalmente i
cittadini-soldati tornavano in
città per attendere alle
proprie cose, per evitare che
le stesse, lasciate
incustodite, fossero disfatte
o distrutte dai nemici.
Nonostante
la decisa opposizione dei
Tribuni della plebe, si giunse
alla straordinaria decisione
di mantenere l'esercito in
armi ad assediare Veio finché
questa non sarebbe caduta; ai
soldati in armi la città
avrebbe garantito il soldo
grazie ad una nuova
imposizione straordinaria.
Veio
dal canto suo trovò
l'appoggio dei Capenati e
dei Falisci,
nel 402
a.C. e
nel 399
a.C.,
appoggio che inizialmente non
riuscì ad allentare la
pressione dell'assedio romano.
Nel 396
a.C. però
i Capenati e i Falisci
riuscirono a sorprendere i
romani in un'imboscata, dove
insieme a molti soldati, trovò
la morte anche Gneo
Genucio Augurino, uno dei 6 tribuni consolari eletti per quell'anno; come per altre
situazioni di crisi Roma reagì
nominando un dittatore, che
questa volta fu trovato nella
persona di Marco
Furio Camillo.
Furio
Camillo, dopo essersi coperto
le spalle sbaragliando
Capenati e Falisci, intensificò
l'assedio di Veio, iniziando
anche la costruzione di una
galleria sotterranea, che
arrivava fin sotto la
cittadella di Veio. Completata
l'opera, il dittatore attaccò
in forze e in più punti le
mura della città, per
dissimulare la presenza di
soldati nella galleria
sotterranea.
Veio
fu conquistata, con grande
bottino per i romani, che con
questa vittoria posero le basi
della propria supremazia
sull'altra sponda del Tevere,
fino ad allora controllata da
popolazioni etrusche. Ma
proprio la questione della
suddivisione del bottino, così
ingente come mai si era visto
a Roma, da dividere tra
soldati, cittadini, erario e
templi, avrebbe portato
ulteriori divisioni
all'interno della città.
Durante
i 10 anni di assedio, a Roma
non mancarono i consueti
attacchi dei Volsci,
che tentavano di riconquistare Anxur e
degli Equi,
che però furono facilmente
contrastati dalle più
organizzate legioni romane.
L'invasione
celtica
-
La caduta
di Veio aveva
comportato un riequilibrio
degli assetti politici delle
altre capitali
etrusche e
delle loro tradizionali
tensioni interne: l'ostilità
verso Veio era malamente
adombrata dalla neutralità
manifestata dalle altre città
della dodecapoli
etrusca gravitante
intorno al Fanum
Voltumnae:
in almeno un caso, questa
ostilità era apertamente
sfociata nell'aperta alleanza
offerta a Roma da Caere (Cerveteri). Un
altro effetto fu l'accresciuta
consapevolezza delle
potenzialità, anche militari,
della res publica.
Contemporaneamente,
verso la fine del V
secolo a.C.,
numerose popolazioni celtiche
cominciarono a migrare
dall'Europa Settentrionale (a
est del Reno ed
a nord del Danubio)
per insediarsi nei territori
dell'attuale Francia, Spagna e Gran
Bretagna.
Attorno al 400
a.C.,
infatti, alcune di queste
popolazioni raggiunsero
l'Italia Settentrionale. E così
a minare il clima di fiducia e
a mettere in allarme Roma
furono proprio i Celti, della
tribù dei Senoni, i
quali attaccarono la città
etrusca di Clusium, non
molto distante dalla sfera
d'influenza di Roma. Gli
abitanti di Chiusi,
sopraffatti dalla forza dei
nemici, superiori in numero e
per ferocia, chiesero aiuto a
Roma, che rispose all'appello.
Così, quasi senza volerlo, i
Romani si ritrovarono ad
essere il principale obiettivo
di questo popolo calato dal
Nord.
I
Romani li fronteggiarono in
una battaglia
campale presso il fiume Allia variamente
collocata tra il 390 e
il 386
a.C. I
Galli, guidati dal condottiero Brenno,
sconfissero un'armata romana
di circa 15.000 soldati e
incalzarono i fuggitivi fin
dentro la stessa città, che
fu costretta a subire una
parziale occupazione e un umiliante
sacco, prima che gli
occupanti fossero scacciati o,
secondo altre fonti, convinti
ad andarsene dietro pagamento
di un riscatto.

Roma
resiste - L'episodio
del Sacco di Roma ebbe
l'effetto di indebolire Roma e
rivitalizzare la speranza dei
popoli confinanti di riuscire
ad intaccare la potenza
romana.
Nel
decennio successivo
all'invasione dei Senoni Roma
dovette combattere per
ribadire la propria superiorità
sulle popolazioni confinanti,
non solo quelle
tradizionalmente nemiche come
Volsci, Equi ed Etruschi, ma
anche su quelle ritenute
alleate, come
i Tuscolani,
che evitarono la punizione di
Roma solo aprendo
completamente la città alle
truppe condotte da Furio
Camillo e ottenendo il perdono
dal Senato di Roma. Anche i
Prenestini, nel 380
a.C.,
provarono ad uscire
dall'orbita romana, ma furono
duramente sconfitti dai
romani. L'effetto principale
della sconfitta subita dai
Galli fu quello di affidare la
conduzione delle guerre a dei dittatori,
o al tribuno consolare più
esperto, come sempre accadde
quando tra questi era eletto
Furio Camillo.
Le
guerre con le popolazioni
confinanti non impedirono però
che a Roma si sviluppasse una
forte dialettica interna, tra
Plebei e Patrizi; in questo
periodo si ripresentò con
forza la questione dei romani
tratti in schiavitù per
debiti, visto che a soffrirne
maggiormente erano i piccoli
proprietari terrieri plebei
che, a causa delle vicende
belliche, cui pure
partecipavano, finivano in
schiavitù perché non
riuscivano ad onorare i debiti
contratti.
Il
conflitto tra patrizi e plebei
portò ad una situazione di
stallo tra il 375
a.C. e
il 371
a.C.,
quando a Roma non furono
eletti
i tribuni
consolari,
a causa dei veti posti dai tribuni
della plebe Gaio
Licinio Stolone e Lucio
Sestio Laterano, come reazione alle politiche ostruzionistiche dei patrizi, contrari alle
loro proposte di legge, volte
ad equilibrare i rapporti di
forza tra i due ordini.
Il
durissimo conflitto tra plebei
e patrizi, trovò un momento
di sintesi, con la
promulgazione, nel 367
a.C.,
delle Leges
Liciniae Sextiae, che, tra le altre cose, permettevano l'accesso al consolato dei plebei.
Nel
periodo successivo, e fino al 350
a.C.,
Roma condusse con successo una
serie di campagne militari
contro gli Ernici,
contro la città etrusca di Tarquinia,
cui in diverse occasioni si
allearono i Falisci,
e successivamente contro i
Galli, cui si allearono, in
funzione anti-romana, i
tiburtini (mentre Ernici e
Latini si allearono a Roma).
Durante
questo periodo, nonostante la Leges
Liciniae Sextiae, i
patrizi tentarono, con alterne
fortune, di ottenere
l'elezioni di candidati
patrizi per entrambe le
cariche consolari, non
esitando a ricorrere
all'elezione di un dittatore,
unicamente allo scopo di
controllare l'elezione
consolare, e non, come
normalmente accadeva, per far
fronte ad un grave pericolo
militare.
Dopo
gli accordi stipulati con Etruschi e Latini,
Roma poté avviare, nella
seconda metà del IV
secolo a.C.,
un intenso processo di
espansione verso il Meridione
della penisola
italica. Nel 348
a.C. rinnovò
il trattato
con Cartagine, già stipulato al tempo del passaggio dalla monarchia alla repubblica,
attorno al 509
a.C.
DALLE
GUERRE SANNITICHE ALLA
CONQUISTA DELLA MAGNA GRECIA
(343-272 A.C.)

Dal
Latium Vetus alle guerre
sannitiche (343-290 a.C.)
- Le
Guerre sannitiche sono una
serie di 3 conflitti
combattuti nell'arco di 67
anni dalla giovane Repubblica
romana contro la popolazione
italica dei sanniti e numerosi
loro alleati tra il IV ed il
III secolo a.C.. Le guerre,
terminate tutte con la
vittoria dei romani,
scaturirono dalla politica
espansionistica dei due popoli
che a quell'epoca si
equivalevano militarmente e
combattevano per conquistare
l'egemonia nell'Italia
meridionale oltre che per la
conquista del porto
magno-greco di Napoli.
All'epoca
dei fatti i romani dominavano
già su Lazio, Campania
settentrionale, sulla città
etrusca di Veio ed avevano
stretto alleanze con diverse
altre città e popolazioni
minori. I sanniti dal canto
loro erano padroni di quasi
tutto il resto della Campania
e cercavano di espandersi
ulteriormente lungo la costa a
discapito delle colonie della
Magna Grecia e verso la
Lucania nell'entroterra.
Romani
e sanniti quando erano venuti
in contatto per la prima volta
avevano comunque preferito
stipulare un patto di non
belligeranza così da potersi
espandere tranquillamente in
altre direzioni, ma il
confronto era solo rimandato.
La
grande importanza che i romani
e i loro storiografi sempre
diedero a questa lotta per la
supremazia nell'Italia
meridionale è sottolineata
dal gran numero di episodi
leggendari o colorati dalla
storiografia, come La subjugatio
delle Forche Caudine, la Devotio
del Console Decio Mure nella
terza guerra, e forse di suo
padre nella prima, la Legio
Linteata.
Prima
guerra sannitica (343-341
a.C.) -
Il casus belli che fece
scoppiare la prima guerra tra
sanniti e romani fu offerto
dalla città di Capua,
fiorente centro della Magna
Grecia sulla costa campana e,
quindi, nelle mire dei
sanniti. Quando questi la
posero sotto assedio, la città
di Capua mandò un'ambasceria
a Roma chiedendone la
protezione. Il Senato romano
però si tirò indietro a
causa di un trattato di non
belligeranza stipulato in
precedenza proprio con i
sanniti, al che gli
ambasciatori tentarono
l'ultima carta che avevano per
ottenere soccorso:
consegnarono la loro città
nelle mani di Roma. Il Senato
accettò, ovviamente, e mandò
ambasciatori ai sanniti per
informarli della mutata
situazione e per chiedere che
l'assedio fosse levato. I
sanniti, però, non
accettarono il nuovo stato di
cose e così a Roma non restò
che dichiarare loro guerra.
Era il 343 a.C..
Contravvenendo
alle Leggi Licinie Sestie da
poco approvate, a dirigere la
guerra il Senato romano nominò
due consoli patrizi: in
Campania fu inviato Marco
Valerio Corvo, nel Sannio Aulo
Cornelio Cosso.
Non
sono ben note i luoghi ed il
numero delle battaglie
combattute, comunque, per
quanto è dato sapere, le cose
si misero subito bene per
l'esercito di Valerio, che
sconfisse i sanniti abbastanza
facilmente, mentre Cornelio
Cosso, impantanato tra le
strette gole del Sannio e
vittima della guerriglia e
delle imboscate, necessitò di
rinforzi che gli furono
portati dal tribuno militare
plebeo Publio Decio Mure.
La
guerra si concluse nel 341
a.C. con la battaglia di
Suessola, presso Acerra e
Capua, a seguito della quale
fu firmato un nuovo trattato
di pace niente affatto gravoso
per i Sanniti perché il
Senato era molto preoccupato
dalla recrudescenza degli
scontri sociali nella stessa
Roma.

Seconda
guerra sannitica (327-304
a.C.) - Casus
belli della seconda guerra
sannitica furono una serie di
reciproci atti ostili.
Cominciarono i romani fondando
nel 328 una colonia a
Fregellae presso l'odierna
Ceprano, sulla riva orientale
del fiume Liri, cioè in un
territorio che i sanniti
consideravano propria
esclusiva sfera di influenza.
L'anno successivo scoppiò un
conflitto nella città di
Napoli: la parte osca della
città si era infatti alleata
con i Sanniti mentre quella
greca con i Romani. La città
venne assediata dai Sanniti e
i Romani accorsi in aiuto
degli alleati greco-napoletani
sconfissero i Sanniti e
stipularono con la città un foedus
aequuum (trattato di
alleanza paritaria) immettendo
il territorio napoletano nella
loro area di influenza. In
questa occasione i sanniti
ottennero un concreto aiuto da
altri popoli che si sentivano
minacciati dall'espansionismo
romano, soprattutto etruschi,
umbri, sabini e lucani.
La
prima fase della guerra fu
favorevole al fronte sannitico
e si consluse con una sonora
sconfitta del grosso
dell'esercito romano alle
Forche Caudine (dal latino
Furculae Caudinae) nel 321
a.C.: mentre l'esercito romano
si stava spostando da Capua a
Benevento, spie sannite
travestite da pastori li
indirizzarono verso una
stretta gola montuosa dove
furono presi facilmente in
trappola dai nemici capeggiati
da Gaio Ponzio Telesino. Alla
fine i sanniti lasciarono
andare l'esercito romano ma
imposero gravose condizioni di
resa; tra queste la subjugatio,
il passaggio sotto il giogo:
due lance confitte in terra,
una sospesa orizzontalmente a
queste ultime: lo sconfitto,
nudo, doveva passarvi sotto,
inchinandosi, in presenza
dell'esercito nemico.
Lo
storico Tito Livio riferisce
che ritornati a Roma, Tito
Veturio e Spurio Postumio
riferirono in Senato, che
avrebbe deciso di rifiutare le
condizione di resa, destituto
i due consoli e nominato al
loro posto il patrizio Lucio
Papirio Cursore ed il plebeo
Quinto Publilo Filone. Gli
storici moderni sono d'accordo
nel ritenere che il Senato, al
contrario, si attenne ai
termini della resa - fra
l'altro, la consegna delle
colonie di Fregellae e Cales -
fino al 316 a.C..
Alla
ripresa delle ostilità
seguirono anni di dura guerra
con i sanniti che riuscirono
ad espandersi non solo in
Campania ma anche nel Lazio.
Qui infatti potevano contare
sull'alleanza della Lega
Ernica, o almeno sulla parte
di essa che si era ribellata a
Roma. Nel 306 a.C. la lega
capitolò ed Anagni(vera guida
della rivolta) venne
assoggettata; diversa sorte
toccò invece ad Alatri e
veroli, rimaste fedeli a Roma.
L'esercito romano, forte di
queste vittorie, si riebbe e
riuscì ad avere la meglio nel
304 a.C.. con la vittoria a
Boviano che consentì loro di
fondare diverse colonie anche
nel sud della Campania ed
addirittura una a Luceria oggi
Lucera nell'attuale Puglia
quasi a voler accerchiare i
loro indomiti nemici.
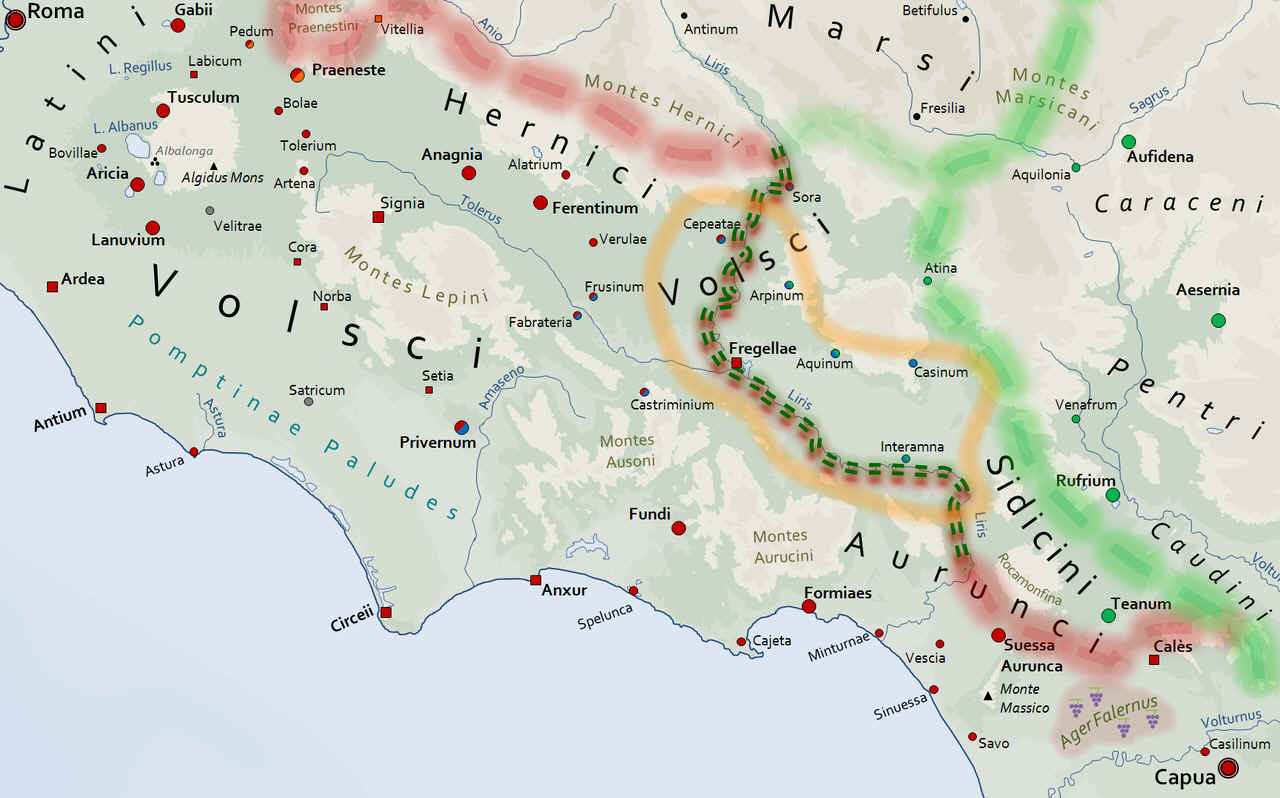
Roma
tra la seconda e la terza
guerra sannitica - Le
guerre sannitiche
determinarono un forte
incremento del fenomeno
dell'inurbazione; i cittadini
romani infatti restarono
mobilitati per lunghi anni,
ritrovando spesso al loro
ritorno i loro campi
impoveriti dal lungo abbandono
o addirittura devastati dalla
guerra. A molti non rimaneva
altra scelta che vendere il
campo, fortemente deprezzato,
a qualche latifondista e
partire per Roma in cerca di
opportunità, o di un Patrono
che accettasse di riceverlo
come Cliens (Cliente).
Cominciò così la formazione
di una massa di cittadini che
non aveva alcun mezzo di
sussistenza ma che poteva
servire per ottenere risultati
politici; inoltre la
popolazione residente aumentò
di molto rendendo necessarie
importanti opere pubbliche la
cui portata esemplifica la
potenza raggiunta dallo stato
romano. Nel 312 a.C. il
censore Appius Claudius Caecus
ordinò la costruzione di:
-
un acquedotto, aqua Appia,
per dissetare la città di
Roma raccogliendo acqua da
molto lontano. Da questo si
deduce che l'aumento della
popolazione cittadina aveva
reso insufficienti le sorgenti
locali. (la successiva
costruzione nel 272 a.C. dell'Anio
Vetus, un ulteriore
acquedotto ordinato dal
censore Manius Curius
Dentatus, conferma la crescita
della popolazione urbana
durante tutto il periodo di
espansionismo romano in
Italia).
-
una lunga strada che da Roma
portava Capua in Campania che
poi sarebbe stata battezzata
via Appia. Il suo scopo
originale era di velocizzare
lo spostamento delle truppe
verso quei turbolenti
territori e lascia intendere
che i romani si attendevano
una lunga guerra per
sottometterli.
Sempre
a partire dal 312, inoltre, i
romani si impegnarono contro
altre città e confederazioni,
il che dimostra la capacità
di mobilitazione raggiunta:
-
nel 311 avanzarono su per la
Valle tiberina contro le città
etrusche di Perusia, Cortona
ed Arretium, tre anni dopo
avrebbero affrontato anche
Volsinii. Questi conflitti si
conclusero con la firma di
armistizi della durata da uno
a cinquanta anni.
-
nel 299 fondarono una colonia
a Narnia, sull'alto corso del
Tevere ad 80 km da Roma.
-
tra il 306 ed il 304 a.C
sconfissero gli Ernici e gli
Equi che abitavano le colline
a sudest di Roma. Si racconta
che queste campagne di
conquista furono molto aspre e
terminarono con la distruzione
di parecchie città collinari
degli Aequi ed il massacro
delle popolazioni.
-
tra il 304 ed il 302 a.C.
altre popolazioni vicine come
i Marsi, i Paeligni, i
Marrucini, i Frentani ed i
Vestini preferirono
sottomettersi a Roma
Oltre
a ciò furono fondate numerose
colonie.

Terza
guerra sannitica (298-290
a.C.)
- Questa
volta sembra che le ostilità
siano cominciate a seguito
delle attività romane in
Lucania che indusse sanniti,
etruschi ed umbri a
coalizzarsi per contrastarla
verso la fine del 297 a.C.. A
loro si unirono anche i galli
Senoni autori del sacco di
Roma nel 390 a.C. e che poi si
erano stanziati nel territorio
poi denominato dai romani ager
Gallicus compreso tra i fiumi
Uso (Rimini) e l’Esino.
La
resa dei conti ci fu con la
Battaglia di Sentino nella
pianura umbra nel 295 a.C.
dove i romani vennero
inizialmente sorpresi dai
Galli che si gettarono nella
mischia con carri trainati da
cavalli carichi di arcieri che
scagliavano frecce. Il
fracasso dei carri spaventò i
cavalli romani, i quali
batterono in ritirata. il
Console plebeo Publio Decio
Mure, figlio del tribuno
militare Decio Mure che aveva
combattuto nella Prima guerra
Sannitica compì il rito della
devotio consacrandosi a
Marte ed agli Dei Inferi,
scagliandosi contro i carri e
perdendo la vita nella
mischia. Il gesto eroico e
ancor più la morte del
console, che indicava
l'accettazione del sacrificio
da parte degli Dei, rianimò
le schiere romane che
riportarono alla fine una
completa vittoria. Il vero
eroe di Sentinum fu però
probabilmente l'altro Console,
Quinto Fabio Massimo Rulliano.
È degno di nota che il gesto
di Decio Mure, per un fenomeno
di duplicazione, venne più
tardi attribuito anche al
padre e al figlio del Console
morto a Sentinum.
Dopo
questa battaglia il sistema di
alleanze tra i sanniti e gli
altri italici andava in
frantumi, costringendo gli
sconfitti alla difensiva; I
sanniti rinforzarono le loro
piazzeforti, rinserrarono i
ranghi, forse crearono una
speciale task force
specializzata in attacchi a
largo raggio, veloce e
micidiale, la legio
linteata che divenne
l'unità d'elite
sannita. I romani si
dedicarono all'annientamento
delle popolazioni minori
cercando, non sempre
riuscendovi, anzi rischiando
talvolta gravi sconfitte, di
evitare che i Sanniti
spezzassero il cerchio delle
guarnigioni romane.
Nel
293 i consoli Papirio Cursore
e Spurio Carvilio Massimo
condussero i loro eserciti, su
rotte parallele, partendo
dalla media valle del Liri
mantenendosi a circa 30 km di
distanza e tenendosi in
contatto tramite messaggeri:
Papirio Cursore dalla Campania
settentrionale puntò su
Aquilonia mentre Spurio
Carvilio Massimo si dirigeva
su Cominium. Il piano
era di attaccare
contemporaneamente e con la
massima durezza; questa doveva
essere una guerra di
sterminio, la "soluzione
finale" del problema dei
Sanniti. I combattimenti
furono durissimi e costarono
oltre 50.000 morti, ma a sera
i comandanti romani entravano
vittoriosi nelle rovine delle
due fortezze; da Aquilonia,
dove aveva combattuto la Legio
Linteata alcuni superstiti si
rifugiarono a Bovianum
da dove riorganizzatisi
condussero una resistenza
disperata che durò fino al
290, con l'ultima, durissima
campagna condotta dai consoli
Manio Curio Dentato e P.
Cornelio Rufino. L'anno
precedente i consoli Fabio
Gurgite e Postumio Megello
avevano conquistato la
roccaforte di Venusia, ora
Venosa, in cui subito fu
dedotta una grande colonia.
 I
patti della Resa non sono
noti: Livi dice solo che
"il trattato fu
rinnovato" ma sicuramente
non possiamo aspettarci che ai
Sanniti fossero lasciate le
favorevoli condizioni
dell'ultimo trattato; essi però,
sia pure ridotti di numero, in
un territorio rimpicciolito e
stretto da ogni parte da
colonie romane, probabilmente
conservavano una certa
indipendenza e la libertà di
erigersi in lega di
Popolazioni. I
patti della Resa non sono
noti: Livi dice solo che
"il trattato fu
rinnovato" ma sicuramente
non possiamo aspettarci che ai
Sanniti fossero lasciate le
favorevoli condizioni
dell'ultimo trattato; essi però,
sia pure ridotti di numero, in
un territorio rimpicciolito e
stretto da ogni parte da
colonie romane, probabilmente
conservavano una certa
indipendenza e la libertà di
erigersi in lega di
Popolazioni.
Con
la vittoria sui sanniti i
Romani conquistarono una
posizione egemonica in tutto
il centro sud, imponevano alle
altre, ancora forti
popolazioni italiche, le loro
decisioni in politica estera,
le riducevano a fornire
contingenti di truppe e a
finanziare campagne militari;
Roma forgiava lo strumento che
avrebbe vibrato contro
Cartagine.
Roma
e la Magna Grecia fino a Pirro
(280-272 a.C.)
- Le Guerre
pirriche furono un
conflitto che vide tra il 280
a.C. ed il 275 a.C.
la Repubblica
romana affrontare l'esercito
del re epirota, Pirro,
a capo di una coalizione
greco-italica. Ebbero luogo
nell'Italia meridionale e
coinvolsero anche le
popolazioni italiche del
posto. Generata dalla reazione
di Taranto, città della Magna
Grecia, all'espansionismo
romano, la guerra coinvolse
presto anche la Sicilia greca
e Cartagine. Dopo alterne
vicende, i Romani riuscirono
alla fine a battere Pirro,
costretto a lasciare
definitivamente l'Italia;
l'esito fu l'egemonia romana
sull'intera Magna Grecia.
Dopo
il superamento del pericolo
costituito dalla presenza
delle popolazioni galliche a
Nord, temporaneamente respinte
grazie alla battaglia
dell'Aniene, le
vittorie su Volsci ed Equi e
gli accordi stipulati con Etruschi e Latini,
Roma poté avviare, nella
seconda metà del IV
secolo a.C., un intenso
processo di espansione verso
il Meridione della penisola
italica.
La
vittoria romana nelle tre guerre
sannitiche (343-341; 326-304; 298-290
a.C.) e nella guerra
latina (340
a.C.-338
a.C.) assicurò dunque
all'Urbe il controllo di buona
parte dell'Italia
centro-meridionale; le
strategie politiche e militari
attuate da Roma - quali la
fondazione di colonie di diritto
latino, la deduzione di
colonie romane e
la costruzione della via
Appia -
testimoniano la potenza di
tale spinta espansionistica
verso Sud. L'interesse
per il dominio territoriale
non era infatti una semplice
prerogativa di alcune famiglie
aristocratiche, tra cui la gens
Claudia, ma investiva
tutta la scena politica
romana, e a esso aderiva
l'intero senato assieme alla plebe. A
sollecitare l'avanzata verso
Sud erano infatti interessi di
tipo economico e culturale; a
frenarla contribuiva invece la
presenza di una civiltà,
quella della Magna
Grecia, ad alto livello
di organizzazione,
militarmente, politicamente e
culturalmente capace di
resistere all'espansione
romana.
La
strategia romana si basava
dunque sulla capacità di
rompere i legami di solidarietà
tra popoli diversi o tra città,
in modo tale da indebolire le
capacità di resistenza dei
nemici: a tale fine puntavano
le deduzioni coloniarie in
terra straniera (Luceria nel
315 o 314; Venusia nel 291
a.C.) e
l'avanzamento verso Sud della
via Appia. A tali
processi, che non erano
direttamente rivolti verso i
centri della Magna Grecia,
aveva contribuito in
particolare l'opera di Appio
Claudio Cieco, che,
caratterizzato da una forte
sensibilità verso la società
greca, fu tra i primi ad
intendere la fusione tra di
essa e il mondo romano come
un'occasione di profondo
arricchimento per l'Urbe. Egli
si era reso, in particolare,
interprete delle esigenze
della plebe urbana,
interessata a intessere
rapporti commerciali con i
mercanti greci e oschi.
Durante
e subito dopo le Guerre
sannitiche, Roma mantenne un
atteggiamento ambiguo nei
confronti dei popoli
italici più
meridionali, i Lucani,
che ora appoggiò ora osteggiò
secondo le convenienze del
momento. Intorno al 303
a.C. siglò un
trattato con i Lucani,
incoraggiandone le aspirazioni
contro Taranto, salvo
accordarsi anche con la stessa
città greca e sostenerne
indirettamente la lotta contro
gli Italici. Il doppio gioco
era motivato dalla volontà di
includere comunque i Lucani
nella propria rete
diplomatica, in quel momento
tutta tesa a piegare i Sanniti,
ma senza che veri interessi
comuni propiziassero legami più
forti. Rispetto
all'ordinamento che Roma stava
dando alla Penisola, l'assetto
dei territori occupati dai
Lucani rimase in uno stato
fluido, basato su semplici
alleanze, fino alle guerre
puniche.
Non
è possibile determinare con
precisione quali fossero i
rapporti commerciali che
univano Roma con i centri
della Magna Grecia, ma risulta
probabile una certa
compartecipazione di interessi
commerciali tra l'Urbe e le
città greche della Campania,
testimoniata dall'emissione, a
partire dal 320
a.C., di monete
romano-campane. Non è
tuttavia chiaro se tali intese
commerciali siano state il
fattore o il prodotto delle
guerre sannitiche e
dell'espansione romana verso
Meridione, e non è dunque
possibile determinare quale
sia stato l'effettivo peso dei negotiatores nella
politica espansionistica,
almeno fino alla seconda metà
del III
secolo a.C. A
determinare la necessità di
un'espansione territoriale
verso Sud erano, però, anche
le esigenze della plebe
rurale, che richiedeva nuove
terre coltivabili che
l'espansione nell'Italia
centrale e settentrionale non
era bastata a procurare.
 Lo
sviluppo economico che
interessò l'Urbe tra IV e III
secolo a.C. portò, comunque,
ad un progressivo
avvicinamento di Roma all'area
magnogreca, ed ebbe, dunque,
anche pesanti ripercussioni
sugli aspetti istituzionali,
culturali e sociali della vita
nell'Urbe. Il contesto
culturale romano fu fortemente
influenzato dalla penetrazione
della filosofia
pitagorica, presto
accettata dalle élite
aristocratiche, e dal contatto
con la storiografia
greca, che modificò
profondamente la produzione
storiografica romana. Lo
sviluppo economico che
interessò l'Urbe tra IV e III
secolo a.C. portò, comunque,
ad un progressivo
avvicinamento di Roma all'area
magnogreca, ed ebbe, dunque,
anche pesanti ripercussioni
sugli aspetti istituzionali,
culturali e sociali della vita
nell'Urbe. Il contesto
culturale romano fu fortemente
influenzato dalla penetrazione
della filosofia
pitagorica, presto
accettata dalle élite
aristocratiche, e dal contatto
con la storiografia
greca, che modificò
profondamente la produzione
storiografica romana.
Contemporaneamente,
lo sviluppo economico favorì
l'elevazione politica e
sociale di una parte della
classe plebea e portò alla
scomparsa o all'attenuazione
delle antiche forme di
subordinazione sociale, come
la schiavitù per debiti, garantendo
dunque una maggiore mobilità
sociale che causò la nascita
del proletariato urbano: essa
comportò a sua volta un forte
aumento della popolazione di
Roma, favorì la costruzione
di nuove strutture nella città
e modificò profondamente gli
equilibri sociali.
Al
periodo tra il IV secolo e il
III secolo a.C. risalgono
infine alcuni mutamenti nelle
istituzioni militari: al
tradizionale schieramento
oplitico-falangitico basato
sulla centuria,
si sostituì l'ordinamento manipolare,
che rendeva più agile e
articolato l'impiego tattico
della legione
romana.
Contemporaneamente,
alla suddivisione delle
milizie secondo la classe di
appartenenza, prevista dall'ordinamento
serviano, si sostituì
quella secondo il criterio
dell'anzianità, e la
base del reclutamento fu
allargata, per la prima volta
tra il 281 e
il 280
a.C., anche ai
proletari.
A
partire dalla seconda metà
del IV
secolo a.C., le città
della Magna
Grecia cominciarono
lentamente a tramontare sotto
i continui attacchi delle popolazioni
sabelliche di Bruzi e Lucani.
Le
città più meridionali, tra
cui Taranto era
la più importante grazie al
commercio con le popolazioni
dell'entroterra e la Grecia
stessa,
furono più volte costrette a
chiedere soccorso a
condottieri provenienti dalla
madrepatria greca, come Archidamo
III di Sparta negli
anni 342-338
a.C. o Alessandro
il Molosso negli
anni 335-330
a.C., per difendersi
dagli attacchi dalle
popolazioni italiche che,
con la nuova federazione dei Lucani,
alla fine del V
secolo a.C. si
erano espanse fino alle coste
del Mar
Ionio. Nel corso
di queste guerre i Tarantini,
nel tentativo di far valere i
propri diritti sull'Apulia,
stipularono un trattato con
Roma, di consueto collocato
nell'anno 303
a.C. ma forse
risalente già al 325
a.C., secondo il
quale alle navi romane non era
concesso di superare ad
Oriente il promontorio
Lacinio (oggi capo
Colonna, presso Crotone).
La successiva alleanza di Roma
con Napoli nel 327
a.C. e la
fondazione della colonia
romana di Luceria nel 314
a.C. preoccuparano
non poco i Tarantini che
temevano di dover rinunciare
alle loro ambizioni di
conquista sui territori
dell'Apulia settentrionale a
causa dell'avanzata romana.
Nuovi
attacchi da parte dei Lucani costrinsero,
ancora una volta, i Tarantini
a chiedere aiuto ai mercenari
della madrepatria: fu
ingaggiato questa volta un
certo Cleonimo di Sparta (303-302
a.C.), che fu, però,
sconfitto dalle popolazioni
italiche, forse sobillate
dagli stessi Romani. Il
successivo intervento di un
altro paladino della grecità, Agatocle
di Siracusa, portò di
nuovo l'ordine nella regione
con la sconfitta dei Bruzi (298-295
a.C.), ma la fiducia
dei Greci delle piccole città
dell'Italia meridionale in
Taranto e Siracusa iniziò a
svanire a vantaggio di Roma,
che nel contempo si era
alleata con i Lucani ed era
risultata vittoriosa a
settentrione su Sanniti,
Etruschi e Celti.
Morto
Agatocle di Siracusa nel 289
a.C., i Lucani, un
tempo alleati di Roma, si
ribellarono insieme ai Bruzi
ed iniziarono ad avanzare nel
territorio di Thurii devastandolo;
gli abitanti della città,
consci della propria debolezza
inviarono due ambasciate a
Roma per chiedere aiuto, la
prima nel 285
a.C. e poi nel 282
a.C..
Solo
in questa seconda circostanza
Roma inviò il console Gaio
Fabricio Luscino il
quale, posta una guarnigione a
Thurii, avanzò contro i
Lucani sconfiggendo il loro
principe Stenio
Stallio, come riportano
i Fasti
triumphales. A seguito
di questo successo, le città
di Reggio, Locri e Crotone chiesero
di essere poste sotto la
protezione di Roma la quale
inviò una guarnigione di
4.000 uomini a presidio di
Reggio: Roma si proiettava,
ormai, verso il Meridione
d'Italia.

CASUS
BELLI - L'aiuto
accordato da Roma a Thurii fu
visto dai Tarantini come un
atto compiuto in violazione
dell'accordo che le due città
avevano firmato diversi anni
prima: sebbene le operazioni
militari romane fossero state
compiute per via di terra,
Thurii gravitava pur sempre
sul golfo di Taranto, a nord
della linea di demarcazione
stabilita presso il capo
Lacinio; Taranto temeva dunque
che il suo ruolo di patronato
nei confronti delle altre città
italiche venisse meno.
Roma,
tuttavia, in aperta violazione
degli accordi, forse per la
forte pressione esercitata dai negotiatores o
forse perché gli accordi
stessi erano ritenuti
decaduti, nell'autunno
del 282
a.C. inviò una
piccola flotta duumvirale composta
da dieci imbarcazioni da
osservazione nel golfo di
Taranto che provocò i
tarantini; le navi,
guidate dall'ammiraglio Lucio
Valerio Flacco o
dall'ex console Publio
Cornelio Dolabella, erano
dirette a Thurii o verso
la stessa Taranto, con
intenzioni amichevoli. I
Tarantini, che stavano
celebrando in un teatro
affacciato sul mare delle
feste in onore del dio Dioniso,
in preda all'ebbrezza, scorte
le navi romane, credettero che
esse stessero avanzando contro
di loro e le attaccarono: ne
affondarono quattro e una fu
catturata, mentre cinque
riuscirono a fuggire; tra
i Romani catturati, alcuni
furono imprigionati, altri
mandati a morte.
Dopo
l'attacco alla flotta romana,
i Tarantini, resisi conto che
la loro reazione alla
provocazione romana avrebbe
potuto condurre alla guerra e
convinti dell'atteggiamento
ostile di Roma, marciarono
contro Thurii, che fu presa e
saccheggiata; la guarnigione
che i Romani avevano posto a
tutela della città ne fu
scacciata assieme agli
esponenti dell'aristocrazia
locale.
Gli avvenimenti subito
successivi all'attacco
tarantino testimoniano la
cautela e l'accortezza del
gruppo dirigente romano, che,
pur senza sottovalutare la
situazione, preferì
tentare un'azione diplomatica
piuttosto che muovere subito
guerra a Taranto: da
Roma, non appena si ebbe
notizia di quanto era
accaduto, si decise
infatti di inviare a Taranto
un'ambasceria guidata da
Postumio, per chiedere la
liberazione di coloro che
erano stati fatti prigionieri,
il rimpatrio dei cittadini
aristocratici espulsi da
Thurii, la restituzione dei
beni a loro depredati e la
consegna di coloro che erano
responsabili dell'attacco alle
navi romane: dal rispetto
di tali condizioni sarebbe
dipeso il futuro svolgimento
delle relazioni tra le due
potenze.
 I
diplomatici romani, giunti a
Taranto, furono ricevuti non
senza riserve nel teatro
da cui i Tarantini avevano
scorto le navi attraversare il
golfo; il discorso di
Postumio, tuttavia, fu
ascoltato con scarso interesse
da parte dell'uditorio, più
attento alla correttezza della lingua
greca parlata
dall'ambasciatore romano che
alla sostanza del messaggio. I
diplomatici romani, giunti a
Taranto, furono ricevuti non
senza riserve nel teatro
da cui i Tarantini avevano
scorto le navi attraversare il
golfo; il discorso di
Postumio, tuttavia, fu
ascoltato con scarso interesse
da parte dell'uditorio, più
attento alla correttezza della lingua
greca parlata
dall'ambasciatore romano che
alla sostanza del messaggio.
Vittime di risate di scherno
da parte dei Tarantini, che si
prendevano gioco dell'eloquio
scorretto e delle loro toghe
dalle fasce purpuree, gli
ambasciatori furono condotti
fuori dal teatro; nel momento
in cui ne stavano uscendo,
tuttavia, un uomo chiamato
Filonide, in preda
all'ubriachezza, si
sollevò la veste e orinò
sulla toga degli ambasciatori
con l'intento di oltraggiarli.
A
tale atto, che ledeva il
diritto all'inviolabilità
degli ambasciatori, Postumio
reagì tentando di suscitare
lo sdegno della folla dei
Tarantini verso il
concittadino; tuttavia,
accortosi che tutti coloro che
erano presenti nel teatro
sembravano aver apprezzato
l'atto di Filonide, li
apostrofò, secondo Appiano
di Alessandria,
promettendo loro che avrebbero
pulito con il sangue la toga
sporcata da Filonide, o
dicendo, secondo la
testimonianza di Dionigi
di Alicarnasso,
"Ridete finché potete,
Tarantini, ridete! In futuro
dovrete a lungo versare
lacrime!". Detto ciò, gli
ambasciatori lasciarono dunque
la città di Taranto per
rientrare in Roma, dove
Postumio mostrò ai
concittadini la toga sporcata
da Filonide.
Gli
ambasciatori giunsero a Roma,
senza portare risposte, nel 281
a.C., nei giorni in cui
i nuovi consoli, Lucio
Emilio Barbula e Quinto Marcio
Filippo, entravano in
carica; Postumio riferì
l'esito della sua ambasceria e
l'offesa che aveva subito: i
consoli, dunque, convocarono
il senato, che si riunì per
più giorni dall'alba fino al
tramonto, per decidere sul da
farsi. Un certo numero di
senatori riteneva poco
prudente intraprendere una
spedizione militare contro
Taranto quando le ribellioni
dei popoli italici non erano
ancora state del tutto sedate,
ma la maggior parte preferì
che la decisione di dichiarare
guerra a Taranto venisse messa
subito ai voti: risultarono
essere in maggioranza coloro
che volevano che Roma si
impegnasse all'istante in
un'azione militare, e la
popolazione ratificò la
decisione senatoria. Lo
storico Marcel
Le Glay pone
l'accento sulle pressioni di
una parte dei politici romani
e delle grandi famiglie, tra
cui la gens Fabia,
per l'espansione territoriale
di Roma verso il sud
Italia.
Lucio
Emilio Barbula fu dunque
costretto a sospendere
temporaneamente la campagna
che aveva intrapreso contro i
Sanniti e fu incaricato dal
popolo di riproporre a
Taranto, per salvare la pace,
le stesse condizioni proposte
da Postumio. I Tarantini,
impauriti dall'arrivo
dell'esercito consolare
romano, si divisero tra
coloro che sarebbero stati
intenzionati ad accettare le
condizioni di pace offerte dai
Romani e coloro che avrebbero
invece voluto dare inizio alle
ostilità.
Barbula
cominciò a devastare le
campagne circostanti la città, tanto
che i Tarantini, consci di non
poter affrontare a lungo l'assedio romano,
cercarono nuovi aiuti questa
volta in Epiro,
richiedendo l'intervento del
re Pirro. Quest'ultimo,
che aveva avuto un'educazione
militare dall'allora sovrano
di Macedonia, Demetrio
I Poliorcete(aveva tra
l'altro combattuto, assai
giovane, nella battaglia
di Ipso), accolta la
richiesta di aiuto dei
Tarantini, desideroso di
ampliare il proprio regno ed
incorporare nella propria
sfera d'influenza la Magna
Grecia, compresa la Sicilia (contesa
dai Cartaginesi e
dalla città greca di Siracusa)
fondando uno stato nell'Italia
meridionale, inviò Cinea per
comunicare la sua decisione,
poco prima che Taranto
capitolasse. Pirro non poteva
respingere la richiesta di
aiuto fatta da Taranto poiché
quest'ultima aveva dato un
contributo importante per la
conquista di Corfù e
per la riconquista della Macedonia,
persa nel 285
a.C.
Scullard
scrive che se Pirro non avesse
aderito alla richiesta dei
Tarantini, il dissidio tra
Taranto e Roma si sarebbe
risolto facilmente e
velocemente. E invece fu
la guerra.
 FORZE
IN CAMPO - Considerando
i rinforzi che Pirro ottenne,
egli si pose a capo di un
esercito di 31500 soldati e 22 elefanti.
3.000 uomini furono lasciati a
presidio di Taranto, quindi le
unità effettive che si
scontrarono coi Romani nella battaglia
di Eraclea, stando a Plutarco,
furono 28.500 uomini e 22
elefanti. FORZE
IN CAMPO - Considerando
i rinforzi che Pirro ottenne,
egli si pose a capo di un
esercito di 31500 soldati e 22 elefanti.
3.000 uomini furono lasciati a
presidio di Taranto, quindi le
unità effettive che si
scontrarono coi Romani nella battaglia
di Eraclea, stando a Plutarco,
furono 28.500 uomini e 22
elefanti.
Il
re epirota sbarcò in Italia nel 280
a.C. con circa 25.500
uomini e 20 elefanti.
Tra
i rinforzi inviati dall'Epiro
al servizio di Pirro, secondo
Plutarco ci furono 3.000
uomini erano giunti al comando
di Cinea in aiuto a Taranto.
In
totale le truppe al seguito di
Pirro, giunte dall'Epiro,
furono 28.500 uomini e 20
elefanti.
Sappiamo
che gli Italioti (ovvero
i Greci della Magna
Grecia, da non confondere con
la Sicilia greca)
conferirono a Pirro il comando
supremo. Tra le promesse che
adularono e convinsero il re
d'Epiro a giungere in soccorso
degli Italioti, fu l'offerta
di porsi generale di 350.000
armati e 20.000 cavalieri.
Il
re d'Egitto, Tolomeo
II, inviò nel maggio del 280
a.C., in Epiro, secondo
Giustino: 5.000 uomini,
400 cavalieri e 50 elefanti.
Alcuni storici vedono la cifra
al ribasso e credono che le
reali proporzioni del
contingente si limitarono a 20
elefanti di sostegno. In
ogni caso Pirro, durante la
sua spedizione, non poté
usufruirne perché questi
rinforzi restarono in Epiro
per tenere sotto controllo la
regione.
Dopo
aver lasciato l'Epiro, Pirro
avanzò richieste di aiuti
militari a vari sovrani ellenistici,
in quanto l'Epiro era un regno
montanaro e da solo non aveva
sufficienti mezzi per condurre
una lunga e dispendiosa
campagna contro Roma. Chiese
aiuti ad Antioco I (re
del regno seleucide) e ad Antigono
II Gonata (figlio di Demetrio
I Poliorcete), nonché al re
di Macedonia, Tolomeo
Cerauno, al quale chiese
sostegno finanziario e
marittimo. Pirro aveva
trascorso alcuni anni ad Alessandria
d'Egitto con il cognato Tolomeo
II, che gli promise aiuti
militari. Analogamente, Pirro
reclutò anche altre forze
mercenarie, tra cui i
cavalieri di Tessaglia e
i frombolieri di Rodi.
In Italia godette del supporto
di Lucani, Messapi, Sanniti, Apuli
e Campani.
Dopo
aver atteso l'arrivo delle
restanti navi, Pirro lasciò a
Taranto un presidio di 3.000
uomini con il suo fidato
ambasciatore
Cinea e
si spostò verso sud,
accampandosi nei pressi di Heraclea con
un esercito forte di circa
25.500 uomini.
I Romani furono
costretti a dividersi su due
fronti, poiché la guerra etrusca a
settentrione non era ancora
stata portata a termine. Nel 280
a.C. l'esercito romano del
fronte meridionale, schierato
contro Pirro, era composto da
circa 20.000 armati ed
affidato al console di
quell'anno Marco Valerio
Levino, così suddivisi:
-
2 legioni di cittadini
romani e 2 Alae di Socii (alleati
italici, che erano posti alle
ali dello schieramento),
composte ciascuna da
4.200/5.000 fanti per un
totale di 16.800 / 20.000
fanti;
-
600 cavalieri legionari e
1.800 alleati, pari a
2.400 complessivi.
A
questo esercito
consolare andrebbe
aggiunto un contingente di
4.000 armati, inviato a Reggio nel 280
a.C., a protezione della città
alleata.
Per
un totale di circa 20.000
uomini, all'incirca pari
all'entità dell'esercito di
Pirro.
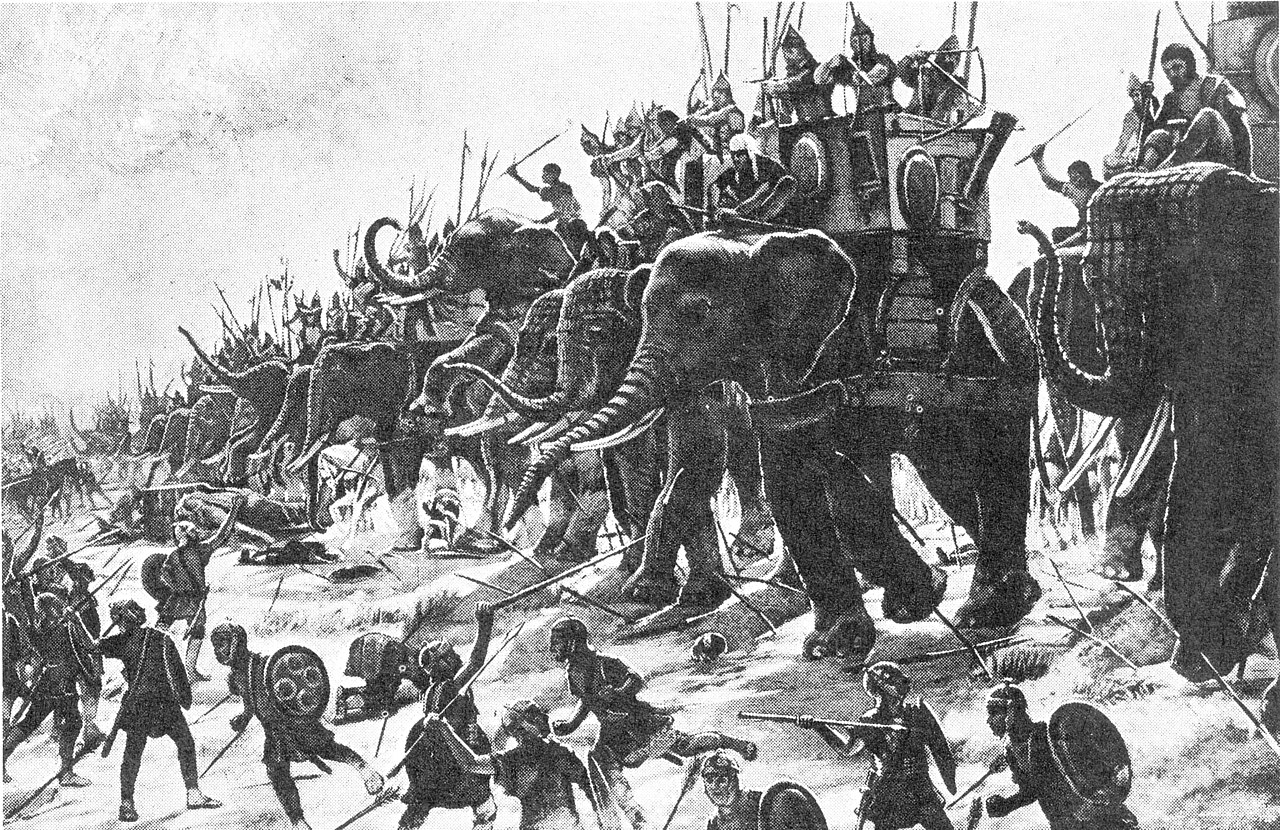
FASI
DEL CONFLITTO - Si
dice che i Tarantini e i loro
alleati si vantassero di poter
disporre di 350.000 uomini e
20.000 cavalieri
reclutati
tra Sanniti, Lucani e Bruzi.
Nel 281 a.C. le
legioni romane, al comando di Lucio
Emilio Barbula, entrarono in
Taranto e la conquistarono,
malgrado i rinforzi dei
Sanniti e dei Messapi.
All'indomani della battaglia i
Greci chiesero una breve
tregua e la possibilità di
intavolare delle trattative
con i Romani.
I
negoziati vennero bruscamente
interrotti con l'arrivo a
Taranto dell'ambasciatore Cinea che
precedeva (o accompagnava)
3.000 soldati, forza
d'avanguardia di Pirro posta
sotto il comando del generale Milone
di Taranto. Il console romano
Barbula, che si era spinto nel Metapontino,
si ritrovò sotto il tiro
delle macchine da guerra delle
navi nemiche che erano
disposte lungo la costa a
presidiare il golfo. Nella
battaglia che ne scaturì,
Barbula riuscì a subire
perdite minori del previsto
poiché aveva astutamente
disposto sul lato destro della
colonna, esposto ai colpi, i
prigionieri di guerra.
Il
piano di Pirro era quello di
aiutare Taranto e respingere i
Romani al di là del meridione
italiano, per poi iniziare ad
espandere la propria influenza
in Sicilia e
quindi attaccare Cartagine,
nemica storica dei greci della
Magna Grecia. Così fece nel 278
a.C. aiutando i Siracusani in
guerra contro Cartagine.
Ma dopo la campagna in
Sicilia, fu costretto ad
abbandonare il suo progetto,
sia per la forte resistenza
dei Cartaginesi a Lilibeo,
sia perché le città greche
sue alleate non riuscivano ad
accordarsi fra di loro e non
mandarono i contingenti
promessi e sia per il
malcontento che scatenò sulla
popolazione del luogo per la
sua avida gestione delle
risorse.
Dopo
aver lasciato l'Epiro, Pirro
avanzò richieste di aiuti
militari a vari sovrani ellenistici,
in quanto l'Epiro era un regno
montanaro e da solo non aveva
sufficienti mezzi per condurre
una lunga e dispendiosa
campagna contro Roma. Chiese
aiuti ad Antioco I (re
del regno seleucide) e ad Antigono
II Gonata (figlio di Demetrio
I Poliorcete), nonché al re
di Macedonia, Tolomeo
Cerauno, al quale chiese
sostegno finanziario e
marittimo. Il re dell'Egitto Tolomeo
II promise l'invio di una
forza di 4.000 soldati, 5.000
cavalieri e 50 elefanti
da guerra destinata a
difendere l'Epiro durante la campagna
d’Italia. Analogamente,
Pirro, reclutò anche altre
forze mercenarie, tra cui i
cavalieri di Tessaglia e
i frombolieri di Rodi.
Nel 280
a.C. Pirro salpò verso
le coste italiche ma, durante
la traversata, fu sorpreso da
una tempesta che arrecò danni
alle navi e lo indusse a
sbarcare le truppe,
probabilmente nei pressi di Brindisi.
Era a capo di 28.500 armati e
20 elefanti. Di lì proseguì
via terra verso Taranto dove
si acquartierò, aiutato dai Messapi.
Dopo
aver atteso l'arrivo delle
restanti navi, Pirro lasciò a
Taranto un presidio di 3.000
uomini con il suo fidato
ambasciatore
Cinea e
si spostò verso sud,
accampandosi nei pressi di Heraclea con
un esercito forte di circa
25.500 uomini.
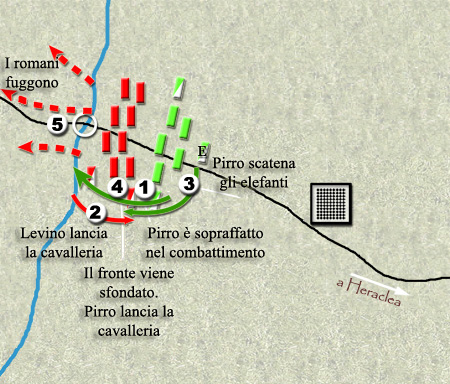 I
Romani avevano previsto
l'imminente arrivo di Pirro e
mobilitarono otto legioni.
Queste comprendevano circa
80.000 soldati divisi in
quattro armate: I
Romani avevano previsto
l'imminente arrivo di Pirro e
mobilitarono otto legioni.
Queste comprendevano circa
80.000 soldati divisi in
quattro armate:
-
la prima armata, comandata da
Barbula, si stanziò a Venosa
per
impedire ai Sanniti e ai
Lucani di congiungersi con le
truppe di Pirro;
-
la seconda armata fu schierata
a protezione di Roma
nell'eventualità che Pirro
tentasse di attaccarla;
-
la terza armata, comandata dal
console Tiberio
Coruncanio, aveva il compito
di attaccare gli Etruschi per
scongiurare che si alleassero
con Pirro;
-
la quarta armata, comandata da Publio
Valerio Levino, avrebbe dovuto
attaccare Taranto ed invadere
la Lucania.
Difatti,
Levino invase la Lucania ed
intercettò Pirro nei pressi
di Heraclea, città
alleata dei Tarantini, con
l'intento di bloccare la sua
avanzata verso sud,
scongiurando in questo modo
una sua alleanza con le
colonie greche di Calabria.
Pirro si dispose alla
battaglia organizzando una
"falange articolata"
con divisioni di fanteria
leggera fra i falangiti, per
renderla più mobile sul
collinoso territorio italiano,
e gli elefanti a sostegno
della fanteria.
Il primo
scontro tra gli Epiroti
ed i Romani avvenne in
Basilicata, nella piana di Eraclea (presso
l'odierna Policoro),
nello stesso 280 a.C. Nonostante
la sorpresa di trovarsi di
fronte gli elefanti,
animali mai visti in
precedenza, i Romani ressero
bene l'urto fino a sera, anche
se la battaglia alla fine si
risolse con una sconfitta in
cui ne morirono 7.000 (circa
un terzo, dei 20.000 iniziali)
e 1.800 furono fatti
prigionieri. Pirro lasciò
invece sul campo 4.000 armati dei
25.000 iniziali: troppe
perdite per il contingente
epirota, che difficilmente
poteva ottenere rinforzi al
contrario di Roma che poteva
reclutare in fretta nuove
truppe; ma, fortunatamente per
Pirro, queste perdite vennero
rimpiazzate dai soldati di
Lucani, Bruzi e Messapi,
assieme ad alcuni rinforzi
mandati dalle città greche
(Crotone, Locri
Epizefiri) che alla notizia
della vittoria decisero di
unirsi a lui.
Dopo
la battaglia, sembrò
finalmente cementarsi
quell'intesa tra Greci ed
Italici in funzione
antiromana, che parte
dell'aristocrazia tarentina si
augurava da tempo. Rinforzi
provenienti dalla Lucania e
dal Sannio si
unirono all'esercito di Pirro.
Anche i Bruzi si
ribellarono. Le città
greche d'Italia si allearono
con Pirro e a Locri fu
cacciata la guarnigione
romana. Una scelta analoga
sembra si verificò nella
stessa Crotone poco
dopo. A Reggio, ultima
posizione della costa ionica
ancora controllata da Roma,
il pretore campano Decio
Vibellio, che comandava la
guarnigione cittadina, massacrò
una parte degli abitanti,
cacciò i restanti e si
proclamò amministratore della
città, ribellandosi
all'autorità di Roma.
Pirro
aveva appreso che il console
Levino sostava a Venosa,
impegnato ad assicurare le
cure ai feriti e a
riorganizzare l'esercito in
attesa di rinforzi,
mentre il console Coruncanio era
impegnato in Etruria.
Pertanto avanzò verso Roma
con l'intento di spingere i
suoi alleati alla ribellione e
di sorreggere gli Etruschi
contro Coruncanio. Durante
l'avanzata deviò su Napoli con
l'intento di prenderla o di
indurla a ribellarsi a Roma.
Il tentativo fallì e comportò
una perdita di tempo che giocò
a vantaggio dei Romani: quando
giunse a Capua la
trovò già presidiata da
Levino. Proseguì allora verso
Roma devastando la zona del Liri e
di Fregellae giungendo
così ad Anagni e
forse anche a Preneste. Qui
ebbe sentore di una manovra a
tenaglia progettata dai
Romani: gli Etruschi avevano
appena concluso la pace,
liberando le forze di
Coruncanio, che ora stavano
muovendo dal nord dell'Etruria
contro di lui.
Consapevole di non disporre di
forze sufficienti per
affrontare le armate di
Coruncanio, di Levino e di
Barbula, decise di ritirarsi.
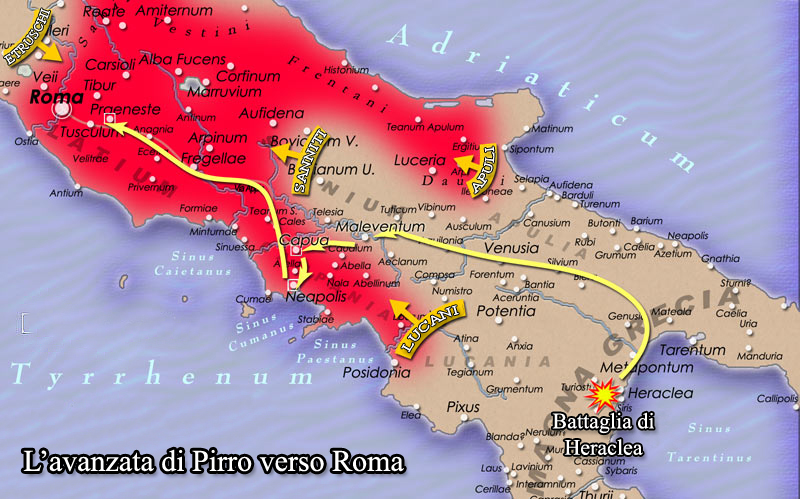
In
seguito, Gaio
Fabricio Luscino venne
inviato come ambasciatore
presso Pirro per trattare lo
scambio dei prigionieri. Pirro
fu favorevolmente attratto
dalle qualità
dell'ambasciatore, il quale
non si piegò ad essere
corrotto dal re epirota che
gli offrì la quarta parte del
suo regno. Il re epirota,
non avendo ottenuto ciò che
voleva da Fabricio, inviò a
sua volta a Roma, il suo
fidato consigliere, Cinea,
per chiedere la pace,
affidandogli anche quei
soldati romani fatti
prigionieri nella battaglia
di Eraclea per i quali
non volle alcun riscatto.
L'obiettivo del re epirota era
di ottenere l'assenso dal Senato
romano a mantenere il
dominio sui territori
meridionali del suolo italico,
finora conquistati. Il
Senato respinse la richiesta
di Pirro e considerò i
prigionieri romani
"infami", poiché
erano stati catturati con le
armi in pugno, e perciò
allontanati. Questi ultimi
avrebbero potuto essere
reintegrati nello Stato
romano solo nel caso in
cui ciascuno di loro avesse
consegnato le spoglie di due
nemici uccisi.
Pirro,
a questo punto, si trovava in
seria difficoltà per gli
approvvigionamenti: riceverli
via mare dall'Epiro era troppo
dispendioso. Prelevarli in
loco dagli alleati italici gli
avrebbe alienato la loro
benevolenza e scatenato
probabilmente qualche azione
di guerriglia a
vantaggio dei romani. Il re
epirota si risolse così a
tentare un accomodamento
diplomatico col senato
romano. Roma venne minacciata
di occupazione se non avesse
ritirato il suo esercito al di
qua del fiume Garigliano e
non avesse smesso di compiere
sortite con azioni di
guerriglia ai danni di epiroti
e di tarantini. Ma l'anziano
console Appio Claudio
Cieco, capofila degli
intransigenti, fece fallire le
trattative, consapevole
dell'appoggio logistico e
finanziario di Cartagine, che
non desiderava lo sbarco
dell'esercito epirota in
Sicilia, e conscio della
capacità dell'esercito romano nel
rimpiazzare le perdite senza
problemi, a differenza
dell'esercito di Pirro. A
Pirro non rimaneva che cercare
uno scontro decisivo che
obbligasse Roma a piegarsi.
Nel
corso del 279
a.C. i Romani si
scontrarono con Pirro ad Ascoli
di Puglia, dove furono
nuovamente sconfitti (persero
6.000 uomini) infliggendo
tuttavia, in proporzione,
perdite talmente alte alla
coalizione
greco-italico-epirota (3.500
soldati) che Pirro fu
costretto a ripiegare per
evitare ulteriori scontri coi
romani che avrebbero
assottigliato ulteriormente le
sue forze.
È
forse in seguito a questi
eventi che Romani e Cartaginesi decisero
di stipulare un trattato di
alleanza contro il comune
nemico epirota.
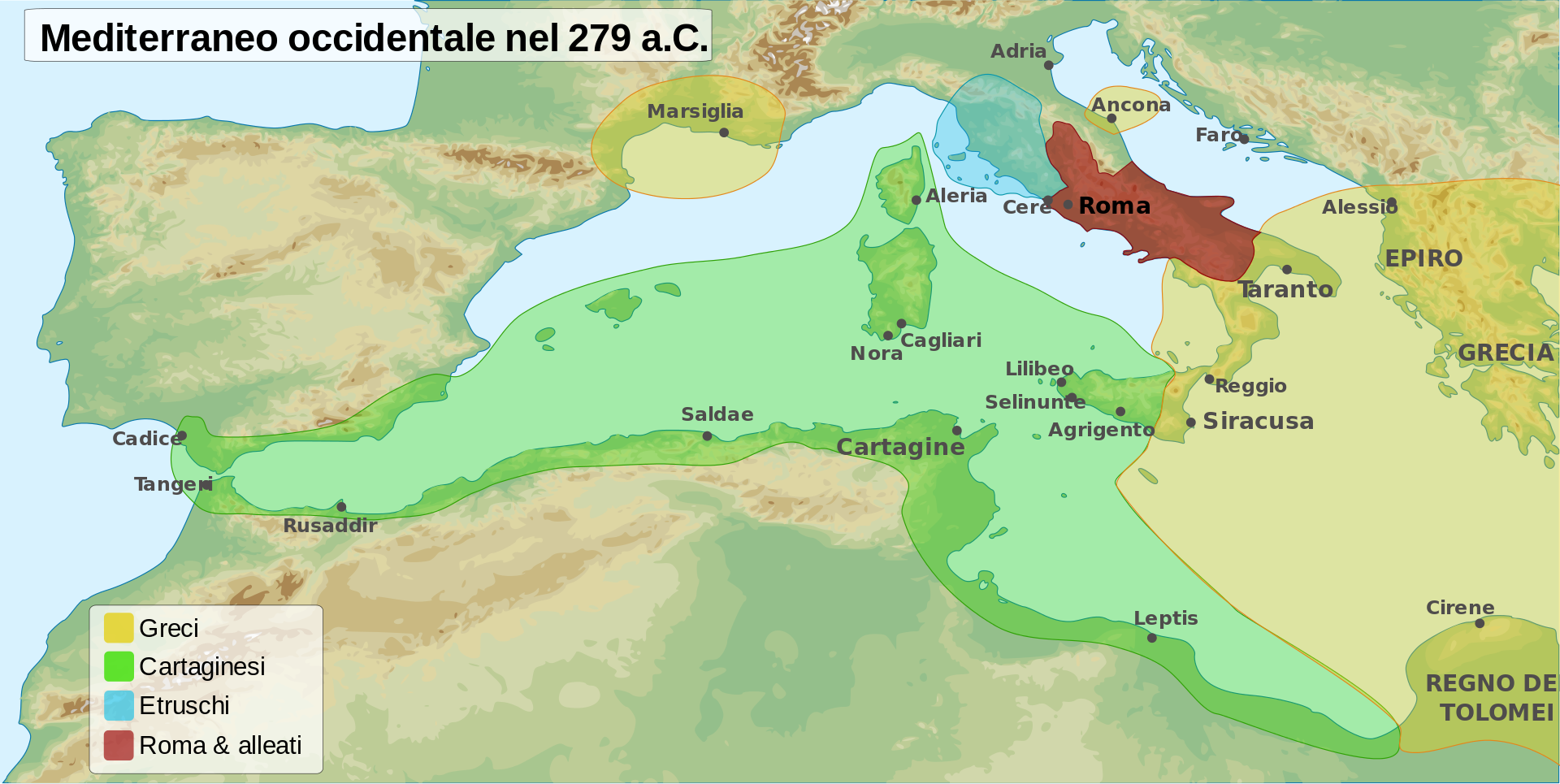
278
a.C.
- Pirro
ricevette due offerte allo
stesso tempo: da un lato, le
città greche di Sicilia gli
proposero di estromettere
i Cartaginesi (l'altra
grande potenza del
Mediterraneo occidentale)
dalla metà occidentale
dell'isola; dall'altro, i Macedoni gli
chiesero di salire al trono di
Macedonia al posto di re Tolomeo
Cerauno, decapitato
nell'invasione della Grecia e
della Macedonia da parte
dei Galli. Pirro giunse a
conclusione che le opportunità
maggiori venivano
dall'avventura in Sicilia e
decise, pertanto, di
abbandonare l'Italia
meridionale e andare in aiuto
dell'isola, non avendo
ottenuto però nessun trattato
preciso dai romani. Al comando
di un esercito di 37.000
uomini mosse da Agrigento
verso Erice e la
espugnò: caduta la città
filo-cartaginese più
fortificata, altre come Segesta si
consegnarono all'epirota. Fu
così nominato re di Sicilia,
e i suoi piani prevedevano la
spartizione dei territori fin
lì conquistati tra i due
figli, Eleno (a cui
sarebbe andata la Sicilia) e Alessandro (a
cui sarebbe andata l'Italia).
277
a.C.
- Cartagine aveva
deciso di non difendere città
come Palermo ed Eraclea
Minoa, ma concentrò i suoi
sforzi su Lilibeo, città
che veniva rifornita via mare:
fu così possibile ai fenici
di sostenere l'assedio posto
da Pirro.
276
a.C.
- Il
re epirota intavolò
trattative coi cartaginesi.
Per quanto essi fossero già
pronti a venire a patti con
Pirro, e fornirgli denaro e
navi quando fossero stati
ripristinati rapporti
amichevoli, questi richiese
che tutti i cartaginesi
lasciassero l'isola per fare
del mare una linea di confine
tra punici e greci. Al loro
rifiuto seguì l'assedio
infruttuoso di Lilibeo che,
unito al suo comportamento
dispotico nei confronti delle
colonie siceliote, causò
un'ondata di risentimento nei
suoi confronti: Pirro fu
costretto ad abbandonare la
Sicilia inseguito dai
Cartaginesi ed a tornare in
Italia, senza fra l'altro
ottenere cospicui rinforzi,
perché fino a quel momento le
città greche che aveva
preteso di proteggere non
riuscirono mai a concordarsi
fra di loro per sostenere lo
sforzo bellico comune. Il
mancato successo finale
produsse uno scollamento tra
Pirro ed i sicelioti ed egli
dovette tornare in Italia
prendendo come pretesto la
richiesta d'aiuto di Taranto.
Durante
il trasferimento delle truppe,
i Cartaginesi ne
approfittarono per attaccarlo
sul mare, così che l'esercito
di Pirro,
nella Battaglia
dello Stretto di Messina subì
gravissime perdite.
Fine
della guerra: la battaglia di Maleventum
- Nel
frattempo Roma, sempre
rifornita abbondantemente da
Cartagine, rioccupava senza
colpo ferire tutto il
territorio precedentemente
perduto in Puglia ed in
Lucania. Sedata
definitivamente la ribellione
degli Oschi e
dei Sanniti (la
componente stanziata al
confine tra le attuali
Campania e Puglia), arrivò
nell'inverno del 276 a.C. a
porre nuovamente sotto assedio
Taranto, per terra e questa
volta anche per mare, complice
la flotta cartaginese. I
tarantini invocarono
nuovamente l'aiuto di Pirro,
che dovette dunque abbandonare
la Sicilia e sbarcare in
Lucania.
275
a.C.
- Lo
scontro definitivo con Roma
avvenne nel Sannio, a Maleventum nella
tarda primavera di quest'anno.
L'intento di Pirro era quello
di far togliere l'assedio a
Taranto minacciando
direttamente Roma. Ma i
romani, intuita la strategia
dell'epirota, non solo non
tolsero l'assedio a Taranto,
bensì risposero inviandogli
contro tutte le legioni
stanziate in Etruria,
devastando l'esercito
avversario che non disponeva
più degli elefanti, tutti
eliminati nelle azioni di
guerriglia seguite allo
scontro di Ascoli, che era
stato logorato da anni di
guerre e che era provato nel
morale per gli insuccessi
strategici.
Pirro,
per non cadere prigioniero dei
romani, dovette far ritorno
precipitosamente nel suo regno
con quanto rimaneva del suo
esercito.
Conseguenze
- A
causa della sconfitta Pirro
abbandonò la campagna
d'Italia e tornò in Epiro,
dove, non pago del grave
prezzo in uomini, denaro e
mezzi della sua avventura a
Occidente, due anni dopo
preparò un'altra spedizione
bellica contro Antigono
II Gonata: il successo fu
facile e Pirro tornò a
sedersi sul trono macedone,
dove morì di lì a poco
mentre tentava di conquistare
il Peloponneso. Taranto
rimase sotto assedio altri tre
anni, capitolando nel 272
a.C., e di lì a poco tutto il
resto dell'Italia meridionale
passò nell'orbita dell'Urbe
(Reggio fu presa nel 271
a.C.): Roma aveva completato
la sottomissione della Magna
Grecia e la conquista di tutta
l'Italia meridionale. In
seguito alla vittoria romana
la città di Maleventum divenne colonia (268
a.C.) e ribattezzata Beneventum (da
cui l'odierna Benevento),
nome più adeguato alla felice
circostanza.
L'integrazione
della Magna Grecia nel dominio
della Repubblica Romana fu
l'inizio di varie evoluzioni
sociali per la città, che
accoglieva così molti più
greci con la loro cultura che
avrebbe in seguito influenzato
la stessa società romana. Ma
mise anche Roma a diretto
contatto con la Sicilia,
divisa fra i greci e i
cartaginesi, situazione che
avrebbe in seguito condotto
alle guerre
puniche.
A
seguito della guerra vennero
fatti molti prigionieri, tra
cui lo scrittore Livio
Andronico, che dopo la guerra
divenne schiavo
di Marco
Livio Salinatore.
Pag.
5 
 Pag.
7
Pag.
7
|