|
Dalla
monarchia alla repubblica
DOPO
ROMOLO SUL TRONO DI ROMA SI
SUCCEDONO SEI RE
Secondo
la tradizione, alla morte di
Romolo si sarebbero succeduti
tre re, alternativamente di
stirpe sabina e romana
(latina), le cui figure e
opere rimangono avvolte nella
leggenda: Numa Pompilio,
Tullio Ostilio, Anco Marzio.
La
tradizione assegnò loro una
serie di iniziative, tra cui
imprese militari contro altre
città sia latine sia etrusche
(Anco Marzio avrebbe portato
Roma ad affacciarsi
direttamente sul mare,
fondando Ostia alla foce del
Tevere), ampliamenti della
città e alcune iniziative
"di carattere religioso
(Numa Pompilio avrebbe posto
le basi per un ordinamento
religioso comune alle varie
genti).
Alla
fine del VII secolo a.C., gli
Etruschi, che allora si
stavano espandendo verso la
Campania, posero sotto il
proprio controllo questo
centro, così importante per
le comunicazioni con le zone
da poco conquistate. Perciò,
nel VI secolo troviamo Roma
sottoposta all’influenza
etrusca non solo dal punto di
vista commerciale ma anche da
quello politico. Gli Etruschi,
infatti, misero a capo della
città re della loro stessa
stirpe: Tarquinio Prisco,
Servio Tullio, Tarquinio il
Superbo.
La
monarchia etrusca diede un
vigoroso impulso alle opere
pubbliche e
all’organizzazione politica
della città: secondo la
tradizione, Tarquinio Prisco
fece prosciugare le paludi
nella valletta tra il Palatino
e il Capitolino, ove sorse il
foro, area degli scambi
commerciali
della
città; Servio Tullio fece
costruire le mura della città
ed emanò ordinamenti civili e
militari.
La
leggenda racconta, invece, che
Tarquinio il Superbo perse il
favore della popolazione a
causa del suo governo crudele
ed autoritario: nel 509 a.C.
egli fu quindi cacciato dalla
ccittà e venne sostituito da
un governo aristocratico. In
realtà il passaggio che portò
alla costituzione di un
diverso regime politico fu
lento e graduale: il re,
divenuto insufficiente per
governare una città in
continuo sviluppo,
probabilmente delegò ad altri
collaboratori, membri del
Senato, alcune delle sue
funzioni, fino a essere
scalzato dall’aristocrazia.
NEL
PERIODO REGIO SOLO I PATRIZI
PARTECIPANO ALLA VITA POLITICA
DI ROMA
L’antica
monarchia romana non era
assoluta: infatti il re (rex,
cioè colui che regge,
governa) amministrava la
giustizia, era a capo
dell’esercito e svolgeva i
compiti di sommo sacerdote, ma
era eletto e assistito
nell’esercizio del potere
dal Senato (dal latino senex,
«anziano»), un consiglio di
anziani, capi (patres) delle
«genti» (gentes), ossia di
gruppi di famiglie (familiae)
riunite da un comune antenato
illustre (eroe o divinità),
che si erano imposte
nell’economia locale (allora
basata prevalentemente
sull’agricoltura e sulla
pastorizia).
Erano
dunque chiamati "patrizi"
tutti coloro che discendevano
dai patres: essi partecipavano
alla vita politica attraverso
i comizi curiati,
assemblee generali che
venivano consultate dal re e
dal Senato per le questioni più
importanti. I comizi curiati
comprendevano tutti i membri
delle gentes, atti alle armi,
divisi in 30 curie, ossia 10
curie per ciascuna delle tre
tribù in cui, secondo quanto
tramandato dalla tradizione,
Romolo aveva suddiviso
l’originario popolo romano.
Anche l’esercito era formato
sulla base delle curie,
ciascuna delle quali forniva
100 fanti e 10 cavalieri.
II
resto della popolazione era
costituito dai plebèi
i quali, sebbene liberi, erano
esclusi dalla partecipazione
al governo dello Stato. Essi
disponevano di minuscoli
poderi o praticavano
l’artigianato, il commercio
o, ancora, erano lavoratori a
giornata. Esclusi
dall’attività politica
erano anche i clienti
(clientes) stranieri o plebei
in condizioni disagiate che si
mettevano al servizio di
patrizi, ricevendone in cambio
protezione. Gli schiavi,
poco numerosi nei primi
secoli, erano spesso
considerati beni materiali,
piuttosto che persone.
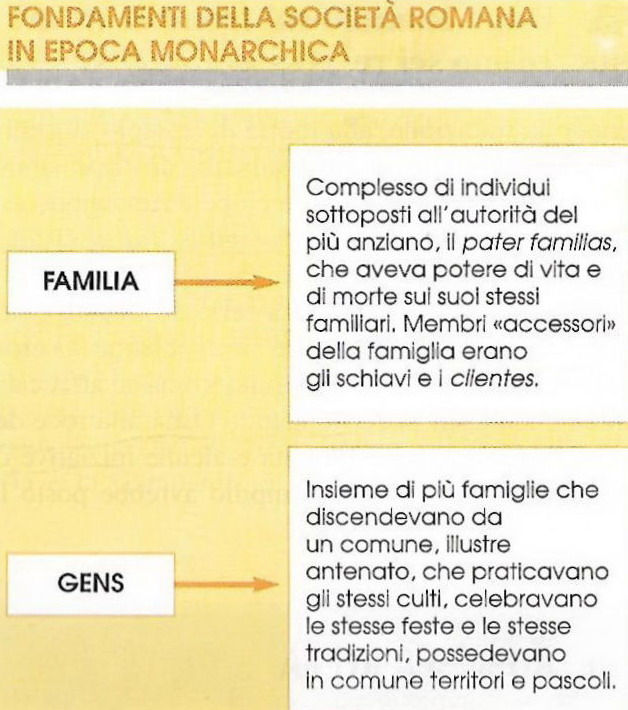 I
CITTADINI ROMANI SONO DIVISI
IN CLASSI, A SECONDA DEL CENSO I
CITTADINI ROMANI SONO DIVISI
IN CLASSI, A SECONDA DEL CENSO
La
riforma che pose fine al
privilegio politico delle
famiglie gentilizie fu quella
che divise i cittadini in
classi, a seconda della
ricchezza. La tradizione
attribuiva questa riforma a
Servio Tullio, che avrebbe
regnato tra il 578 e il 535
a.C.: si creava così un
parallelismo tra la storia
romana e la storia di Atene
che, con Solone, era passata
da un ordinamento
aristocratico a uno
timocratico.
In
realtà gli storici sono
concordi nel datare questa
riforma all'età repubblicana,
al V secolo a.C. o agli inizi
del IV. La popolazione venne
dunque divisa in 5 classi in
base al reddito; ogni classe
fu a sua volta divisa in
centurie, ossia in gruppi di
cento uomini atti alle
armi.
Con
la divisione per censo si
raggiungeva lo scopo di armare
convenientemente l'esercito:
infatti i cittadini - a
seconda del loro reddito -
dovevano procurarsi essi
stessi le armi.
Certo,
il potere rimase nelle mani
dei più ricchi, che più
contavano nell'armare
l'esercito, ma questa riforma
permise a tutti i cittadini
maschi in grado di armarsi di
partecipare alle assemblee
della città, che presero il
nome di "comizi
centuriati". Essi
deliberavano sulla pace e
sulla guerra ed eleggevano i
magistrati (che a lungo furono
scelti all'interno della prima
classe), cui era affidato il
governo della città.
NELLA
ROMA REPUBBLICANA IL POTERE É
AFFIDATO A PIÚ MAGISTRATI
Nel
corso del V secolo a.C. si
vennero progressivamente
delineando le caratteristiche
del nuovo ordinamento
repubblicano. I romani
chiamarono lo Stato "res
publica", che significa
"cosa pubblica",
appartenente cioè a tutti i
cittadini e non a uno solo o a
una minoranza di potenti: a
poco a poco il potere venne
quindi diviso tra diversi
magistrati, appartenenti
però, inizialmente, solo alla
classe dei patrizi.
Il
potere fu affidato non più a
un
re ma a due consoli, eletti
annualmente: a loro furono
affidati il
comando dell'esercito
e l'amministrazione della
giustizia; i consoli inoltre
presiedevano le riunioni del
Senato, l'assemblea patrizia,
cui spettavano le più
importanti decisioni
politiche, economiche e
militari.
In
caso di gravissimo pericolo
per lo Stato, veniva eletto
per sei mesi un dittatore,
magistrato straordinario con
poteri assoluti: egli poteva,
a suo arbitrio, far dimettere
o tenere ai propri ordini gli
altri magistrati. Al di sotto
dei consoli vi erano i
questori (inizialmente 3, due,
poi quattro, in seguito otto),
anch'essi eletti per un anno e
che avevano il compito di
amministrare le finanze dello
Stato.
I
censori, in numero di due,
erano eletti ogni
cinque
anni e avevano il compito di
redigere il censo, ossìa di
registrare i nomi dei
cittadini e l’ammontare
delle loro ricchezze. Vi erano
infine i pretori, con nomina
annuale; essi esercitavano
funzione di giudice nei
processi.
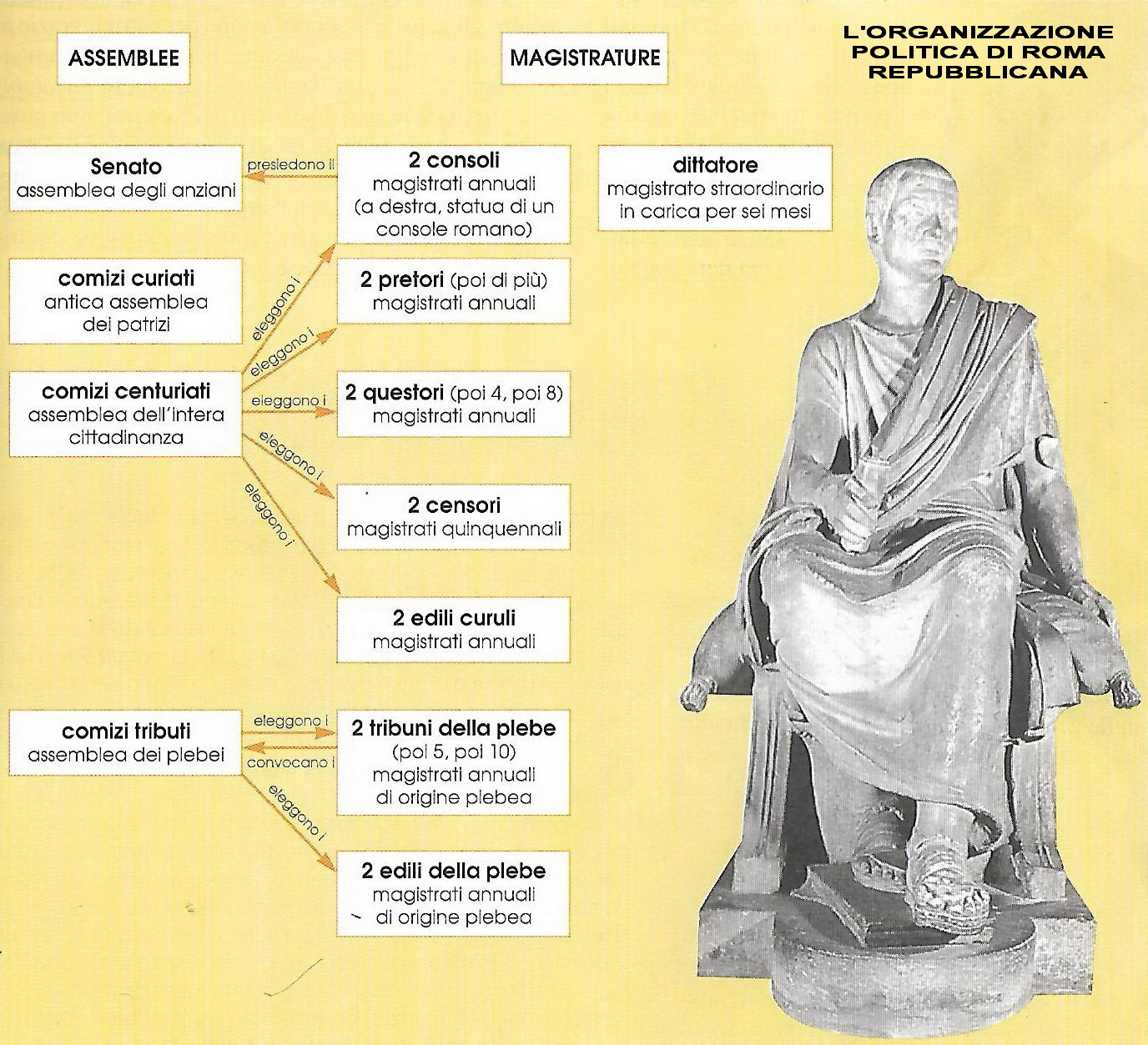
I
PLEBEI SI RIBELLANO AI
PRIVILEGI POLITICI DEI PATRIZI
Nonostante
partecipassero attivamente
alla difesa di Roma e alla sua
continua espansione, i plebei
erano
esclusi da una reale
partecipazione alla vita
politica. Proprio il servizio
militare li poneva spesso in
difficoltà: infatti, i
patrizi durante le guerre (che
nel corso del V secolo a.C. si
succedettero quasi senza
sosta) lasciavano la cura dei
campi ai propri lavoratori
dipendenti o a schiavi
e alla fine di
ogni guerra si accaparravano i
terreni dei nemici vinti; al
contrario
i plebei,
che già dovevano sostenere
ingenti spese per
l’armamento, erano costretti
a lasciare
incolti i loro terreni, poiché
non avevano dipendenti che li
lavorassero; essi inoltre non
avevano
diritto
di utilizzare le nuove terre
conquistate: a causa di tale
situazione i plebei erano
sempre più poveri e
indebitati.
Esasperati
da queste ingiustizie, nel 494
a.C. i plebei si rifiutarono
di prendere le armi e anzi
abbandonarono
la città, ritirandosi sul
Monte Sacro. Subito si diedero
nuove istituzioni, mostrando
di non riconoscere lo Stato
patrizio e anzi di opporsi a
esso.
Di
fronte a questa
ribellione,
che comportava una notevole
riduzione dell’esercito, i
patrizi si trovarono costretti
ad accettare l’istituzione
dei tribuni della plebe.
Questi magistrati, nominati
dagli stessi plebei, dovevano
difenderli contro gli abusi e
la sopraffazione dei patrizi,
grazie al diritto di veto di
cui godevano. Perché fossero
protetti da ogni attacco, i
tribuni furono dichiarati
inviolabili: non rispondevano
a nessuno dei loro atti, non
potevano essere trascinati in
tribunale e se qualcuno avesse
usato loro violenza lo
aspettava una condanna a
morte.
In
principio i tribuni furono
due, in seguito cinque e alla
fine dieci; è facile capire
come l’istituzione dei
tribuni della plebe
costituisse una vera
rivoluzione.
ALLA
DIVISIONE TRA PATRIZI E PLEBEI
SI SOSTITUISCE QUELLA TRA
RICCHI E POVERI
All’istituzione
dei tribuni della plebe seguì
quella degli edili della
plebe, due magistrati che
avevano il compito di
controllare la manutenzione di
strade, templi, edifici
pubblici, di sorvegliare i
mercati e i prezzi, di
organizzare gli spettacoli
pubblici.
Un
altro obiettivo dei plebei era
ottenere l’uguaglianza
davanti alla legge, sottraendo
il verdetto all’arbitrio dei
tribunali patrizi che si
fondavano sulla consuetudine:
furono allora introdotte, nel
451 a.C., leggi scritte, le
famose «dodici favole».
Verso
la metà del V secolo a.C. fu
creata l’assemblea dei
plebei, i comizi tributi, cui
fu data la facoltà di votare
vere e proprie leggi, i
plebisciti, facoltà che nei
comizi centuriati era di fatto
esclusiva dei patrizi.
Via
via i plebei riuscirono ad
accedere a tutte le cariche
pubbliche: anche il Senato,
roccaforte dei patrizi,
divenne accessibile ai plebei,
in quanto dal III secolo a.C.
vi confluirono tutti i
magistrati usciti di carica. I
plebei che pervenivano alle
maggiori cariche erano
comunque i più ricchi, che
avevano il tempo e i mezzi per
occuparsi della carriera
politica. Abolita dunque
l’antica divisione tra
patrizi e plebei, ne sorse
un’altra: quella tra ricchi
e poveri.
 IL
SOLDATO ROMANO IL
SOLDATO ROMANO
Essere
romano - secondo la tradizione
- voleva dire essere
guerriero, o meglio soldato,
cioè non tanto un combattente
avido di imprese individuali,
quanto un cittadino
disciplinato, inserito e
inquadrato in una temibile
struttura bellica,
l’esercito appunto, la cui
potenza derivava dalla
coesione e
dall’organizzazione
interna.
Proprio
per mantenere la disciplina,
il comandante dell'esercito
infliggeva punizioni severe ma
efficaci: ad esempio i soldati
che si erano lasciati
sopraffare e avevano
abbandonato il posto di
combattimento venivano
fustigati e lasciati fuori
dell’accampamento.
Tuttavia
il soldato romano considerava
la partecipazione militare non
solo un dovere, ma anche un
privilegio: privilegio dovuto
alla ricchezza necessaria per
fornirsi di un’adeguata
armatura, privilegio in caso
di vittoria (la spartizione
del bottino), privilegio
onorifico nella misura in cui
l’individuo aveva
l’opportunità di provare il
suo coraggio e la sua
devozione.
Il
soldato era infatti ciecamente
devoto alla causa della patria
e fermamente convinto che Roma
fosse destinata a conquistare
il mondo intero; si
considerava pronto a servire
sotto le armi pressoché per
tutta la durata della sua vita
attiva.
I
VALORI SU CUI SI FONDA LA
SOCIETÀ ROMANA SI RIFLETTONO
NELLA RELIGIONE
Nei
primi secoli della repubblica,
i valori su cui si fondava la
società romana erano il culto
della famiglia e delle
tradizioni degli antenati, la
semplicità nei costumi, il
rispetto per il lavoro
contadino. L’importanza di
questi valori si rifletteva
anche nella vita religiosa.
Ogni
anno, ad esempio, il 21
aprile, giorno leggendario
della fondazione di Roma, vi
era una festa dedicata a Pale,
dea della pastorizia. Con
questa festa si voleva
propiziare fecondità al
gregge, da cui si ricavano il
latte per farne il cacio,
alimento quotidiano dei Romani
(la carne era riservata ai
giorni di festa), e la lana
per tessere abiti semplici.
Un’altra
festa era quella dei
Lupercali, celebrata a Roma il
15 febbraio. La leggenda narra
che ai piedi del Palatino vi
era una grotta, in cui si
rifugiavano i lupi e perciò
detta «Lupercale», dove
Romolo e Remo sarebbero stati
allattati da una lupa. Qui si
riunivano i «Luperci», gli
addetti al rito: essi, dopo
aver sacrificato degli
animali, ne indossavano le
pelli e correvano attorno al
colle.
Il
simbolo degli affetti
familiari era il focolare
domestico presso il quale si
onoravano le immagini degli
antenati - gli iniziatori
della stirpe - detti «Lari»
o «Penati» o «Mani»;
mantenere in vita il loro
ricordo significava conservare
un legame con il proprio
passato e l’unità della
famiglia.
Legata
al culto familiare era Vesta,
dea del focolare, sia di
quello domestico sia di quello
pubblico dello Stato; a lei
era dedicato un tempio nel
Foro, nel quale era custodito
il fuoco perenne, simbolo
della conservazione dello
Stato.
Era
infine venerata
un’antichissima divinità
italica: Giano, il cui nome
derivava da «ninna», che in
latino significa «porta»,
dio della soglia della casa.
Rappresentato di solito con
due volti contrapposti, e
perciò chiamato «bifronte»,
egli presiedeva a tutti gli «inizi»,
sia dei tempi (come l’inizio
dell’anno che da lui prese
nome, ianuarius, «gennaio»)
sia di cose (l’apertura di
una porta, sia della casa sia
della città).
Giano
diventerà, nell’epoca
augustea (fine del I secolo
a.C.), il custode della pace:
le porte del suo tempio
potevano esser chiuse solo in
tempo di pace; le porte aperte
indicavano che Roma era in
guerra.

Pag.
4 
 Pag.
6
Pag.
6
|