|
Lucrezia
 Lucrezia
(in latino Lucretia), figlia
di Spurio Lucrezio Tricipitino
e moglie di Collatino, è un
figura mitica della storia di
Roma legata alla cacciata
dalla città dell'ultimo re
Tarquinio il Superbo. Lucrezia
(in latino Lucretia), figlia
di Spurio Lucrezio Tricipitino
e moglie di Collatino, è un
figura mitica della storia di
Roma legata alla cacciata
dalla città dell'ultimo re
Tarquinio il Superbo.
LA
LEGGENDA -
Secondo la versione di Livio
sulla istituzione della
Repubblica, l'ultimo re di
Roma, Tarquinio il Superbo
aveva un figlio assolutamente
sgradevole, Sesto Tarquinio.
Durante
l'assedio della città di
Ardea, i figli del re assieme
ai nobili, per ingannare il
tempo si divertivano a vedere
ciò che facevano le proprie
mogli durante la loro assenza,
tornando nascostamente a Roma.
Collatino
sapeva che nessuna moglie
poteva battere la sua Lucrezia
in quanto a pacatezza,
laboriosità e fedeltà. Così
portò con se gli altri
nobili, tra cui Sesto
Tarquinio, a vederla, nel
pieno della notte, e poterono
constatare che Lucrezia stava
tranquillamente tessendo la
lana, con le sue ancelle.
Sesto
Tarquinio se ne innamorò, e
tornò a trovarla di nascosto
dal marito, ma fu da lei
respinto. Per niente vinto
Sesto minacciò di ucciderla e
di farvi trovare accanto un
corpo mutilato di uno schiavo:
ciò l'avrebbe incolpata di
adulterio e avrebbe messo in
cattiva luce la sua casata. A
questo punto Lucrezia fu
costretta a cedere alle voglie
del figlio del re, ma appena
poté andò all'accampamento
romano presso Ardea a riferire
il tutto al padre ed al
marito.
Il
marito Collatino, il padre ed
il suo grande amico Lucio
Giunio Bruto decisero di
vendicarla, provocando e
guidando una sommossa popolare
che cacciò via i Tarquini da
Roma e li costrinse a
rifugiarsi in Etruria. Così
nacque la repubblica romana, i
cui primi due consoli furono
proprio Lucio Tarquinio
Collatino e Lucio Giunio Bruto
artefici della rivolta contro
quello che poi divenne l '
ultimo re di Roma.
Lucio
Iiunio Bruto
Lucio Iiunio Bruto fu il fondatore della
Repubblica romana e secondo la
tradizione uno dei primi
consoli nel 509 a.C..
Fino ad allora Roma era stata
una monarchia. Bruto guidò la
sommossa che scacciò l'ultimo
re, Tarquinio il Superbo,
poiché il figlio di Tarquinio
aveva violentato una parente
di Bruto, Lucrezia.
Secondo Livio, Bruto aveva
molti motivi di ostilità
contro il re: fra loro era il
fatto che Tarquinio aveva
disposto l'omicidio del
fratello, un potente senatore,
che si era opposto
all'assunzione del trono da
parte di Tarquinio.
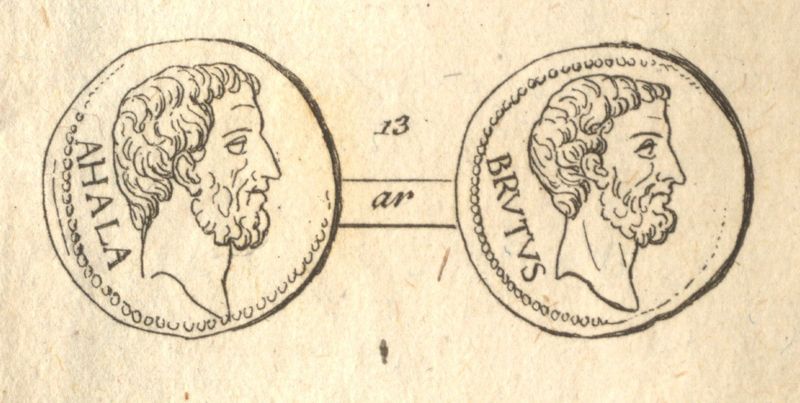 Bruto
allora si infiltrò nella
famiglia di Tarquinio
impersonando la parte dello
sciocco (in Latino brutus
significa sciocco). Lui
accompagnò i figli di
Tarquinio in un viaggio
all'oracolo di Delfi. I figli
chiesero all'oracolo chi
sarebbe stato il successivo
sovrano a Roma. L'oracolo
rispose che la prossima
persona che avrebbe baciato
sua madre sarebbe diventato
re. Bruto interpretò la madre
nel significato di terra, così
finse di inciampare e baciò
la terra. Al ritorno a Roma,
Bruto dovette combattere in
una delle guerre senza fine di
Roma contro le tribù vicine. Bruto
allora si infiltrò nella
famiglia di Tarquinio
impersonando la parte dello
sciocco (in Latino brutus
significa sciocco). Lui
accompagnò i figli di
Tarquinio in un viaggio
all'oracolo di Delfi. I figli
chiesero all'oracolo chi
sarebbe stato il successivo
sovrano a Roma. L'oracolo
rispose che la prossima
persona che avrebbe baciato
sua madre sarebbe diventato
re. Bruto interpretò la madre
nel significato di terra, così
finse di inciampare e baciò
la terra. Al ritorno a Roma,
Bruto dovette combattere in
una delle guerre senza fine di
Roma contro le tribù vicine.
Bruto tornò alla città
quando venne a sapere che
Lucrezia aveva subito
violenza. Lucrezia, credendo
di essere stata disonorata si
uccise. Questo evento risultò
essere la goccia che fece
traboccare il vaso: Bruto
allora istigò una
sollevazione popolare contro
la monarchia, obbligando
Tarquinio a rientrare a Roma.
Quando Tarquinio arrivò a
Roma, lui e la sua famiglia
furono cacciati in esilio e
Bruto dichiarò che il potere
era nelle mani del Senato.
C'è una certa confusione sui
particolari della vita di
Bruto. Il suo consolato, per
esempio, può essere un
abbellimento successivo per
dare alle istituzioni
repubblicane maggior
legittimità associandole alla
cacciata dei re. Il racconto
dell'esecuzione da parte di
Bruto dei propri figli per
aver mancato nelle loro
funzioni militari può essere
stata ugualmente un'invenzione
successiva. Il suo consolato
termina durante una battaglia
con gli Etruschi, che si erano
alleati con i Tarquini per
restaurare il loro potere a
Roma.
Secondo la tradizione ebbe il
suo consolato assieme a Lucio
Tarquinio Collatino, il vedovo
di Lucrezia.
Lucio Quinzio Cincinnato
Lucio Quinzio Cincinnato
(latino Lucius Quinctius
Cincinnatus), era nato prima
della Repubblica Romana,
intorno al 520 a.C. Fu console
nel 460 a.C. e due volte
dittatore, nel 458 a.C. e nel
439 a.C.. La data di nascita
non è precisa ma sappiamo da
Tito Livio che aveva
passato gli ottant'anni quando
fu eletto dittatore per la
seconda volta.
Cincinnato era un esponente di
spicco della Gens Quinctia
che, anche se non facente
parte delle prime gentes
organizzate da Romolo, era
stata cooptata a Roma
all'epoca della conquista e
distruzione di Alba Longa da
parte dei romani di Tullo
Ostilio.
Della vita e della carriera
politica di Cincinnato si
hanno notizie soprattutto da
Tito Livio che ne offre una
visione abbastanza neutrale.
Il primo Quinctius salito al
rango di console a Roma fu
Tito Quinzio Barbato negli
anni 471 a.C., 468 a.C. e 465
a.C.; era il fratello di Lucio
Quinzio Cincinnato. Certamente
il fatto che Quinzio Barbato
fosse assurto al rango
consolare facilitò l'ascesa
politica di Cincinnato che a
sua volta fu scelto tre volte
dai romani come guida dello
Stato.
La prima elezione di
Cincinnato ai massimi livelli
politici avvenne nel 460 a.C..
Lucio Quinzio fu eletto consul
suffectus (supplente) in
sostituzione del console
Publio Valerio Publicola che
era caduto durante la
riconquista del Campidoglio
occupato dai ribelli guidati
da Appio Erdonio.
Secondo gli annalisti,
Cincinnato si era dedicato ad
una vita di agricoltura e
sapeva che la sua partenza
poteva rendere povera la sua
famiglia se in sua assenza i
raccolti non fossero stati
curati. Secondo Tito Livio lo
storico padovano del I secolo,
viceversa, Lucio Quinzio si
era visto costretto in un
podere fuori Roma, perché gli
erano rimaste le sole
inalienabili terre di
famiglia; aveva dovuto vendere
tutti i suoi beni per pagare
una pesante cauzione. Il
figlio, Cesone Quinzio, dopo
un processo per omicidio
basato sulla testimonianza
dell'ex Tribuno della plebe
Marco Volscio Fittore aveva
scelto la fuga in Etruria, con
ciò costringendo il padre a
risarcire i mallevadori.
La descrizione che alcuni fanno di Cincinnato
come agreste coltivatore, si
scontra con l'acume politico e
giuridico che questi dimostra
nel corso di questo suo
mandato. Lucio Quinzio fu
eletto suffectus nel dicembre
del 458 a.C. e la maggioranza
dei senatori si era
battuta per questo. I plebei
erano intimoriti dal fatto di
vedere al rango consolare una
persona che nutriva un grande
risentimento contro di loro
per l'esilio di Cesone Quinzio
e per la situazione
finanziaria del padre Lucio. E
non avevano del tutto torto;
Cincinnato prese a difendere
il figlio Cesone, ad attaccare
i tribuni della plebe. Il
tribuno della plebe Aulo
Virginio, che aveva
organizzato il processo a
Cesone fu pesantemente
attaccato e paragonato al
nemico interno Appio Erdonio.
Oltre a questa difesa del
figlio e a questo attacco al
tribuno, quasi obbligatori,
Lucio Quinzio informò il
popolo romano che, assieme al
collega stava organizzando la
guerra ai soliti nemici gli
Equi e i Volsci. L'obiezione
dei tribuni fu che non poteva
radunare l'esercito senza il
loro consenso.
 Questa convocazione toglieva
un'arma potente dalle mani dei
tribuni della plebe. Il popolo
convocato in armi per
deliberare al di fuori del
pomerio, costituiva i
cosiddetti "comizi
centuriati", un'assemblea
legislativa militare con il
potere di abrogare quanto in
città, all'interno del
pomerio, veniva deciso dal
potere politico civile. I
maneggi dei tribuni della
plebe, che in quel periodo
stavano cercando di far
approvare la Lex Terentilia,
si sarebbero scontrati con le
decisioni prese da cittadini
forzati a votare in modo non
libero in quanto costretti da
giuramento a seguire le leggi
militari, a tutto vantaggio
del patriziato che avversava
l'approvazione di tale legge. Questa convocazione toglieva
un'arma potente dalle mani dei
tribuni della plebe. Il popolo
convocato in armi per
deliberare al di fuori del
pomerio, costituiva i
cosiddetti "comizi
centuriati", un'assemblea
legislativa militare con il
potere di abrogare quanto in
città, all'interno del
pomerio, veniva deciso dal
potere politico civile. I
maneggi dei tribuni della
plebe, che in quel periodo
stavano cercando di far
approvare la Lex Terentilia,
si sarebbero scontrati con le
decisioni prese da cittadini
forzati a votare in modo non
libero in quanto costretti da
giuramento a seguire le leggi
militari, a tutto vantaggio
del patriziato che avversava
l'approvazione di tale legge.
Cincinnato, alla fine "si
rimise alla volontà del
Senato" (cioè della
"sua" parte
politica) e il senato sentenziò
che la legge non doveva essere
votata ma che l'esercito non
doveva essere convocato. In più
i magistrati e i tribuni della
plebe non avrebbero più
potuto essere rieletti. I
consoli non ripresentarono la
candidatura ma i tribuni della
plebe si ripresentarono fra le
proteste dei patrizi che, per
ripicca volevano rieleggere
Cincinnato. Fu lui stesso a
rifiutare con un discorso che
riportava i senatori al
rispetto delle decisioni
prese, in contrapposizione
alla malafede della plebe.
Furono eletti consoli Quinto
Fabio Vibuleno per la terza
volta e Lucio Cornelio
Maluginense; Cincinnato ritornò
alle sue rurali occupazioni
assieme alla moglie Racilia.
L'anno seguente Roma ebbe
ancora bisogno di lui.
LA PRIMA DITTATURA - Il
console Lucio Minucio
Esquilino Augurino era rimasto
assediato all'interno del suo
accampamento durante le
operazioni di guerra che i
romani avevano portato agli
Equi. Nemmeno l'altro console,
Gaio Nautio Rutilo, che pur
stava vincendo contro i Sabini
sembrava in grado di
fronteggiare la situazione.
Nei momenti di grave crisi
Roma eleggeva un dittatore con
pieni poteri: per unanime
consenso fu deciso di eleggere
Lucio Quinzio Cincinnato.
Cincinnato accettò e ritornò
a Roma attraversando il Tevere
su una barca "noleggiata
a spese dello Stato. Il neo
dittatore, preceduto dai
littori fu "scortato a
casa" dalla folla degli
amici.
Ma Cincinnato si dimostrò al
di sopra di meschine ripicche.
Il giorno seguente prese in
mano la direzione delle
operazioni e in poche ore
radunò l'esercito e lo
condusse con marcia forzata al
soccorso dei concittadini
assediati nel loro stesso
accampamento. Quella stesa
notte iniziò la battaglia del
Monte Algido che vide gli Equi
sconfitti.
Cincinnato, una volta liberato
l'esercito che era assediato,
distribuì il bottino e le
punizioni ai soldati e al
console incapace. Il bottino
andò ai suoi soldati, Lucio
Minucio depose la carica di
console e rimase in armi al
comando di Quinzio, ai soldati
soccorsi non toccò nulla
avendo rischiato di essere
loro stessi preda. Questo non
creò malumori, tanto che a
Lucio Quinzio venne donata una
corona d'oro da una libbra.
Cincinnato, comunque, ritorna
ad arare il suo terreno e a
condurre una vita fuori
dall'agone politico. Nel 450
a.C. ritroviamo Lucio Quinzio
con il fratello Tito che si
batte inutilmente contro Appio
Claudio il Decemviro il quale,
giocando tra le coalizioni,
fece si che non risultassero
eletti i due Quinzi,
Capitolino e Cincinnato
Nel 445 a.C., cinque anni dopo
la liberazione di Roma dal
nefasto governo dei Decemviri,
Gaio Canuleio presentò la sua
legge per abrogare il divieto
di matrimonio fra patrizi e
plebei, imposto proprio dai
Decemviri con le Leggi delle
XII tavole. È la famosa Lex
Canuleia. Quando alla fine
venne approvata i patrizi si
divisero sulla soluzione del
problema arrivando perfino,
con Gaio Claudio, zio
dell'Appio Claudio il
Decemviro, a ipotizzare
l'azione armata dei consoli
contro i Tribuni della plebe
che erano, fin dalla loro
creazione, dichiarati
intoccabili e protetti dagli
dei. I due Quinzi, Tito
Capitolino Barbato e Lucio
Cincinnato si opposero al
sacrilegio.
LA
SECONDA DITTATURA - Nel 439 a.C., si indicazione del fratello Tito
Capitolino Barbato al suo
sesto consolato, viene eletto
dittatore per la seconda
volta. Il presunto tentativo
di Spurio Melio di farsi
nominare "re"
(titolo aborrito dai romani
dopo la caduta dei Tarquini)
richiedeva un magistrato con
le mani più libere e poteri
più ampi dei consoli. La
nomina di Lucio Quinzio con la
successiva scelta di questi di
nominare Gaio Servilio Strutto
Ahala magister equitum
permette l'eliminazione del
presunto "golpista"
senza intaccare la figura
pubblica del console e senza
uscire dal dettato
costituzionale. Gaio Servilio,
inviato dal dittatore a
condurre Melio al processo, lo
uccide durante il tentativo di
fuga dell'imputato e il
patriziato romano viene
liberato da un pericolo.
Straordinario come dopo oltre
duemila anni le motivazioni di
certe morti siano ricorrenti.
Indubitabilmente l'obbedienza
al dittatore dei romani doveva
essere "pronta e
assoluta". Questa
dittatura, però, e questa
decisione provocarono moti e
tumulti della plebe e favorì
la sempre più utilizzata
elezione di Tribuni consolari
al posto dei consoli veri e
propri, favorì l'incremento
del potere della plebe
impegnata nel conflitto degli
Ordini con il patriziato e la
parificazione dei diritti
della plebe nell'accesso alla
più alta magistratura
dell'Urbe.
Appio
Claudio Cieco
Patrizio
romano (secc. IV-III a.C.).
Percorse una brillante
carriera politica: tre volte
tribuno militare, questore,
due volte edile curule, tre
volte pretore, censore
(310 a.C.), due volte console
(307 e 296 a.C.), dittatore.
Più
che uomo di guerra fu un
grande politico, un
amministratore di somma abilità
e, nel campo intellettuale,
uno spirito dotato di una
cultura superiore al suo tempo
e al suo ambiente. Mente
lungimirante, in politica mirò
a conciliare gli interessi dei
patrizi intransigenti con
quelli dei plebei proletari,
contro la nobiltà
patrizio-plebea destinata
quarant'anni dopo a prendere
nelle mani il potere
approfittando della situazione
politico-militare che gli
forniva l'occasione di attuare
la sua grande idea.
Per
far fronte agli attacchi delle
coalizioni di popoli italici,
Roma doveva disporre di un
numero sempre maggiore di
uomini e di mezzi e, per
averli, bisognava legare allo
Stato coloro che si erano
arricchiti nel commercio e
nell'industria con la
concessione di diritti
politici che comportassero
doveri patriottici.
Egli
pertanto nel corso della sua
censura (312) tenne conto, nel
determinare il censo, della
ricchezza mobiliare e non più
soltanto di quella fondiaria;
sempre col medesimo intento
introdusse nell'ordine
senatorio uomini di bassi
natali, tra cui alcuni figli
di liberti, e distribuì i
liberti stessi nelle tribù
rustiche col permesso di
iscriversi in tutte le classi
dell'ordinamento centuriato.
Grazie
alle sue riforme la ricchezza
mobiliare fu in grado di
opporre i suoi interessi a
quelli dei contadini e dei
proprietari fondiari. La
nobiltà reagì con grande
vigore al grave colpo che le
veniva inflitto, ma non poté
impedire che tali innovazioni
democratiche vitali per
l'esistenza e il progresso
dello Stato romano, venissero
attuate e si sviluppassero
negli anni seguenti.
Il
prestigio politico di Appio
Claudio durò a lungo: assai
vecchio e cieco (donde il
soprannome), con un'orazione
rimasta famosa, influì
decisamente sul senato perché
respingesse le proposte di
pace di Pirro (280 a.C.).
Tra
i molti suoi meriti si
annoverano la costruzione
della Via Appia,
dell'acquedotto Appio (Aqua
Appia), l'influsso esercitato
sul suo liberto Gneo Flavio,
autore della pubblicazione dei
fasti e delle formule
regolanti le azioni
giudiziarie, e l'attività
letteraria (oratoria,
linguistica, gnomica) per cui
è considerato la prima
personalità della letteratura
latina.
 Annibale
Barca Annibale
Barca
Annibale
Barca (Barca nella lingua
cartaginese significava assai
probabilmente Folgore) (247
a.C. - 182 a.C.) fu un
comandante militare
dell'antica Cartagine.
Famosissimo
per i suoi risultati nella
Seconda guerra punica, da lui
stesso scatenata marciando
dalla Spagna, attraverso i
Pirenei e le Alpi, fino in
Italia dove sconfisse le
legioni romane in tre
battaglie principali;
Battaglia della Trebbia (218
a.C.), Battaglia del Lago
Trasimeno (217 a.C.),
Battaglia di Canne (216 a.C.)
e molteplici scontri minori.
Dopo
la Battaglia di Canne i Romani
rifiutarono lo scontro diretto
e gradualmente riconquistarono
i territori del sud Italia di
cui avevano perso il
controllo. La Seconda guerra
punica terminò con l'attacco
romano a Cartagine che
costrinse Annibale al ritorno
in Africa nel 204 a.C. e con
la sua definitiva sconfitta
nella Battaglia di Zama nel
202 a.C..
Dopo
la fine della guerra, Annibale
guidò Cartagine per parecchi
anni cercando di ripararne le
devastazioni, fino a quando i
Romani non lo forzarono
all'esilio nel 195 a.C..
Annibale
si rifugiò quindi dal re
Seleucide Antioco III in Siria
dove continuava a propugnare
guerre contro Roma. Nel 189
a.C. Antioco III fu sconfitto
dai Romani e Annibale dovette
ricominciare la fuga, questa
volta presso il re Prusia I in
Bitinia. Quando i Romani
chiesero a Prusia la sua
consegna, Annibale preferì
suicidarsi. Era il 182 a.C.
Publio
Cornelio Scipione Africano
Uomo
politico e generale romano
(236-235 - Literno 183 a.C.). Appartenente alla Gens Cornelia, una delle più antiche
e potenti gentes patrizie di
Roma, era figlio di Publio
Cornelio Scipione, che fu
console nel 218 a.C. e che morì
in Spagna assieme al fratello
Gneo durante la Seconda guerra
punica. Sposò Emilia Terza,
sorella di Paolo Emilio
Macedonico, e fu il padre di
Cornelia, la famosa
"madre dei Gracchi".
A
diciassette anni, nella
sfortunata battaglia del
Ticino (218 a.C.), salvò la
vita al padre; tribuno
militare a Canne (216 a.C.),
fu tra quelli che a Canusium
(Canosa di Puglia)
riordinarono i resti
dell'esercito disfatto.
A
ventiquattro anni, dopo essere
stato edile (213), per unanime
consenso del senato e del
popolo e contro la
consuetudine (era infatti un
semplice privato e, per di più,
molto giovane) fu investito
dell'imperium proconsulare e
inviato in Spagna a
ristabilire la critica
situazione lasciata dalla
morte del padre e dello zio.
Ivi, mediante nuovi
accorgimenti tattici e una
strategia costantemente
offensiva, traendo profitto
dalle discordie dei capi
cartaginesi e dalle simpatie
degli indigeni, conseguì un
completo successo. Dapprima
conquistò Carthago Nova
(Cartagena) [209 a.C.]; poi
sconfisse a Becula (208 a.C.)
Asdrubale Barca, che muoveva
verso l'Italia in aiuto del
fratello Annibale, senza però
riuscire a fermarlo; distrusse
quindi due armate cartaginesi
a Ilipa e da ultimo ottenne
l'alleanza di Cadice (206
a.C.).
 Tornato
quindi a Roma, Scipione, forte
del favore popolare, ottenne
il consolato per il 205 e come
provincia la Sicilia, che nei
suoi disegni avrebbe dovuto
servirgli come base per
portare la guerra in Africa,
così da costringere Annibale
a uscire dall'ltalia e da
poter risolvere
definitivamente il lungo
conflitto. Il suo audace piano
incontrò l'opposizione di
Fabio Massimo e dei suoi
fautori, cosicché il senato
gli negò i mezzi e le truppe
necessari. Ma, nonostante
difficoltà e sospetti,
Scipione con l'aiuto spontaneo
ed entusiastico delle città
italiche e italiote, allestì
una flotta e un esercito
agguerrito, se non molto
numeroso, con il quale sbarcò
in Africa presso Utica (204
a.C.). Tornato
quindi a Roma, Scipione, forte
del favore popolare, ottenne
il consolato per il 205 e come
provincia la Sicilia, che nei
suoi disegni avrebbe dovuto
servirgli come base per
portare la guerra in Africa,
così da costringere Annibale
a uscire dall'ltalia e da
poter risolvere
definitivamente il lungo
conflitto. Il suo audace piano
incontrò l'opposizione di
Fabio Massimo e dei suoi
fautori, cosicché il senato
gli negò i mezzi e le truppe
necessari. Ma, nonostante
difficoltà e sospetti,
Scipione con l'aiuto spontaneo
ed entusiastico delle città
italiche e italiote, allestì
una flotta e un esercito
agguerrito, se non molto
numeroso, con il quale sbarcò
in Africa presso Utica (204
a.C.).
Trovatosi
di fronte a forze superiori al
previsto, alternò azioni di
guerra a proposte di pace,
riportando, con l'aiuto del re
numida Massinissa, una grande
vittoria ai Campi Magni (203);
poi, al ritorno di Annibale
dall'ltalia, per stroncare le
rinascenti velleità bellicose
dei Cartaginesi, attaccò
battaglia presso Naraggara
(Zama) infliggendo loro la
sconfitta decisiva (202) cie
pose fine alla seconda guerra
punica. Accolto a Roma con uno
splendido trionfo (201 a.C.),
a ricordo della vittoria
ricevette il soprannome di
Africano.
Censore
nel 199, più di una volta
princeps senatus e di nuovo
console nel 194, propugnò, in
contrasto con Catone il
Vecchio e il partito
conservatore, una politica
d'espansione in Oriente,
cosicché, quando scoppiò la
guerra con Antioco III di
Siria, fece pressione perché
il comando della spedizione
toccasse a suo fratello Lucio
e a lui fosse concesso di
accompagnarlo in qualità di
legato.
Di
fatto ne fu il capo, sia nella
preparazione diplomatica sia
nel predisporre il piano delle
operazioni belliche Il
successo gli arrise a Magnesia
al Sipilo anche se una
malattia lo tenne lontano dal
campo di battaglia. Ma dalla
vittoria, che con la pace di
Apamea (188 a.C.) procurò a
Roma il dominio in Oriente e
un enorme bottino, trasse alla
fine più motivo di amarezza
che di compiacimento.
Al
ritorno a Roma Scipione trovò
gli avversari politici
allarmati del crescente
prestigio suo e della sua
famiglia, più accaniti che
mai contro di lui e desiderosi
di rovinarlo, Il procedimento
fu quello comune di una
campagna di accuse di
corruzione nei riguardi suoi
e, soprattutto, del fratello
Lucio, per cui avrebbero
privatamente ricevuto danaro
da Antioco III e non avrebbero
reso conto di 500 talenti
dell'indennità di guerra
versata dal re. Come
conseguenza si ebbero
tentativi di incriminazione se
non veri processi (cosiddetti
« processi degli Scipioni »),
sui quali la tradizione
storica presenta molte lacune
e punti oscuri.
E'
accertato, peraltro, che negli
ultimi anni della vita,
sdegnato con i concittadini,
egli abbandonò Roma
(pronunciando, secondo Valerio
Massimo, la frase « Ingrata
patria non avrai le mie ossa
») per ritirarsi nella sua
villa di Literno dove,
cagionevole di salute, morì a
circa cinquant'anni.
Grandissimo
generale, a giudizio dello
stesso Annibale, che lo
avrebbe incontrato alla corte
di Antioco III, nel campo
politico, con il suo programma
filoellenico ed
espansionistico, non ebbe la
fortuna che forse si
aspettava.
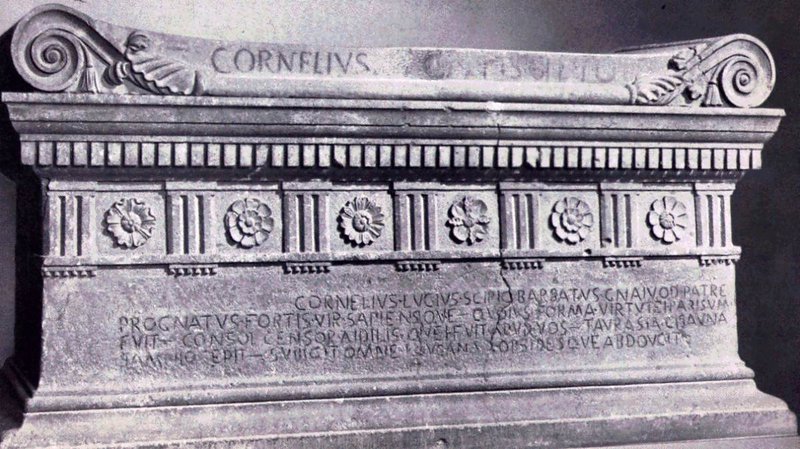
Publio
Cornelio Scipione Emiliano
Publio
Cornelio Scipione Emiliano
(189 ca. - 129 a.C.) (detto
anche Africano minore),
(Emiliano aveva valore di
patronimico, era infatti
figlio di Lucio Emilio Paolo
il Giovane e fu poi adottato
da Publio Cornelio Scipione,
il figlio di Publio Cornelio
Scipione Africano)
Generale
e politico romano. Grande
interprete della politica
imperiale mediterranea della
nobiltà romana, console nel
147 a.C., concluse
vittoriosamente la terza
guerra punica (149 a.C.-146
a.C.) distruggendo Cartagine
(146 a.C.) e la città
spagnola di Numanzia (133
a.C.).
Già
da giovane, all'età di 17
anni, riusci a conseguire dei
notevoli successi militari in
Macedonia assieme al padre.
Nel 151 a.C. divenne tribuno
militare e l'anno successivo
legato del console Lucullo.
Nel 153 a.C. tornò in Africa,
sempre nel ruolo di tribuno
militare, con la quarta
legione sotto il comando del
console Manio Manilio. Nel 147
a.C. raggiunse la carica di
console, condusse la guerra
contro Cartagine e, dopo un
assedio durato tre anni, la
sconfisse e la rase al suolo
nel 146 a.C. Successivamente
riuscì ad ottenere un secondo
consolato durante il quale
sconfisse i Celtiberi in
Spagna distruggendo la città
di Numanzia nel 133 a.C. A
seguito di questi successi gli
furono dati gli appellativi di
Africano Minore e di
Numantino.
A
Roma, grazie all'avvento di
Tiberio Gracco, fu approvata
la legge agraria, una legge
che prevedeva la spartizione
dei territori italici
conquistati dai romani al
popolo. Questi agri infatti
erano passati sotto il
possesso di importanti
famiglie patrizie, che
lasciavano il lavoro pesante
per la maggior parte a
schiavi. L'intenzione di
Tiberio Gracco era di spartire
i terreni alla Plebe, come già
previsto da una antica legge
in vigore a Roma ma non
rispettata.
Tiberio
Gracco venne assassinato lo
stesso anno dell'emanazione
della legge, ma i suoi seguaci
si facevano sentire,
specialmente tra la Plebe. Tra
i Patrizi occorreva dunque una
misura forte per contrastare i
voleri del popolo, tanto che
fu proposta una dittatura di
Scipione l'Emiliano in misura
straordinaria.
Le
dittature erano state molto
comuni nei secoli passati, e
consistevano nell'affidare ad
una sola persona per sei mesi
un comando illimitato, ma in
seguito divennero sempre più
rare, prima di Silla, infatti,
ci fu un periodo di quasi
cent'anni senza ricorso a
dittatori.
Scipione
riuscì a fermare
momentaneamente la legge
agraria, diventando molto
impopolare. Prima del suo
discorso per spiegare la
necessità dell'abrogazione
della legge fu ritrovato
morto. I motivi del suo
decesso rimangono tuttora
ignoti. Molti si divisero,
qualcuno pensò che si fosse
trattato di qualche
sostenitore dei Gracchi,
qualcun'altro si limitò a
pensare ad una morte naturale
(l'amico Lelio pensò anche ad
un suicidio motivato dalle
difficoltà trovate nel
soddisfare le esigenze degli
alleati italici e latini).
Cicerone attribuisce la causa
ai parenti, in particolare
alla moglie Sempronia, sorella
di Gaio Gracco e di Tiberio
Gracco.
Marco
Porcio Catone
Marco Porcio Catone (234 a.C.,
Tusculum nei pressi
dell'odierna Frascati - 149
a.C.) fu un uomo politico e
scrittore latino romano,
soprannominato "il
Censore", per
distinguerlo da Catone il
giovane (il suo bis-nipote).
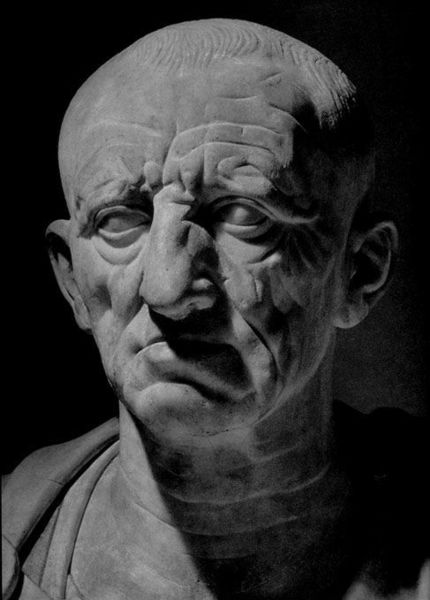 Nacque in un'
antica famiglia plebea, che si
era fatta notare per qualche
servizio militare, ma non
nobilitata dal fatto di aver
rifiutato le più importanti
cariche civili. Fu allevato,
secondo la tradizione dei suoi
antenati latini, perché
divenisse agricoltore, attività
alla quale egli si dedicò
costantemente quando non fu
impegnato nel servizio
militare. Ma, avendo attirato
l'attenzione di Lucio Valerio
Flacco, fu condotto a Roma, e
divenne successivamente
questore (204), edile (199),
pretore (198) e console nel
195 assieme al suo vecchio
protettore; nel 184 divenne
infine censore. Nacque in un'
antica famiglia plebea, che si
era fatta notare per qualche
servizio militare, ma non
nobilitata dal fatto di aver
rifiutato le più importanti
cariche civili. Fu allevato,
secondo la tradizione dei suoi
antenati latini, perché
divenisse agricoltore, attività
alla quale egli si dedicò
costantemente quando non fu
impegnato nel servizio
militare. Ma, avendo attirato
l'attenzione di Lucio Valerio
Flacco, fu condotto a Roma, e
divenne successivamente
questore (204), edile (199),
pretore (198) e console nel
195 assieme al suo vecchio
protettore; nel 184 divenne
infine censore.
Nel 191 a.C. ricoprì il ruolo
di tribuno militare nella
guerra contro Antioco di
Siria, e giocò un ruolo
importante nella battaglia
delle Termopili, che segnò la
fine dell'invasione seleucida
della Grecia.
La sua reputazione di soldato
era quindi consolidata; da
quel momento in poi egli
preferì servire lo stato a
casa, esaminando la condotta
morale dei candidati alle
cariche pubbliche e dei
generali sul campo. Pur non
essendo egli personalmente
coinvolto nel processo per
corruzione contro gli Scipioni
(l'Africano e l'Asiatico), fu
tuttavia lo spirito che animò
l'attacco contro di loro.
Persino Scipione l'Africano,
che si rifiutò di rispondere
all'accusa, trovò necessario
ritirarsi, auto-esiliandosi,
nella sua villa a Liternum.
L'ostilità di Catone risaliva
alla campagna d'Africa quando
discusse con Scipione per
l'eccessiva distribuzione del
bottino tra le truppe, e la
vita sfarzosa e stravagante
che quest'ultimo conduceva.
Catone si oppose inoltre al
diffondersi della cultura
ellenistica, che egli riteneva
minacciasse di distruggere la
sobrietà dei costumi del vero
romano. Fu nell'esercizio
della carica di censore che
questa sua determinazione fu
più duramente esibita, e il
motivo dal quale gli derivò
il suo celebre soprannome.
Revisionò con inflessibile
severità la lista dei
senatori e degli equites,
cacciando da ogni ordine
coloro che riteneva indegni,
sia per quanto riguarda la
moralità sia per la mancanza
dei requisiti economici
previsti. L'espulsione di
Lucio Quinto Flaminio per
ingiustificata crudeltà fu un
esempio della sua rigida
giustizia.
La sua lotta contro il lusso
fu assai serrata. Impose una
pesante tassa sugli abiti e
gli ornamenti personali,
specialmente delle donne, e
sui giovani schiavi comprati
come concubini o favoriti
domestici (quindi superflui).
Nel 181 a.C. appoggiò la lex
Orchia (secondo altri egli
prima si oppose alla sua
introduzione, e
successivamente alla sua
abrogazione), la quale
prescriveva un limite al
numero di ospiti in un
ricevimento, e nel 169 a.C. la
lex Voconia, uno dei
provvedimenti che intendevano
impedire l'accumulo di
un'eccessiva ricchezza nelle
mani delle donne.
Riguardo le altre questioni
egli fece riparare gli
acquedotti, pulire le
fognature, impedì a soggetti
privati di deviare le acque
pubbliche per il loro uso
personale, ordinò la
demolizione di edifici che
ostruivano le vie pubbliche, e
costruì la prima basilica nel
foro vicino alla Curia. Aumentò
inoltre la somma dovuta allo
stato dai pubblicani per il
diritto di riscuotere le tasse
e allo stesso tempo diminuì
il prezzo contrattuale per la
realizzazione di lavori
pubblici.
Dalla data della sua carica di
censore (184 a.C.) alla sua
morte nel 149 a.C., Catone non
occupò nessun'altra carica
pubblica, ma continuò a
distinguersi in senato come
tenace oppositore ad ogni
nuova influenza. Fu assai
disgustato, assieme a molti
altri dei romani più
conservatori, alla diffusione
dei riti misterici dei
Baccanali, che egli attribuì
all'influenza negativa dei
costumi greci; e perciò
sollecitò con veemenza
l'espulsione dei filosofi
greci, che erano giunti come
ambasciatori da Atene, sulla
base della pericolosa
influenza che avevano le idee
diffuse da questi.
Catone provava ripugnanza per
i medici, che erano
principalmente greci. Ottenne
il rilascio di Polibio, lo
storico, e dei suoi compagni
prigionieri, chiedendo
sprezzante perché il senato
non avesse niente di più
importante da discutere se
qualche greco doveva morire a
Roma o nella loro terra. Non
era ancora ottantenne che,
secondo quanto dicono le fonti
biografiche, ebbe il suo primo
contatto con la letteratura
greca, sebbene dopo aver
esaminato i suoi scritti è
verosimile ritenere che possa
aver avuto un contatto con le
opere greche per gran parte
della sua vita.
Il suo ultimo impegno pubblico fu di spronare
i suoi compatrioti verso la
terza guerra punica e la
distruzione di Cartagine. Nel
157 a.C. fu uno dei delegati
mandati a Cartagine per
arbitrare tra i cartaginesi e
Massinissa, re di Numidia. La
missione fu fallimentare e i
commissari ritornarono a casa.
Ma Catone fu colpito dalle
prove della prosperità dei
cartaginesi a tal punto da
convincerlo che la sicurezza
di Roma dipendesse dalla
distruzione totale di
Cartagine.
Per Catone la vita individuale
era un continuo
auto-disciplinarsi, e la vita
pubblica era la disciplina dei
molti. Egli riteneva il
singolo pater come il
principio della famiglia, e la
famiglia come il principio
dello stato. Attraverso una
rigida organizzazione del suo
tempo egli realizzò un'enorme
quantità di lavoro; pretese
inoltre la medesima
applicazione dai suoi
dipendenti, e si dimostrò un
marito e un padre severo, un
inflessibile e crudele
padrone. Ci fu apparentemente
poca differenza, nel modo in
cui trattava sua moglie e i
suoi schiavi; il suo orgoglio
soltanto lo indusse a prestare
una più calorosa attenzione
verso i figli.
Catone forse merita ancora più
riguardo come letterato che
come statista o soldato. Egli
fu un annalista, il primo
prosatore romano di una
qualche importanza, e il primo
autore di una storia di Roma
in latino. Il suo trattato
sull'agricoltura è l'unico
suo lavoro che è ci è
pervenuto integro, anche se
non c'è accordo se l'opera
che possediamo è l'originale
o una revisione postuma.
Contiene una raccolta di
regole per il buon padre di
famiglia, consegnandoci molte
informazioni curiose sulle
abitudini domestiche dei
romani della sua epoca. La sua
opera più importante, le
Origines, organizzata in sette
libri, racconta la storia di
Roma dalla fondazione fino ai
suoi tempi. Fu chiamata così
per il secondo e il terzo
libro, che descrivono la
nascita e lo sviluppo delle
diverse città italiane.
Alcuni sostengono che se non
fosse stato per il suo impatto
sulla prosa latina, la lingua
latina sarebbe potuta essere
sostituita da quella greca.
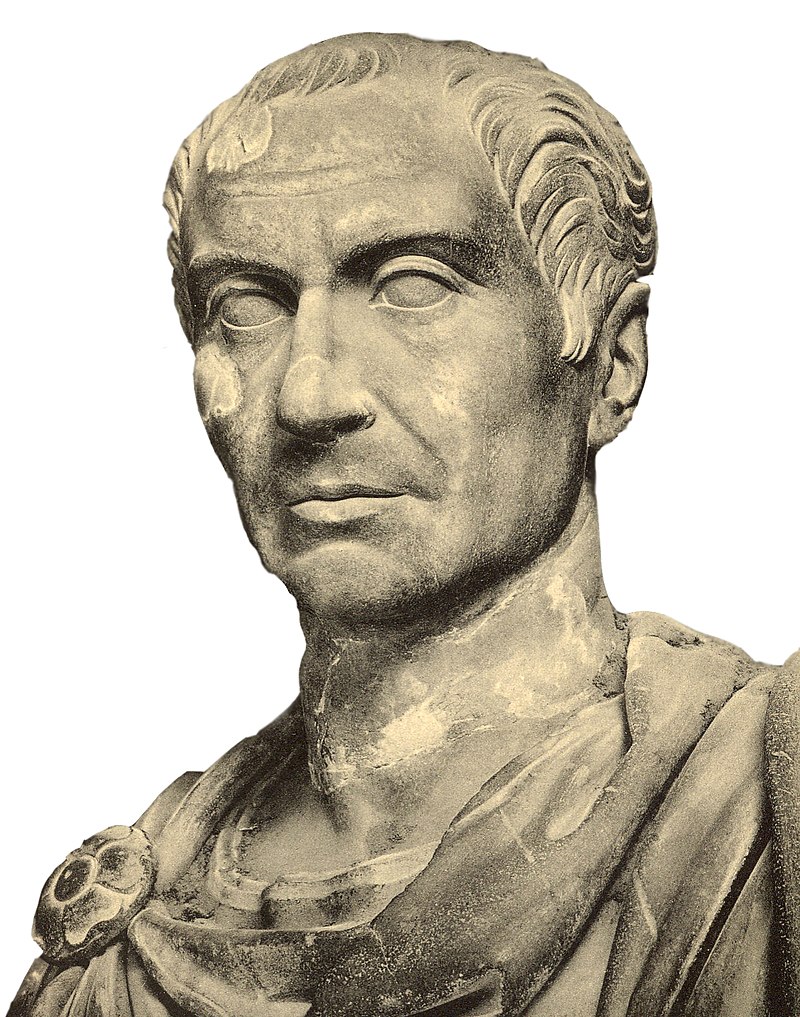 Caio
Giulio Cesare
Caio
Giulio Cesare, (Como, 13
luglio 100 a.C. – Nicomedia, 15
marzo 44 a.C.) è stato
un politico, generale e
scrittore latino nonché
personalità fra le più
influenti e celebri della
storia al punto di essere
chiamato tanto Giulio Cesare
quanto semplicemente Cesare,
lasciando la lettura di tutti
i nomi agli altri Cesari della
storia Romana.
Ebbe
un ruolo cruciale nella
transizione del sistema di
governo dalla forma
repubblicana a quella
imperiale. Le sue conquiste
militari in Gallia Transalpina
estesero il dominio della
Repubblica fino all'Atlantico
e al Reno. Portò gli eserciti
romani ad invadere per la
prima volta la Britannia, nel
55 a.C..
La
spartizione del potere con
Gneo Pompeo Magno e Marco
Licinio Crasso (Primo
Triumvirato) segnò l'inizio
della sua ascesa. Alla morte
di Crasso (Carre, 53 a.C.),
Cesare si scontrò con Pompeo
e la fazione degli Optimates
per il controllo dello stato.
Di
ritorno dalla Gallia, guidando
le sue legioni attraverso il
Rubicone, Cesare scatenò nel
49 a.C. la guerra civile, che
lo consacrò capo indiscusso
di Roma: sconfisse Pompeo a
Farsalo (48 a.C.) e
successivamente gli altri
Ottimati, tra cui Catone
Uticense, in Africa e in
Spagna.
Divenuto
dittatore a vita, diede inizio
a un processo di radicale
riforma della società e del
governo di Roma,
riorganizzando e
centralizzando la burocrazia
repubblicana.
Il
suo operato provocò la
reazione dei conservatori,
finché un gruppo di senatori
capeggiati da Marco Giunio
Bruto non cospirò contro di
lui, uccidendolo, alle Idi di
Marzo del 44 a.C.. Nel 42
a.C., appena due anni dopo il
suo assassinio, il Senato lo
santificò ufficialmente
elevandolo a divinità.
L'eredità riformatrice e
storica di Cesare venne quindi
raccolta da Ottaviano Augusto,
suo nipote e figlio adottivo.
BIOGRAFIA
-
Giulio Cesare nacque a Roma da
un'antichissima e nota
famiglia patrizia, la Gens
Julia o Iulia, figlio del
principe troiano Enea, secondo
il mito figlio a sua volta di
Venere. Al culmine del suo
potere, nel 45 a.C., Cesare
per sottolineare la sua
discendenza dalla dea dedicò
a Venere Genitrice un tempio
nel nuovo Foro da lui fatto
costruire.
Nonostante
le aristocratiche origini, la
famiglia di Cesare non era
ricca per gli standard della
nobiltà romana; ciò
rappresentò inizialmente un
serio ostacolo alla sua
carriera politica e militare;
inoltre, negli anni della
giovinezza di Cesare, suo zio
Gaio Mario era stato
dichiarato nemico della
Repubblica. Suo padre era Gaio
Giulio Cesare il Vecchio, la
cui sorella Giulia aveva
sposato Gaio Mario; la madre
era Aurelia Cotta, proveniente
da una notabile famiglia che
aveva dato a Roma numerosi
consoli. La famiglia viveva in
una modesta casa nella
Suburra, dove il giovane
Giulio Cesare fu educato da un
illustre grammatico nativo
della Gallia, Marco Antonio
Gnifone.
Cesare
trascorse il suo periodo di
formazione in un epoca
tormentata da gravi disordini.
Mitridate VI, Re del Ponto,
minacciava le province
orientali; contemporaneamente,
La Guerra sociale era in corso
a Roma, con la città divisa
in due fazioni contrapposte:
gli Optimates, favorevoli al
potere aristocratico, e i
Populares o democratici, che
sostenevano la possibilità di
rivolgersi direttamente
all'elettorato. Pur se di
nobili origini, fin
dall'inizio della sua carriera
Cesare si schierò dalla parte
dei Populares, scelta
sicuramente condizionata dalle
convinzioni di suo zio Gaio
Mario, capo dei Populares e
rivale di Lucio Cornelio
Silla, sostenuto da
aristocrazia e Senato.

Nell'86
a.C. il padre e lo zio Gaio
Mario morirono, e nell'84
Cesare ripudiò la sua
promessa sposa Cossuzia per
sposare Cornelia, figlia di
Lucio Cornelio Cinna, alleato
e amico di Gaio Mario. Il
nuovo legame con una famiglia
notoriamente schierata con i
popolari, oltre alla parentela
con Mario, causarono problemi
non indifferenti al giovane
Cesare negli anni della
dittatura di Silla.
Questi
cercò di ostacolarne in tutti
i modi le ambizioni, bloccando
la sua nomina a flamen dialis;
la situazione poi si aggravò
quando il dittatore, avuta la
meglio su Mitridate VI, rientrò
in Italia e sconfisse i
seguaci di Mario nella
Battaglia di Porta Collina,
l'82 a.C..
Ormai
capo indiscusso di Roma, Silla
si autoproclamò dittatore a
vita, e iniziò ad eliminare i
suoi avversari politici; ordinò
a Cesare di divorziare da
Cornelia, poiché non era
patrizia, ma Cesare rifiutò e
temendo per la sua vita lasciò
Roma, prima ritirandosi in
Sabina e poi, raggiunta la
giusta età, partendo per il
servizio militare in Asia,
come legato di Marco Minucio
Termo.
Fu
Minucio ad ordinare al giovane
legato di recarsi presso la
corte di Nicomede, sovrano del
piccolo stato della Bitinia.
In ogni modo, come legato di
Minucio durante l'assedio di
Mitilene, Cesare partecipò
per la prima volta ad uno
scontro armato, distinguendosi
per il suo coraggio, tanto che
gli fu conferita la corona
civica, che veniva conferita
al primo che attraversasse le
mura di una città in
battaglia. In seguito alle
riforme promulgate da Silla a
chi fosse stata conferita una
corona militare sarebbe stato
garantito l'accesso al senato.
Rientrato
a Roma Minucio, Cesare rimase
in Asia Minore, partecipando
come patrizio romano a diverse
operazioni militari che si
svolsero in quella zona, come
l'azione contro i pirati sotto
il comando di Servilio
Isaurico.
Dopo
due anni di potere assoluto,
Silla si dimise da dittatore
ristabilendo il governo
consolare. Cesare rientrò a
Roma solo quando ebbe notizia
della morte di Silla (78
a.C.), e il suo ritorno
coincise con il tentativo di
ribellione anti-silliana
capeggiato da Marco Emilio
Lepido e bloccato da Gneo
Pompeo. Cesare, non fidandosi
delle capacità di Lepido, non
partecipò alla ribellione, e
iniziò invece a dedicarsi
alla carriera forense come
pubblico accusatore e quella
politica come esponente dei
popolari e nemico dichiarato
degli ottimati.
Cesare
sostenne l'accusa contro Gneo
Cornelio Dolabella per
concussione e contro Gaio
Antonio Ibrida per estorsione
nei confronti dei Greci;
entrambi gli accusati erano
membri influenti del partito
degli ottimati e in entrambi i
casi, anche se l'accusa fu
portata con dovizia, perse le
cause; tuttavia in questo modo
si accreditò come importante
rappresentante tra i popolari,
anche se l'esito per lui
negativo dei processi lo
convinse a lasciare Roma una
seconda volta. Mentre si
recava a Rodi per i suoi studi
di filosofia fu rapito dai
pirati, e egli stesso convinse
i rapitori a chiedere un
riscatto molto alto, in modo
da aumentare così il suo
prestigio a Roma. Dopo la
liberazione organizzò una
spedizione, catturò i pirati
e li fece condannare a morte
per crocifissione.
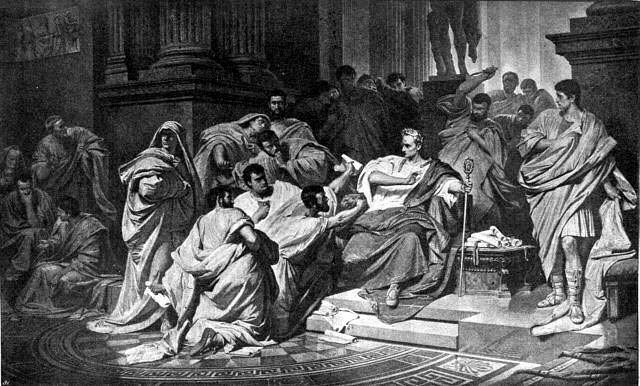 Dopo
aver retto la carica di
questore in Spagna (69 a.C.),
Cesare fu eletto edile curule
nel 65 a.C., pontefice massimo
nel 63 a.C. e pretore nel 62
a.C.. Aderì al programma
antioligarchico di Catilina e
sostenne il suo progetto di
congiura, ma non ne rimase
danneggiato. Dopo
aver retto la carica di
questore in Spagna (69 a.C.),
Cesare fu eletto edile curule
nel 65 a.C., pontefice massimo
nel 63 a.C. e pretore nel 62
a.C.. Aderì al programma
antioligarchico di Catilina e
sostenne il suo progetto di
congiura, ma non ne rimase
danneggiato.
Cesare
era stato anche al servizio
del generale Pompeo, con il
quale avrebbe più tardi
diviso il potere. Dopo la
morte della moglie Cornelia 68
a.C., sposò Pompea, nipote di
Silla, per poi divorziare da
lei nel 62 a.C. in seguito a
uno scandalo. Nel 61 a.C.
Cesare fu governatore della
provincia della Spagna
ulteriore, e nel 60 a.C. fu
eletto console.
Nel
59 a.C., l'anno del suo
consolato, Cesare formò una
alleanza strategica con due
altri capi politici, Crasso e
Pompeo. Crasso era l'uomo più
ricco di Roma; Pompeo era in
quel momento il generale con
più successi alle spalle.
Cesare portò al servizio
dell'alleanza la sua popolarità
politica e il suo prestigio.
Pompeo sposò Giulia, la
figlia di Cesare. Questo
accordo non ufficiale fu poi
chiamato dagli storici Primo
Triumvirato.
Nel
59 a.C. fu anche governatore
della Gallia Narbonese, della
Gallia Cisalpina e
dell'Illiria. Come Proconsole
in Gallia (58 a.C. - 49 a.C.)
ingaggiò la guerra contro
vari popoli, sconfiggendo gli
Elvezi nel 58 a.C., i Belgi ed
i Nervii nel 57 a.C. ed i
Veneti nel 56 a.C.. Nel 55
a.C. tentò la prima invasione
della Britannia, e nel 52 a.C.
sconfisse una coalizione di
Galli guidati da
Vercingetorige. Il Comandante
gallico si trovava assediato
ad Alesia, capitale del suo
regno, mentre Cesare lo
attaccava cingendo la città
con una robusta palizzata. Nel
frattempo un immenso esercito
gallico si era radunato e
marciava su Alesia per rompere
l'assedio, ma Cesare, avendolo
saputo, eresse una seconda
palizzata per coprirsi le
spalle. I Galli attaccanti
furono in questo modo
duramente sconfitti e Cesare
assicuro' a Roma il dominio
sull'intera regione.
Dopo
la morte di Crasso, ucciso nel
53 a.C. durante la guerra
contro i Parti, si aprì una
spaccatura fra Cesare e
Pompeo, ingigantita anche
dalla morte di Giulia, figlia
di Cesare nonché moglie di
Pompeo, in seguito al parto.
Invitato nel 50 a.C. dal
Senato a sciogliere il suo
esercito di ritorno dalla
Gallia, Cesare rifiutò
provocando lo scoppio della
guerra civile. Un indovino
allertò Cesare sulla sua
futura sorte: gli fu
raccomandata prudenza sul
Rubicone, il fiume che allora
segnava il confine del pomerio
e dei territori controllati da
Roma e che un generale non
poteva passare in armi.
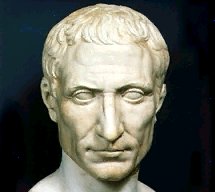 Cesare
varcò il fiume il 10 gennaio
del 49 a.C., e inseguì Pompeo
fino a Brindisi, sperando di
poter rimettere in piedi
un'alleanza ormai vecchia di
dieci anni. Tuttavia Pompeo lo
evitò e Cesare compì allora
una sorprendente marcia di 27
giorni sino in Spagna, per
incontrarvi il luogotenente di
Pompeo. Successivamente si
diresse di nuovo verso
oriente, per sfidare Pompeo in
Grecia. Il 10 luglio del 48
a.C. evitò di poco una
catastrofica sconfitta a
Dyrrhachium (Durazzo), mentre
la battaglia decisiva ebbe
luogo a Farsalo, il 9 agosto
del 48: Cesare sconfisse il
suo ex alleato e amico e fu
quindi nominato console per 5
anni, mentre Pompeo fuggì in
Egitto, dove fu poi
assassinato da un sicario del
re Tolomeo XIII. Cesare
varcò il fiume il 10 gennaio
del 49 a.C., e inseguì Pompeo
fino a Brindisi, sperando di
poter rimettere in piedi
un'alleanza ormai vecchia di
dieci anni. Tuttavia Pompeo lo
evitò e Cesare compì allora
una sorprendente marcia di 27
giorni sino in Spagna, per
incontrarvi il luogotenente di
Pompeo. Successivamente si
diresse di nuovo verso
oriente, per sfidare Pompeo in
Grecia. Il 10 luglio del 48
a.C. evitò di poco una
catastrofica sconfitta a
Dyrrhachium (Durazzo), mentre
la battaglia decisiva ebbe
luogo a Farsalo, il 9 agosto
del 48: Cesare sconfisse il
suo ex alleato e amico e fu
quindi nominato console per 5
anni, mentre Pompeo fuggì in
Egitto, dove fu poi
assassinato da un sicario del
re Tolomeo XIII.
Non
contento del vantaggio
guadagnato, Cesare si recò
egli stesso in Egitto, e qui
si impegnò per sostenere
Cleopatra, che per la legge
egiziana divenne sua moglie e
dalla quale ebbe un figlio,
(Cesarione, poi fatto uccidere
da Ottaviano Augusto). Quindi
sconfisse successivamente gli
ultimi sostenitori di Pompeo a
Tapso (46 a.C.) e Munda (45
a.C.).
Dopo
esser stato nominato dictator
per 10 anni nel 46 a.C.,
divenne l'anno seguente
dittatore e Console a vita e
fu chiamato Padre della
Patria. Sempre nel 46, nella
sua qualità di Pontefice
Massimo, promulgò il
calendario giuliano, basato
sul ciclo delle stagioni ed
elaborato dall'astronomo
egiziano Sosigene di
Alessandria. Esso fu da allora
il calendario ufficiale di
Roma e dei suoi domini (la
Chiesa ortodossa tuttora usa
il calendario giuliano come
proprio calendario liturgico).
Il mese di quintilis fu
ribattezzato iulius in suo
onore.
Furono
erette sue statue a fianco di
quelle degli antichi re ed
ebbe un trono d'oro in Senato
ed in Tribunato. Nella Vita di
Augusto, Nicolao Damasceno
racconta che una mattina su
una di queste statue venne
posto un diadema, ritenuto
simbolo di regalità e di
schiavitù. Due tribuni della
plebe, Lucio e Gaio,
sconcertati, fecero togliere
il diadema e accusarono Cesare
di volersi proclamare re di
Roma, ma questi convocò
immediatamente il Senato e
accusò a sua volta i tribuni
di aver posto il diadema per
screditarlo: i due vennero
cacciati e sostituiti.
Ancora
più importante è l'episodio
dei Lupercali, una festività
romana durante la quale Marco
Antonio mise un diadema sulla
testa di Cesare. Questi lo
rifiutò e lo gettò via, ma
Antonio lo ripose per una
seconda volta. Il popolo
allora applaudì e lo salutò
dicendo "Salve,
re!". In risposta Cesare
ordinò di mettere il diadema
sulla testa di Giove Ottimo
Massimo, la maggiore divinità
romana.
Cesare
fu assassinato in Campo Marzio
nei pressi del Teatro di
Pompeo, (dove si riuniva il
Senato dopo che la sua sede
era andata distrutta in un
incendio), alle Idi di marzo
(15 marzo) del 44 a.C.. Fu
accoltellato da un gruppo di
cospiratori nostalgici della
Repubblica, che mal
sopportavano il suo potere
assoluto e lo accusavano di
avere ambizioni monarchiche.
Fra i cospiratori c'era Bruto,
forse suo figlio naturale; il
secondo attentatore eccellente
fu Gaio Cassio Longino, altro
repubblicano che come Bruto,
aveva ottenuto da Cesare la
grazia.
Dopo
la sua morte, scoppiò una
lotta fra i suoi nipoti per
accaparrarsi il potere: il
figlio adottivo Ottaviano, il
suo luogotenente Marco
Antonio, ed i suoi assassini
Bruto e Cassio. Ottaviano in
seguito prevalse e divenne il
primo Imperatore Romano, con
il nome di "Cesare
Augusto".

Tiberio
Sempronio Gracco
Tiberio Sempronio Gracco
(Roma, 163 a.C. - ivi 132
a.C.). Figlio maggiore
dell'omonimo Tiberio Sempronio
Gracco e di Cornelia, figlia
di Publio Cornelio Scipione
Africano.
Poco più che fanciullo fece
parte dei sacerdoti Auguri
grazie anche all'approvazione
dell'influente senatore Appio
Claudio che poco più tardi
gli darà in moglie la figlia
Claudia. Nel 146 a.C. all'età
di diciassette anni militò in
Libia sotto il comando del
cognato Scipione Emiliano.
Nove anni dopo al suo ritorno
a Roma venne eletto questore e
dovette partire per la guerra
contro i Numantini sotto il
comando del console Gaio
Mancino.
L'esito della guerra fu
disastroso e una volta messi
in fuga i Romani i nemici si
dichiararono disposti a
trattare soltanto con Tiberio
Gracco, memori delle gesta del
padre che in passato era stato
loro alleato. Accettò di
trattare con i Numantini anche
per recuperare le il diario e
le tavole del suo ufficio di
questore che erano state
rubate nel saccheggio
successivo ala fuga romana.
Tornato a Roma fu accusato e
biasimato per il suo gesto, ma
il popolo e le famiglie dei
soldati scampati al massacro
lo acclamarono come un
salvatore.
Fu eletto tribuno della plebe
nel 133 a.C. e la sua prima
vera iniziativa fu quella di
compilare una legge, con
l'aiuto del pontefice massimo
Crasso e del console Muzio
Scevola, per la
ridistribuzione delle terre
del suolo italico, usurpate
dai ricchi ai più poveri e
offerte ai forestieri per la
lavorazione. La legge limitava
l'occupazione delle terre
dello stato a 125 ettari e
riassegnava le terre eccedenti
ai contadini in rovina. Una
famiglia nobile poteva avere
500 iugeri di terreno, più
250 per ogni figlio, ma non più
di 1000; I terreni confiscati
furono distribuiti in modo che
ogni famiglia della plebe
contadina avesse 37 iugeri.
Il provvedimento era sostenuta
dal popolo anche attraverso
scritte sui maggiori monumenti
e sulle pareti dei portici di
Roma fu ricusata sdegnosamente
dai ricchi che tentarono
inutilmente di incitare una
rivolta contro Tiberio.
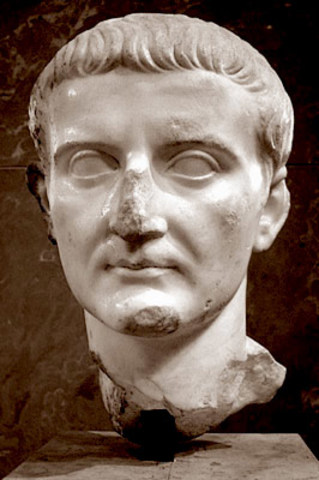 I
possidenti si appoggiarono
allora ad un altro tribuno
della plebe, il giovane Marco
Ottavio, che accettò di porre
il veto alla legge agraria.
Tiberio in risposta al veto
scrisse una legge ancora più
restrittiva per i possidenti
terrieri e iniziò così una
sfida tra i due tribuni che
quotidianamente si cimentavano
in senato in dure sfide
oratorie. Con un nuovo editto
proibì ai magistrati di
intraprendere affari sino alla
votazione della legge e questi
come risposta si dimisero
dalle loro cariche arrivando
anche ad assoldare sicari per
far uccidere Tiberio. I
possidenti si appoggiarono
allora ad un altro tribuno
della plebe, il giovane Marco
Ottavio, che accettò di porre
il veto alla legge agraria.
Tiberio in risposta al veto
scrisse una legge ancora più
restrittiva per i possidenti
terrieri e iniziò così una
sfida tra i due tribuni che
quotidianamente si cimentavano
in senato in dure sfide
oratorie. Con un nuovo editto
proibì ai magistrati di
intraprendere affari sino alla
votazione della legge e questi
come risposta si dimisero
dalle loro cariche arrivando
anche ad assoldare sicari per
far uccidere Tiberio.
Il giorno nel quale il popolo
fu chiamato a votare i nemici
di Tiberio asportarono le urne
creando gran tumulto, ma lo
scontro fu evitato anche
grazie alla mediazione dei
consolari Manlio e Fulvio che
lo convinsero a rimettersi al
senato. La discussione in
assemblea fu però infruttuosa
e così Tiberio fu costretto a
proporre la destituzione di
Ottavio che il giorno dopo fu
approvata dal concilio della
plebe portando così anche
all'approvazione della legge;
ma il clima era sempre
infuocato e nonostante i gesti
distensivi di Tiberio nei
confronti dell'avversario,
Ottavio fu a fatica sottratto
dalle grinfie della folla
inferocita.
Sorvegliare l'equità della
divisione spettò, oltre allo
stesso Tiberio, al suocero
Appio Claudio e al fratello
Gaio Gracco. Intanto
l'opposizione dei più ricchi
si faceva sempre più
estenuante e andava dal
rifiuto di costruire un
edificio pubblico preposto
alla causa della legge agraria
fino all'avvelenamento di un
amico di Tiberio.
alla sua morte il re di
Pergamo Attalo III Filopatore
lasciò in eredità le sue
terre e le sue ricchezze al
popolo romano. Tiberio propose
che il suo patrimonio fosse
destinato all'acquisto di
sementi e attrezzi agricoli
per i nuovoi proprietari e che
le nuove terre fossero
anch'esse divise tra la plebe.
Intanto i suoi amici pensarono
di farlo candidare nuovamente
al tribunato e perciò doveva
in tutti i modi accattivarsi
in maniera esponenziale i
favori della plebe. Propose
leggi sull'abrogazione del
servizio militare per lungo
tempo, sulla concessione del
diritto all'appello contro
tutti i magistrati e
sull'ingresso in senato di un
maggior numero di cavalieri.
Il giorno della votazione non
disponeva però della
maggioranza ed i suoi alleati
fecero ostruzionismo fino al
rinvio dell'assemblea al
giorno dopo: Tiberio scoppiò
a piangere per paura di
possibili attentati alla sua
persona suscitando commozione
nel popolo che si offrì di
sorvegliare la sua casa
durante la notte.
La mattina seguente al
Campidoglio, dove era radunato
il popolo per votare, c'era un
tale rumore che non si
riusciva a parlare. Tiberio fu
informato che i suoi nemici
avevano un piano per uccidere
il console Muzio Scevola e
negli sviluppi dell'assemblea
cominciò a diffondersi il
panico, con i sostenitori di
Tiberio che impugnarono le
lance come per difendersi.
I nemici di Tiberio corsero al
Senato e denunciarono il
fatto: il senatore Nasica
esortò i suoi a far
rispettare la legge e i suoi
partigiani marciarono armati
fino al Campidoglio. Ne seguì
una carneficina nella quale
persero la vita oltre trecento
cittadini romani e tra loro lo
stesso Tiberio. Il suo
cadavere fu gettato nel Tevere
e i suoi amici condannati a
morte o esiliati senza
processo.
Il senato non si oppose però
alla spartizione delle terre
ed elesse come nuovo esecutore
il suo parente Publio Crasso.
Nasica fu ripetutamente offeso
e minacciato ed il senato
decise di mandarlo in Asia per
precauzione. La sua opera sarà
poi continuata dal fratello
Gaio.
Gaio
Sempronio Gracco
Gaio
Sempronio Gracco
(154 a.C. - 121 a.C.),
fratello di Tiberio, eletto
tribuno della plebe, riprese
l'opera di riforma sociale
intrapresa dal fratello
maggiore nel 123 a.C., 10 anni
dopo.
Per
ottenere il consenso della
plebe cittadina e degli
equites fece approvare alcune
leggi, di cui la più
importante prevedeva che lo
Stato comprasse il grano dai
privati per rivenderlo a
prezzi minori, e per rendere
possibile ciò propose di
sfruttare la provincia d'Asia
con addetti alla riscossione
delle tasse. Concepì così
una riforma di più ampio
respiro proponendo leggi che
prevedevano il consolidamento
del potere tribunizio,
l'eliminazione dei tribunali
speciali, l'istituzione di
colonie, la concessione della
cittadinanza romana ai latini
e agli italici la cittadinanza
latina, le leggi frumentarie.
Dopo
esser stato rieletto nel 122
a.C. i patrizi gli
contrapposero nel 121 a.C.
Livio Druso che riuscì con la
demagogia a sobillare il
popolo provocando disordini.
Grazie a questi disordini, il
Senato proclamò il
"Senatum Consultum
Ultimum", durante il
quale i magistrati potevano
prendere qualsiasi decisione.
Capendo che poteva essere
messo a morte da un momento
all'altro e non riuscendo a
farsi eleggere per la terza
volta tribuno, Gaio Sempronio
si fece uccidere da uno
schiavo nei pressi del bosco
sacro della ninfa Furrina.

Caio
Mario
Mario, generale
e uomo politico romano, nacque nel 157 a.C. ad Arpino nel Lazio
meridionale, precisamente
nella frazione che ancora oggi
porta il suo nome: Casamari.
Nato
da oscura famiglia, ancora
legata ai parsimoniosi e duri
costumi degli agricoltori
latini, Mario non ebbe modo di
avvicinarsi alla cultura
romana né tantomeno a quella
greca. Ma il suo coraggio e le
sue doti militari lo imposero
all'attenzione di Scipione
l'Emiliano durante il suo
servizio in Spagna, che lo
indicò suo degno successore.
Con l'aiuto della gens Metella
divenne tribuno della plebe e
durante questa carica rivelò
le sue simpatie per la causa
popolare.
Dapprima
combatté in Spagna sotto il
generale Scipione Emiliano;
nel 119 a.C. diventò tribuno
della plebe e si sposò con
una giovane appartenente alla
gens Giulia. Pretore nel 115
a.C., ritornò in Spagna per
condurre una campagna contro i
briganti che terrorizzavano il
paese. Accompagnò poi il
generale romano Quinto Cecilio
Metello in Africa (109 a.C.);
due anni dopo, eletto console,
ebbe il comando della guerra
contro Giugurta, re di
Numidia, che catturò con
l'aiuto del proquestore Lucio
Cornelio Silla nel 106 a.C.
Dopo
aver sottomesso la Numidia,
Mario diventò console per la
seconda volta nel 104 a.C.;
ebbe poi il comando nella
guerra contro le tribù
germaniche dei teutoni e dei
cimbri: sconfisse i primi ad
Aquae Sextiae (oggi
Aix-en-Provence) nel 102 a.C.
e i secondi l'anno dopo presso
Vercelli. Considerato il
salvatore della patria, nel
100 a.C venne riconfermato
nella carica di console (per
la sesta volta consecutiva).
Quando
a Silla, divenuto console,
venne affidata la guida della
guerra contro il potente re
Mitridate VI il Grande nell'88
a.C., Mario, già da tempo in
conflitto con il collega di
rango patrizio, cercò di
privarlo dell'incarico. Scoppiò
allora la guerra civile che
oppose le due fazioni in cui
si divise l'esercito romano:
quella "popolare",
sostenitrice di Mario, e
quella "patrizia" di
Silla. In una prima fase
prevalse Silla, che costrinse
l'avversario a fuggire
dall'Italia e gli subentrò
come comandante in Asia
Minore. Successivamente il
conflitto volse a favore di
Mario, grazie a Lucio Cornelio
Cinna che si schierò con lui
e organizzò tumulti a Roma.
Sulla capitale si diressero le
truppe di Mario e Cinna che,
dopo la resa della città,
massacrarono gli aristocratici
della fazione di Silla. I due
vincitori si proclamarono
consoli (86 a.C.) ma, pochi
giorni dopo, Mario morì.
Lucio
Cornelio Silla
Silla,
Lucio Cornelio (Roma 138 -
Cuma 78 a.C.), uomo politico e
generale romano, dittatore
dall'82 al 79 a.C. Membro
della famiglia patrizia dei
Cornelii, Silla intraprese la
carriera militare nel 107 come
questore di Caio Mario, nella
guerra giugurtina (111-106) in
Africa, riuscendo a farsi
consegnare da Bocco I, re di
Mauretania (che regnò dal 111
all'80), il re di Numidia,
Giugurta.
 Questo
episodio pose termine alla
guerra, ma fece nascere una
rivalità tra Mario e Silla;
questi, comunque, rimase
sottoposto al primo fino al
103, partecipando anche alla
campagna contro i Cimbri e i
Teutoni (104-101). Nel 93
divenne pretore e l'anno
seguente propretore in
Cilicia. Dopo aver vinto la
guerra sociale (90-88) che
aveva contrapposto i Romani
agli alleati italici, che
rivendicavano la parità
giuridica, Silla divenne
console; in quello stesso anno
(88) fu investito del comando
della guerra contro Mitridate
VI, re del Ponto. Questo
episodio pose termine alla
guerra, ma fece nascere una
rivalità tra Mario e Silla;
questi, comunque, rimase
sottoposto al primo fino al
103, partecipando anche alla
campagna contro i Cimbri e i
Teutoni (104-101). Nel 93
divenne pretore e l'anno
seguente propretore in
Cilicia. Dopo aver vinto la
guerra sociale (90-88) che
aveva contrapposto i Romani
agli alleati italici, che
rivendicavano la parità
giuridica, Silla divenne
console; in quello stesso anno
(88) fu investito del comando
della guerra contro Mitridate
VI, re del Ponto.
Tuttavia
Mario, che era a capo dei
popolari (il partito della
plebe) e da tempo nemico di
Silla, capo degli ottimati (il
partito degli aristocratici),
cercò di privarlo del
comando. Silla marciò allora
su Roma dando inizio alla
guerra civile. Proscritto
Mario stesso, Silla partì per
l'Asia Minore, dove vinse
Mitridate nell'83. Ritornato a
Roma, debellò la potente
fazione mariana, che nel
frattempo si era ricostituita:
proclamatosi dittatore (82-79)
fece condannare a morte o
all'esilio molti sostenitori
di Mario. Riformò la
costituzione, restituendo il
potere ai senatori e agli
aristocratici, e impose severi
controlli sull'operato dei
tribuni e di altri magistrati.
Riorganizzò i tribunali,
aumentando il numero delle
quaestiones perpetuae,
tribunali speciali permanenti
incaricati di giudicare
singoli specifici delitti. Nel
79 rinunciò alla dittatura e
si ritirò in Campania, dove
morì.
Gneo Pompeo Magno
Gneo Pompeo Magno
è il più noto personaggio
della gens Pompea (106 a.C.,
Picenum - 48 a.C., Egitto).
Generale e politico Romano,
figlio di Gneo Pompeo
Strabone, fu prima alleato e
poi avversario di Cesare.
Pompeo Magno nacque il 28
settembre 106 a.C., come
figlio di Gneo Pompeo
Strabone, un uomo estremamente
ricco proveniente dal Piceno.
Questo ramo della famiglia dei
Pompei era tradizionalmente
provinciale, il che lo
sottoponeva inevitabilmente ai
pregiudizi della elite Romana.
La sua famiglia aveva
raggiunto il consolato per la
prima volta solo 35 anni
prima. Di conseguenza aveva un
background rispettabile ma un
po' troppo provinciale, un
leggero neo che lo ha segnato
durante tutto la sua
competizione politica con i più
potenti patrizi di Roma.
Suo padre, Pompeo Strabone,
era un importante generale ed
il primo della famiglia a
diventare senatore, essendo
stato eletto console il 89
a.C.. Pompeo crebbe con il suo
padre negli accampamenti
militari, coinvolto con
l'esercito e gli affari
politici. Strabone aveva
combattuto prima con Gaio
Mario, poi con Silla nelle
guerre civili dell'88-87 a.C..
A 17 anni, Pompeo era oramai
completamente coinvolto nelle
guerre di suo padre. Inoltre
aveva un suo protetto, un
giovane ufficiale suo
coetaneo, Marco Tullio
Cicerone.
Strabone morì nei conflitti
tra Gaio Mario e Lucio
Cornelio Silla, lasciando al
giovane Pompeo il controllo
dei suoi affari e della sua
fortuna. Malgrado la sua
gioventù, Pompeo fu al fianco
di Silla dopo il suo ritorno
dalla guerra Mitridatica il 83
a.C.. A Roma, Silla prevedeva
difficoltà con Cinna ed trovò
il giovane 23enne, e le tre
legioni di veterani di suo
padre, utili. Questa alleanza
politica accelerò la carriera
di Pompeo a Roma. Silla, ora
dittatore, con il controllo
assoluto della città, forzò
il divorzio dal marito di
Emilia Scaura, la figliastra
incinta per farle sposare il
suo giovane alleato. Pompeo
era semplicemente felice di
divorziare da Antistia, una
matrona provinciale e di
prendere la patrizia Emilia.
Il giovane Pompeo era ora in
un'ottima posizione nei ranghi
di Silla. Durante le campagne
di Silla attraverso l'Italia,
Pompeo incontrò due individui
che avrebbero entrambi
modellato il futuro suo e di
Roma: Marco Licinio Crasso e
Gaio Giulio Cesare. Pompeo
venne a contatto con Crasso
nell'esercito. Crasso, come
Pompeo, era stato lasciato con
una piccola fortuna e con la
forza militare di suo padre ed
aveva parteggiato per Silla. I
due avrebbero sviluppato una
rivalità che sarebbe durata
negli anni a venire. Pompeo
incontrò per la prima volta
Cesare quando Silla portò
Cesare davanti a lui e chiese
a Cesare di divorziare da sua
moglie Cornelia, la figlia di
Cinna. Quando Cesare rifiutò,
Silla lo perdonò. Quando
Pompeo encomiò l'azione,
Silla rispose dicendo che
desiderava lasciare alcuni
nemici vivi per le avventure
successive. Pompeo vide Cesare
così non tanto come un
nemico, ma come un ostacolo
rispettato. Alcuni rapporti
dell'evento suggeriscono che
Pompeo fosse ispirato dal
rifiuto di Cesare a divorziare
da sua moglie, che gli
ricordava lo stesso scenario
che Pompeo aveva affrontato
soltanto due anni prima.
 Pompeo era un uomo molto ricco
e un generale di talento con
il controllo di tre legioni di
veterani, era ambizioso di
gloria e potere. Felice di
recepire i desideri del genero
e di riordinare la sua
situazione come dittatore,
Silla inviò Pompeo in Sicilia
per recuperare dai Mariani
l'isola con il suo
inestimabile rifornimento di
grano. Pompeo era un uomo molto ricco
e un generale di talento con
il controllo di tre legioni di
veterani, era ambizioso di
gloria e potere. Felice di
recepire i desideri del genero
e di riordinare la sua
situazione come dittatore,
Silla inviò Pompeo in Sicilia
per recuperare dai Mariani
l'isola con il suo
inestimabile rifornimento di
grano.
La Sicilia era strategicamente molto
importante, poiché produceva
la maggior parte del grano per
Roma. Senza la popolazione
della città avrebbe sofferto
la fame e ci sarebbero
certamente state delle
sommosse. Pompeo si occupò
della resistenza con mano
dura, scacciò le forze
avversarie dalla Sicilia e poi
andò in Africa, in cui
continuò la sua serie
ininterrotta di vittorie nel
82-81 a.C.
Il suo sterminio spietato delle forze
avversarie generò un odio
amaro fra i Mariani
sopravvissuti. Proclamato sul
campo Imperator dalle sue
truppe in Africa, Pompeo
richiese un trionfo per le sue
vittorie africane. Pompeo
rifiutò di sciogliere le sue
legioni e si presentò con la
sua richiesta alle porte di
Roma dove, Silla consentì ad
assegnargli il trionfo. È
anche su questo punto che
Pompeo si guadagnò il
cognomen di Magno, cioè
Grande.
La
reputazione di Pompeo genio
militare, e gli occasionali
giudizi negativi, continuarono
quando richiese l'imperium
proconsolare per andare in
Spagna e combattere contro
Sertorio, un generale Mariano
che continuava a governare la
Spagna.
Pompeo
rifiutò di sciogliere le sue
legioni fino a che la sua
richiesta non fu accettata e
si unì con Metello Pio contro
Sertorio. La campagna contro
la brillante guerriglia del
generale durò dal 76 a.C. al
71 a.C.. È significativo che
la guerra infine fu vinta solo
grazie all'assassinio di
Sertorio e non perché Pompeo
o Metello Pio fossero stati in
grado di ottenere una netta
vittoria sul campo di
battaglia.
Nei mesi successivi alla morte
del Sertorio, tuttavia, Pompeo
rivelò uno dei suoi talenti
più significativi: il genio
per l'organizzazione e la
gestione di una provincia
conquistata. Sistemi di
governo giusti e generosi
fecero estendere il suo
controllo su tutta la Spagna e
sulla Gallia meridionale. Fu
quando Marco Licinio Crasso si
trovò in difficoltà contro
Spartaco alla fine della
rivolta degli schiavi del 71
a.C., che Pompeo tornò in
Italia con il suo esercito per
mettere fine alla sommossa.
Gli avversari si lagnarono e,
specialmente Crasso,
sostennero che Pompeo stava
sviluppando azioni per
arrivare alla fine della
campagna e raccogliere tutta
la gloria per il successo
ottenuto. Ciò avrebbe
assicurato l'inimicizia
perenne tra Crasso e Pompeo,
che durò per più di un
decennio. Tornato a Roma,
Pompeo celebrò il suo secondo
trionfo extralegale per le
vittorie in Spagna. Gli
ammiratori vedevano in Pompeo
il generale più brillante
dell'epoca. Il 71 a.C., a solo
35 anni, Pompeo fu eletto per
la prima volta console, per il
70 a.C. come partner più
giovane di Crasso, grazie
all'appoggio irresistibile
della popolazione romana.
Nel 69 a.C., Pompeo era il
beniamino delle masse romane
anche se molti Ottimati erano
profondamente sospettosi delle
sue intenzioni. Il suo primato
nello stato fu accresciuto da
due incarichi proconsolari
straordinari, senza precedenti
nella storia romana. Nel 67
a.C., due anni dopo il suo
consolato, Pompeo fu nominato
comandante di una flotta
speciale per condurre una
campagna contro i pirati che
infestavano il Mar
Mediterraneo. Questo incarico,
come ogni cosa nella vita di
Pompeo, fu circondato da
polemiche.
A Pompeo occorsero solo pochi
mesi per eliminare dal
Mediterraneo il pericolo dei
pirati. In tre brevi mesi le
forze di Pompeo ripulirono
letteralmente il Mediterraneo
dai pirati, dimostrando
straordinaria precisione,
disciplina ed abilità
organizzativa. La rapidità
della campagna indicò che era
un generale di talento anche
in mare, con forti capacità
logistiche. Pompeo era l'eroe
del momento.
Fu allora incaricato di
condurre la guerra
mitridatica, contro Mitridate
VI re del Ponto, in oriente.
Questo comando affidava
essenzialmente a Pompeo la
conquista e la
riorganizzazione dell'intero
Mediterraneo orientale. Fu il
secondo comando sostenuto da
Cesare a favore di Pompeo.
Questi condusse le campagne
dal 65 a.C. al 62 a.C. con
tale potenza militare e
capacità amministrativa che,
Roma annesse gran parte
dell'Asia sotto un saldo
controllo.
Pompeo non solo distrusse
Mitridate, ma sconfisse anche
Tigrane il grande, re di
Armenia, con cui in seguito
fissò dei trattati. Conquistò
Antioco XIII di Siria, che
annesse e mosse verso
Gerusalemme, che conquistò.
Pompeo impose una
riorganizzazione generale ai
re delle nuove province
orientali, tenendo
intelligentemente conto dei
fattori geografici e politici
connessi alla creazione di una
nuova frontiera di Roma in
oriente. Con tutte le sue
campagne il Ponto e la Siria
divennero province romane e
Gerusalemme fu conquistata,
tutto a nome di Roma.
Con Tigrane come nuovo amico
ed alleato di Roma, la catena
dei protettorati romani si
estese ad est fino al Mar Nero
ed al Caucaso. La quantità di
tributi ed il bottino che
Pompeo portò a Roma era
incalcolabile, l'aumento in
tasse al pubblico erario
aumentò annualmente da 50
milioni a 85 milioni di
dracme. Il suo genio
amministrativo era tale che le
sue disposizioni resisterono
in gran parte identiche fino
alla caduta di Roma.
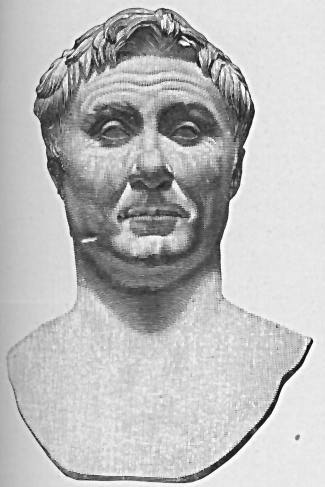 Nel
dicembre del 62 a.C., Pompeo
infine tornò a Roma con un
dilemma su cosa fare. Da una
parte desiderava il suo terzo
trionfo, d'altro canto
desiderava candidarsi per un
secondo consolato. Scelse il
trionfo, ma non poté
candidarsi per il consolato.
Se non poteva essere scelto,
almeno poteva corrompere gli
elettori per scegliere il suo
candidato, Affranio. Nel
dicembre del 62 a.C., Pompeo
infine tornò a Roma con un
dilemma su cosa fare. Da una
parte desiderava il suo terzo
trionfo, d'altro canto
desiderava candidarsi per un
secondo consolato. Scelse il
trionfo, ma non poté
candidarsi per il consolato.
Se non poteva essere scelto,
almeno poteva corrompere gli
elettori per scegliere il suo
candidato, Affranio.
Il suo terzo trionfo avvenne
il 29 settembre del 61 a.C.,
celebrando le vittorie sopra i
pirati e nel Medio Oriente, e
doveva essere un evento
indimenticabile a Roma. Due
interi giorni furono previsti
per l'enorme parata di prede,
prigionieri, l'esercito e i
vessilli che descrivevano
scene di battaglia riempirono
tutto la strada tra il Campo
Marzio ed il tempio di Giove
Ottimo Massimo. Per completare
i festeggiamenti, Pompeo offrì
un banchetto trionfale e fece
parecchie donazioni al popolo
di Roma, aumentando
ulteriormente la sua popolarità.
Pompeo abilmente allontanò i
suoi eserciti, disarmando le
preoccupazioni che intendesse
passare dalle sue conquiste al
dominio di Roma come
Dittatore. Tuttavia Pompeo era
ancora un tattico supremo;
cercò semplicemente nuovi
alleati e tirò le file dietro
le scene politiche. Gli
Ottimati aveva combattuto di
nuovo per avere il controllo
di gran parte del potere reale
del Senato; nonostante i suoi
sforzi, Pompeo trovò che le
loro azioni era contro di lui.
I suoi magnifici accordo in
Oriente non furono ratificati
subito. Le terre pubbliche che
aveva promesso ai suoi
veterani non arrivavano.
D'ora in poi, la strategia
politica di Pompeo suggerisce
che, anche se aveva fissato
una linea prudente per evitare
di offendere i conservatori,
era sempre più sconcertato
dalla riluttanza degli
Ottimati a riconoscere i suoi
solidi successi. La
frustrazione e la
costernazione di Pompeo lo
avrebbero spinto verso
alleanze politiche
sconosciute.
Anche se Pompeo e Crasso non
avevano stima e fiducia l'uno
dell'altro, nel periodo
antecedente il 61 a.C. si
ritenevano entrambi
ostacolati. Una tassa proposta
da Crasso era stata rigettata
e i veterani di Pompeo erano
ignorati. Cesare, di ritorno
dal servizio in Spagna e
pronto per candidarsi al
consolato si inserì tra i due
uomini, riuscendo in qualche
modo a creare un'alleanza
politica sia con Pompeo che
con Crasso (il cosiddetto
primo triumvirato). Pompeo e
Crasso lo avrebbero aiutato ad
essere eletto console e lui
avrebbe usato il proprio
potere di console per favorire
le loro leggi. Plutarco cita
Catone che più tardi avrebbe
affermato che la tragedia di
Pompeo non era essere il
nemico sconfitto di Cesare, ma
essere stato, troppo a lungo
amico e sostenitore di Cesare.
Il consolato tempestoso di
Cesare del 59 a.C. portò a
Pompeo non solo la terra e gli
insediamenti che desiderava,
ma anche una nuova moglie: la
giovane figlia di Cesare,
Giulia. Si pensa che Pompeo
fosse inebriato dalla sposa.
Dopo che Cesare si fu
assicurato il comando
proconsolare in Gallia alla
fine dell'anno consolare, a
Pompeo fu dato il governo
della Spagna ulteriore e
tuttavia gli fu consentito di
rimanere a Roma a sorvegliare
il rifornimento romano del
grano, che era critico,
esercitando il comando
attraverso subalterni. Pompeo
organizzò la fornitura del
grano con la usuale eccellente
efficienza ma il suo successo
negli affari politici era meno
sicuro.
Gli Ottimati non gli avevano
mai perdonato di aver
abbandonato Cicerone quando
Publio Clodio aveva imposto il
suo esilio; soltanto quando
Clodio cominciò ad
attaccarlo, Pompeo si persuase
ad agire con altri per il
richiamo di Cicerone nel 57
a.C.. Una volta che Cicerone
fu tornato, la sua usuale
magia vocale contribuì a
migliorare in parte la
posizione di Pompeo, ma molte
persone ancora lo vedevano
come un traditore per la sua
alleanza con Cesare. Altri
agitatori provarono a
persuadere Pompeo che Crasso
stava complottando per
assassinarlo.
Cesare, nel frattempo, stava
accrescendo la sua fama di
genio militare. Dal 56 a.C., i
legami fra i tre uomini
stavano sfilacciandosi; Cesare
chiamò prima Crasso, poi
Pompeo, ad una riunione
segreta a Lucca per ripensare
sia la strategia che le
tattiche. In questo momento
Cesare non era più il socio
sottoposto e silenzioso del
trio. A Lucca fu deciso che
Pompeo e Crasso avrebbero di
nuovo avuto il consolato nel
55 a.C.. Alla loro elezione,
il comando di Cesare in Gallia
sarebbe stato prolungato per
altri cinque anni, mentre
Crasso avrebbe ricevuto il
comando in Siria. Pompeo
avrebbe continuato a governare
la Spagnadopo il loro anno
consolare. Questa volta,
tuttavia, l'opposizione ai tre
uomini era elettrica; si
ricorse alla corruzione su una
scala senza precedenti per
assicurare l'elezione di
Pompeo e di Crasso nel 55. I
loro sostenitori ricevettero
la maggior parte dei restanti
incarichi importanti. La
violenza fra Publio Clodio e
le altre fazioni aumentava e
l'agitazione civile stava
diventando endemica.
Anche se all'inizio Pompeo
aveva avuto la presunzione di
poter sconfiggere Cesare ed
arruolare eserciti soltanto
ponendo il suo piede sul suolo
dell'Italia, nella primavera
del 49 a.C., quando Cesare
passò il Rubicone e le sue
legioni attraversavano la
penisola, Pompeo ordinò di
abbandonare Roma.
Gli eserciti si scontrarono
nella battaglia di Farsalo nel
48 a.C.. Lo scontro fu duro
per entrambi gli schieramenti
ma alla fine le truppe del
futuro dittatore di Roma
conquistarono la vittoria,
segnando così
l'inequivocabile sconfitta di
Pompeo. Come tutti gli altri
conservatori, egli dovette
fuggire per salvarsi la vita.
Incontrò la moglie Cornelia e
il figlio Sesto Pompeo
sull'isola di Mitilene.
Ricongiuntosi con la propria
famiglia Pompeo si chiese
quindi dove avrebbe potuto
recarsi. La decisione fu di
fuggire in Egitto.
Arrivato in Egitto, il destino
di Pompeo fu deciso dai
consiglieri del giovane re
Tolomeo. Mentre Pompeo
aspettava in mare aperto un
accordo, essi proposero di
assassinarlo, al fine di
ingraziarsi Cesare già in
viaggio per l'Egitto. Il 29
settembre, il giorno del suo
cinquantottesimo compleanno,
Pompeo Magno fu adescato col
pretesto di un' udienza a
bordo di una piccola barca in
cui riconobbe due vecchi
compagni d'arme dalle gloriose
campagne militari della sua
giovinezza. Erano i suoi
assassini. Quando si fu seduto
nella barca, studiando il suo
discorso per Tolomeo, lo
pugnalarono alla schiena con
una spada ed un pugnale. Dopo
la decapitazione, il corpo fu
sprezzantemente lasciato
incustodito e nudo, sulla
spiaggia. Il suo liberto,
Filippo, organizzò un
semplice funerale e cremò il
corpo su una pira del fasciame
di una nave.
Cesare arrivò poco dopo. Come
regalo di benvenuto ricevette
la testa di Pompeo ed il suo
anello in un cesto. Tuttavia,
non fu contento di vedere il
suo nemico, una volta suo
alleato e genero, assassinato
dai traditori. Depose Tolomeo,
fece giustiziare Potino ed
elevò Cleopatra al trono
dell' Egitto. Cesare diede le
ceneri di Pompeo e l'anello a
Cornelia, che le portò
indietro nelle sue proprietà
in Italia.
Alla fine del 45 a.C., Pompeo
fu deificato dal senato su
richiesta di Cesare. Per
ironia della sorte, Cesare fu
assassinato, alle Idi di marzo
del 44 a.C., nel teatro di
Pompeo, ai piedi della statua
del suo defunto rivale. Si
dice che in punto di morte
Cesare abbia rivolto preghiere
al suo migliore amico, genero
e maggior avversario.
Marco
Licinio Crasso
Marco
Licinio Crasso
(Roma 114 o 115 a.C. - Carre
53 a.C.) appartenente alla
gens Licinia, fu un uomo
politico romano ed un valoroso
generale; era figlio di Publio
Licinio Crasso Muciano, faceva
parte di una ricca e nobile
famiglia romana.
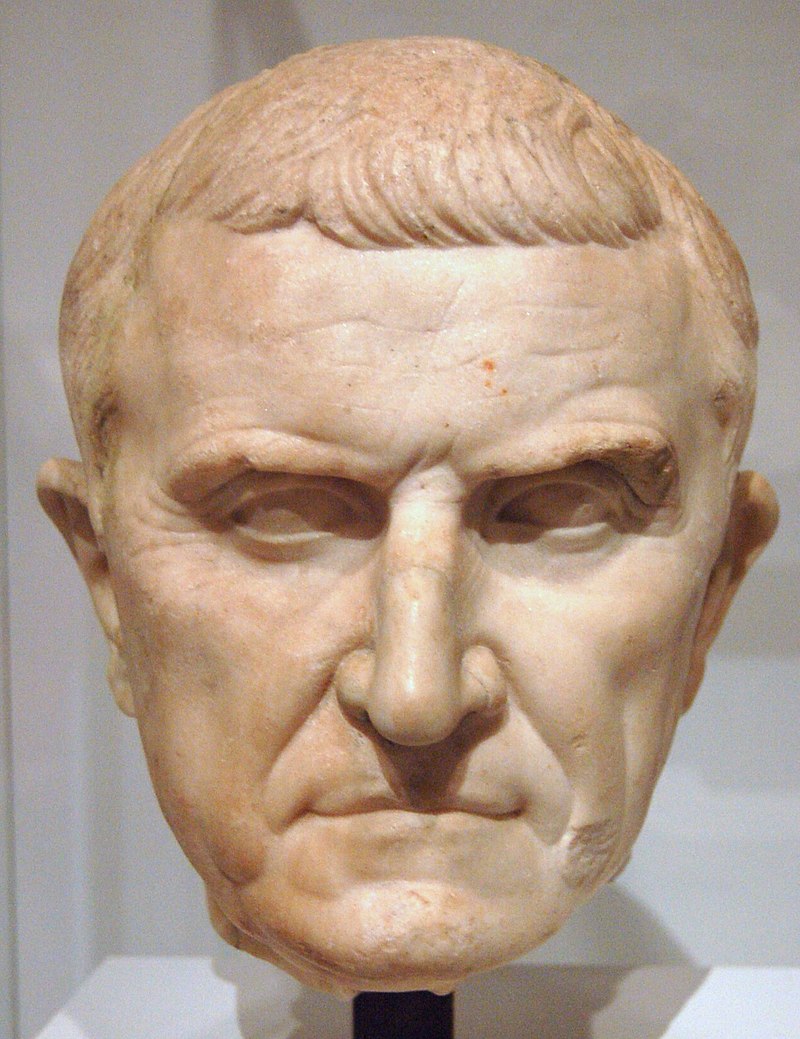 Sfuggito
alle persecuzioni di Mario e
Cinna, appoggiò Silla durante
la guerra civile (83 - 82
a.C.) contribuendo in maniera
decisiva alla vittoria presso
la porta Collina, allorquando
guidò l'ala destra
dell'esercito sillano. In
questi anni svolse un'intensa
attività di affarista e
soprattutto di speculatore di
beni immobili. Nel 72 a.C. fu
pretore. Sfuggito
alle persecuzioni di Mario e
Cinna, appoggiò Silla durante
la guerra civile (83 - 82
a.C.) contribuendo in maniera
decisiva alla vittoria presso
la porta Collina, allorquando
guidò l'ala destra
dell'esercito sillano. In
questi anni svolse un'intensa
attività di affarista e
soprattutto di speculatore di
beni immobili. Nel 72 a.C. fu
pretore.
Volendo
accrescere ancor più la sua
popolarità nella vita
politica di Roma, nel 71 a.C.,
Crasso ritenne un ottimo
trampolino di lancio politico
l’impresa che si preparava a
compiere e vale a dire il suo
intervento al comando di otto
legioni contro i servi che si
erano ribellati, capeggiati da
un gladiatore di nome
Spartaco, nella città di
Capua. Con una serie di rapide
azioni, al comando di un
esercito numeroso e ben
addestrato, riuscì in poco
tempo a soffocare la rivolta
servile, vincendo Spartaco in
Lucania.
Dopo
aver portato a termine con
successo la campagna di
repressione della rivolta
servile, Marco Licinio Crasso
ritenne opportuno costruire un
alleanza insieme a Pompeo
Magno; i due divennero consoli
nel 70 a.C.. Entrambi, avevano
minacciato il Senato di
scatenare una guerra civile in
caso di mancata elezione al
consolato. Marco Licinio
Crasso, eletto censore nel 65
a.C., nel 64 a.C. con Giulio
Cesare sostenne Catilina
contro Cicerone. Dopo aver
revisionato la costituzione di
Silla, Crasso strinse alleanza
con Giulio Cesare,
impegnandosi a sostenerlo per
l'elezione al consolato. Una
volta console, Cesare, con
Crasso e Pompeo, costituì il
primo triumvirato nel 60 a.C..
La
vittoriosa operazione contro
Spartaco e il rapporto di
amicizia con Cesare, permisero
a Crasso di poter emergere nel
quadro politico di Roma e di
entrare a far parte del famoso
primo triumvirato della storia
romana e cioè quello
stipulato nel 60 a.C. tra
Marco Licinio Crasso, Pompeo
Magno e Giulio Cesare. Codesto
accordo, combinato
segretamente, garantiva ai tre
contraenti aiuto reciproco
contro il senato per ottenere
consistenti vantaggi politici.
Ognuno dei tre uomini aveva un
suo seguito di adepti e di
clienti: queste forze, da sole
insufficienti, se coalizzate
avrebbero garantito al
triumvirato un solido
predominio. A seguito di un
deterioramento del
triumvirato, il quale col
passare del tempo aveva visto
cedimenti, Cesare decise di
convocare Pompeo e Crasso,
affinché fosse rinsaldata
l’ormai disgregata alleanza.
Nel
56 a.C., infatti i tre alleati
riunitisi a Lucca arrivarono
ad una conclusione molto
importante. In quella sede, si
decise la spartizione
dell’impero Romano in tre
parti che andavano sotto la
giurisdizione dei rispettivi
tre uomini. Crasso avrebbe
ottenuto il governo della
Siria, Pompeo quello della
penisola Iberica e il
proconsolato di Cesare in
Gallia sarebbe stato
prolungato per altri cinque
anni.
Crasso
quindi pensò di utilizzare la
carica di governatore della
Siria per rafforzare il suo
prestigio di condottiero, che
non poteva assolutamente
essere paragonato a quello di
Cesare e Pompeo. Decise
pertanto di intraprendere una
spedizione militare, che
puntava all’assoggettamento
del regno dei Parti, con il
quale Roma aveva, da qualche
tempo, rapporti difficili.
Deboli
nella fanteria, i Parti
potevano contare su una
cavalleria molto temibile, che
combatteva in modo
imprevedibile e applicava una
tattica militare del tipo
“colpisci e scappa” (la
cavalleria attaccava il nemico
scagliando una raffica di
frecce, evitava il contatto
diretto per ritornare a
scagliare nuovamente micidiali
piogge di dardi).
Crasso difatti, benché avesse
un esercito potentissimo, fu
sorpreso dalla insolita
tattica del nemico e in una
pianura della Mesopotamia
occidentale, nei pressi della
città di Carre, nel 53 a.C.
fu sconfitto e ucciso.
Si
narra che durante la battaglia
suo figlio Publio Licinio
Crasso, avendo fallito un
attacco al comando di un
grossa parte dell'esercito,
sia stato ucciso ed un soldato
partico gli abbia troncato la
testa, infitta poi su un'asta
per atterrire i Romani. La
disfatta di Carre, fu una
delle più drammatiche
catastrofi della storia
militare di Roma. Con la sua
fine ingloriosa, Crasso ruppe
l'equilibrio del triumvirato
ed aprì la strada verso una
nuova guerra civile.
Marco
Tullio Cicerone
Marco
Tullio Cicerone (Arpino (FR),
3 gennaio 106 a.C. - Formia, 7
dicembre 43 a.C.), esponente
di una agiata famiglia
dell'ordine equestre, fu un
celebre scrittore e filosofo
latino, nonché uomo politico
dell'ultimo periodo della
Repubblica Romana.
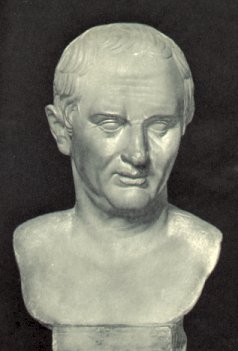 Il
padre Marco Tullio Cicerone il
Vecchio, auspicando per i
figli Marco e Quinto una
carriera forense e politica,
li condusse a Roma dove Marco
venne introdotto nel circolo
dei migliori oratori del suo
tempo, Licinio Crasso e Marco
Antonio, e dove poté formarsi
contemporaneamente nella
giurisprudenza, grazie alla
guida di Quinto Mucio Scevola.
A 17 anni dovette interrompere
gli studi per compiere il
servizio militare, che svolse
agli ordini dapprima del
console Gneo Pompeo Strabone e
poi di Lucio Cornelio Silla. Il
padre Marco Tullio Cicerone il
Vecchio, auspicando per i
figli Marco e Quinto una
carriera forense e politica,
li condusse a Roma dove Marco
venne introdotto nel circolo
dei migliori oratori del suo
tempo, Licinio Crasso e Marco
Antonio, e dove poté formarsi
contemporaneamente nella
giurisprudenza, grazie alla
guida di Quinto Mucio Scevola.
A 17 anni dovette interrompere
gli studi per compiere il
servizio militare, che svolse
agli ordini dapprima del
console Gneo Pompeo Strabone e
poi di Lucio Cornelio Silla.
Riprese
gli studi interrotti e nell'87
a.C. conobbe il maestro di
retorica Apollonio Molone,
ascoltò le lezioni degli
epicurei Fedro e Zenone, e
dell'accademico Filone di
Larissa che esercitò in lui
un'influenza profonda.
L'ingresso
di Cicerone nella carriera
forense avvenne ufficialmente
nel 81 a.C. con la sua prima
orazione pubblica, la Pro
Quinctio, per una causa in cui
ebbe come avversario Quinto
Ortensio Ortalo. Ma il suo
vero esordio nell'oratoria a
carattere politico si ebbe con
la Pro Roscio Amerino, molto
concitata ed a tratti
enfatica, che conserva molto
di scolastico nello stile
patetico ed esuberante.
Tra
il 79 ed il 77 a.C. Cicerone
viaggiò in Grecia ed in Asia
Minore, seguendo ad Atene le
lezioni di filosofia di
Antioco di Ascalona; a Rodi
ebbe la possibilità di
conoscere lo stoico Posidonio.
Tornato a Roma dopo la morte
di Silla e la reazione alla
sua politica, iniziò la sua
vera e propria carriera
politica in un ambiente
sostanzialmente favorevole:
nel 76 a.C. si presentò come
candidato alla questura.
Eletto
alla carica, svolse il lavoro
con scrupolo ed onestà tanto
che cinque anni dopo i
siciliani gli affidarono la
causa contro il propretore
Verre, reo di aver dissanguato
l'isola nel triennio 73-71
a.C.. Cicerone raccolse con
zelo le prove della
colpevolezza, pronunciò due
orazioni preliminari e l'ex
governatore, oberato da prove
schiaccianti, scelse l'esilio
volontario. Le cinque orazioni
preparate per le successive
fasi del processo furono
pubblicate più tardi e
costituiscono una importante
prova del malgoverno che
l'oligarchia senatoria
esercitava a seguito delle
riforme di Silla. Attaccando
Verre, Cicerone attaccò la
prepotenza della nobiltà
corrotta ma non l'istituzione
senatoria, anzi fece proprio
appello alla dignità di tale
ordine perché estromettesse i
membri indegni.
Nel
69 a.C. venne eletto alla
carica di edile, nel 66 a.C.
diventò pretore con una
elezione all'unanimità. Nel
64 a.C. Cicerone presentò la
candidatura al consolato per
l'anno successivo, e per un
gioco delle classi, Cicerone
risultò eletto con il voto di
tutte le centurie.
Più
tardi si adoperò per far
fallire una nuova candidatura
al consolato di Catilina, che
aveva allarmato i ceti
possidenti per il suo progetto
di remissione dei debiti.
Cicerone alimentò voci di una
congiura contro lo stato da
parte di Catilina - che preparò
poi un'azione rivoluzionaria
sventata sempre dal console
riconfermato e che costrinse
lui a fuggire da Roma, mentre
i capi del complotto
rivoluzionario furono
arrestati.
A
seguito del riemergere dei
contrasti tra senatori e
pubblicani, e dell'accordo tra
Cesare e Pompeo ai danni
dell'oligarchia senatoria,
Cicerone scivolò da parte.
L'ultimo tentativo di
rientrare nel gioco politico
gli fu offerta nel 60 a.C. dai
tre più potenti uomini del
momento, ovvero Pompeo, Cesare
e Crasso, alla conclusione
dell'accordo per il primo
triumvirato: essi chiesero a
Cicerone di appoggiare la
legge agraria a favore dei
veterani di Pompeo e della
plebe meno abbiente. Cicerone,
tuttavia, rifiutò non solo
per non apparire un traditore
dell'aristocrazia, ma anche
per l'attaccamento all'ordine
legale e sociale di cui gli
ottimati si proclamavano
difensori.
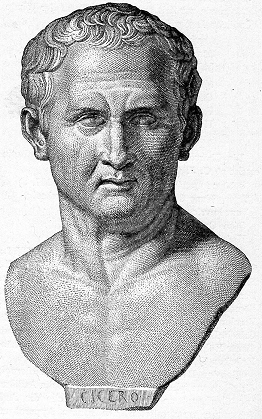 Dopo
questo rifiuto e la
costituzione del primo
triumvirato, Cicerone si tenne
fuori dalla politica ma questo
non bastò a salvarlo dalle
vendette dei populares:
all'inizio del 58 a.C. il
tribuno della plebe Clodio
Pulcro, nemico di Cicerone per
un precedente processo per
sacrilegio, fece approvare una
legge che condannava
all'esilio chiunque avesse
mandato a morte un cittadino
romano senza l'appello al
popolo. Costretto all'esilio,
Cicerone non si diede pace,
implorando le sue conoscenze
per il suo ritorno. Nel 57
a.C. la situazione a Roma
migliorò, allorché i nobili
e Pompeo posero un freno alle
iniziative di Clodio Pulcro,
permettendo a Cicerone di
tornare e ricominciare la sua
lotta contro il tribuno del
popolo. Dopo
questo rifiuto e la
costituzione del primo
triumvirato, Cicerone si tenne
fuori dalla politica ma questo
non bastò a salvarlo dalle
vendette dei populares:
all'inizio del 58 a.C. il
tribuno della plebe Clodio
Pulcro, nemico di Cicerone per
un precedente processo per
sacrilegio, fece approvare una
legge che condannava
all'esilio chiunque avesse
mandato a morte un cittadino
romano senza l'appello al
popolo. Costretto all'esilio,
Cicerone non si diede pace,
implorando le sue conoscenze
per il suo ritorno. Nel 57
a.C. la situazione a Roma
migliorò, allorché i nobili
e Pompeo posero un freno alle
iniziative di Clodio Pulcro,
permettendo a Cicerone di
tornare e ricominciare la sua
lotta contro il tribuno del
popolo.
Nel
56 a.C. Cicerone pronunciò
l'orazione Pro Sestio in cui
allargava il suo precedente
ideale politico: l'alleanza
tra cavalieri e senatori a suo
avviso non era più
sufficiente per stabilizzare
la situazione politica.
Occorreva quindi un fronte
comune di tutti i possidenti
per opporsi alla sovversione
tentata dai populares.
Possidenti e plebe si
scontravano con l'uso di bande
armate, e in uno di questi
scontri Milone, organizzatore
delle bande dei possidenti,
uccise il tribuno Clodio. Al
processo per omicidio,
Cicerone difese Milone, ma,
non riuscendo a pronunciare il
suo discorso per il clamore
della folla, Milone venne
condannato all'esilio.
Nel
51 a.C. come proconsole si recò
in Cilicia, proprio mentre i
rapporti tra Cesare e Pompeo
si inasprivano. Durante il
soggiorno lontano da Roma, i
pensieri dell'oratore furono
rivolti alla minaccia della
guerra civile. Tornato in
patria, non cessò di invitare
le parti alla moderazione alla
conciliazione, ma i suoi
inviti caddero nel vuoto anche
a causa del fanatismo che
spingeva Pompeo
all'intransigenza nei
confronti delle richieste di
Cesare. Dopo lo scoppio della
guerra, cercò di fare ancora
da moderatore, ma lasciando
infine l'Italia e seguendo i
pompeiani.
La
speranza di Cicerone di
collaborare al governo di
Cesare venne frustrata dalla
piega assolutistica e
monarchica che prese il
governo. L'oratore si ritirò,
iniziando la stesura di opere
di carattere filosofico. A
questo si aggiunse il divorzio
dalla moglie Terenzia e la
morte della figlia Tullia,
seguita dalla separazione
dalla seconda moglie Publilia.
Dopo la morte di Cesare,
durante la stagione delle
speranze di restaurazione
repubblicana, Cicerone riprese
l'attività politica
attaccando Marco Antonio con
veemenza, pronunciando 14
orazioni dette Filippiche, in
analogia a quelle di Demostene
contro Filippo II di
Macedonia.
Nel
tentativo di salvare la
Repubblica, proprio Cicerone
fu uno di quelli che nutrivano
le maggiori speranze sul
giovane Ottaviano, il quale,
dopo aver battuto Antonio a
Modena, scese con lui a patti,
gettando le basi per il
secondo triumvirato, a seguito
del quale vennero compilate
lunghe liste di proscrizione.
Nonostante Ottaviano non fosse
d'accordo, Antonio impose la
presenza su di esse anche del
nome di Cicerone, che venne
ucciso dai sicari presso la
sua villa di Formia, il 7
dicembre 43 a.C..
Spartaco
Spartaco
(Tracia, 104 a.C. - Lucania,
71 a.C.) è stato un
gladiatore romano che capeggiò
una rivolta di schiavi, la più
impegnativa delle guerre
servili che Roma dovette
affrontare: viene per questo
motivo soprannominato "lo
schiavo che sfidò
l'impero".
Si
racconta che nacque da una
famiglia di pastori;
intraprese la professione dei
padri, ma ridotto in miseria
accettò di entrare
nell'esercito romano, con cui
combatté in Macedonia col
grado di milite ausiliario. La
dura disciplina cui era
obbligato e i numerosi episodi
di razzismo che dovette subire
all'interno della milizia lo
convinsero a disertare e a
scappare.
Catturato,
fu bollato come un traditore e
condannato prima alla schiavitù
e in seguito, intorno al 75
a.C., fu destinato a fare il
gladiatore. Infatti Spartaco
venne venduto a Lentulo
Battiato, un organizzatore di
spettacoli residente a Capua.
Spartaco fu obbligato a
combattere contro belve feroci
e contro altri gladiatori
com'era in uso a quel tempo
per divertire popolo e
aristocrazia.
Spartaco,
resosi conto delle inumani
condizioni che Lentulo
riservava a lui e agli altri
gladiatori in suo possesso,
decise di ribellarsi a questo
stato di cose e nel 73 a.C.
scappò dall'anfiteatro in cui
era confinato. Lo seguirono
200 compagni, di cui però
solo una settantina arrivarono
fino al Vesuvio, la prima
tappa della rivolta
spartachista. Il comandante
Trace, infatti, si fermò ai
piedi del famoso vulcano
napoletano ed attaccò le città
limitrofe.
 Il
governo di Roma inviò due
pretori, Caio Clodio e Publio
Vatinio, a Napoli nel
tentativo di reprime la
rivolta. Spartaco li sconfisse
entrambi in quella che viene
denominata "La battaglia
del Vesuvio". I successi
militari ottenuti da Spartaco
fecero aumentare il numero
degli schiavi ribelli, che
crebbe a tal punto da
sconfiggere per altre due
volte gli eserciti romani
regolari. Il
governo di Roma inviò due
pretori, Caio Clodio e Publio
Vatinio, a Napoli nel
tentativo di reprime la
rivolta. Spartaco li sconfisse
entrambi in quella che viene
denominata "La battaglia
del Vesuvio". I successi
militari ottenuti da Spartaco
fecero aumentare il numero
degli schiavi ribelli, che
crebbe a tal punto da
sconfiggere per altre due
volte gli eserciti romani
regolari.
Infatti
schiavi, braccianti, contadini
poveri e pastori dei territori
circostanti cominciarono ad
aderire alla rivolta. Sicché
la linea di blocco posta
intorno al Vesuvio fu spezzata
e più divisioni romane furono
nettamente sconfitte in
Campania.
Il
successo militare più
eclatante ottenuto dai
rivoluzionari fu quello
conseguito contro il pretore
Publio Varinio ed i suoi
luogotenenti: Spartaco non si
limitò a sconfiggere i
soldati, ma riuscì anche a
impadronirsi persino dei
cavalli e dei simboli littori
dell'esercito. Da questa
posizione egli riuscì a
dominare su tutta la ricca
regione campana.
A
quel punto, Spartaco decise di
estendere la rivolta anche a
Sud della Campania, occupando
quindi la Calabria e la
Lucania (oggi Basilicata): in
queste zone altri uomini si
aggregarono alla sua comitiva,
riuscendo ad armare
regolarmente l'esercito
nell'inverno 73-72 a.C.
Anche
un comandante celta, Crixio
(detto anche Crisso), aderì
alla rivolta spartachista e
nel 72 a.C. egli, con 20.000
schiavi, in maggioranza celti
e germanici, scese in Apulia
(oggi Puglia), ma fu sconfitto
dai generali romani Lucio
Gellio e Gneo Cornelio Lentulo
Clodiano nella "Battaglia
del Gargano". L'esito fu
così disastroso che Quinto
Avio, il propretore di Gellio,
riuscì assolutamente
indisturbato ad uccidere
Crixio con un pugnale.
Spartaco
non si intimorì alla notizia
della morte dell'alleato, ed
anzi riuscì a battere
nuovamente le truppe romane,
attestate in due eserciti
comandati dai consoli Lucio
Gellio Publicola e Gneo
Cornelio Lentulo Clodiano uno
di qua e uno di là
dell'Appennino. A quel punto
decise di estendere la
rivolta, arrivando con circa
150.000 uomini fino a Modena
dove riuscì a sconfiggere
anche il proconsole Caio
Cassio Longino Varo. Era
quindi praticamente riuscito
nel suo intento, cioè quello
di attraversare le Alpi e
congiungersi con gli schiavi
del Nord Europa in modo da
formare un esercito più
potente. Tuttavia una grande
parte degli schiavi vittoriosi
volle restare in Italia o al
limite marciare contro Roma,
approfittando del momento di
debolezza dell'esercito
romano.
Spartaco
inizialmente non aderì a
questo progetto, convinto del
suo fallimento: egli avrebbe
preferito arrivare fino in
Gallia, in modo da avere il
sostegno della popolazione
locale che già da tempo
mostrava una certa
insofferenza verso la
dominazione romana. Decise
comunque di accettare la
volontà della maggioranza, a
patto che essi sarebbero
tornati al sud in modo da
avere più alleati: quindi
guidò le sue truppe verso la
Lucania.
Nel
dicembre nel 72 a.C., proprio
mentre Spartaco tornava in
Basilicata, il Senato romano
diede a Marco Licinio Crasso
l'incarico di reprimere la
rivolta. Crasso pretese il
comando su otto legioni, in
modo tale da avere una
schiacciante superiorità in
termini numerici. Con tutti
questi uomini egli ordinò la
creazione di una grande
muraglia tesa a non fare
arrivare rifornimenti di alcun
genere alle truppe di
Spartaco.
Spartaco,
preso in controtempo da questa
decisione, decise allora di
sbarcare in Sicilia in modo
tale da unirsi a una rivolta
di schiavi, indipendente alla
sua, che si stava svolgendo in
quel momento in Trinacria.
Tuttavia, a causa del
tradimento di alcuni pirati,
fu costretto a rimanere fermo.
Crasso lo attaccò alle
spalle, ma egli riuscì
inizialmente a sconfiggerlo
nella battaglia di Petilia.
Tuttavia, a causa della
stanchezza dei suoi uomini,
Spartaco non poté sfruttare
al meglio il suo successo,
avvenuto nel gennaio del 71
a.C., permettendo così alle
truppe di Gneo Pompeo di
unirsi a quelle di Crasso: il
nuovo esercito romano,
numeroso e armato fino ai
denti, costrinse Spartaco
prima alla fuga verso Brindisi
(dove due suoi ex alleati,
Castro e Giaunico, vollero
muovere battaglia da soli ai
romani, perdendo nettamente) e
poi alla ritirata, ancora
verso la Lucania.
Nei
pressi del fiume Sele si
svolse la battaglia finale:
60.000 schiavi, tra i quali
Spartaco, morirono (ma il
corpo del condottiero non fu
mai trovato). I romani persero
solo 1.000 uomini e fecero
6.000 prigionieri, che Crasso
fece crocifiggere – nudi –
lungo la via Appia (che porta
da Capua a Roma). Altri
reparti dell'esercito ribelle,
circa 5.000 uomini, tentarono
la fuga verso nord, ma vennero
raggiunti e annientati da
Pompeo. Terminava così la
rivolta di Spartaco.
Pag.
9

 Pag.
11
Pag.
11
|