|
Strasburgo,
"la città delle strade", è una città
della Francia orientale, capoluogo della
regione Grande Est e del dipartimento
del Basso Reno, al confine con la Germania sulla
riva sinistra del Reno.
Il
nome è tedesco perché in passato il territorio
dell'Alsazia fu dominio sia della Francia
che della Germania.
Gli
abitanti sono chiamati strasburghesi. La città
fa parte di un agglomerato urbano transfrontaliero
di 1 145 000 abitanti che comprende
anche la città tedesca di Kehl.
Strasburgo
è sede, con Bruxelles, del parlamento
europeo. Ospita, inoltre, il Consiglio
d'Europa. Insieme a Basilea, Ginevra e New
York fa parte delle poche città al mondo
che sono sede di organizzazioni
internazionali di prim'ordine, pur non
essendo la capitale di un paese.
Vi
operano l'Università di Strasburgo, la seconda
più importante università francese, e la
prestigiosa Scuola Nazionale della Pubblica
Amministrazione (ENA) fondata dal presidente De
Gaulle.

Il sito su
cui sorge Strasburgo fu inizialmente occupato
dall'accampamento militare romano di Argentorate
dopo le campagne di Germanico del 14-16,
all'interno della provincia di Germania
superiore. A partire dal IV secolo, Strasburgo
fu sede di un vescovato.
Presso le
sue porte fu combattuta una grande battaglia nel
357, tra gli Alemanni e l'imperatore Giuliano
l'Apostata, il quale riuscì a respingerli
mentre il loro re, Conodomario, fu fatto
prigioniero. Pochi anni più tardi (nel 361),
Giuliano, diventava imperatore romano. Un nuovo
attacco viene sferrato il 2 gennaio del 366,
approfittando della superficie ghiacciata del
Reno ed all'inizio del V secolo gli Alemanni
risultano insediati nell'area oggi occupata
dall'Alsazia ed in una grande parte dell'attuale
Svizzera.
Nel corso
del V secolo la città passa dal dominio degli
Alemanni a quello degli Unni e poi dei Franchi;
nell'842 vi viene siglato il Giuramento di
Strasburgo.
Grande
centro di scambi commerciali nel tardo medioevo,
nel 1262 diventa una città libera del Sacro
Romano Impero con un governo autonomo dal 1332.
Nel 1439 viene completata la realizzazione della
Cattedrale di Strasburgo, destinata a diventare
l'edificio più alto del mondo. Negli anni
successivi al 1520 la città fa propria la
dottrina religiosa di Martin Lutero, i cui
adepti fondano a Strasburgo nel secolo
successivo una loro università.

La Francia
annette Strasburgo nel 1681, sotto il regno di
Luigi XIV, e la conquista viene ratificata dal
Trattato di Ryswick nel 1697. La politica di
intolleranza religiosa verso i protestanti
adottata in Francia con l'Editto di
Fontainebleau ma non applicata a Strasburgo,
unita alla crescita dell'industria e del
commercio, porta la popolazione cittadina a
triplicare fino a 150.000 abitanti.
L'inno
nazionale francese, "La Marsigliese",
viene composto a Strasburgo il 25 aprile del
1792 da Claude Joseph Rouget de Lisle, durante
una cena organizzata dal sindaco della città,
Frédéric de Dietrich.
Nel 1871,
terminata col Trattato di Francoforte la guerra
franco-prussiana, la città torna ad essere
parte del Reichsland di Alsazia-Lorena
dell'Impero tedesco. Strasburgo diventa
nuovamente francese dopo la prima guerra
mondiale, con la sigla nel 1919 del Trattato di
Versailles e di nuovo tedesca durante gli anni
della seconda guerra mondiale, dal 1940 al 1945.
La linea
del fronte tra Francia e Germania che nei secoli
ha attraversato Strasburgo e la sua regione ha
anche diviso le comunità e le famiglie, spesso
trovatesi su fronti opposti nei diversi
conflitti. Per questo il monumento cittadino ai
caduti di tutte le guerre raffigura una madre
che regge i corpi di due figli volutamente nudi,
cioè privi di qualsiasi divisa o insegna
riconducibile ad una particolare fazione.
Il simbolo
della città, esaltato già da Goethe, è la sua
cattedrale, uno degli edifici sacri più
significativi del medioevo. La costruzione di
questo capolavoro iniziò nel 1015, ovvero in
epoca romanica, sui resti di un edificio
preesistente, ma il protrarsi dei lavori per
diversi secoli fece sì che la chiesa
presentasse anche elementi stilistici gotici. Di
particolare importanza è la facciata,
straordinaria per le proporzioni e per la
decorazione scultorea dei portali; essa
rappresenta l'autocelebrazione della
cittadinanza, che dal 1286 finanziò il
proseguimento dei lavori che portarono al
completamento di questa gigantesca opera. Di
grande interesse storico e artistico sono anche
le magnifiche vetrate policrome e l'orologio
astronomico.
La piazza antistante è
delimitata da edifici a graticcio con un massimo
di cinque piani come la Maison Kammerzell
edificata nel 1589 di fronte alla cattedrale,
con i suoi portici, le sculture in legno e la
facciata inclinata in avanti. e il Palais Rohan,
costruito in stile Luigi XV intorno
al 1740.

La Grande Île affascina sia per
le case a graticcio, i canali e i cortili
lastricati ricoperti di vite vergine sia per i
nomi delle strade evocatori del passato: rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
(dove visse Goethe nel 1770), pont
du Corbeau,
pont
des Moulins,
rue
du Fossé des Tanneurs, rue
du Bain aux Plantes, rue des Dentelles...
Infine, il centro storico è
completato dalla Petite France, il pittoresco
quartiere dei conciatori costruito fra il XVI e il XVII secolo, dai ponts couverts (ponti che in origine
erano coperti).
Questo quartiere che avrebbe affascinato Walt
Disney, deve il suo nome all'ospedale costruito
nel XVI secolo per i soldati di Francesco I che
avevano portato dall'Italia il vaiolo. Ma la
Petite France era soprattutto il quartiere dei
pescatori, dei mugnai e dei conciatori.
Le case a graticcio che si riflettono nell'acqua del
canale risalgono alla fine del '500 o del '600.
La più celebre è quella detta "des
Tanneurs"
(dei conciatori) edificata nel 1572. Sono tutte
costruite con le tipiche gallerie in legno, le
logge su mensole dove i conciatori facevano
asciugare le pelli dopo averle lavate e grattate
nell'acqua del canale.
È a
Strasburgo che vissero dal XVII al XVIII secolo
i più celebri fabbricanti di organi d'Europa, i
Silbermann, fabbricanti di padre in figlio, e i
cui strumenti, cari al grande Jean-Sébastien
Bach, sono tuttora considerati la perfezione
stessa, come gli stradivari per il violino...
Potrai ammirare una delle loro realizzazioni
(del 1741) nella chiesa St-Thomas.
Ma la tradizione dell'organo si
è perpetuata a Strasburgo! Gli appassionati
devono assolutamente visitare anche la Cité
de la Musiqueet de la Danse inaugurata nel mese di
maggio 2006 e che ospita un organo nuovo
fiammante di 7 tonnellate, alto 11 metri,
fabbricato dalla manifattura strasburghese
Mühleisen.
Situato in una sala a forma di
cono alto 18 metri, circondato di pietra
antracite per ragioni acustiche, questo
strumento appartiene al Conservatorio Nazionale
della Regione di Strasburgo (CNR). La cassa
disegnata dall'architetto Henri Gaudin affascina
per le sue linee pure e racchiude non meno di 26
registri per tutti i repertori. Di notevole
fattura e armonizzazione, quest'organo moderno,
uno dei più belli di Francia, soddisfa già 35
allievi del CNR ma anche i più grandi oganisti
invitati, come Martin Gester, specialista di
Bach, e il compositore Thierry Escaich.

Cattedrale
di Notre Dame
La
cattedrale di Strasburgo (chiamata Notre-Dame
e Liebfrauenmünster in francese
e in tedesco)
è una delle chiese più note di Francia
e del mondo. Da sempre è stata un importante
parametro di riferimento per gli edifici più
alti del mondo.
Gli
scavi archeologici sotto e intorno alla
cattedrale sono stati condotti nel 1896–1897,
1907, 1923–1924, 1947–1948, tra il 1966 e il
1972, e infine tra il 2012 e il 2014.
Il
sito dell'attuale cattedrale è stato utilizzato
per diversi edifici religiosi precedenti, a
partire dal periodo Argentoratum, quando un
santuario romano occupava il sito fino
all'edificio che si trova oggi.
Si
sa che una cattedrale fu eretta dal vescovo sant'Arbogaste della diocesi
di Strasburgo alla fine del VII secolo,
sulla base di un tempio dedicato alla Vergine
Maria, ma oggi non ne rimane nulla. La
precedente cattedrale di Strasburgo, i cui resti
risalenti alla fine del IV secolo o all'inizio
del V secolo sono stati riportati alla luce nel
1948 e nel 1956, si trovava nel sito
dell'attuale chiesa di Santo Stefano.
Nell'VIII
secolo, la prima cattedrale fu sostituita da un
edificio più importante che sarebbe stato
completato sotto il regno di Carlo Magno.
Il vescovo Remiglio di Strasburgo (detto anche Rémi)
volle essere sepolto nella cripta, secondo il
suo testamento del 778. Fu certamente in questo
edificio che nell'842 furono pronunciati i giuramenti
di Strasburgo. Gli scavi hanno rivelato che
questa cattedrale carolingia aveva tre navate e
tre absidi. Una poesia descrive questa
cattedrale come decorata con oro e pietre
preziose dal vescovo Ratho (anche Ratald o
Rathold). La basilica prese fuoco in diverse
occasioni, nell'873, nel 1002, a causa del duca
di Svevia Ermanno II e del di lui
genero e duca di Carinzia Corrado, nel
contesto della successione al trono
imperiale di quell'anno, e nel 1007.
 Nel
1015 il vescovo Guarniero I d'Asburgo posò
la prima pietra di una nuova cattedrale sulle
rovine della basilica carolingia. In seguito,
costruì una cattedrale in stile romanico, ma fu
poi continuata secondo i canoni
dell'architettura gotica sia francese che
tedesca. Quel duomo fu raso al suolo nel 1176
perché all'epoca le navate erano coperte da
un'intelaiatura di legno. Nel
1015 il vescovo Guarniero I d'Asburgo posò
la prima pietra di una nuova cattedrale sulle
rovine della basilica carolingia. In seguito,
costruì una cattedrale in stile romanico, ma fu
poi continuata secondo i canoni
dell'architettura gotica sia francese che
tedesca. Quel duomo fu raso al suolo nel 1176
perché all'epoca le navate erano coperte da
un'intelaiatura di legno.
Dopo
quel disastro, il vescovo Enrico di Hasenburg
decise di costruire una nuova cattedrale, per
essere più bella di quella di Basilea, che
era appena terminata. La costruzione del nuovo
duomo iniziò sulle fondamenta della struttura
precedente, e si concluse solo secoli dopo. La
cripta del duomo di Guarniero, che non era
bruciata, fu conservata e ampliata verso ovest.
I lavori proseguirono fino al 1439.
Fu costruita a partire dal 1176 ed iniziata in stile romanico,
anche se fu poi continuata secondo i canoni
dell'architettura
gotica sia francese che tedesca.
Essenzialmente, i lavori proseguirono fino al 1439.
Si basava sulle fondamenta della precedente
costruzione del periodo ottoniano. Per la sua
fattezza, è un illustre esempio di costruzione
in pietra
arenaria dei Vosgi (grès rouge des Vosges). Questa pietra tipica delle
zone renane le conferisce il tipico colore
rossiccio, che caratterizza anche opere situate
in città vicine, come la cattedrale di Friburgo in Brisgovia o il münster
di Basilea.



Ha la forma
di una basilica
a tre navate, con transetto.
È rimasta incompiuta anche in funzione delle
enormi dimensioni del progetto, che il comune di
Strasburgo
ed il vescovo Henri de Hasenbourg perseguivano
in concorrenza con altre città nelle zone
limitrofe. Per questo, oggi si distingue da
molte altre cattedrali gotiche per l'evidente
mancanza di una delle due torri campanarie,
quella meridionale, il che ha causato uno forte
effetto asimmetrico dell'insieme (in contrasto
con la regolarità che caratterizza la facciata,
la cui struttura a scacchiera è facilmente
riconoscibile).
La parte posteriore della chiesa,
soprattutto il presbiterio
ma anche il transetto, è quella maggiormente
caratterizzata da elementi romanici che peraltro
sono evidenti nella cripta dell'XI secolo.
Ciononostante,
l'interno è caratterizzato da una spiccata
dissoluzione delle pareti secondo i parametri
delle cattedrali gotiche francesi dell'epoca.
D'altro
canto, le sculture della chiesa lasciano
trasparire nuove tendenze dell'arte gotica, dato
che in opere come la morte della Vergine
il drappeggio dei vestiti non nasconde più
completamente le forme del corpo: la scultura
riacquista così una parte della plasticità che
il gotico tendeva in precedenza a tralasciare
per assecondare le forme snelle e lo slancio
verso l'alto tipico della scultura gotica.







Si
distingue per un orologio
astronomico di grande fattura che
riproduce, unico nel suo genere, la precessione
degli equinozi. È in grado di battere
anche le 13.
Costruito
durante il XVI
secolo, l'orologio
astronomico di Strasburgo
è un capolavoro del Rinascimento,
all'epoca considerato una delle sette meraviglie
della Germania. È stato portato alle forme
attuali nel corso di diversi secoli.
Verso la
fine del secolo XIII con l'invenzione
dell'orologio meccanico si produsse un grande
cambiamento nel modo di misurare il tempo in
precedenza affidato alle clessidre e agli
orologi solari. Avvenne allora che molti edifici
pubblici furono dotati di grandi orologi
meccanici e Strasburgo fu una delle prime città
a realizzarne uno costruendo all'interno della
cattedrale negli anni fra il 1352 e il 1354 il
cosiddetto Orologio dei Re Magi. Si
trattava di una costruzione dotata di una cassa
contenente il dispositivo meccanico alta circa
dodici metri e di un calendario, un astrolabio
e, in alto la statua della Vergine col Bambino
davanti al quale s'inginocchiavano ogni ora i Re
Magi mentre un carillon
suonava e un gallo cantava innalzando le ali.
 Nel 1547,
essendosi l'orologio ormai irrimediabilmente
deteriorato, si decise di costruirne uno nuovo
anziché cercare di ripararlo. Questa
costruzione andò per le lunghe, la cattedrale
fu adibita al rito protestante poi a quello
cattolico e poi ancora a quello protestante
sicché cambiarono i preposti alla chiesa, i
lavori iniziarono tardi, furono poi interrotti,
lunghi furono i tempi per reperire uomini capaci
di fare avanzare il progetto iniziale, finché
l'ingranaggio in ferro battuto smise di
funzionare definitivamente poco prima della Rivoluzione
francese. Nel 1547,
essendosi l'orologio ormai irrimediabilmente
deteriorato, si decise di costruirne uno nuovo
anziché cercare di ripararlo. Questa
costruzione andò per le lunghe, la cattedrale
fu adibita al rito protestante poi a quello
cattolico e poi ancora a quello protestante
sicché cambiarono i preposti alla chiesa, i
lavori iniziarono tardi, furono poi interrotti,
lunghi furono i tempi per reperire uomini capaci
di fare avanzare il progetto iniziale, finché
l'ingranaggio in ferro battuto smise di
funzionare definitivamente poco prima della Rivoluzione
francese.
Finalmente
nel 1838 fu dato l'incarico a Jean Baptiste Schwilgué (1776-1856) di restaurare l'orologio. Il
restauro durò fino al 1842, si realizzò così
il compito che Schwilgué si era prefisso fin da
giovane di far ripartire l'orologio, per cui
aveva studiato da autodidatta tutta la vita per
acquisire le conoscenze e le capacità
necessarie.
Formò gli
operai in modo che fossero in grado di seguirlo,
realizzò le macchine per costruire le parti
dell'orologio in modo più preciso possibile e
le macchine per intagliare il legno per sbozzare
le figure mobili partendo dai modelli in gesso.
Avrebbe voluto costruire un orologio ex novo ma
la comunità arretrò dinanzi al costo che
avrebbe dovuto sostenere e gli affidò soltanto
l'incarico del restauro. Questo consentì che
non andassero perdute le decorazioni pittoriche
rinascimentali della grande cassa.
La
struttura dell'orologio è composta dalla cassa
alta 18 metri che poggia su un basamento
alto più di 4 metri e largo 7,30 metri dal
quale s'innalzano anche una scala a chiocciola per accedere alla parte superiore e al
quadrante esterno e da una torre entro la quale
scorrono i cinque pesi che forniscono la forza
motrice dei meccanismi contenuti nella cassa; la
ricarica avviene ogni settimana cioè quanto
impiegano i pesi a compiere la discesa. Il tutto
è ornato da pitture e sculture in legno.
L'indicazione
dell'ora è data da un quadrante sul quale le
lancette argentate indicano l'ora ufficiale e
quelle dorate, in ritardo di circa mezz'ora su
quelle argentate, indicano l'ora locale alla
quale sono sincronizzate le sonerie dei vari
personaggi meccanici: il primo quarto d'ora è
scoccato da un putto alato, il secondo da un
fanciullo adolescente, il terzo da un adulto e
il quarto da un vecchio a simboleggiare le
quattro età della vita. Tutti sfilano davanti
alla morte che ha in una mano una falce e
nell'altra un battaglio col quale batte le ore
senza mai fermarsi mentre le età, come gli
uomini, riposano durante la notte; dopo i
rintocchi dell'ora un'altra figura di putto
alato rovescia la clessidra che tiene in mano.
Allo
scoccare del mezzogiorno le statue
rappresentanti gli apostoli sfilano davanti al
Cristo che, passato l'ultimo apostolo, benedice
i visitatori; durante la sfilata degli apostoli
un gallo canta per tre volte. Da sempre questo
animale ha infatti rappresentato la misura del
tempo e, ricordando la rinnegazione del Cristo
da parte dell'apostolo Pietro prima che il
gallo canti , simboleggia anche la fragilità
umana.
I giorni
sono rappresentate da statue delle divinità
mitologiche dalla domenica con Apollo e
successivamente i vari giorni della settimana
rappresentati da Diana, Marte, Mercurio, Giove,
Venere fino al sabato che vede Saturno
raffigurato mentre divora i suoi figli e
rappresenta il tempo che divora ciò che crea .
La freccia tenuta da Apollo ha anche la funzione
di indicare sul calendario il giorno attuale.
L'anno è descritto da un calendario perpetuo a
forma di anello con i mesi, i giorni e i
rispettivi santi, le feste fisse e mobili.

Un globo celeste riproduce i
movimenti della volta stellata intorno alla
terra immobile al centro secondo la visione
tolemaica. Ha più di 5000 stelle e gira
in un giorno
siderale, cioè nel tempo intercorrente
fra due passaggi successivi di una stella sullo
stesso meridiano, più breve di circa quattro
minuti del giorno solare medio. È pure indicato
il tempo apparente, o vero tempo solare, dato
dal tempo intercorrente fra due passaggi
successivi del sole sul meridiano.
Due lancette indicano il movimento apparente del
sole e quello della luna intorno all'emisfero
terrestre settentrionale e indicano quindi con
la loro posizione anche le eclissi
del sole e della luna.
Il
complesso delle pitture, opera dell'artista Tobias Stimmer e del fratello Josias,
operanti nel XVI secolo, evoca il tempo sotto i
diversi aspetti, cronologico, storico e
teologico ma sempre tendendo a dimostrare che
l'uomo e l'umanità sono indirizzati verso la
fine. Così è evocata la creazione degli uomini
mediante la estrazione di Eva da una costola
d'Adamo da parte di Dio, che, secondo la
tradizione protestante, non è rappresentato
direttamente ma è soltanto indicato da una
scritta al centro di un globo di fuoco.
 Il
giudizio
universale a rappresentare la fine è
illustrato in tre scene di contenuto teologico.
Di concezione teologica luterana
sono la rappresentazione della Caduta e della
Salvezza mediante la Fede e la Grazia. Le
quattro stagioni rappresentano le età dell'uomo
e il tempo irreversibile della vecchiaia perché
dietro all'inverno si scorge la morte con la sua
clessidra. Il
giudizio
universale a rappresentare la fine è
illustrato in tre scene di contenuto teologico.
Di concezione teologica luterana
sono la rappresentazione della Caduta e della
Salvezza mediante la Fede e la Grazia. Le
quattro stagioni rappresentano le età dell'uomo
e il tempo irreversibile della vecchiaia perché
dietro all'inverno si scorge la morte con la sua
clessidra.
Altre
pitture rappresentano uomini che hanno
illustrato la scienza e le arti. Copernico
è raffigurato con in mano un ramo di mughetto a
significare il fatto che fu un medico, ma non in
relazione alla sua teoria astronomica
eliocentrica vista dai suoi contemporanei e
dall'ideatore dell'orologio soltanto come una
geniale ma bizzarra ipotesi, tant'è che il
complesso dello strumento abbraccia ancora la
teoria geocentrica tolemaica. Il planetario
mostra la circolazione dei pianeti visibili e i
segni dello zodiaco tracciati sul quadrante
permettono di determinare in quale costellazione
si trovano i pianeti, le fasi lunari sono
determinate dal globo della luna per metà
bianco e per metà nero che compie una rotazione
completa della durata del mese lunare di 29
giorni e 55 minuti. I moti dei pianeti e della
luna sono realizzati con estrema precisione
rispetto alla realtà, precisione che stupisce
se si pensa che è ottenuta con congegni
meccanici di oltre 150 anni fa.
In sintesi
l'orologio realizza una completa visione
dell'astronomia del Cinquecento oltre che un
esempio dell'abilità raggiunta dalla tecnologia
meccanica nella metà dell'Ottocento, un bel
esempio di arte rinascimentale tedesca e un
motivo di riflessione sul mistero del tempo.

Le
prime notizie circa la presenza di un organo
all'interno della cattedrale di Strasburgo
risalgono al 1260, quando, benché la navata non
fosse ancora stata completata, era presente un
piccolo organo positivo vicino la cappella di
San Giovanni Battista. Guncelin (o Gunzelin,
Guncelinus) da Francoforte, nel 1292, realizzò
un nuovo strumento, forse già ubicato nella
posizione attuale. Il 15 agosto 1298, però,
l'organo andò distrutto da un incendio.
Un
nuovo strumento venne realizzato da Claus Karlé
(o Karlen, Carlé) fra il 1324 e il 1327. Benché
fosse certamente di piccole dimensioni, l'organo
era accompagnato da due automi soprannominati
"rohraffes", realizzati da Karlé e
posti ai lati inferiori della cassa. Questi
automi, ancora esistenti, sono l'araldo
cittadino, rappresentato da un trombettiere
vestito con una giubba e un paio di calzoni
bianchi e rossi, i colori di Strasburgo, e il
venditore di brezel, una figura corpulenta con
una folta barba nera. Grazie a dei meccanismi
l'araldo poteva muovere il braccio e portare lo
strumento alla bocca, mentre il venditore di
brezel apriva la bocca e agitava le braccia. Nel
grande pendaglio centrale posto sotto la cassa,
inoltre, alla fine del Trecento venne aggiunta
una scultura raffigurante la vicenda di Sansone
e il leone, al quale un meccanismo faceva
spalancare le fauci.
Nei
giorni di Pentecoste, quando i pellegrini
giungevano in cattedrale da tutta la diocesi,
era tradizione che il loro ingresso
nell'edificio fosse accompagnato da un vero a
proprio spettacolo prodotto dai
"rohraffes", manovrati da alcuni
inservienti nascosti sulla tribuna dell'organo:
l'araldo imboccava la tromba, il leone apriva e
chiudeva le fauci (e forse ruggiva) e il
venditore di brezel accoglieva i fedeli con
urla, commenti satirici e canzoni profane. Il
nome "rohraffes" deriva da
"rohn" (canna) e da
"affes" (scimmie), e significa scimmie
delle canne, con riferimento all'organo.
Altre fonti, invece, fanno derivare il termine
"rohn" da "röhren" (urlare),
dando al nome degli automi il significato di scimmie
urlatrici.
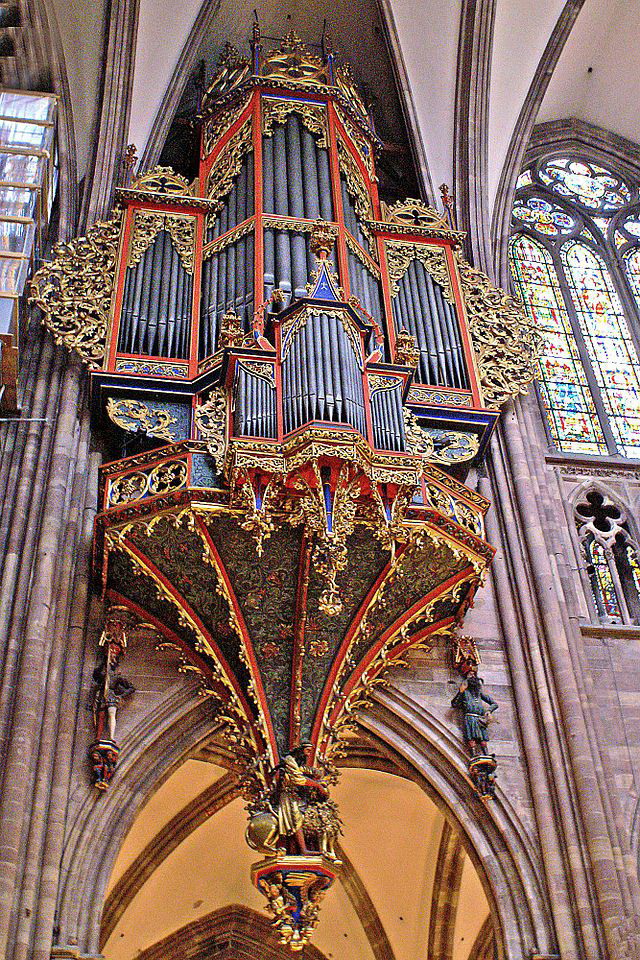 Poiché
anche la celebrazione della messa era
continuamente disturbata da rumori e interventi
sarcastici provenienti dall'automa del venditore
di brezel, Jean Geiler de Kaysersberg, alla fine
del XV secolo, invocò a più riprese la
soppressione di questa tradizione, ma gli automi
continuarono a essere utilizzati. La tradizione
fu interrotta dalla Riforma, nella seconda metà
del XVI secolo, anche se gli automi vennero
lasciati al loro posto. Poiché
anche la celebrazione della messa era
continuamente disturbata da rumori e interventi
sarcastici provenienti dall'automa del venditore
di brezel, Jean Geiler de Kaysersberg, alla fine
del XV secolo, invocò a più riprese la
soppressione di questa tradizione, ma gli automi
continuarono a essere utilizzati. La tradizione
fu interrotta dalla Riforma, nella seconda metà
del XVI secolo, anche se gli automi vennero
lasciati al loro posto.
Il
17 marzo 1384 l'organo bruciò in un incendio,
andando completamente distrutto. I due
"rohraffes", però, scamparono alle
fiamme. Si decise allora di costruire subito un
nuovo strumento, il quale venne ultimato già
l'anno successivo. È a questo periodo che
risale il grande pendaglio posto sotto la cassa,
ornato dalla già citata scena di Sansone e il
leone e da un sostegno con tre angeli che
suonano un liuto, una chitarra e un organo
portativo. Appeso al positivo tergale è
presente un pendaglio più piccolo, decorato da
due selvaggi che si arrampicano a un albero.
L'organaro è sconosciuto, anche se si ipotizza
il nome di Corrado da Rotenburg. La cassa,
invece, è opera di Michele da Friburgo.
Nel
1434 lo strumento venne sostituito da un organo
nuovo, realizzato da Michel Gerlach (o Grolach)
e da Pierre Generis (o Gereis). Frédéric Krebs
(o Krebser), nel 1491, collocò l'organo
all'interno della cassa attuale, alta 24 metri e
larga 8. Erano presenti anche delle ante a
protezione delle canne: quelle del corpo
centrale erano dipinte con l'adorazione dei
Magi, mentre quelle del positivo erano decorate
da una natività. Lo strumento di Krebs era
dotato di tre manuali, i primi due accoppiabili,
e dieci mantici.
A
differenza degli strumenti precedenti, nei quali
tutte le canne suonavano insieme
contemporaneamente, lo strumento di Krebs era
invece sicuramente dotato di registri inseribili
e disinseribili, a eccezione però del
grand'organo, nel quale i registri erano ancora
indivisibili. Poiché Krebs, in tedesco,
significa granchio, l'organaro posizionò
due ornamenti a forma di chele sopra il
positivo. L'organo fu rinnovato fra il 1507 e il
1511 da Hans Süss, il quale modificò numerosi
registri e alzò il corista del La. Nel 1542
Hans Schentzer eseguì alcune riparazioni,
seguite da altre nel 1564 a opera di Sigmund
Peistle.
Circa
un secolo dopo, Antoine Neuknecht ricevette
l'incarico di rinnovare lo strumento. Neuknecht
aumentò l'estensione dei manuali e della
pedaliera e cambiò qualche registro, ultimando
i lavori nel 1609. I mantici erano dodici, a
cuneo, i manuali disponevano di 42 note e il
corista del La era molto alto, forse intorno ai
510 Hz.
Dopo
la guerra dei trent'anni Mathias Tretzscher (o
Troestler, Tretscher, Tretzscher) ricevette
l'incarico di restaurare lo strumento,
lavorandoci dal 1624 al 1660. Tretzscher realizzò
un vero grand'organo (fino ad allora tutti i
registri presenti suonavano contemporaneamente),
aumentò l'estensione dei manuali e abbassò il
corista del La. La facciata e la cassa furono
preservate, ma le ante vennero rimosse.
Andreas
Silbermann, nel 1713, descrisse lo strumento
come inaccordabile e non riparabile, parlando
anche di numerosi registri non funzionanti.
Silbermann voleva realizzare un nuovo strumento,
con una cassa nuova, da posizionare sotto il
rosone centrale. I superiori della chiesa,
invece, gli imposero di mantenere la cassa
gotica e la posizione nella navata. Il contratto
venne firmato il 23 febbraio 1714 e i lavori si
conclusero nell'agosto 1716. Si trattava di un
grande strumento, dotato di tre manuali,
pedaliera, 39 registri, 2.242 canne, sei somieri
e dodici mantici, sul quale era presente una
placca con l'iscrizione: «Er heisset Silbermann
Werk und seine seynd Gülden» (tedesco arcaico:
Il suo nome è Silbermann, ma i suoi lavori
sono d'oro, giocando sul fatto che silbermann,
letteralmente, significa uomo d'argento).
Nel
1833 i superiori della chiesa decisero di
rinnovare lo strumento, affidando i lavori a
Georges Wegmann. Il maestro di cappella Joseph
Wackenthaler, tuttavia, desiderava un organo
sinfonico: nel 1850 elaborò il progetto per un
organo completamente nuovo, e, per il 1869,
aveva programmato un intervento di rifacimento a
opera di Aristide Cavaillé-Coll. La guerra
franco-prussiana del 1870, però, fece sfumare
qualsiasi progetto.

Il
conflitto danneggiò lievemente lo strumento,
che venne riparato da Charles Wetzel nel 1873 e
nel 1876. Heinrich Koulen, nel 1880, propose di
modificare completamente la trasmissione
dell'organo, dotandolo di un sistema pneumatico.
La sua idea venne accettata nel 1889 e i lavori
si conclusero nel 1897, ma gli fu impedito di
manomettere la cassa gotica. Koulen, inoltre,
aggiunse sette registri al positivo, quattro al
grand'organo, nove al recitativo e quattro alla
pedaliera, dando allo strumento una sonorità
prettamente ottocentesca. Al termine dei lavori,
Koulen, accusato di aver irreparabilmente
manomesso un capolavoro dell'arte organaria
antica, venne duramente contestato.
All'inizio
del XX secolo si aprì una crepa su uno dei
pilastri che sostengono il peso della volta. Per
poter costruire le impalcature, l'organo venne
smontato e rimosso poco prima dello scoppio
della Prima guerra mondiale. Purtroppo, a causa
del conflitto, le autorità militari ordinarono
di requisire tutto il metallo disponibile, e le
canne vennero così fuse a scopi bellici.
Solamente alcune delle canne della facciata,
risalenti all'organo di Frédéric Krebs, si
salvarono.
Dopo
la guerra vennero proposti diversi progetti per
la realizzazione di un nuovo strumento, dotato
di trasmissione meccanica, il più simile
possibile all'organo di Andreas Silbermann. Alla
fine, la chiesa commissionò i lavori a
Edmond-Alexandre Roethinger. Quest'ultimo,
tuttavia, non era esperto nel realizzare
strumenti a trasmissione meccanica. Inoltre, la
profondità della cassa gotica era molto
limitata (da 120 a 150 centimetri), rendendo il
lavoro ancora più complesso. Per risolvere la
situazione, Roethinger decise di costruire un
organo a trasmissione pneumatica, terminando i
lavori nel 1935.
Lo
strumento, tuttavia, si rivelò insoddisfacente,
anche per via dell'acustica della cattedrale,
non adatta alle sonorità di un organo
sinfonico. Max Roethinger, nel 1959, eseguì
alcune modifiche. Durante gli anni Settanta la
chiesa decise di rinnovare l'organo. I lavori
vennero affidati ad Alfred Kern, il quale si
avvalse della collaborazione di Michel Chapuis
per realizzare uno strumento stilisticamente
adatto alla cattedrale.
Il
nuovo organo, completato nel 1981, è dotato di
trasmissione meccanica, l'aria è fornita da due
mantici, il corista del La corrisponde a 440 Hz
e il temperamento è equabile.
Un
organo nel coro, detto dei tre re,
venne citato per la prima volta nel 1352 e restò
nell'edificio fino al 1400. Fra il 1400 e il
1402 fu realizzato un nuovo strumento,
sostituito nel 1478 da un piccolo organo
costruito da Frédéric Krebs (o Krebser).
Mathias Tretzscher (o Troestler, Tretscher,
Tretzscher), nel 1660, realizzò uno strumento
di piccole dimensioni e lo pose sul jubé, e lì
restò fino al 1681, anno in cui fu trasferito
nella chiesa di Temple Neuf. Nel 1694, però, è
attestata nuovamente la presenza di un piccolo
organo all'interno della cattedrale. I superiori
della chiesa, all'inizio del XVIII secolo,
decisero di far realizzare un nuovo strumento,
affidando i lavori a Joseph Waltrin, il quale li
ultimò nel 1712. Intorno al 1727 lo strumento
venne spostato dal jubé al coro e andò
completamente distrutto durante la Rivoluzione
francese. Per gran parte del XIX secolo la
cattedrale restò priva dell'organo del coro,
finché, nel 1878, Joseph Merklin portò a
termine un nuovo strumento. Edmond-Alexandre
Roethinger eseguì alcune riparazioni nel 1909,
seguite da altre nel 1958. Nel 1970 la chiesa si
rivolse a Jean-Georges Koenig per rinnovare lo
strumento, che venne ultimato nel 1976.

 Pag.
2
Pag.
2
|