|
Avignone
è
una
città
della
Francia
meridionale,
situata
sulle
rive
del
Rodano,
immediatamente
a
nord
della
pianura
della
Bassa
Linguadoca.
Già
in
età
romana
fu
un
fiorente
municipio
della
Gallia
Narbonese;
occupata
in
seguito
dai
Burgundi,
dagli
Ostrogoti
e
dai
Franchi,
dal
933
fece
parte
del
regno
di
Arles;
divenne
comune
autonomo
dal
1146
e
nel
1290
fu
annessa
ai
territori
del
conte
di
Provenza,
Carlo
d'Angiò.
Dal
1309
al
1377,
la sede
stabile
del papato non
fu
Roma,
ma Avignone,
città
della Francia meridionale.
La
presenza
dei
sovrani
pontefici,
avrebbe
dovuto
essere
provvisoria,
ma
si
protrarrà
fino
al
1377.
Inizialmente
una
piccola
città,
durante
il
periodo
in
cui
ospiterà
i
papi Avignone si
trasformerà
in
una
vera
capitale,
con
una
corte
in
grado
di
attirare
alcuni
tra
i
maggiori
artisti
e
uomini
di
lettere
dell’epoca.
Il
regno
di Filippo
IV di
Francia
(1268
–
1314,
re
dal
1285),
detto
il
Bello,
era
stato
contraddistinto
da
un
drammatico conflitto
con
il
papato.
Per
questo
motivo,
durante
il
turbolento
conclave
del
1305,
che
si
svolge
a
Perugia,
fece
il
possibile
per
assicurarsi
l’elezione
di
un papa
francese: Clemente
V.
Il
nuovo
papa,
che
pure
aveva
intenzione
di
recarsi
prima
o
poi
a
Roma,
fu
incoronato
a
Lione.
Cagionevole
di
salute
e
impegnato
in
complesse
e
prolungate
trattative
col
re
di
Francia,
non
lasciò
mai
la
Francia:
nel
1309
si
trasferì
ad Avignone,
già
al
tempo
proprietà
di
Carlo
II
d’Angiò,
re
di
Napoli
e
conte
di
Provenza,
un
fedele
vassallo
del
papa.
D’altro
canto, Roma,
in
questi
anni
funestata
da
una
guerra
tra
fazioni,
per
i
papi
era tutt’altro
che
sicura.
All’inizio,
in
ogni
caso,
non
ci
fu
il
progetto
di spostare
la
capitale
della
Cristianità
da
Roma
ad
Avignone:
in
passato
era
già
capitato
che
un
pontefice,
per
qualche
anno, si
allontanasse
da
Roma.

Il
papa
successivo,
Giovanni
XXII
(al
secolo
Jacques
Duèse,
1245
-
1334,
eletto
papa
nel
1316),
era
stato
vescovo
di Avignone,
servendo
da
vicino
il
suo
predecessore
dal
1310:
rimanervi,
fu
per
lui
una
scelta
piuttosto
naturale.
A
partire
dal papato di
Clemente
V,
le
ingerenze
della monarchia
francese furono
talmente
gagliarde
da
rendere
inevitabile
e
una
progressiva
‘francesizzazione’
del papato.
Basti
pensare
al
fatto
innegabile
che
tutti
e
sei
i
successori
di
Clemente
V,
eletti
dal
1316
e
fino
al
1378,
nonché
111
dei
134
cardinali
da
loro
nominati,
furono
francesi.
Nonostante
questo,
il papato
avignonese -
tradizionalmente
visto
come
un’autentica
catastrofe per
la
chiesa
-
non
fu
semplicemente
una
dipendenza
del papato dal
re
di
Francia.
In
questi
anni,
al
contrario,
i
papi
introdussero
una
serie
di innovazioni
determinanti:
una
centralizzazione
amministrativa,
riforme
del
clero, tentativi
di
evangelizzazione
in
Cina,
e interessanti
politiche
universitarie.
Nonostante
questo
il
prestigio
del papato,
visto
dai
contemporanei
come
un’istituzione
asservita
alla
monarchia
francese,
ed
anche
per
il
suo
antagonismo
con
l’Inghilterra e
con
l’Impero,
ne
risultò
inevitabilmente
danneggiato,
tanto
da
essere
una
delle
principali
cause
del
successivo scisma
d’Occidente.
Giovanni
XXII,
tra
le
altre
cose,
condannò
come eresia la
dottrina
che
proclamava
la
povertà
assoluta
di Cristo,
e
con
il
sostegno
di
Napoli
lanciò
quasi
una crociata,
nella
speranza
di
recuperare
il controllo
d’Italia,
contro
il
potente
stato
dei Visconti,
signori
di
Milano (1320),
tentando
di
facilitare
un ritorno
a
Roma
del
papato.
Intervenne
poi
pesantemente
nella
contesa
per
il trono
imperiale tra
Ludovico
IV
detto
il
Bavaro
(1287-1347)
ed
il
duca
d’Austria
Federico
I
(detto
anche
lui
il
Bello,
1289-1330).

Il
suo
successore Benedetto
XII (morto
nel
1342,
eletto
papa
nel
1334),
iniziò
la
costruzione
del
costosissimo palazzo
dei
papi
ad
Avignone,
continuò
a
riformare
la
chiesa
e
tentò
di
lanciare,
senza
successo,
una
crociata
nel
1335.
In
questi
anni
la corte dei
papi
presso
Avignone raggiungeva
il
suo
massimo
splendore.
Con Clemente
VI (1291-1352,
papa
dal
1342), si
riaprì
la
lotta con
l’imperatore
Lodovico
il
Bavaro.
Anche
lui
tentò
di
intervenire
in Italia,
ma
con
esiti
incerti:
approvò
inizialmente
l’operato
di Cola
di
Rienzo (1313-1354)
a
Roma,
per
poi
scomunicarlo,
e
nel
1351
cedette
Bologna
ai Visconti.
Fu
lui,
nel
1348,
ad
acquistare
definitivamente
Avignone
per
80.000
fiorini
d’oro,
rendendola
da
allora
una
proprietà
del papato.
Innocenzo
VI (morto
nel
1362,
papa
dal
1352),
tentò
senza
successo
di riappacificare
Francia
ed
Inghilterra,
nella
fase
finale
della Guerra
dei
cent’anni (1337-1453);
limitò
poi
il
potere
dei
cardinali
e
tentò
una
riforma
del
clero.
Il
suo
più
importante
successo
fu
tuttavia
l’ottenimento
dell’incoronazione
a
Roma
(1355)
del
nuovo
imperatore,
Carlo
IV,
celebrata
però
da
un
legato
pontificio.
Urbano
V (1310-1370,
papa
dal
1362),
riuscì
ad
allontanare
i
Visconti
da
Bologna,
e
tentò
un
primo
ritorno
a
Roma
(1367)
di
breve
durata.
La
storia
artistica
di
Avignone
durante
il
Medioevo
ha
una
rilevanza
straordinaria,
ma
non
conosce
uno
svolgimento
lineare
e
omogeneo.
Fino
all'inizio
del
Trecento
essa
si
inquadra
senza
contrasti
nella
più
generale
vicenda
artistica
della
Provenza.
I
suoi
monumenti,
le
sue
sculture,
le
sue
costruzioni
trovano
molti
confronti
con
monumenti
e
opere
create
nel
territorio
dell'arcidiocesi
di
Arles,
da
cui
dipese
il
vescovado
di
Avignone
fino
al
1475,
quando
la
città
fu
proclamata
sede
metropolitana.
La
situazione
cambiò
radicalmente
quando
i
pontefici
-
e
di
conseguenza
la
curia
-
vennero
a
installarsi
nella
città
provenzale
facendo
di
essa
per
molti
decenni
(1316-1376)
la
capitale
della
cristianità.
La
mole
e
il
numero
delle
imprese
artistiche
allora
portate
avanti,
la
varietà
dei
committenti
e
degli
artisti
giunti
ad
Avignone
da
città
e
nazioni
molto
diverse,
ne
alterarono
radicalmente
la
situazione
e
il
ruolo,
facendone
uno
dei
centri
artistici
più
vivi,
importanti
e
significativi
dell'Europa
intera,
un
luogo
di
incontri,
di
scambi,
di
incroci,
un
autentico
crogiuolo
dove
le
diverse
esperienze
vennero
a
confronto,
si
intrecciarono,
si
fusero.

Ad
ottenere
il definitivo
ritorno
a
Roma del papato sarà Gregorio
XI (1329-1378,
papa
dal
1370),
convinto
che
fosse
l’unico
modo
per
placare
la
turbolenta
situazione
a
Roma
e
ristabilire
un
equilibrio
in
Italia,
martoriata
da
conflitti
tra
comuni,
signori
e
fazioni,
e
dove
i
Visconti
continuavano
a
puntare
su
Bologna
e
la
Romagna.
L’intenzione
definitiva
di
tornare
da Avignone fu
annunciata
nella
primavera
del
1372.
Non
fu
semplice
l’organizzazione,
che
si
protrasse
per
anni
e
costò
una
fortuna
alle
finanze
del papato.
Il
viaggio
vero
e
proprio
si
protrasse
dal
settembre
del
1376
al
gennaio
del
1377.
Arrivato
a
Roma,
il
papa,
ormai
malato,
morì
nel
marzo
del
1378:
da
allora
non
ci
sarebbero
più
stati
papi
di
nazionalità
francese.
Ragioni
di
immagine,
di
legittimazione
nei
confronti
di
Roma,
di
primato,
di
dominazione
simbolica,
incoraggiarono
in
questo
periodo
gli
investimenti
artistici.
Sorsero
nuove
fondazioni,
nuove
chiese,
vennero
scolpiti
eccezionali
monumenti
funerari.
Né
gli
investimenti
simbolici
vennero
a
cadere
completamente
quando,
in
un
momento
successivo,
la
città
perse
il
suo
prestigioso
ruolo
europeo
per
divenire
sede
dei
legati
papali.
Per
tutto
il
Quattrocento
Avignone,
enclave
papale
in
territorio
angioino,
continuò
a
essere
un
importante
centro
artistico,
un
luogo
di
scambi
e
di
incontri,
un'area
cerniera.
Il
successore Urbano
VI (1318
-
1389,
papa
dal
1378),
si
scontrò
da
subito
con
la
curia,
ed
in
particolare
con
i cardinali
francesi,
molti
dei
quali,
gelosi
delle
proprie
prerogative
e
dunque
contrari
al
ristabilimento
del papato
a
Roma,
si
rifugiarono
a
Fondi.
Qui,
con
il
pretesto
di
alcune
irregolarità
ma
con
il
reale
intento
di
riportare
il papato
ad
Avignone,
elessero
un
secondo
papa,
l’antipapa Clemente
VII.
La cristianità
occidentale
restò
così
divisa
in
due (e
talvolta
in
tre)
fino
al
1417,
e
ancora
una
volta
Avignone giocò
il
suo
ruolo
di
sede
papale,
dove
si
trasferirono
i
due
antipapi
Clemente
VII
e
Benedetto
XIII.
Lo Scisma
d'Occidente fu
un
tentativo,
da
parte
del
collegio
dei
cardinali,
di
limitare
l’assoluto
potere
del
papa,
ma
anche
e
soprattutto
la
conseguenza
di
interessi
nazionali
ed
economici:
contrariamente
ad
altri
scismi
nella
storia,
infatti, non
c’era
nessun
disaccordo
di
tipo
dottrinale.
Queste
considerazioni
hanno
portato
molti
storici
ad
individuare
nello Scisma
d’Occidente
una
crisi
profonda,
al
termine
della
quale
i
rapporti
tra
il papato ed
i
paesi
Europei
ne
usciranno
fortemente
e
definitivamente
ridimensionati.
Dopo
una
complessa
serie
di
concili
ed
elezioni
contestate,
nel
1417
verrà
eletto
a
Costanza
un
pontefice
dalla
quasi
totalità
del
collegio
dei
cardinali:
il
romano
(per
la
verità
nato
a
Genazzano) Martino
V (1368-1431),
della famiglia
Colonna.
Il ritorno
del
pontificato
a
Roma non
fu
scontato:
i
cardinali
francesi
proponevano
naturalmente Avignone,
e
l’imperatore
Sigismondo
alcune
città
tedesche.
Il
papa
si
stabilì
a
Roma
soltanto
nel
1420,
al
termine
di
un
lungo
viaggio.
Quanto
ad Avignone,
sarà
governata
da
un
legato
pontificio
fino
al
1791,
anno
in
cui
verrà
annessa
alla
Francia
rivoluzionaria.

Monumenti
A
voler
tracciare
una
storia
basata
sui
monumenti
ancora
esistenti,
la
vicenda
artistica
avignonese
dovrebbe
iniziare
nel
XII
secolo.
A
questo
periodo
risalgono
infatti
le
grandi
testimonianze
monumentali
tuttora
conservate.
Si
sa
però
che
la
storia
monumentale
di
Avignone
è
assai
più
antica
e
che
non
presenta
una
decisa
soluzione
di
continuità
con
l'epoca
romana.
Ci
fu,
naturalmente,
un
restringersi
dello
spazio
abitato,
un
suo
raccogliersi
sull'altura
dominante
il
Rodano
dove
era
sorto
il
primo
agglomerato
preromano.
Il
più
antico
luogo
di
culto
cristiano
doveva
trovarsi
fuori
dello
spazio
urbano,
laddove
poi
venne
fondata
l'abbazia
di
Saint-Ruf,
presso
l'antica
strada
romana
che
portava
ad
Arles.
Qui
venne
rinvenuto
un
sarcofago
di
tipo
arlesiano
con
la
rappresentazione
dell'episodio
di
Anania
e
di
Saffira,
oggi
conservato
al
Museo
Calvet
di
Avignone.
Ben
poco
peraltro
si
conosce
della
storia
di
Avignone
nell'Alto
Medioevo;
è
possibile
che
un
monastero
fosse
stato
fondato
nel
VII
secolo
da
S.
Agricola,
vescovo
di
Avignone,
e
che
esso
sia
all'origine
della
odierna
chiesa
di
Saint-Agricol,
ma
notizie
più
precise
si
trovano
solo
nel
X
e
XI
secolo;
per
oltre
un
secolo
e
mezzo,
dal
700
all'855
non
si
conosce
del
resto
un
solo
nome
di
vescovo
avignonese.
È
possibile
che
la
chiesa
di
Saint-Pierre
esistesse
già
nel
919
e
che
vi
fosse
conservato
il
corpo
del
santo
vescovo
Agricola,
ma
le
prime
date
consistenti
risalgono
al
secolo
seguente:
nel
1039
una
nuova
comunità
di
religiosi
fu
autorizzata
dal
vescovo
Benedictus
a
Saint-Ruf
e
nel
1068
un
testo
emanato
dal
vescovo
nomina
la
chiesa
di
Saint-Didier.
Nel
1069
(o
nel
1063)
si
colloca
la
consacrazione
della
cattedrale
di
Notre-Dame
des
Doms,
elemento
principale
del
complesso
episcopale
posto
sul
Rocher
des
Doms,
che
comprendeva
anche
il
battistero
di
Saint-Jean,
la
chiesa
parrocchiale
di
Saint-Etienne
e
la
residenza
vescovile,
mentre
sull'altra
riva
del
Rodano,
laddove
sorse
in
seguito
Villeneuve,
era
riattata
verso
il
980
l'abbazia
benedettina
di
Saint-André.
Altra
impresa
rilevante
del
XII
secolo
fu
la
costruzione
del
ponte
sul
Rodano,
iniziato
nel
1179
da
un
frater
Benedictus
(il
leggendario
Saint-Bénézet
che
ha
dato
nome
al
ponte),
terminato
nel
gennaio
1185,
molte
volte
rovinato
e
restaurato,
di
cui
rimangono
oggi
alcune
arcate
e
la
cappella
consacrata
a
S.
Nicola,
in
parte
romanica.
A
questo
periodo
appartiene
anche
una
grande
lunetta
scolpita
con
il
rilievo
di
un
cavaliere
armato
che
proviene
dall'antico
palazzo
del
comune,
situato
anch'esso,
come
quello
del
vescovo,
sul
Rocher
des
Doms.
Il
periodo
comunale
(1146-1251)
fu
estremamente
prospero
per
Avignone,
che
vide
in
questi
anni
l'estendersi
della
città
e
la
costruzione
successiva
di
due
cinte
di
mura,
una
probabilmente
nella
prima
metà
del
XII
secolo,
l'altra
verso
il
1220-1225,
smantellata
dopo
l'assedio
di
Luigi
VIII
nel
1226
e
quindi
restaurata.
Alla
seconda
metà
del
XIII
secolo,
quando
oramai
era
finito
il
periodo
comunale
e
Avignone
apparteneva
in
co-signoria
ai
due
fratelli
del
re
di
Francia,
Alfonso
di
Poitiers,
conte
di
Tolosa,
e
Carlo
d'Angiò,
conte
di
Provenza,
risale
la
costruzione
del
primo
edificio
religioso
eretto
secondo
i
modi
gotici
del
Nord,
la
cappella
a
due
piani
della
commenda
dei
Templari,
ancora
conservata
e
inglobata
in
un
edificio
ottocentesco.

Lo
stabilirsi
della
sede
papale
in
Avignone
non
avvenne
in
modo
improvviso
e
definitivo.
Fu
piuttosto
un'operazione
graduale
che
solo
a
un
certo
momento
assunse
un
carattere
massiccio
e
irreversibile.
Per
il
primo
papa
avignonese,
Clemente
V,
eletto
nel
1305,
Avignone
fu
tutt'al
più
una
residenza
di
fortuna
dove
risiedette,
dal
1309,
nel
convento
dei
Domenicani,
mentre
la
corte
aveva
trovato
una
provvisoria
installazione
a
Carpentras.
Non
era
intenzione
del
nuovo
papa
abbandonare
definitivamente
Roma
e
l'Italia
e
la
sua
politica
artistica
risentì
anche
di
questa
situazione,
sì
che
riguardò
assai
poco
la
città
provenzale.
La
situazione
però
mutò
radicalmente
dopo
la
sua
morte
(20
aprile
1314),
con
il
lungo
pontificato
di
Giovanni
XXII
(1316-1334).
Questi,
che
tra
il
1310
e
il
1312
era
stato
vescovo
di
Avignone,
si
installò
con
la
sua
corte
nella
città,
facendo
riattare
e
decorare
con
nuove
pitture
il
palazzo
vescovile,
mutando
compiti
e
funzioni
della
corte,
che
vide
aumentare
grandemente
il
numero
degli
addetti,
facendo
di
Avignone
un
grande
centro
internazionale.
Si
trasformò
così
la
fisionomia
della
committenza
avignonese;
accanto
al
papa
si
stabilirono
in
Avignone
i
cardinali,
che
si
installarono
nelle
'livree'
(termine
con
cui
si
indicavano
le
case
che
venivano
consegnate
ai
membri
del
sacro
collegio
per
farne
la
loro
residenza),
giunse
una
folla
di
intellettuali,
re
e
potenti
vi
eressero
dimore
dove
risiedere
durante
i
loro
soggiorni.
Si
trasformò
di
conseguenza
la
fisionomia
artistica
della
città,
che
divenne
un
grande
centro
di
produzione
libraria
e
un
punto
di
incontro
di
artisti
di
diverse
provenienze
che
vi
convergevano
per
lavorare
alle
nuove
fabbriche.
Il
pontefice
si
preoccupò
dello
stato
dei
monumenti
avignonesi,
deplorando,
in
una
bolla
del
21
novembre
1319,
lo
stato
rovinoso
del
chiostro
romanico
della
cattedrale,
ingrandendo
la
chiesa
di
Saint-Agricol,
dove
nel
1322
fondò
un
collegio
di
canonici,
riattando
e
decorando
gli
antichi
castelli
vescovili
del
contado
venassino,
intervenendo
nei
monasteri
dei
Domenicani
e
dei
Francescani
e
in
diverse
altre
chiese
cittadine.
Molti
sono
i
nomi
degli
artisti
meridionali,
tra
cui
quello
di
un
Petrus
Masonerii
incaricato
di
molte
imprese
nelle
chiese
avignonesi.
Tra
gli
inglesi
furono
l'architetto
Hugh
Wilfred,
che
costruì
tra
il
1321
e
il
1322
una
cappella
in
Notre-Dame
des
Doms,
e
un
pittore,
Thomas
Daristot
-
attivo
ad
Avignone
e
al
nuovo
castello
di
Pont-de-Sorgues,
costruito
per
alloggiare
gli
ospiti
di
qualità
-,
in
cui
si
è
voluto
riconoscere,
ma
con
scarsa
probabilità,
quel
maestro
Thomas,
figlio
di
Walter
di
Durham,
pittore
di
Edoardo
II
e
autore
della
splendida
decorazione
dei
sedilia
di
Westminster.
Forse
era
di
origine
inglese
anche
Jean
Oliver,
autore
dei
dipinti
fortemente
gotico-lineari
del
refettorio
della
cattedrale
di
Pamplona.
È
infine
molto
probabile
che
giungesse
in
questo
periodo
in
Avignone
un
grande
pittore
e
miniatore
italiano,
il
Maestro
del
Codice
di
S.
Giorgio,
attivo
per
l'ambiente
dei
cardinali
italiani.
La
fisionomia
artistica
avignonese
si
arricchì
ulteriormente
sotto
Benedetto
XII
(1334-1342),
successore
di
Giovanni
XXII.
A
questo
punto
si
precisò
la
scelta
di
Avignone
come
residenza
stabile
della
curia
e
pertanto
venne
eretto
un
palazzo
nuovo
che,
accanto
agli
appartamenti
del
pontefice,
potesse
ospitare
i
principali
uffici
della
curia.
E
a
questo
punto
si
infittì
l'arrivo
di
artisti
provenienti
da
diverse
regioni
e
nazioni,
e
in
particolare
dei
pittori
senesi,
tra
cui,
dal
1336,
uno
dei
massimi
artisti
d'Europa,
Simone
Martini.
Di
persona
-
o
almeno
per
opera
-
furono
presenti
anche
Lippo
Memmi
e
suo
fratello
Tederico,
mentre
lavorarono
alla
decorazione
del
nuovo
palazzo
Filippo
e
Duccio
di
Siena,
che
i
conti
pontificali
indicano
come
pittori
di
primo
piano,
accanto
a
maestri
della
Francia
meridionale
quali
Jean
Dalbon,
che
dirigeva
le
imprese
pittoriche
del
papa,
Domenico
de
Bellona,
Pierre
de
Castres,
Symonnet
de
Lyon,
Robin
de
Romans,
Pierre
Boyer.
I
lavori
di
costruzione
del
nuovo
palazzo
cominciarono
tra
il
1335
e
il
1336.
Per
questo
il
papa
cedette
al
vescovo
di
Avignone
la
livrea
cardinalizia
che
si
era
fatta
costruire
Arnaud
de
Via,
nipote
di
Giovanni
XXII,
in
cambio
dell'antico
palazzo
vescovile
già
trasformato
dal
suo
predecessore.

Avignone
è
un
vivace
centro
culturale
e
artistico,
conosciuta
in
tutto
il
mondo
per
essere
stata
sede
papale
sette
secoli
fa,
per
il
suo
Festival
Internazionale
di
musica
e
teatro
e
per
la
sua
gastronomia.
E'
anche
il
luogo
dove
il
nostro
Petrarca
incontrò
Laura,
nella
chiesa
di
Santa
Chiara,
e
se
ne
innamorò.
Avignone,
un
luogo
tutto
da
scoprire,
custodisce
un
eccezionale
patrimonio
storico-artistico,
come
il
Palazzo
dei
Papi
e
il
Ponte
di
St-Bénezet,
dichiarati
nel
1995
Patrimoni
dell'Umanità
dell'Unesco.
Le
acque
del
Rodano,
il
fiume
che
attraversa
la
città,
riflettono
sagome
di
bastioni,
campanili
e
tetti
di
tegola
rossa.
Un
luogo
suggestivo,
che
non
deluderà.
Avignone
venne
alla
ribalta
della
storia
come
sede
artistica
e
culturale
quando,
durante
il
XIV
secolo,
il
Papa
Clemente
V
vi
si
stabilì,
insieme
alla
Curia,
spostandosi
da
Roma
alla
Provenza,
sotto
l'egida
e
la
protezione
del
re
di
Francia
Filippo
il
Bello,
dando
vita
alla
cosiddetta
Cattività
Avignonese.
Da
quel
momento,
tra
il
1309
e
il
1377,
nella
'cité
des
papes'
(città
dei
Papi),
furono
investiti
grandi
quantità
di
soldi
nella
costruzione
e
la
decorazione
del
Palazzo
dei
Papi.
Anche
dopo
che
la
corte
pontificia
ritornò
a
Roma,
e
Avignone
diventò
un
luogo
malfamato
dove
imperversavano
bande
criminali,
la
città
rimase
un
notevole
centro
culturale.
Oggi
la
città
mantiene
le
sue
tradizioni
di
centro
artistico,
attraverso
un
calendario
fitto
di
appuntamenti,
tra
cui
spicca
il
famosissimo
Festival
D'Avignone
in
Luglio
che
attira
centinaia
di
migliaia
di
visitatori
ogni
anno
e
di
cui
più
sotto
potete
vedere
una
veloce
antologia
di
questo
ultimo
decennio.
Avignone
ha
una
popolazione
di
quasi
86.000
abitanti
ed
è
una
delle
più
importanti
città
storiche
della
Francia.
La
cittadina
si
trova
al
centro
di
un
territorio
da
sempre
strategico
per
le
via
di
comunicazione
e
per
questo
ambito
da
vari
potentati.
Dista
580
km
da
Parigi,
a
230
km
da
Lione
e
a
85
km
da
Marsiglia,
ed
è
capoluogo
del
dipartimento
del
Vaucluse,
sul
fiume
Rodano.
Le
città
più
vicine
sono
anch'esse
d'importanza
storica,
culturale
e
turistica,
come
Aix
en
Provence,
che
dista
soli
80
km,
e
Orange
(a
nord),
Nimes
e
Montpellier
(a
sud-ovest),
Arles
(a
sud)
e
Salon
de
Provence
(a
sud-est).
Il
centro
storico
di
Avignone
è
racchiuso
da
mura
medievali,
costruite
nel
1403
da
Benedetto
XII,
l'ultimo
dei
cosiddetti
anti-Papi.
Il
primo
di
questi
fu
per
l'appunto
Clemente
V
nel
1309.
Quest'ultimo,
fu
invitato
nella
città
(allora
parte
del
Regno
di
Arlese
circondata
dalla
contea
di
Comtat-Venaissant,
già
proprietà
della
Chiesa
dal
1274),
dall'astuto
re
Filippo
il
Bello,
(lo
stesso
che
incamerò
parte
delle
ricchezze
dei
templari
dopo
la
messa
al
bando
dell'ordine
cavalleresco),
con
il
pretesto
di
essere
protetto
dall'anarchia
e
dalle
lotte
tra
fazioni
della
Roma
di
quel
periodo.
In
realtà,
'ospitando'
il
Papa,
Filippo
vide
la
possibilità
di
estendere
il
proprio
potere
sulla
Chiesa,
ed
è
ciò
che
accadde.
I
Papi
comprarono
Avignone
dal
sovrano
angioino
per
80.000
fiorini
nel
1348
e
da
allora
fino
alla
Rivoluzione
Francese
la
città
e
la
contea
divennero
possedimenti
dello
Stato
della
Chiesa
(prima
sotto
il
Grande
Scisma
e
poi
sotto
la
Roma
papalina
attraverso
dei
delegati
pontifici).
L'eredità
lasciata
dalla
corte
papale
fa
di
Avignone,
una
delle
più
interessanti
e
belle
città
medievali
d'Europa.
Le
prime
mura
della
città
furono
in
origine
romane,
costruite
intorno
al
I
secolo
in
forma
rettangolare.
Purtroppo
non
esiste
alcun
documento
che
ne
verifichi
l'esatta
delimitazione.
Nel
XIII
secolo
il
re
di
Francia
Luigi
VIII
ne
ordinò
l'ampliamento,
conclusosi
nel
1248.
Le
pareti
oggi
visibili,
misurano
circa
8
metri
d'altezza
e
sono
caratterizzate
da
35
alte
torri
e
una
cinquantina
di
altre
più
piccole.
Tra
il
1309
e
il
1377,
Avignone
divenne
la
sede
più
importante
della
cristianità
cattolica,
e
un
ingente
quantità
di
denaro
fu
usata
nella
costruzione
di
quello
che
oggi
è
noto
come
il
Palazzo
dei
Papi,
attrazione
principale
e
simbolo,
insieme
al
ponte
spezzato,
dell'odierna
città.
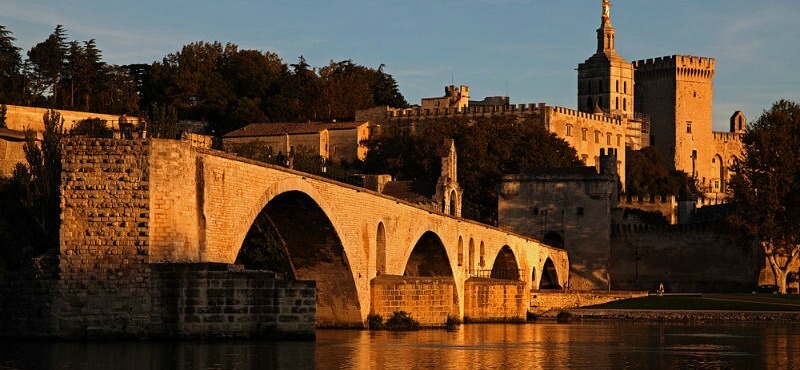
 Pag.
2
Pag.
2
|