Situato
su un promontorio che scende a
picco sul fiume Loir, il
castello offre l'aspetto di
un' austera e inespugnabile
fortezza, ma, appena entrati
nel cortile interno, appare
una lussuosa dimora signorile.
La
sua torre del XII sec. è uno
dei masti più imponenti e
meglio conservati. L'ala
Dunois (c.1460) e l'ala
Longueville (XVI sec.) sono
entrambi dotate di sontuose
scale, una in stile gotico
fiammeggiante, l'altra
rinascimentale. Degna di nota
la Sainte-Chapelle (XV sec.)
con le sue quindici statue e
le vaste cucine medievali.
All'indomani
delle invasioni normanne del
910, Thibaut le Tricheur,
conte di Blois, fa edificare
una fortezza a Chàteaudun. Nel XII
secolo, il suo discendente vi fa aggiungere un
imponente torrione.
Nel 1391, le contee di Blois e del Dunois
sono acquisite da Luigi d'Orléans, fratello del re di
Francia Carlo VI. Suo figlio
nel 1439 le offre in dono al
suo fratellastro Jean, detto
il "bastardo d'Orléans"
o "Dunois", compagno
d'armi di Giovanna d'Arco.
Nel 1452 inizia la
trasformazione del castello al
quale viene aggiunta una
Sainte-Chapelle. Questi lavori
saranno poi portati avanti dai
discendenti di Dunois, i duchi
di Longueville.
Quando
la famiglia Longueville si
estingue, nel 1694, il
castello passa in mano ai
duchi di Luynes.
Semiabbandonato, nel 1723
accoglie le vittime di un
incendio che ha devastato la
città.
Ormai danneggiato, durante
la Rivoluzione subisce il
saccheggio della sua cappella
e la trasformazione in caserma
dei suoi edifici. Il castello
viene ulteriormente
danneggiato dai Prussiani nel
1870. Viene acquisito dallo
Stato nel 1938 e restaurato
dall'architetto Jean
Trouvelot.

1
- Il cortile
d'onore presenta tre scale a
chiocciola che mostrano le
evoluzioni architettoniche
all'avvicinarsi del
Rinascimento, La prima, datata
intorno al 1460, è situata in una torre poligonale esterna, nel
rispetto della tradizione
francese. Le altre due,
interne, sono caratterizzate
dalle facciate a logge. La
prima, vicina all'ala Durtois,
datata intorno al 1470, è un
capolavoro dello stile gotico
fiammeggiante. All'altra
estremità dell'ala, la
seconda scala, dell'inizio del
XVI secolo,
resta gotica per la sua
pronunciata verticalità e per
il decoro scolpito
esteriormente, ma mostra
all'interno un decoro di
impronta italiana.
2
- Il
mastio, di forma circolare, ha
un'altezza complessiva di 42
metri un diametro di 17 metri. Fu
costruito nel 1180 con muri
spessi 4 metri e si articola
su tre livelli. L'accesso
all'edificio in origine
avveniva attraverso una porta
situata a 10 metri di altezza;
oggi questa porta è in
comunicazione con il solaio
della cappella.
 3
-
La cappella, costruita
tra il 1451 e il 1493, è stata edificata come
Sainte-Chapelle su decisione
del papa nel 1468. Jean
de Dunois, detto il
bastardo d'Orléans, compagno
d'armi di Giovanna
d'Arco, ricevette nel 1439 le
contee di Dunois e di Châteaudun dal fratellastro, Carlo
d'Orléans,
per l'aiuto nella guerra
contro gli inglesi. 3
-
La cappella, costruita
tra il 1451 e il 1493, è stata edificata come
Sainte-Chapelle su decisione
del papa nel 1468. Jean
de Dunois, detto il
bastardo d'Orléans, compagno
d'armi di Giovanna
d'Arco, ricevette nel 1439 le
contee di Dunois e di Châteaudun dal fratellastro, Carlo
d'Orléans,
per l'aiuto nella guerra
contro gli inglesi.
Dopo
essere stato nominato anche Gran ciambellano di Francia, fu considerato a tutti gli effetti un principe
di sangue reale, pur non
essendo mai stato
ufficialmente riconosciuto dal
padre. Egli iniziò
l'ampliamento del castello di
Châteaudun a partire dal 1451
e decise di fondare una
Sainte-Chapelle, che passasse
direttamente sotto l'autorità
papale.
Come
tutte le altre cappelle
fondate da principi reali,
anche questa aveva lo scopo di
commemorare gli esponenti di
una dinastia reale, quella dei
Valois-Orléans, comprendente
il nonno di Jean de Dunois, Carlo
V di Francia, suo cugino Carlo
VII di Francia, suo padre Luigi
I di Valois-Orléans, suo
fratellastro Carlo di
Valois-Orléans e sua
moglie Marie d'Harcourt.
Nonostante i membri della
casata fossero sepolti nella
basilica di Notre-Dame di Cléry,
i loro cuori furono conservati
in questa cappella.
La
cappella, intitolata alla Vergine e
a San Giovanni Battista,
protettori di Jean de Dunois e
di sua moglie, venne costruita
su due livelli in tre fasi.
Tra il 1460 e il 1464 furono
costruite la navata e la sala
superiore, la parete nord del
coro, la sacrestia e la volta
dell'oratorio sud. Infine, a
partire dal 1493, Agnese
di Savoia, vedova di Francesco I d'Orléans-Longueville, fece costruire il campanile, l'oratorio
nord e la parte orientale
dell'oratorio sud.
Nel
1492, il re Carlo
VIII di Francia ottenne
da papa Alessandro VI che
alla cappella del castello di
Châteaudun fossero concessi
gli stessi privilegi di quelli
di una Sainte-Chapelle. La
cappella era stata consacrata
nel 1465, mentre gli oratori
furono consacrati nel 1494.
Nel
1938 il castello fu acquistato
dallo Stato francese e venne
affidato al Centre
des monument nationaux,
venendo classificato come
Monumento storico nel 1918.
La
cappella è impreziosita con
dodici statue che
rappresentano i patroni della
cappella, la Vergine e San
Giovanni Battista, e dieci
santi scelti da Jean de
Dunois: San Giovanni
Evangelista, Santa Maria
Maddalena, Santa Caterina d'Alessandria, Santa
Margherita, Santa
Genoveffa, Sant'Apollonia, Santa
Barbara, Santa Maria
Egiziaca, Sant'Elisabetta
d'Ungheria e Santa
Radegonda. Nel 1494 furono
aggiunte le statue di San
Francesco e Sant'Agnese.
Un
dipinto a tempera, realizzato
probabilmente prima della
consacrazione degli oratori,
raffigurante il Giudizio
Universale orna la parete sud
dell'Oratorio di San
Francesco. Le vetrate colorate
della cappella furono
distrutte dai prussiani nel
1815 durante la battaglia
di Châteaudun. Anticamente la
cappella conservava tra le sue
reliquie un frammento della Vera
Croce posto in un
reliquiario d'oro.
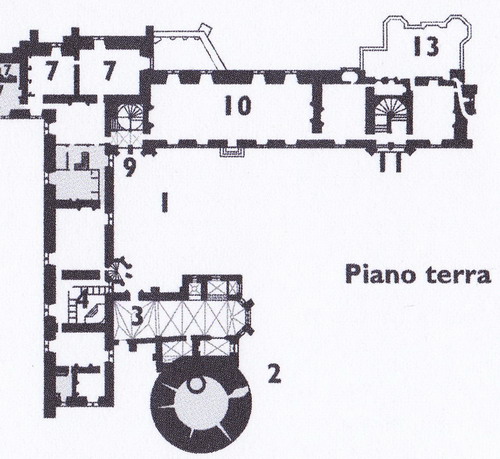
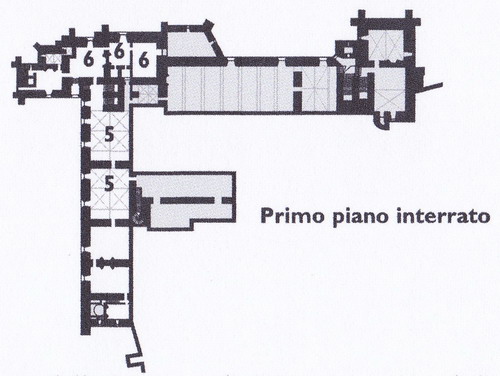
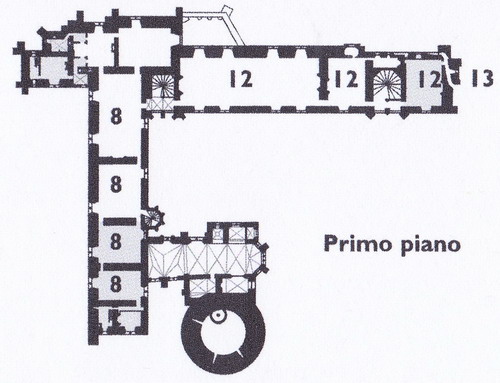
L'ala
Dunois
L'ala
ovest, o ala Dunois, fu voluta
da Jean de Dunois e fu
costruita intorno al 1460 in
stile gotico su cinque piani. Al
suo interno è conservata una
delle poche aule di tribunale
dell'Ancien Régime, che fu
rivestita in legno e decorata
con lo stemma reale nel
Seicento, quando Luigi
XIV soggiornò nel
castello, e che fu utilizzata
anche durante la Rivoluzione
francese. L'edificio
comprende uno scalone in stile
gotico che ricorda quello
voluto da Carlo V al Palazzo
del Louvre.
4
- La sala di giustizia è un raro esempio di giurisdizione
dell'Antico regime ad avere
conservato il suo decoro del XVII secolo.
Nel 1793 ha servito da
tribunale rivoluzionario.
5
-
Le cucine medievali, al
piano interrato, sono
particolarmente ben
conservate. Le loro volte a
ogiva sovrastano due grandi
caminetti.
 6
- Le prigioni, allo
stesso livello, comportano
diverse celle. 6
- Le prigioni, allo
stesso livello, comportano
diverse celle.
7
- L'edificio nord, al
piano terra, comprende diverse
stanze, tra cui una ornata di
gigli e di L incorniciate a
celebrazione delle visite al
castello di Luigi XIV,
nel
1682 e nel 1685. Di fianco, la
sala rivestita in legno era
utilizzata come sala da pranzo
dagli ultimi proprietari, i
duchi di Luynes.
8
- L'alloggio di Jean
Dunois si trova al primo
piano.
9
- La grande scala gotica
ricorda la celebre
"grande scala a
chiocciola" costruita al
Louvre durante il regno di
Carlo V.
Alla
sua sommità, i lucernari sono ornati di gigli per ricordare
che il proprietario del
castello è un discendente di
Carlo V.
L'ala
Longueville
L'ala
nord, o ala Longueville, è un
esempio di stile Luigi XII,
che costituisce una
transizione tra il gotico e lo
stile rinascimentale. L'inizio
della costruzione,
comprendente i piani
interrati, fu eseguito sotto
Francesco I di
Orleans-Longueville dal 1469
al 1491, mentre i piani
superiori furono completati da
Francesco II e dai suoi
discendenti durante il primo
quarto del XVI secolo,
utilizzando come materiale da
costruzione il tuffeau. L'ala comprende un'ampia stanza di 300 mq e una scala in stile
rinascimentale decorata con
motivi all'italiana, che
richiama la disposizione della
scala gotica dell'ala Dunois.
10
- La grande sala bassa di 300
mq, è dotata di due camini di
cui uno è sormontato da un
cervo in posizione detta
"di riposo".
11
-
La
grande scala rinascimentale
presenta, all'interno, un
decoro a motivi di stile
italiano sugli architravi
delle porte dei pianerottoli,
sui capitelli e sulle mensole
figurate.
12
- Negli
appartamenti di Caterina
d'Alençon, situati al piano
nobile dell'ala Longueville,
è conservata una collezione
di settanta arazzi, tra
cui una serie di sette pezzi
arazzi, classificati come
Monumento storico di Francia,
che rappresentano la Storia di
Clorinda e Tancredi, ispirata
alla Gerusalemme liberata di Torquato
Tasso. Il ciclo di arazzi
è stato realizzato a partire
da cartoni di Michel Corneille
dagli atelier del faubourg di
Saint-Germain a Parigi intorno
al 1661.
Al
piano terra della stessa ala,
negli appartamenti del Duca,
sono conservati i sette pezzi
dell'Arazzo dell'Antico
Testamento. Questi arazzi,
tessuti in lana e seta, furono
realizzati a Parigi nelle
botteghe del faubourg di
Saint-Marcel tra il 1640 e il
1650, sulla base di cartoni
del pittore Simon Vouet.
13
- La terrazza. Al suo posto vi
erano una stanza, una cappella
e uno studio, crollati nel XVIII secolo.


Il
giardino completa il
percorso-scoperta dedicato
alla gastronomia medievale.
Dodici riquadri piantati a
bossi racchiudono 150 specie dì piante conosciute nel Medioevo, qui classificate
per uso alimentare (piante
aromatiche, radici, ecc),
medicinale (antidoti, panacee,
rimedi femminili, ecc.) e
domestico (tinture, tessili,
ecc). Tutte le piante di uso
culinario erano considerate
medicinali.
La "teoria degli umori" formulata da
Galeno e Ippocrate fin
dall'Antichità raccomandava
un'alimentazione equilibrata
per conservare un'ottima
salute.
Un
volta si distinguevano quattro
temperamenti principali
(collerico, sanguigno,
flemmatico e melanconico)
derivati dai quattro elementi
e dai quattro umori (bile,
sangue, flemma e bile nera)
secreti dal corpo. Per Galeno
l'eccessiva produzione di un
umore provocava uno squilibrio
interno e quindi le malattie.
Pertanto era necessario
ristabilire l'equilibrio per
ristabilire la salute. Un
eccesso dì flemma (il raffreddore, ad esempio) sì curava
mangiando degli alimenti caldi
e secchi (spezie, carni
arrostite, ecc). Delle
etichette permettono di
individuare le piante che
calmano i temperamenti
collerici (rosso), sanguigni
(giallo), melanconici (viola)
e flemmatici (blu).
Pag.
6 
 Pag.
8
Pag.
8
|