Fondazione
Le
prime tracce di insediamenti
nell'area risalgono alla
cultura dell'uomo di
Neanderthal, con il famoso
ritrovamento dell'uomo di
Saccopastore.
Nella
zona di Roma sono stati
effettuati diversi
ritrovamenti, il più antico
dei quali si riferisce al sito
della Valchetta, con
resti risalenti a 65.000 anni
fa. Nella zona di Casal
de' Pazzi, uno scavo ha
restituito ossa di animali
risalenti a circa 20.000 anni
fa; mentre a Quadrato di Torre
Spaccata, presso la via
Tuscolana, sono stati portati
alla luce resti di un
insediamento del Neolitico
finale risalente a circa
6200-6100 anni fa e di un
altro della fine dell'età del
Rame risalente a
4700-4600 anni fa. Numerosi
altri insediamenti e necropoli
con tombe ipogeiche a
grotticella (facies di
Rinaldone, gruppo Roma-Colli
Albani e del Gaudo) sono stati
identificati nel territorio
del suburbio e coprono un arco
di tempo compreso tra il
Neolitico antico (facies della
Ceramica impressa
medio-tirrenica, circa 7600
anni fa) e la fine dell'età
del Rame (facies della
ceramica a pettine trascinato,
circa 4700-4000 anni fa),
documentando una intensa
frequentazione e sfruttamento
del territorio da parte di
comunità complesse e ben
strutturate.
Le
tracce successive risalgono
all'età del ferro e sono
riferibili all'arrivo di genti
di stirpe indoeuropea (Latini),
stando alle teorie correnti,
nel quadro di un generale
fenomeno di migrazione che
sembra essersi svolto verso la
penisola italiana in due
ondate successive (prima il
gruppo latino-falisco e quindi
il gruppo umbro-sabello). I Falisci occupavano
la valtiberina, tra i monti
Cimini e i Sabatini,
mentre i Latini si
erano stanziati nel Latium
vetus ("Lazio
antico"), che andava
dalla riva sinistra del corso
finale del Tevere ai Colli
Albani. Il loro territorio
confinava con quello di
diverse altre popolazioni, la
più importante delle quali
era sicuramente quella degli Etruschi,
a nord del Tevere.
I Volsci,
di origine osca,
occupavano la parte
meridionale del Lazio e
i monti Lepini; gli Aurunci,
la costa tirrenica a cavallo
dell'attuale confine tra Lazio
e Campania; a nord,
sull'Appennino, si trovavano i Sabini;
a est gli Equi. Nella
valle del Trero, gli
Ernici controllavano la
via commerciale per la
Campania e, tra Ardea ed Anzio,
erano stanziati i Rutuli.
La
posizione geografica della
futura Roma ebbe sicuramente
un ruolo fondamentale, posta
all'incrocio tra la via
fluviale e la via di terra
che, tramite il guado
dell'Isola Tiberina, mette in
collegamento l'Etruria con
la Campania, quindi il
mondo etrusco con
quello della Magna
Grecia. Nell'urbanistica
attuale si è conservato il
ricordo di questo passaggio:
da via Lungaretta, che
anticamente corrispondeva al
tratto finale della via
Aurelia, si scende dal Gianicolo fino
al moderno ponte Palatino (ma
che si trova accanto ai resti
dell'antichissimo ponte
Sublicio), per trovarsi nella
zona dell'antico mercato del Foro
Boario; da qui, lungo la valle
del Circo Massimo, si
arriva facilmente al punto
dove si biforcano la via
Latina e la via
Appia.
Fondazione
di Roma
La fondazione
di Roma, altrimenti detta Natale
di Roma, è stata
fissata al 21 aprile dell'anno 753
a.C., dal letterato
latino Varrone,
sulla base dei calcoli
effettuati dall'astrologo Lucio
Taruzio. Altre
leggende, basate su altri
calcoli indicano
date diverse. In realtà
Varrone conosceva bene la
Grecia e come tutti i Romani
del primo secolo a.C. aveva
numerose date tra le quali
scegliere per fissare la
fondazione dell'antica
Roma. Scelsero il 753
a.C. poiché si collegava alla
nascita della democrazia
ateniese, che avvenne
appunto con l'inizio della
nomina degli arconti
decennali e poi
annuali ad Atene.
I
Romani avevano elaborato un
complesso racconto mitologico sulle
origini della città e dello
stato; il racconto ci è
giunto con le opere storiche
di Tito
Livio, Dionigi
di Alicarnasso, Plutarco e
le opere poetiche di Virgilio e Ovidio,
quasi tutti vissuti nell'età
augustea. In quest'epoca le
leggende, riprese da testi più
antichi, vengono rimaneggiate
e fuse in un racconto
unitario, nel quale il passato
viene interpretato in funzione
delle vicende del presente. I
moderni studi archeologici,
che si basano su queste e su
altre fonti scritte, nonché
sugli oggetti e sui resti di
costruzioni rinvenuti in vari
momenti negli scavi, tentano
di ricostruire la realtà
storica che sta dietro il
racconto mitico, nel quale man
mano si sono andati
riconoscendo elementi di verità.
Secondo la storiografia moderna,
Roma non fu fondata con un
atto volontario ma, come altri
centri coevi dell'Italia
centrale, dalla progressiva
riunione di villaggi.
La
leggenda

Il
mito racconta di una
fondazione avvenuta a opera di Romolo,
discendente dalla stirpe
reale di Alba
Longa,
che a sua volta discendeva da Ascanio,
figlio di Creusa e di Enea,
l'eroe troiano giunto nel Lazio dopo
la caduta di Troia.
Il
viaggio di Enea: da Troia al Latium
vetus
- Come
si racconta nell'Eneide,
Enea, figlio della dea Venere,
fugge da Troia,
presa dagli Achei,
con il padre Anchise e
il figlioletto Ascanio. Il
viaggio che Enea percorre
prima di raggiungere le coste
del Latium
vetus (antico
Lazio) è lungo e pericoloso. Egli,
infatti, per volere di Giunone,
che si era adirata con lui, è
costretto ad approdare a Cartagine dove,
accolto dalla regina della
città, Didone,
se ne innamora e rimane per un
anno a regnare al suo fianco.
Ma per ordine del Fato e
di Giove,
Enea è costretto a ripartire,
prendendo la via dell'antico Lazio.
La disperazione di Didone nel
vedere l'amato allontanarsi la
porta al suicidio.
Dopo
varie peregrinazioni nel mar
Mediterraneo, Enea approdò
nel Lazio nel territorio di Laurento. Qui,
secondo alcuni, venne accolto
da Latino,
re degli Aborigeni, secondo
altri, fu costretto a
battersi. Il destino vuole che
il re italico fosse vinto in
battaglia e costretto a fare
pace con l'eroe troiano. Si
narra, inoltre, che una volta
conosciuta la figlia del re, Lavinia,
i due giovani si innamorarono
perdutamente l'uno dell'altra,
sebbene Lavinia fosse stata già
promessa in sposa a Turno,
re dei Rutuli.
Latino si convinse ad
assecondare i desideri della
giovane figlia ed a
permetterle dunque di sposare
l'eroe giunto da Troia,
pur sapendo che prima o poi
avrebbe dovuto affrontare
Turno, il quale non aveva
accettato che lo straniero
venuto da lontano gli fosse
preferito. Una volta sposati,
Enea decise di fondare una
città, dandole il nome di Lavinio (l'odierna Pratica
di Mare),
in onore della moglie.
La
guerra che ne seguì non portò
nessuna delle due parti a
rallegrarsi. I Rutuli furono
vinti e Latino, re alleato di
Enea, fu ucciso.
Virgilio
invece narra che la guerra tra
Italici e troiani ebbe inizio
dopo che Giunone provocò tra
le popolazioni rivali una
rissa nella quale morì il
giovane Almone,
cortigiano del re Latino. Il
conflitto vide il tiranno
etrusco Mezenzio e
la maggior parte delle
popolazioni italiche correre
in appoggio a Turno, mentre
Enea ottenne l'alleanza dei Liguri,
di alcune popolazioni greche
provenienti da Argo e
stanziate nella città di
Pallante sul Palatino,
regno dell'arcade Evandro e
di suo figlio Pallante,
nonché degli Etruschi ostili
a Mezenzio. Qui si inserisce
l'episodio dei ragazzi troiani Eurialo
e Niso che,
uscendo nottetempo dal campo
per andare incontro ad Enea,
fecero irruzione in quello dei
nemici, che giacevano
addormentati, e vi fecero una
strage di giovani guerrieri,
culminata con la decapitazione del
condottiero Remo (a
opera di Niso).
Eurialo
e Niso vennero scoperti e
uccisi. La guerra riprese
anche più cruenta: Pallante
cadde nel duello contro Turno,
che riuscì a spogliarlo della
cintura. Ma Enea capovolse le
sorti del conflitto uccidendo
Mezenzio. In seguito per
evitare altre vittime Turno si
decise a sfidare Enea, che
alla fine ebbe la meglio.
Ferito Turno, Enea fu tentato
di risparmiarlo, ma alla vista
della cintura di Pallante non
esitò ad ucciderlo, mettendo
così fine alla guerra. Enea
poté finalmente sposare
Lavinia e fondare la città di Lavinio.
 Da
Ascanio a Romolo e Remo -
Trent'anni
dopo la fondazione di Lavinio,
il figlio di Enea, Ascanio,
fonda una nuova città: Alba
Longa,
sulla quale regnarono i suoi
discendenti per numerose
generazioni (dal XII all'VIII
secolo a.C.)
come ci racconta Tito
Livio. Molto
tempo dopo il figlio e
legittimo erede del re Proca
di Alba Longa, Numitore,
viene spodestato dal fratello Amulio,
che costringe sua nipote Rea
Silvia,
figlia di Numitore, a
diventare vestale e
a fare quindi voto di castità
per impedirle di generare un
possibile pretendente al
trono. Il dio Marte però
s'innamora della fanciulla e
la rende madre di due gemelli, Romolo
e Remo,
quest'ultimo chiamato come il
condottiero rutulo decapitato
nel sonno da Niso durante la
guerra troiano-italica.
Da
Ascanio a Romolo e Remo -
Trent'anni
dopo la fondazione di Lavinio,
il figlio di Enea, Ascanio,
fonda una nuova città: Alba
Longa,
sulla quale regnarono i suoi
discendenti per numerose
generazioni (dal XII all'VIII
secolo a.C.)
come ci racconta Tito
Livio. Molto
tempo dopo il figlio e
legittimo erede del re Proca
di Alba Longa, Numitore,
viene spodestato dal fratello Amulio,
che costringe sua nipote Rea
Silvia,
figlia di Numitore, a
diventare vestale e
a fare quindi voto di castità
per impedirle di generare un
possibile pretendente al
trono. Il dio Marte però
s'innamora della fanciulla e
la rende madre di due gemelli, Romolo
e Remo,
quest'ultimo chiamato come il
condottiero rutulo decapitato
nel sonno da Niso durante la
guerra troiano-italica.
Il
re Amulio, saputo della
nascita, ordina l'assassinio
dei gemelli per annegamento,
ma il servo incaricato non
trova il coraggio di compiere
tale misfatto e li abbandona
sulla riva del fiume Tevere. Rea
Silvia viene poi fatta
uccidere da Amulio, o secondo
versioni meno accreditate,
muore di stenti dopo essere
stata imprigionata: c'è anche
chi afferma che viene messa in
prigione su richiesta della
figlia di Amulio salvo poi
essere liberata.
La
cesta nella quale i gemelli
erano stati adagiati si arenerà
presso la palude del Velabro,
tra Palatino e Campidoglio e Campidoglio,
nei pressi di quello che sarà
poi il foro romano, alle
pendici di una cresta del
Palatino, il Germalus,
sotto un fico, il fico
ruminale o
romulare, nei pressi di una
grotta detta Lupercale.
Lì
i due vengono trovati e
allattati da una lupa che
aveva perso i cuccioli ed era
stata d'altra parte attirata
dal pianto dei gemelli (secondo
alcuni la lupa era forse una
prostituta, all'epoca le
prostitute erano chiamate
anche lupae, donde
l'italiano lupanare), e da un
picchio (animale sacro per i Latini)
che li protegge, entrambi
animali sacri a Marte.
In quei pressi portava al
pascolo il gregge il pastore Faustolo (porcaro
di Amulio) che trova i gemelli
e insieme con la moglie Acca
Larenzia (secondo
alcuni detta lupa dagli
altri pastori, forse in quanto
dedita alla prostituzione) li
cresce come suoi figli.
Una
volta adulti e conosciuta la
propria origine, Romolo e Remo fanno ritorno ad Alba Longa, uccidono Amulio e rimettono sul trono il
nonno Numitore. Romolo
e Remo, non volendo abitare ad Alba
Longa senza
potervi regnare finché era in
vita il nonno materno,
ottengono il permesso di
andare a fondare una nuova
città, nel luogo dove erano
cresciuti.
Morte
di Remo e fondazione di Roma
- Romolo
vuole chiamarla Roma ed
edificarla sul Palatino,
mentre Remo la vuole chiamare
Remora e fondarla sull'Aventino.
È lo stesso Livio che
riferisce le due più
accreditate versioni dei
fatti:
«Siccome
erano gemelli e il rispetto
per la primogenitura non
poteva funzionare come
criterio elettivo, toccava
agli dei che proteggevano quei
luoghi indicare, interrogati
mediante aruspici, chi avrebbe
dato il nome alla città e chi
vi avrebbe regnato. Per
interpretare i segni augurali,
Romolo scelse il Palatino e
Remo l'Aventino.
Il primo presagio, sei avvoltoi,
si dice toccò a Remo. Dal
momento che a Romolo ne erano
apparsi dodici quando ormai il
presagio era stato annunciato,
i rispettivi gruppi avevano
proclamato re entrambi. Gli
uni sostenevano di aver
diritto al potere in base alla
priorità nel tempo, gli altri
in base al numero degli
uccelli visti. Ne nacque una
discussione e dallo scontro a
parole si passò al sangue:
Remo, colpito nella mischia,
cadde a terra. È più nota la
versione secondo la quale
Remo, per prendere in giro il
fratello, avrebbe scavalcato
le mura appena erette [più
probabilmente il pomerium,
il solco sacro] e quindi
Romolo, al colmo dell'ira,
l'avrebbe ucciso aggiungendo
queste parole di sfida: «Così,
d'ora in poi, possa morire
chiunque osi scavalcare le mie
mura». In questo modo Romolo
s'impossessò del potere e la
città prese il nome del suo
fondatore.»
La
versione di Plutarco è simile
alla prima di quelle riportate
di Livio, con l'eccezione che
Romolo potrebbe non aver
avvistato alcun avvoltoio. La
sua vittoria sarebbe pertanto
stata per alcuni frutto
dell'inganno. Questo il motivo
per cui Remo si adirò e ne
nacque la rissa che portò
alla sua morte.
Anche
Ennio riporta la versione
degli auspici tratti dal volo
degli uccelli, con un uccello
avvistato mentre vola da
sinistra (quindi favorevole a
Remo), e un successivo
avvistamento di dodici uccelli
che si posano su loghi belli e
di buon auspicio, che Romolo
interpreta come segno a lui
favorevole.
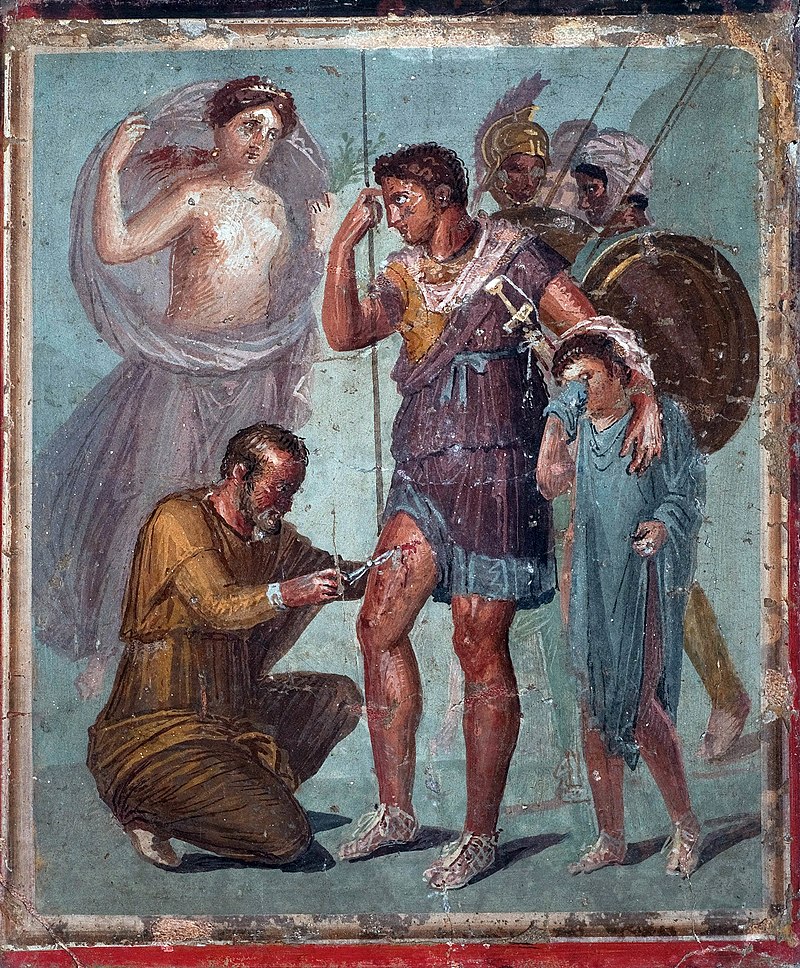 La
città, di forma
quadrata, fu
quindi fondata sul Palatino,
nella sesta Olimpiade, 22 anni
dopo che fu celebrata la
prima, e Romolo divenne il
primo Re
di Roma.
La
città, di forma
quadrata, fu
quindi fondata sul Palatino,
nella sesta Olimpiade, 22 anni
dopo che fu celebrata la
prima, e Romolo divenne il
primo Re
di Roma.
Le
figure di Enea e Romolo nelle
fonti greche
Nell'Iliade, Enea durante
il duello con Achille viene
salvato dal dio Poseidone, che
ne profetizza il futuro
regale. Questo vaticinio e il
fatto che non ne sia narrata
la morte nelle vicende della
caduta della città di Troia,
permise la creazione di
leggende sulla sorte
successiva dell'eroe.
Nell'Iliou
persis di Arctino
di Mileto,
della metà dell'VIII
secolo a.C.,
si racconta la sua partenza
verso il monte Ida, mentre
nell'Inno
omerico ad Afrodite,
della fine del VII
secolo a.C.,
Enea viene visto regnare sulla
nuova Troia ricostruita, al
posto della stirpe di Priamo.
Anche la città di Ainea nella penisola
calcidica si
riteneva fondata da Enea e una
moneta cittadina della fine
del VI
secolo a.C. rappresenta
la fuga dell'eroe da Troia.
Con Stesicoro,
nel VI
secolo a.C.,
viene introdotto il viaggio di
Enea verso l'Occidente. Il
testo letterario non ci è
giunto, ma ne rimane
testimonianza nelle
raffigurazioni con
"didascalie" della Tabula
Iliaca (rilievo
proveniente da Boville nei Musei
Capitolini di Roma,
databile al I
secolo d.C.).
Nel V
secolo a.C. i
Greci crearono quindi
probabilmente la leggenda
della fondazione di Roma da
parte di Enea: Dionigi
di Alicarnasso ci riporta il racconto di Ellanico
di Lesbo e
di Damaste
di Sigeo che
avevano preso a modello le
altre fondazioni di città
greche attribuite agli eroi
omerici. Viene anche inventata
un'eroina troiana che avrebbe
dato il suo nome alla nuova
città ("Rome").
La
presenza di raffigurazioni del
mito di Enea su oggetti
rinvenuti in centri etruschi
tra la fine del VI e
gli inizi del V
secolo a.C. ha
fatto ipotizzare che il mito
si sia sviluppato in realtà
in quest'epoca in Etruria.
La
relazione di Enea con Lavinia
viene introdotta, alla fine
del IV secolo a.C., da Timeo
di Tauromenio,
che, come testimoniato
nuovamente da Dionigi di
Alicarnasso, racconta di
avervi visto i Penati troiani.
Il legame con Lavinio è
testimoniato anche dal poeta Licofrone.
Si tratta forse di un mito di
fondazione di origine latina o
romana, attestato
archeologicamente: un tumulo
funerario, databile in origine
al VII
secolo a.C.,
mostra un adeguamento a
funzioni di culto proprio alla
fine del IV secolo a.C. e
corrisponde a una descrizione
di Dionigi
di Alicarnasso del cenotafio dell'eroe,
costruito nel luogo in cui era
scomparso (rapito in cielo)
nel corso di una battaglia.
A
cavallo tra il VI e il V
secolo a.C. lo storico
siceliota Alcimo descrive
per primo il mito della
fondazione della città, con
la lupa che salva e alleva i
due gemelli discendenti di Enea.
Tra
il IV e il III
secolo a.C. infatti,
dopo una lunga elaborazione di
materiali tradizionali, tra
cui ebbe forse particolare
peso quello di origine
gentilizia (le "storie di
famiglia" del
patriziato), viene a
delinearsi il racconto della
fondazione della città da
parte di Romolo e Remo. Questa
"gestazione" della
leggenda e la selezione dei
materiali della tradizione,
fino a quel momento
probabilmente trasmessi per
via orale, dipende fortemente
dal contesto contemporaneo:
Roma deve poter essere accolta
nel mondo culturale greco
minimizzando l'apporto
etrusco. La storia arcaica di Roma,
a partire dalla fondazione
viene quindi riferita da Fabio
Pittore (che
scrive in greco) e sarà
ripetuta nelle Origines di Catone,
negli scritti di Calpurnio
Pisone e
negli Annales di Ennio.
A Eratostene
di Cirene si
devono l'invenzione della
dinastia regale di Alba
Longa,
l'eliminazione dello scarto
cronologico tra la data della
caduta di Troia, agli inizi
del XII
secolo a.C.,
e la data di fondazione della
città, alla metà dell'VIII
secolo a.C. Secondo
Ennio, Romolo e Remo sono
invece figli della figlia di
Enea, di nome Ilia. Saranno
infine Catone
il Censore, Tito
Livio,
Dionigi di Alicarnasso, Appiano e Cassio
Dione a
narrare la leggenda come è
conosciuta dell'Eneide di Virgilio.
Questi aggiunge tuttavia alle
peregrinazioni dell'eroe la
sosta presso la regina Didone,
che rappresenta la spiegazione
mitica dell'ostilità tra Roma e Cartagine.
 Altre
leggende sulla nascita della
città
- C'è
un'altra tradizione,
raccontata da autori antichi
come Strabone o Tito
Livio,
secondo la quale Roma fu una
colonia
greca arcade,
fondata da Evandro.
A Pallante,
la città sul Palatino sorta
nel luogo in cui sarà fondata
Roma, si colloca anche il
regno di Evandro, citato nell'Eneide
virgiliana. Evandro
avrebbe dato ospitalità a Eracle che
conduceva le mandrie sottratte
a Gerione.
Evandro, che aveva saputo
dalla madre Nicostrata,
esperta di divinazione, il
destino dell'eroe greco,
comprese le fatiche
che avrebbe dovuto superare,
gli dedicò
un altare,
facendovi un sacrificio
secondo il rito greco, ancora
presente ai tempi di Strabone.
Si racconta, inoltre, che
durante il suo soggiorno, le
mandrie gli furono rubate da
Caco, figlio di Tifone,
che egli schiantò con un
colpo di clava mentre cercava
di impedirgli di entrare per
riprendersi la mandria.
Altre
leggende sulla nascita della
città
- C'è
un'altra tradizione,
raccontata da autori antichi
come Strabone o Tito
Livio,
secondo la quale Roma fu una
colonia
greca arcade,
fondata da Evandro.
A Pallante,
la città sul Palatino sorta
nel luogo in cui sarà fondata
Roma, si colloca anche il
regno di Evandro, citato nell'Eneide
virgiliana. Evandro
avrebbe dato ospitalità a Eracle che
conduceva le mandrie sottratte
a Gerione.
Evandro, che aveva saputo
dalla madre Nicostrata,
esperta di divinazione, il
destino dell'eroe greco,
comprese le fatiche
che avrebbe dovuto superare,
gli dedicò
un altare,
facendovi un sacrificio
secondo il rito greco, ancora
presente ai tempi di Strabone.
Si racconta, inoltre, che
durante il suo soggiorno, le
mandrie gli furono rubate da
Caco, figlio di Tifone,
che egli schiantò con un
colpo di clava mentre cercava
di impedirgli di entrare per
riprendersi la mandria.
Ma
il personaggio e la sua città
rivestono anche un'importanza
che probabilmente esula da
quella esclusivamente
mitologica. Dal nome di
Pallante (secondo alcune
versioni, Pallanteo) potrebbe
infatti essere derivato lo
stesso toponimo di Palatino.
La coincidenza poi che le
feste "Palilie" si
celebrassero nella data della
fondazione di Roma può far
pensare a un'ipotesi di
accordo e di spartizione del
territorio tra la gente di
Romolo, stanziata sul Germalo,
altura settentrionale del
Palatino, e quella di Evandro,
stabilitasi sul Palatino vero
e proprio, più a sud,
riservando alla Velia,
l'altura intermedia, il ruolo
forse di area cimiteriale,
come i reperti archeologici
lasciano supporre. Non va
neanche sottovalutato il
rilievo che assume la figura
di Ercole e l'ospitalità offertagli
dallo stesso Evandro: Ercole,
ladro e assassino (avendo
ucciso Gerione per rubargli le
mandrie), che cerca rifugio in
una regione infestata da ladri
(Caco aveva il suo rifugio nel
vicino bosco della dea Laverna –
vedi anche Porta
Lavernalis)
è molto simile ai
proto-romani, pastori e
personaggi comunque poco
raccomandabili, riuniti sul
Germalo in una comunità rozza
e violenta che però è
disposta a riconoscere il diritto
d'asilo.
Altre
varianti riguardano gli stessi Romolo
e Remo,
figli di Enea e Dessitea, nati
già a Troia, oppure di
Latino, figlio di Telemaco e
di Rhome, o ancora di una
Emilia, figlia di Enea, e del
dio Marte.
Una
leggenda racconta infine una
diversa versione: sul focolare
della casa di Tarchezio,
tirannico re
di Alba Longa,
era apparso un fallo, che un
oracolo impose di far unire
con una fanciulla vergine. La
figlia del re si fece tuttavia
sostituire da una schiava, ma
venne scoperta dal padre: le
due donne furono imprigionate
e i gemelli nati da
quell'unione furono esposti in
una cesta lasciata nel Tevere.
Anche
la figura di Acca
Larenzia compare
in un diverso racconto che ci
ha tramandato Plutarco:
il guardiano del tempio di
Ercole aveva perso una partita
a dadi che aveva giocato
contro il dio stesso e la cui
posta era una donna. Il
guardiano invitò dunque Acca
Larenzia nel tempio e ve la
richiuse. Dopo aver passato la
notte con lei Ercole favorì
le sue nozze con il ricco Tarunzio,
che alla sua morte la lasciò
erede delle sue ricchezze:
Acca Larenzia le donò al
popolo romano. L'episodio
spiega in tal modo il culto
che le veniva dedicato (festa
dei Larentalia),
che forse è dovuto all'antico
carattere divino di questa
figura.
Secondo Plinio
il Vecchio e Aulo
Gellio i
dodici figli di Acca Larenzia
e di Faustolo sarebbero stati
all'origine del collegio
sacerdotale dei fratres
Arvales,
caratterizzato dall'uso di
rituali e formulari arcaici.
Origine
del nome nella letteratura
antica
- L'origine
del nome della città era
incerta anche in età arcaica. Servio,
grammatico a cavallo tra il IV e
il V
secolo d.C.,
riteneva che il nome derivasse
da un'antica denominazione del
fiume Tevere, Rumon, dalla
radice ruo (a
sua volta proveniente dal
greco ρεω), scorro, così da assumere il significato di Città del Fiume.
Ma si tratta di un'ipotesi che
non ha riscosso successo.
Gli
autori di origine greca, primo
fra tutti Plutarco,
tendevano naturalmente a
celebrarsi come i
civilizzatori e i
colonizzatori del bacino del
Mediterraneo e quindi
insistevano sulla lontana
origine ellenica della città.
Una prima versione fornita da
Plutarco vede la fondazione di Roma dovuta
al popolo dei Pelasgi,
i quali una volta giunti sulle
coste del Lazio, avrebbero
fondato una città il cui nome
ricordasse la loro prestanza
nelle armi (rhome). Secondo
una seconda ricostruzione
dello stesso autore, i
profughi troiani guidati da
Enea arrivarono sulle coste
del Lazio, dove fondarono una
città presso il colle Pallantion a
cui diedero il nome di una
delle loro donne, Rhome. Una
terza versione, sempre di
Plutarco, offre ipotesi
alternative, secondo le quali
Rome poteva essere un mitico
personaggio eponimo,
figlia di Italo, re degli Enotri o
di Telefo,
figlio di Eracle,
sposò Enea o il figlio,
Ascanio.
Una
quarta versione vede Roma
fondata da Romano, figlio di Odisseo e
di Circe;
una quinta da Romo, figlio di
Emazione, giunto da Troia per
volontà dell'eroe greco Diomede;
una sesta da Romide, tiranno
dei Latini,
che era riuscito a respingere
gli Etruschi,
giunti in Italia dalla Lidia e
in Lidia dalla Tessaglia. Un'altra
versione fa della stessa Rome
la figlia di Ascanio, e quindi
nipote di Enea. Ancora una
Rome profuga troiana giunge
nel Lazio e sposa il re
Latino,
sovrano del popolo lì
stanziato e figlio di Telemaco,
da cui ebbe un figlio di nome
Romolo che fondò una città
chiamata col nome della madre. In
tutte le versioni si ritrova
l'eponima chiamata Rome, la
cui etimologia è la parola
greca rhome con
il significato di
"forza". Le fonti
citano altri possibili eroi
eponimi come Romo, figlio del
troiano Emasione, o Rhomis,
signore dei Latini e vincitore
degli Etruschi.
 Secondo
altre interpretazioni di un
certo interesse, il nome ruma sarebbe
di origine etrusca, in quanto
non è stato trovato l'etimo indoeuropeo e
l'unica lingua non-indoeuropea
della zona era l'etrusco. Il
termine sarebbe entrato come
prestito nel latino
arcaico e
avrebbe dato origine al
toponimo Rume (più
tardi Roma)
e a un prenome Rume (in
latino divenuto Romus),
dal quale sarebbe derivato il
gentilizio etrusco Rumel(e)na,
divenuto in latino Romilius.
Il nome Romolo sarebbe quindi
derivato dal nome della città
e non viceversa.
Secondo
altre interpretazioni di un
certo interesse, il nome ruma sarebbe
di origine etrusca, in quanto
non è stato trovato l'etimo indoeuropeo e
l'unica lingua non-indoeuropea
della zona era l'etrusco. Il
termine sarebbe entrato come
prestito nel latino
arcaico e
avrebbe dato origine al
toponimo Rume (più
tardi Roma)
e a un prenome Rume (in
latino divenuto Romus),
dal quale sarebbe derivato il
gentilizio etrusco Rumel(e)na,
divenuto in latino Romilius.
Il nome Romolo sarebbe quindi
derivato dal nome della città
e non viceversa.
In
ogni caso la tradizione
linguistica assegna al termine
"ruma", in etrusco e
in latino arcaico, il
significato di mammella, come
è confermato da Plutarco.
Questa
interpretazione del termine ruma
è quindi strettamente
collegata con i motivi che
hanno portato alla scelta,
come simbolo della città di
Roma, di una lupa con
le mammelle gonfie che allatta
i gemelli fondatori.
Anche
sulla lupa sono da fare delle
considerazioni: posto che
alcuni ritengono che ad
accudire i gemelli sia stata
effettivamente una lupa (in
quanto mammifero in grado di
avere gravidanze
plurigemellari) la quale,
avendo perso i propri cuccioli
a causa di un predatore, aveva
vagato fino a quando, trovati
i due neonati, li aveva
allevati, impedendone così la
morte certa, occorre rilevare
che il termine
"lupa" in latino
assume anche il significato di prostituta (da
cui, "lupanare",
luogo dove si svolge la
prostituzione), ed è quindi
abbastanza probabile che la
"lupa" in questione
sia stata una prostituta.
Secondo
una tradizione diffusa
nell'antichità, una città
aveva tre nomi: uno sacrale,
uno pubblico e uno segreto.
Posto che al nome pubblico di
Roma era unito il nome
religioso di Flora o
Florens, usato in occasione di
determinate cerimonie sacre,
quello segreto è rimasto
sconosciuto. Il motivo e la
necessità di questa
segretezza riporta a un'altra
tradizione diffusa presso gli
antichi (ma anche in alcune
culture contemporanee non
occidentali) e che si ritrova
anche nella storia
dell'origine della scrittura:
il nome di un oggetto o di una
entità esprimeva l'essenza e
l'energia dell'oggetto o entità
che definiva. Nominare
qualcosa equivaleva a renderlo
vivo ed esistente e la
conoscenza del nome
significava, in pratica, avere
il potere di influire, in bene
o in male, sull'oggetto di cui
si possedeva la conoscenza.
Nel
caso di una città il nome
segreto corrispondeva, di
fatto, al nome segreto del Nume
tutelare e
infatti i Pontefici
romani,
nelle invocazioni, si
rivolgevano a "Giove
Ottimo Massimo o
con qualunque altro nome tu
voglia essere chiamato".
In base a questo principio
negli assedi veniva
evocato il dio protettore
della città assediata,
promettendogli riti e
sacrifici migliori, affinché
abbandonasse la tutela della
città nemica, e per questo
motivo i romani conservarono
con estrema cura il nome
segreto della loro città. Quinto
Valerio Sorano fu giustiziato per avere divulgato il nome.
Secondo
il poeta e latinista Giovanni
Pascoli,
che ne parla nell'ode Inno
a Roma, il nome segreto di
Roma era il palindromo della
stessa, Amor, cioè
amore, il che significava la
dedica segreta della città a Venere,
dea dell'amore e della
bellezza, ricollegandosi
quindi al culto
di Venere genitrice,
madre di Enea e della stirpe
romana. Molti storici hanno
concordato con questa ipotesi.
Secondo
altri studiosi,
il nome segreto sarebbe Maia,
la Pleiade madre
di Mercurio,
e il poeta Ovidio sarebbe
stato esiliato per averlo
rivelato o pronunciato. Le
principali Pleiadi sono sette
e Maia è la più grande; esse
simboleggerebbero i Sette
Colli di Roma.
- Contesto
geografico e orografico
- (Roma
quadrata, Septimontium,
Roma, città antica)
A
metà tra leggenda e
realtà storica
archeologicamente documentata,
per Roma quadrata si
intendono tre diverse
definizioni: una prima
corrispondente al circuito
dell'intero colle Palatino come
riferiscono Plutarco, Dionigi
di Alicarnasso e Appiano; una
seconda, a una ristretta area
monumentale, ovvero l'area
Apollinis che
occupava una piccola parte del
Palatino; e una terza a
un'ara/fossa sul medesimo
Palatino.
La
morfologia dell'area
geografica su cui insisteva la Roma primitiva
può essere dedotta da
analogie e da verifiche geologiche di
quello e altri siti della valle
del Tevere: era una
zona caratterizzata da colline
di altezza di solito
contenuta, ma dai fianchi
tufacei che potevano anche
essere estremamente ripidi e
con le sommità generalmente
abbastanza pianeggianti,
adatte quindi a ospitare
nuclei abitativi che, per ovvi
motivi di sicurezza,
preferivano stabilirsi su
queste alture piuttosto che
nelle valli sottostanti. In
particolare, la sommità del
Palatino aveva una forma
vagamente trapezoidale, che
potrebbe essere stato il
motivo per cui questa prima
Roma venne definita "quadrata”.
Per
la difesa di questi primi
agglomerati urbani si
sfruttava, per quanto
possibile, la conformazione
del terreno, nel senso che
veniva eretto un muro o,
piuttosto, un rinforzo, solo
dove il pendio del colle non
era abbastanza ripido da
impedire l'accesso. Spesso
all'esterno del muro veniva
anche scavato un fossato tale
da rendere quanto meno
difficoltoso l'avvicinamento
sui lati non difesi
naturalmente.

Il
leggendario solco tracciato da Romolo aveva
probabilmente una funzione di pomerium e
quindi di confine, ed è
abbastanza verosimile, data
l'antica conformazione del
colle, che il primitivo muro e
il fossato che lo
accompagnavano fossero stati
realizzati solo sul lato tra
il Germalo e il Palatino, a
difesa del lato più esposto,
anche se il pomerium, per
il suo significato di cinta
sacrale, doveva certamente
circondare tutto il centro
abitato.
Una
diversa spiegazione
dell'aggettivo
"quadrata” viene
fornita da Festo e
da Properzio,
i quali suggeriscono che
quadrato potesse essere il mondus,
cioè quella fossa che veniva
scavata al centro esatto del pomerium e
riempita di tutti quegli
oggetti sacrificali e
beneauguranti che i sacerdoti
utilizzavano durante la
complessa cerimonia di
inaugurazione della nuova città.
Il
baluardo tra Germalo e
Palatino è però poco più di
una verosimile congettura,
sulla base della presenza di
un avvallamento, tra le due
alture, un po' troppo
accentuato. La Roma quadrata
cui accennano alcuni autori
classici comprendeva
invece entrambe le alture, con
l'esclusione del colle
Velia. Tacito fornisce
alcune indicazioni in merito
al primitivo recinto della
città, in base alle quali è
possibile ipotizzare il
seguente percorso, lungo circa
un chilometro e mezzo: dalla basilica
di Sant'Anastasia al Palatino,
all'incirca all'incrocio tra
le odierne via dei Cerchi e
via di S. Teodoro, lungo il
lato meridionale del Palatino
fino alla chiesa
di S. Gregorio,
piegando poi verso l'Arco
di Costantino, quindi
verso l'Arco
di Tito e la basilica
di Santa Francesca Romana per
ricongiungersi poi al
tracciato dell'odierna via di
San Teodoro e scendere per il Velabro fino
alla chiesa
di Santa Anastasia. Le
estremità erano segnalate da
altari: l'ara
massima di Ercole invitto nel Foro
Boario, l'ara
di Conso nella
valle del Circo
Massimo, il santuario
dei Lari ai piedi
della Velia e
le Curiae
Veteres sull'angolo
nord-orientale del Palatino. È
abbastanza evidente che alcuni
di questi tratti sfruttavano
la naturale conformazione del
colle e non necessitavano
pertanto di alcun muro.
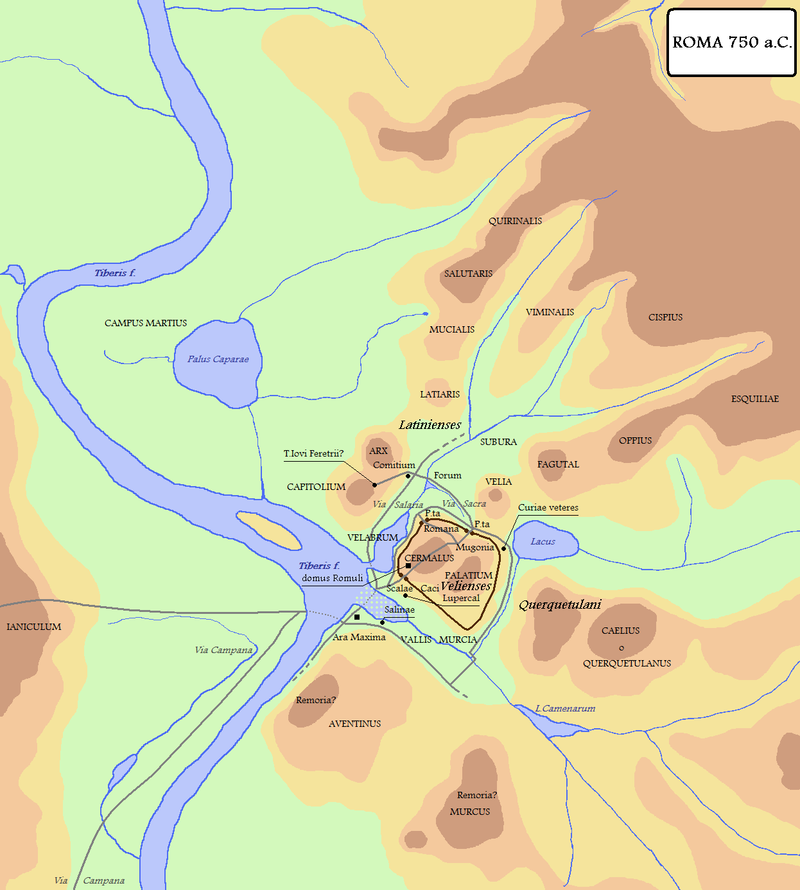 Che
la circondasse completamente o
solo a tratti, il muro che
delimitava la città doveva
certamente avere delle porte
d'accesso. Già gli stessi
autori d'epoca imperiale (che
scrivevano a sette-otto secoli
di distanza) non avevano
notizie certe in proposito, né
sul numero (tre o quattro), né,
tanto meno, sui nomi. Valga
per tutti l'esempio di Plinio,
autore sempre molto attento,
secondo il quale le porte
erano "tre o forse
quattro”, aperte in una
cinta muraria che racchiudeva
il Palatino e il Campidoglio.
E questa notizia
"storica” racchiude già
un'imprecisione in quanto
l'inclusione del Campidoglio
nell'area urbana è posteriore
di un paio di secoli alla Roma
quadrata originaria.
Che
la circondasse completamente o
solo a tratti, il muro che
delimitava la città doveva
certamente avere delle porte
d'accesso. Già gli stessi
autori d'epoca imperiale (che
scrivevano a sette-otto secoli
di distanza) non avevano
notizie certe in proposito, né
sul numero (tre o quattro), né,
tanto meno, sui nomi. Valga
per tutti l'esempio di Plinio,
autore sempre molto attento,
secondo il quale le porte
erano "tre o forse
quattro”, aperte in una
cinta muraria che racchiudeva
il Palatino e il Campidoglio.
E questa notizia
"storica” racchiude già
un'imprecisione in quanto
l'inclusione del Campidoglio
nell'area urbana è posteriore
di un paio di secoli alla Roma
quadrata originaria.
Le
ipotesi più accreditate,
secondo le indicazioni
suggerite da Varrone,
suppongono che possa essere
esistita una Porta
Mugonia (di
etimologia molto incerta),
posizionata nei pressi
dell'arco di Tito, una Porta
Romana o Romanula,
nei pressi della Basilica
di Santa Francesca Romana (la
cui denominazione è stata
forse assegnata dai Sabini che,
stabiliti sul colle Quirinale,
dovevano passare da lì per
entrare in Roma) e una terza
porta (Januaria? Janualis?
Trigonia? Capena?).
L'ubicazione
di quest'ultimo accesso è
assolutamente incerta, ma se
la Mugonia era verso il colle
Velia, cimitero della città e
via di transito verso l'Esquilino e
il Viminale,
la Romana, oltre ad assicurare
i contatti con i Sabini, si
apriva nei pressi della fonte Giuturna,
la più vicina risorsa di
acqua potabile, è più che
lecito ritenere che la terza
porta si dovesse aprire verso
il Velabro, consentendo quindi
l'accesso al Tevere, che
rappresentava
un'importantissima via di
transito commerciale, e di
conseguenza anche al mare.
Da
questa configurazione, che
secondo gli studiosi parrebbe
essere la più verosimile, è
però stranamente assente un
ulteriore accesso dalla parte
del colle Querquetulano (il Celio)
e quindi verso il territorio
dei Latini.
Alcuni studiosi ritengono che
fosse proprio la Trigonia (o
comunque si sia chiamata) ad
aprirsi verso il Celio,
all'altezza della Chiesa
di San Gregorio al Celio,
e in questo caso sarebbe
l'accesso dalla parte del
Tevere a essere stranamente
mancante. Non si può comunque
escludere l'eventualità di
qualche passaggio secondario
lungo il perimetro delle mura,
se non, addirittura, di una
quarta porta. Non è un caso
che Plutarco citi
una Porta Ferentina,
quando Romolo,
in seguito a una grave pestilenza che
aveva colpito la città di
Roma, procedette alla sua
purificazione con sacrifici
espiatori, che si celebrarono
presso questa porta, che
conduceva alla selva
ferentina ai piedi dei Colli
Albani.
La
struttura urbana successiva
alla Roma quadrata e fino alla
costruzione, nel 378
a.C., delle mura
serviane, era
organizzata in modo
decentrato, nel senso che le
varie alture costituenti la
città non facevano parte di
un'unica entità difensiva, ma
possedevano, ciascuna, una
propria struttura militare
indipendente, affidata più
alla forza e al valore degli
uomini che non alle
fortificazioni.
Il
comune romano identificato dal Septimontium,
inizialmente ristretto ai soli montes,
allargato in seguito anche ai colles,
sviluppatosi principalmente
alla falde dei rilievi,
costituì la fase successiva
dello sviluppo urbano di Roma,
durante la quale, i vari
aggregati urbani mantennero
delle caratteristiche
distintive.
Il sacco
di Roma da parte
dei Galli nel 390
a.C. fu
l'avvenimento che mise in
crisi questo sistema e dimostrò
la necessità di una struttura
fortificatoria unitaria. Fino
ad allora la configurazione orografica dei
colli era stata sufficiente a
provvedere, da sola, alle
necessità della difesa,
eventualmente aiutata, dove si
fosse rivelato necessario,
dalla costruzione di mura o
dallo scavo di un fossato e di
un terrapieno (agger).
Il
termine latino Septimontium o Settimonzio (ovvero sette
monti) era utilizzato dagli antichi
Romani sia per
indicare una festività
religiosa sia, secondo Varrone,
per rappresentare anche un
concetto territoriale
collegato alla città di Roma.
Secondo
la tesi più diffusa, il
termine deriva da Septem
Montes, con chiaro riferimento
alle sette cime del primo
nucleo abitato della città.
Per un'altra tesi, il termine
deriva da Saepti Montes,
ovvero da Monti divisi, con
riferimento alle palizzate che
proteggevano i primi nuclei
abitati.
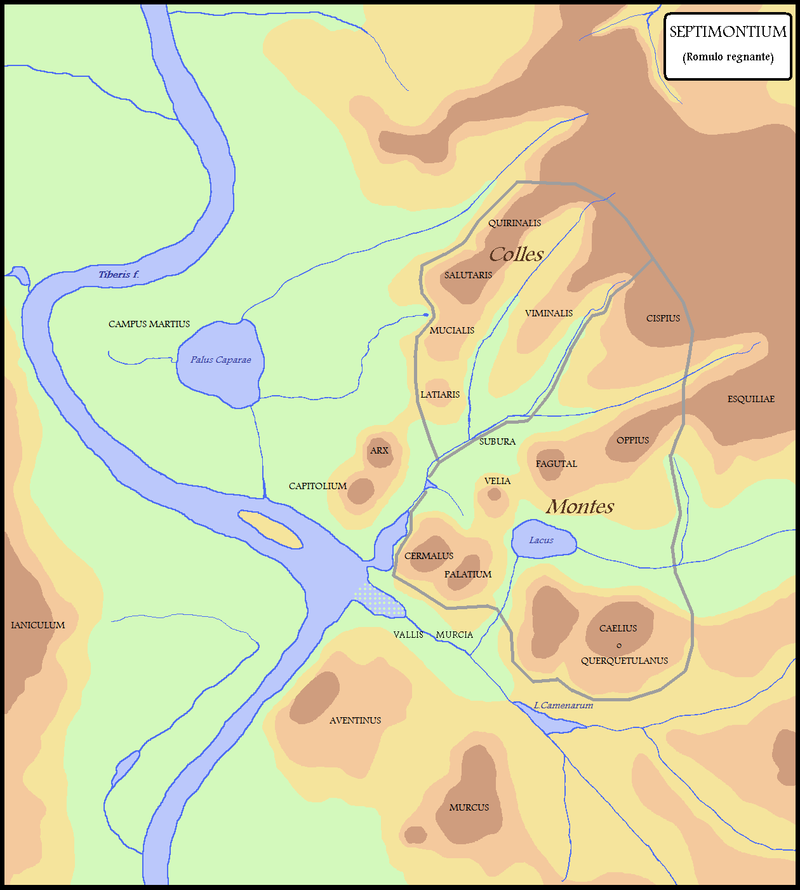 Lo
scrittore latino Sesto
Pompeo Festo riporta
una festa che si celebrava l'11
gennaio. Sembra
fosse stata istituita dal re Numa
Pompilio e che
consistesse in una processione
lungo tutti i "sette
monti" (da cui il nome di Septimontium)
con relativi sacrifici da
celebrare presso i siti dei 27
sepolcri degli Argei (che
si trovavano appunto su quelle
alture) che secondo la
tradizione erano gli eroici
principi greci che, giunti nel Lazio al
seguito di Ercole,
strapparono alle popolazioni
sicule e liguri ivi
stanziate i colli su cui
sarebbe poi sorta Roma.
Lo
scrittore latino Sesto
Pompeo Festo riporta
una festa che si celebrava l'11
gennaio. Sembra
fosse stata istituita dal re Numa
Pompilio e che
consistesse in una processione
lungo tutti i "sette
monti" (da cui il nome di Septimontium)
con relativi sacrifici da
celebrare presso i siti dei 27
sepolcri degli Argei (che
si trovavano appunto su quelle
alture) che secondo la
tradizione erano gli eroici
principi greci che, giunti nel Lazio al
seguito di Ercole,
strapparono alle popolazioni
sicule e liguri ivi
stanziate i colli su cui
sarebbe poi sorta Roma.
La
circostanza che la festa fosse
in origine riservata alle sole
genti di stirpe latina che
abitavano quei luoghi,
sembrerebbe una conferma del
fatto che si tratti di una
festività molto antica, forse
anche precedente all'epoca di
Numa Pompilio, corrispondente
alla prima espansione del
centro urbano dal Palatino ai
colli circostanti. Solo con il
re Servio
Tullio sembra che la
celebrazione sia stata estesa
anche alle genti di origine sabina abitanti
il Quirinale.
In
epoca imperiale si perse il
significato della festa, che
divenne comune a tutta la città.
Dal
punto di vista territoriale ,
i "sette monti" non
corrispondono ai tradizionali "sette
colli": i primi si
riferiscono a una fase più
antica dell'abitato. Il primo
centro proto-urbano di Roma
sarebbe sorto dall'unione di
villaggi pre-urbani, attorno
alla prima metà del IX
secolo a.C.. Secondo Theodor
Mommsen, l'attestazione
in epoca storica di una festa
religiosa sarebbe la prova
dell'esistenza di un centro
proto-urbano, successivo a
quello identificato dalla Roma
quadrata.
Il Septimontium propriamente
detto era formato dalle
seguenti alture, dette montes:
-
le due del Palatino (il Palatium e
il Cermalus)
-
le tre dell'Esquilino (il Fagutal,
l'Oppius e
il Cispius)
-
la Velia,
che collegava Palatino ed
Esquilino, e che fu in parte
spianata nel XX
secolo per
l'apertura di via
dei Fori Imperiali
-
il Caelius
o Querquetual o la Suburra
Il
territorio romano identificato
dal Septimontium,
inizialmente ristretto ai soli montes,
fu allargato in seguito anche
ai due colles del Viminale e
del Quirinale (quest'ultimo
a sua volta includeva Latiaris, Mucialis, Salutaris),
compresi nella lista canonica
dei "sette colli".
La presenza di otto elementi
nel Septimontium appare
difficoltoso se si fa
riferimento al suo significato
territoriale, mentre
presenterebbe minori
problematiche se riferito al
suo significato religioso; in
questo caso, si potrebbe
ipotizzare che la festività,
inizialmente riferita a sette
diverse comunità, abbia poi
ricompreso un'ottava comunità
(Suburra o Celio),
senza che questo però
comportasse la modificazione
del nome. Theodor
Mommsen opta per
la Suburra nel Septimontium
originario (a scapito del
Celio). Altri optano per
il Celio, non considerando la
Suburra propriamente un monte.
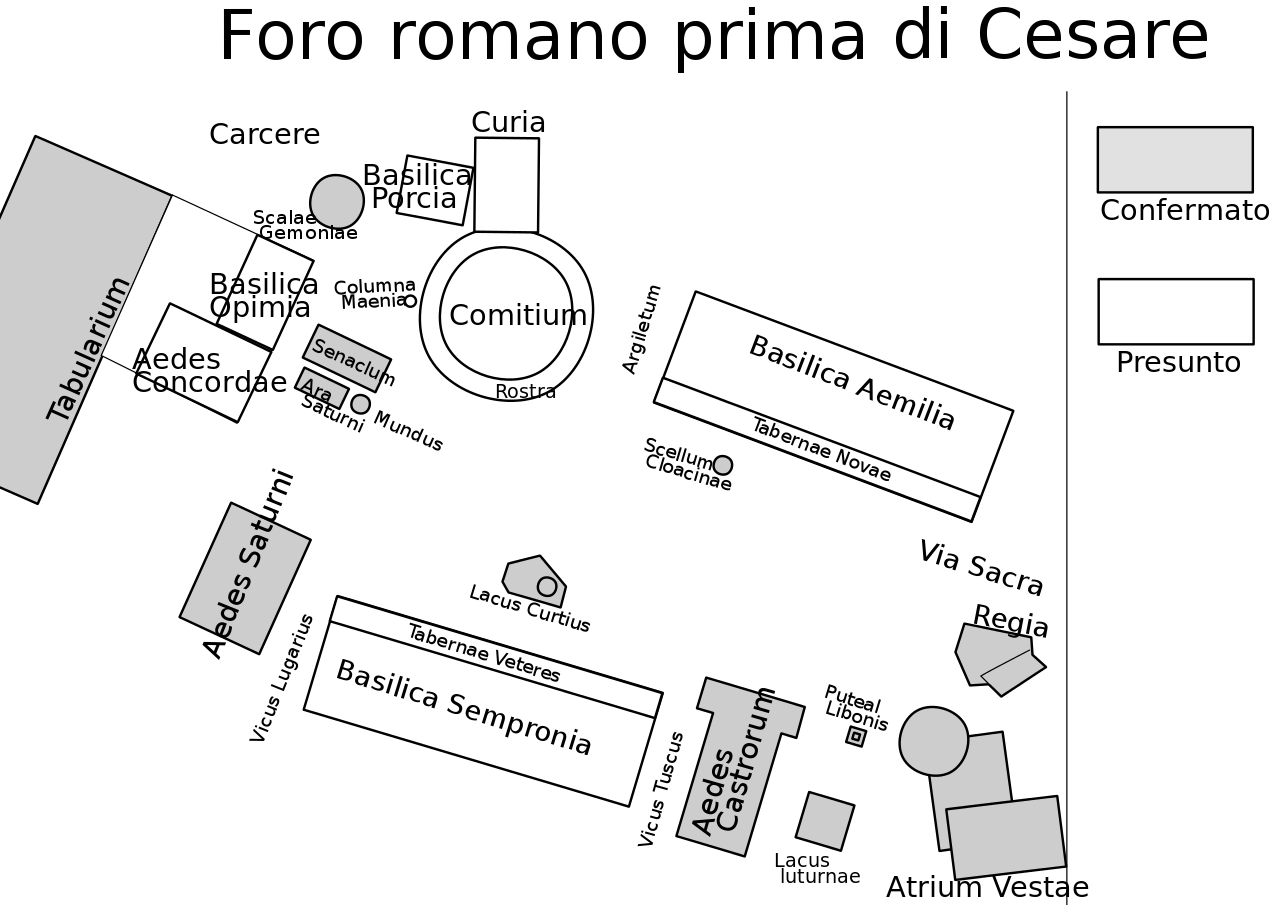
La
natura del luogo dove sorse il
nucleo iniziale di Roma,
città antica era adatta
allo scambio di merci, tra cui
il sale,
di fondamentale importanza, e
il bestiame,
tra differenti culture. Una
zona temperata dell'Italia
centrale,
poco distante dal mare,
lungo la sponda sinistra del
fiume Tevere dotata
di insenature per l'attracco
delle barche (il futuro portus
Tiberinus),
ai piedi di numerosi colli (in
particolare Aventino, Palatino e Campidoglio)
che costituivano un valido
sistema di difesa da attacchi
nemici e sulle cui sommità
sorsero i primi abitati
proto-urbani, nei pressi del guado dell'isola
Tiberina dove
confluivano i percorsi per
l'approvvigionamento del sale
che percorrevano la valle del
fiume (la via
Salaria dalla Sabina e
la via
Campana dal Tirreno), quelli
costieri tra Etruria (con
la vicina Veio)
e Campania (con
le colonie
greche)
e i tratturi per
la transumanza delle
greggi dall'Appennino.
Per
il carattere "emporico"
del luogo, che aveva nell'area
del Foro
Boario il
centro sacro e commerciale,
questo fu frequentato da Fenici fin
dai decenni finali dell'VIII
secolo a.C. e
da Greci (probabilmente
gli Eubei di Cuma)
dal secondo quarto sempre
dell'VIII secolo, oltre agli Etruschi e
alle popolazioni
italiche.
Vi sorgeva un antichissimo
santuario, l'Ara
massima di Ercole, dedicato ad una divinità locale forse di origine sabina,
assimilata al Melqart fenicio e
più tardi all'Ercole greco-romano.
In
particolare, il sistema
collinare è costituito da tre
lunghe "dita di una
mano" che si riuniscono a
est nel pianoro dove oggi
sorge la stazione
Termini (a
sud Aventino e Celio;
al centro Palatino, Velia ed Esquilino;
più a nord Campidoglio e
Quirinale), oltre alle
"dita" più corte
del Viminale e
del Cispius, tra
cui si interponevano alcune
valli come la Vallis
Murcia (tra Aventino
e Palatino, occupata più
tardi dal Circo
Massimo),
l'area del Foro
romano (tra
Palatino, Velia e Campidoglio)
e la Suburra (tra
Quirinale, Viminale ed
Esquilino). Nel centro
proto-urbano di Roma, alcune
di queste alture componevano
il Septimontium,
che con l'espansione della
città fu poi allargato ai
tradizionali "sette
colli".
Il
Tevere, inoltre, costituiva il
confine naturale tra due
differenti culture che, fin
dalla fine dell'età
del bronzo (dopo
il 1000
a.C.),
andavano ormai
contrapponendosi anche
etnicamente: la cultura
laziale a
sud (il Latium
vetus dei Latini-Falisci)
e quella villanoviaina a
nord (l'Etruria degli Etruschi).
Dati
storici e archeologici

Accanto
alle fonti letterarie
tramandateci, i moderni
ritrovamenti archeologici
hanno dimostrato la natura
"emporica"
del primitivo centro preurbano
di Roma,
trattandosi di un'area
racchiusa da un lato dalla
sponda sinistra del fiume Tevere e
dall'altro dai tre vicini
colli dell'Aventino, Palatino e Campidoglio,
identificabile con il
cosiddetto Foro
Boario.
I
reperti più antichi, che
appartengono alla media età
del Bronzo,
sono quelli trovati nei pressi
della chiesa di Sant'Omobono,
sotto al colle del Campidoglio,
a ridosso dell'ansa del fiume Tevere nella
zona del Foro
Boario (all'incrocio
tra l'odierna via L.
Petroselli e il Vico Jugario).
Si tratta di frammenti di
ceramica appenninica, databili
intorno al XIV-XIII
secolo a.C. e
di ossa di animali. A partire
da questo momento nuove tracce
di vita andranno a estendersi
prima nell'area del foro
romano,
dove sono stati trovati resti
di insediamenti risalenti all'XI
secolo a.C. e
corredi funerari risalenti al X
secolo a.C. Qui
si formò, infatti,
progressivamente nei pressi
del guado
del Tevere una
struttura emporica (orrea)
di scambio e
approvvigionamento, sotto la
protezione dell'Ercole italico,
protettore del bestiame
transumante.
Successivamente
le testimonianze archeologiche
si diffusero al vicino colle Palatino,
dove sono stati rinvenuti i
resti di una necropoli
(risalenti sempre al X secolo
a.C.), nella sella compresa
tra le due cime del colle,
il Germalus e
il Palatium. E
ancora sul Palatino sono stati
trovati resti di insediamenti
che si riferiscono al IX
secolo a.C..
Riguardo agli usi funerari
dell'epoca, sono stati
rilevati il rito
dell'inumazione e quello
dell'incinerazione. Questo
testimonia che la popolazione
non era indifferenziata, ma
esisteva già una primitiva
differenza di classi.
L'incinerazione era praticata
dalla classe più ricca, i
patrizi. La forma a capanna
delle urne testimonierebbe la
forma a capanne delle
abitazioni primitive.
Un
elemento di particolare
rilievo nei ritrovamenti
dell'area di S. Omobono è
dato dal fatto che insieme ai
reperti del XIV
secolo sono
stati ritrovati anche resti,
di indubbia provenienza greca,
risalenti all'VIII
secolo,
quindi esattamente coincidenti
con l'epoca della fondazione
di Roma secondo
la tradizione letteraria
latina. Tale circostanza
è pertanto una conferma
archeologica della realtà
storica degli indizi che hanno
poi contribuito a generare la
tradizione mitologica sulle
origini leggendarie della città.
Diverse
teorie e studi cercano di
collegare questi reperti; si
tratta di ritrovamenti in
un'area molto ristretta e che
attestano la presenza di
abitati nella zona del
Campidoglio, Foro, Palatino in
un'età anche antecedente a
quella che la tradizione
tramanda come data di
fondazione della città.

La
tradizione che racconta che Roma fu
fondata con un atto di volontà
di Romolo, sembra avere un
fondamento di verità
soprattutto in seguito alla
scoperta, a opera
dell'archeologo italiano Andrea
Carandini,
di un'antica cinta muraria
(che potrebbe essere l'antico
"muro di Romolo")
costituita da un muro a
scaglie di tufo, con alla
sommità incastri e tracce di
una palizzata e vallo
risalente al 730 a.C., eretto
sul Palatino nel versante
volto verso la Velia dietro la
basilica di Massenzio alla
base nord-orientale del colle
Palatino.
Tale
cinta muraria potrebbe essere
la conferma del tradizionale
racconto sulla fondazione di
Roma ed
è quasi contemporanea a una
fibula di bronzo dell'VIII
secolo, raffigurante un
picchio che acceca Anchise,
il padre di Enea,
punendolo per essersi unito a Venere.
Secondo lo storico Tacito,
infatti, il "solco
primigenio" tracciato da Romolo sul Palatino,
primo nucleo urbano della
futura città di Roma, avrebbe
incluso l'Ara
massima di Ercole invitto,
monumento non solo già
esistente attorno alla metà
dell'VIII
secolo a.C., ma
costituente uno dei quattro
angoli della città
quadrata.
E sempre Tacito aggiunge che
il Campidoglio e
la sottostante piana del Foro
romano furono
aggiunti alla Roma
quadrata da Tito
Tazio.
Quest'ipotesi
è stata ulteriormente
confermata dalla scoperta nel 2005 di
un grande palazzo ad
architettura a capanna
nell'area del tempio di Vesta
che potrebbe essere il palazzo
dei primi re di Roma.
Muro, antico palazzo reale e
primo tempio di Vesta fanno
parte di un complesso
architettonico risalente alla
seconda metà dell'VIII secolo
a.C. che sembra confermare
l'esistenza di un progetto
architettonico ben preciso già
nella seconda metà dell'VIII
secolo, data tradizionale
della fondazione di Roma in
questo periodo.
Un
altro gruppo di studiosi non
ritiene che Roma sia
nata da un atto di fondazione,
sul modello delle polis greche
nel sud Italia e in Sicilia,
ma piuttosto che la fondazione
della città storicamente
debba attribuirsi a un diffuso
fenomeno di formazione dei
centri urbani, presente in
gran parte dell'Italia
centrale, e che nella
fattispecie comprenda un
periodo di diversi secoli: dal
XIV secolo al VII
secolo a.C. La
città si venne quindi
formando attraverso un
fenomeno di sinecismo durato
vari secoli, che vide, in
analogia a quanto accadeva in
tutta l'Italia centrale, la
progressiva riunione in un
vero e proprio centro urbano
degli insediamenti dispersi
sui vari colli. In quest'epoca
infatti i sepolcreti collocati
negli spazi vuoti tra i
primitivi villaggi furono
abbandonati a favore di nuove
necropoli poste all'esterno
dell'area cittadina, in quanto
tali spazi sono ora
considerati parte integrante
dello spazio urbano.
Ed
è anche quello che
verosimilmente può essere
accaduto sul Palatino,
che inizialmente era composto
da vari nuclei abitativi
indipendenti (Palatium e Cermalus)
e che si concluse attorno alla
metà dell'VIII
secolo,
corrispondente alla
tradizionale data di
fondazione del 753
a.C. Il Romolo della
leggenda può essere stato,
pertanto, il realizzatore
della prima unificazione di
questi nuclei in un'entità
unica. Nei due secoli
successivi, tale processo di
unificazione fu probabilmente
accelerato dall'occupazione
etrusca della città andando a
includere ora i famosi "sette
colli".
