Nel
2013, il castello di
Chenonceau, situato nei pressi
della cittadina di
Chenonceaux, nella Valle della
Loira, ha compiuto 500 anni!
La
sua è una storia lunga. Nel
1411 nello stesso luogo
c’era un maniero che fu
bruciato dalle truppe reali
per punire Jean Marques, il
proprietario, accusato di una
cospirazione. Ritornato nelle
grazie della corona, nel 1430
Marques lo ricostruì,
sfruttando il corso del fiume
Cher per porvi un mulino
fortificato. Uno dei suoi
eredi, fortemente indebitato,
vendette il castello a Thomas
Bohier, tesoriere dei re Carlo
VIII, Luigi XII e di Francesco
I.
I
coniugi Bohier, fecero
abbattere quasi tutto il
maniero lasciando solo la
torre di vedetta e, a partire
dal 1513, costruirono sul
mulino il corpo centrale del
castello che vediamo oggi;
mentre il marito seguiva il re
nelle sue campagne militari,
la moglie, Catherine Briçonnet
partecipò attivamente alla
progettazione e sovraintese
alla sua costruzione. Alla
morte di Catherine, il figlio
Antoine dovette cedere il
castello alla corona per
pagare i debiti del padre, e
il castello entrò a far parte
dei beni del re Francesco I.
Il
suo successore, Enrico II,
offrì il castello in dono
alla sua amante, Diana di
Poitiers, già nominata
duchessa di Valentinois. Diana
divenne, in breve, anche una
delle donne più influenti
dell’epoca; a lei si deve la
realizzazione del ponte sul
fiume e la costruzione degli
splendidi giardini lungo le
rive del fiume Cher.
Alla
morte di Enrico II la vedova,
Caterina de Medici, scacciò
Diane dal castello
obbligandola a lasciarlo, e a
vivere a Chaumont. Caterina de
Medici si stabilì a
Chenonceaux e ne fece la sua
residenza preferita,
aggiungendo altri giardini e i
due piani al ponte sul fiume,
dove amava organizzare grandi
feste e intrattenimenti. Nel
castello vissero o vi
abitarono per lunghi periodi
le figlie e le nipoti di
Caterina de Medici: Maria
Stuart, Margherita di Francia
la regina Margherita o Margot,
Elisabetta d’Austria,
Elisabetta di Francia e infine
Luisa di Lorena.
Alla
morte di Caterina il castello
andò alla nuora, Luisa di
Lorena, moglie di re Enrico
III, che venuta a conoscenza
della morte del marito proprio
a Chenonceaux, cadde in una
profonda depressione e vi si
ritirò fino alla sua morte.
Durante quegli anni, la regina
lo trasformò quasi in un
convento tetro e silenzioso;
volle perfino che i muri della
sua camera fossero dipinti di
nero.

Da
Luisa il castello passò a César
di Vendôme, poi a sua moglie
Francesca di Lorena, e poi
seguì la linea ereditaria dei
Valois. Acquistato dal Duca di
Borbone, che lo spogliò di
molte delle sue statue, la
proprietà giunse nelle mani
di Claude Dupin. Sua moglie,
Louise Dupin, riportò il
castello agli antichi
splendori, coltivandovi il
pensiero illuminista ospitando
Voltaire, Buffon, Montesquieu,
Bernard le Bovier de
Fontenelle, Pierre de Marivaux
e Jean-Jacques Rousseau.
Louise
Dupin si prese cura di
ottenere, per editto reale, il
permesso di chiamare il
castello e la sua proprietà
senza la “x”, con cui
terminava il nome della
cittadina vicina, in modo da
dare un tangibile taglio netto
con quello che era stato il
castello dei re, delle loro
amanti e della casa reale
reale francese per quasi tre
secoli. Il suo ponte, elemento
strategico nel passaggio del
Cher per molti chilometri,
l’editto della “x” e la
gestione democratica della
tenuta, salvarono il castello
dalla distruzione da parte
della Guardia rivoluzionaria
durante la Rivoluzione. La
tomba di Louise Dupin si può
ancora ammirare nei giardini
del castello.
Nel
1864 la proprietà passò a
Marguerite, moglie del chimico
Théophile Pelouze, che lo
aveva comprato dagli eredi di
Madame Dupin: i Villeneuve.
Marguerite iniziò dei lavori
di ristrutturazione che
riportarono il castello
all’aspetto che
probabilmente aveva
all’inizio del XVI secolo,
eliminando quanto aveva
snaturato la leggiadra
costruzione voluta dalla Briçonnet.
Nel 1913 il castello divenne
proprietà della famiglia
Menier. Durante la prima
guerra mondiale il castello fu
usato come ospedale e
convalescenziario.
Nei
primi anni del secondo
conflitto mondiale la linea di
demarcazione tra la Francia
occupata dai tedeschi e la
repubblica di Vichy, passava
sul fiume Cher e il castello
fu utilizzato come via di fuga
dalla zona di Vichy, occupata
dai nazisti, fino al momento
della completa occupazione
tedesca della nazione. Nel
1944 una bomba caduta da un
aereo alleato esplose molto
vicino alla cappella del
castello, mandando in mille
pezzi le antiche vetrate
istoriate.
Nel
1951 la famiglia Menier
cominciò la ristrutturazione
del castello e dei giardini,
danneggiati da
un’inondazione nel 1940,
riportando il castello al suo
ruolo di gemma preziosa
incastonata tra i suoi
magnifici giardini. Il
castello, proprio per il gran
numero di donne, dame,
duchesse e regine che lo
abbellirono e curarono, vi
vissero e amarono, viene
chiamato anche “Il castello
delle Dame”.
Il
castello delle Dame, mostra
tutt’oggi le attente cure
delle tante Dame che lo hanno
abitato e amato: vi hanno
lasciato il segno Caterina Briçonnet,
Diane de Poitiers, Caterina de
Medici, le sue figlie e
nipoti: Maria Stuart,
Margherita di Francia, la
regina Margherita, Elisabetta
d’Austria, Elisabetta di
Francia e Louise de Lorraine,
Louise Dupin, Marguerite
Pelouze e… ancora oggi, il
castello è affidato alle cure
di una Dama, Madame Menier.
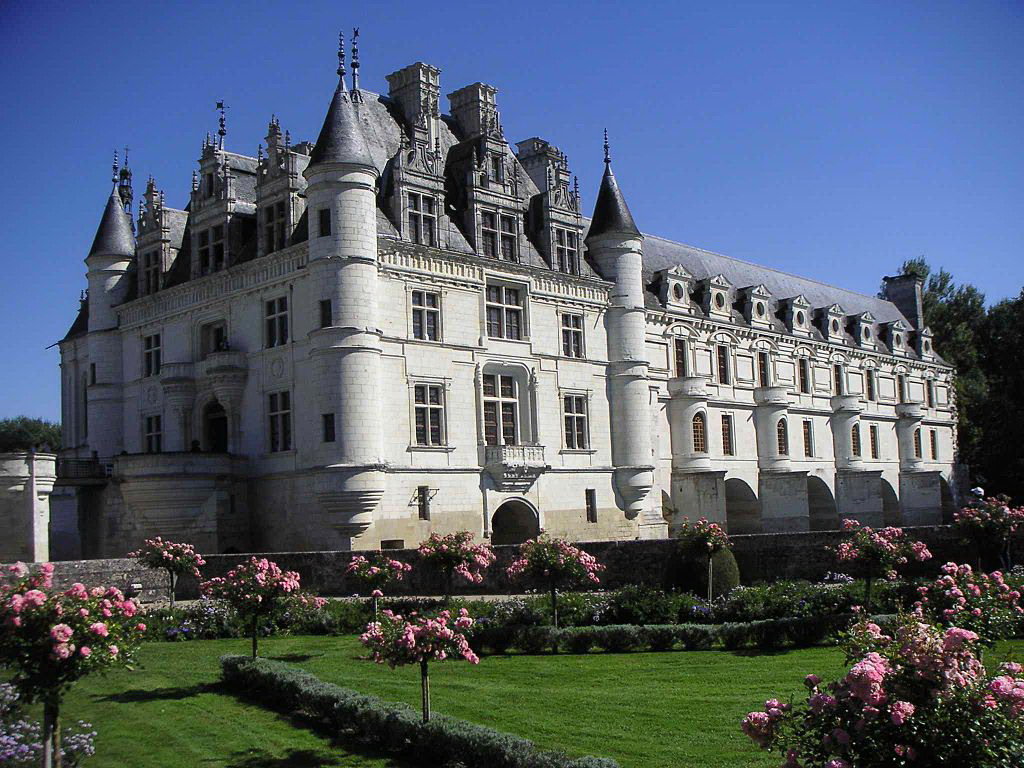
Gran
parte del fascino dei castelli
rinascimentali francesi deriva
dall’abile uso dell’acqua
come elemento architettonico:
quasi sempre si tratta di
costruzioni circondate, o
addirittura affioranti dalle
acque, cosi da rispecchiarsi,
con scenografici e romantici
effetti. Da un punto di vista
funzionale, l’acqua era uno
strumento di difesa, o quanto
meno di selezione. I castelli
non avevano più apparati
bellici e le torrette che li
ornavano non avevano funzioni
militari ma solo decorative:
l’acqua costituiva una buona
barriera contro ladri, banditi
o visitatori indesiderati.
Tuttavia, da un punto di vista
più generale, era un elemento
naturale che dava dolcezza e
risalto all’architettura,
conferendole un aspetto
magico.
Il
castello ha una pianta
centrale con torrette
d’angolo, si dice che il
costruttore si fosse ispirato
a Venezia, in ogni caso ne
aveva tratto la grazia, perché
l’effetto di luminosità dei
giochi di luce e di riflessi
sull’acqua appaiono voluti e
indiscutibilmente la
ricordavano. La progettazione
della galleria centrale con la
scala rettilinea posta di
lato, si orienta ai palazzi
della Serenissima.
Per
le decorazioni Chenonceau fa
parte di una tradizione
rinascimentale, ma con la
chiara volontà di utilizzare
elementi presi in prestito
dall’antichità. Sulla torre
dei Marques si trovano dei
pilastri scolpiti che
sostengono un architrave
decorato a racemi.
La concezione generale del
castello rispetta la
tradizione rinascimentale con
torrette d’angolo, abbaini
ornati, i balconi della
cappella e del gabinetto
costruiti all’esterno.








Architettura
Entrata
principale - Il grande
viale d’onore che porta al
castello è piantato con
platani per quasi 1 km. Da
ogni lato del vicolo
d’onore: la casa colonica
del XVI secolo sulla destra,
il Labirinto e le Cariatidi
sulla sinistra.
La
coppia di sfingi
settecentesche che
fiancheggiano la navata
d’onore installata dal conte
René de Villeneuve proviene
dal castello di Chanteloup ad
Amboise, l’ex tenuta del
duca di Choiseul, che fu
tagliata nel diciannovesimo
secolo; vediamo – tra
l’altro – un paio di
sfingi di pietra dalla scala
principale di Château-Margaux
in Gironde (1810).
Il
piazzale - Dopo aver preso
il grande viale fiancheggiato
da platani e oltre le due
sfingi all’ingresso del
castello, ecco il piazzale
della tenuta. Giusto e
confinante con il piazzale, il
Palazzo delle Cupole e il
Museo delle Cere. Nel centro,
di fronte al castello, la Cour
d’Honneur con la torre
Marques. A sinistra, la
Cancelleria costruita nel XVI
secolo che conduce al Giardino
di Diana.
La
galleria delle cupole - Uno
spazio nella galleria di Domes
è stato dedicato dal 14
luglio 2014 all’ospedale
militare installato nel
monumento durante la prima
guerra mondiale, dal 1914 al
1918. Questa ricostruzione è
un tributo alla memoria dei
feriti e dei badanti, che
vivevano attraverso gli anni
della guerra al castello di
Chenonceau.
Il
galleria di Attelages - E'
stata creata nel gennaio 2014
all’interno della fattoria
del XVI secolo e ha esposto
una collezione di carrozze
trainate da cavalli dal XVIII
secolo al XIX secolo.
Fattoria
del XVI secolo - L’ensemble
risalente al XVI secolo
comprende le scuderie di
Caterina de ‘Medici, un orto
e un laboratorio floreale dove
oggi lavorano due fioristi per
le parti in fiore del
castello. L’orto ospita
diverse varietà di verdure e
piante, tra cui più di 400
rose.
Aranciera
- Situato di fronte al
giardino verde, l’aranciera
ospitava al momento aranci e
limoni. Oggi serve come sala
da tè e ristorante gourmet.

Giardini
- Ci sono due giardini
principali: quello di Diana di
Poitiers e quello di Caterina
de ‘Medici, situato su
entrambi i lati della Torre
del Marques, una traccia delle
fortificazioni che precedono
la costruzione dell’attuale
castello.
Il
giardino di Diane - Il
giardino di Diana di Poitiers,
il cui ingresso è comandato
dalla casa del Regista: la
Cancelleria, costruita nel XVI
secolo; ai piedi del quale si
trova un pontile, impreziosito
da una vite, accesso
essenziale a qualsiasi
passeggiata sul Cher. Al
suo centro c’è un getto
d’acqua, descritto da
Jacques Androuet du Cerceau
nel suo libro, The Most
Excellent Buildings of France
(1576). Sorprendentemente
progettato per il tempo, il
getto di acqua sgorga da un
grande ciottolo tagliato di
conseguenza e cade “in
covone” a un ricettacolo
pentagonale di pietra bianca.
Questo giardino è protetto
dalle inondazioni di Cher da
terrazze rialzate dalle quali
si possono ammirare splendidi
punti di vista sulle aiuole e
sul castello.
Giardino
di Caterina dei Medici - Il
giardino di Caterina de
‘Medici è più intimo, con
un bacino centrale, e si
affaccia sul lato ovest del
castello. La decorazione
floreale dei giardini,
rinnovata in primavera e in
estate, richiede
l’installazione di 130.000
piante da fiore coltivate
nella tenuta.
Giardino
verde - Questo giardino fu
progettato da Lord Seymour nel
1825 per la contessa Vallet de
Villeneuve che voleva un parco
inglese. Il giardino si
affaccia sul lato nord di
Caterina de ‘Medici. È un
recinto erboso delimitato da
una collezione di alberi,
platani, cedri blu, abete
spagnolo, catalpa, castagno,
abeti douglas, sequoie,
robinia, nero noce e leccio.
In precedenza, Caterina de
‘Medici aveva scelto questo
luogo per costruire il suo
serraglio e le sue voliere.
 Labirinto
- Desiderato da Caterina de
‘Medici, il labirinto di
stile italiano è composto da
un tasso di oltre 2000 ettari.
Un gazebo si trova nel centro.
La sua posizione elevata
consente una panoramica. È
sormontato da una statua di
Venere. Il labirinto è
circondato da una pergola dove
troviamo le cariatidi di Jean
Goujon che un tempo adornavano
la facciata del castello. Labirinto
- Desiderato da Caterina de
‘Medici, il labirinto di
stile italiano è composto da
un tasso di oltre 2000 ettari.
Un gazebo si trova nel centro.
La sua posizione elevata
consente una panoramica. È
sormontato da una statua di
Venere. Il labirinto è
circondato da una pergola dove
troviamo le cariatidi di Jean
Goujon che un tempo adornavano
la facciata del castello.
Architettura
all’aperto - Il castello
ha in realtà due parti:
Una
prigione medievale eretta
sulla riva destra del Cher che
è stata ristrutturato nel XVI
secolo.
Un
edificio rinascimentale
costruito sul fiume stesso,
che costituisce la parte
principale del castello.
La
torre del Marques - La
torre Marques è l’unica
traccia visibile dell’antico
castello medievale della
famiglia Marques, rasa al
suolo da Thomas Bohier nel
1515. Corrisponde al
sotterraneo del vecchio
edificio, costituito da una
torre circolare e da una
torretta che ospita la tromba
delle scale. Bohier riabiliterà
la torre dandole un aspetto più
moderno, in stile
rinascimentale, grazie al
piercing di grandi bifore, una
porta scolpita, abbaini in
pietra bianca e l’aggiunta
di un campanile, la cui
campana è datata 1513.
Inoltre ha piccole console
sulla passerella, e copre la
vecchia muratura di malta,
nascondendo i vecchi arcieri,
ma ci sono comunque delle
tracce.
Porta
anche dei gradini in pietra,
del tipo visibile nei castelli
di Bury e Nantouillet o del
primo castello di Chantilly,
corrispondente ad una certa
messa in scena
dell’ingresso, di moda nel
XVI secolo. Infine, Bohier
incise le lettere TBK sulla
torre, che significava Thomas
Bohier-Briçonnet Katherine.
Sul
lato, possiamo ancora vedere
il pozzo, adornato sul bordo
di una chimera e un’aquila a
due teste, emblema della
famiglia di Marques. Questa
torre, che per un certo
periodo ospitava il negozio di
souvenir, non è più
accessibile al pubblico.
La
casa rinascimentale - È
costituito da un edificio
principale a due piani quasi
quadrato (22m x 23m) (più un
seminterrato) fiancheggiato da
torrette angolari, costruito
sulle potenti fondamenta in
pietra del vecchio mulino che
una volta fiancheggiava il
litorale a destra.
È
esteso da un edificio a due
piani e un tetto che si
appoggia sulla facciata sud
della casa, costruita da
Philibert Delorme nel 1560 in
uno stile quasi classico, e
poggiata su un ponte a cinque
archi che attraversa la Cher.
Il piano inferiore è occupato
da una galleria.

Il
tour del castello inizia con
le stanze del piano terra.
L’ingresso
si apre su un vestibolo
centrale che si apre su
quattro stanze su entrambi i
lati. Da una parte: una stanza
delle Guardie, attraverso la
quale si raggiunge una
cappella, la “stanza di
Diana di Poitiers” e
“l’ufficio di lavoro di
Caterina de Medici”.
Dall’altra parte c’è una
scala che dà accesso alle
cucine nel seminterrato, la
“camera François I” e la
“Louis XIV lounge”. Alla
fine del vestibolo, accesso
alla galleria inferiore.
La
scala, con doppio volo
rettilineo, è accessibile
dietro una porta che si trova
nel mezzo del vestibolo
d’ingresso. Fornisce
l’accesso ai piani superiori
ogni apertura su un vestibolo:
Il
primo piano è costituito dal
“vestibolo di Catherine Briçonnet”,
attorno al quale si trovano
quattro stanze: “la stanza
delle cinque regine”, la
“stanza di Caterina de Médicis”,
quella di César de Vendome e
quella di Gabrielle
d’Estrees (preferito da
Enrico IV). In fondo a questo
vestibolo, c’è anche una
porta che dà alle stanze
situate sopra la galleria.
Il secondo piano comprende,
oltre al vestibolo, quattro
stanze di cui è visitabile
solo “la stanza di Luisa di
Lorena”.
PIANO
TERRA
Vestibolo
- Il vestibolo al piano
terra è coperto da un
soffitto a volta le cui pietre
chiave, sfalsate l’una
dall’altra, formano una
linea spezzata. I cesti,
realizzati nel 1515,
rappresentano fogliame, rose,
teste d’angelo, chimere e
corna di abbondanza.
Sopra
le porte, in due nicchie, sono
scolpiti San Giovanni
Battista, patrono di
Chenonceau, e una Madonna
italiana nello stile di Lucca
della Robia. L’arredamento
è composto da un tavolo da
caccia in marmo italiano.
Sopra la porta d’ingresso,
una moderna vetrata,
realizzata nel 1954 da Max
Ingrand, raffigurante la
leggenda di Saint Hubert.
 La
stanza delle guardie - Sopra
la porta di quercia del XVI
secolo, nella forma dei loro
mecenati, Santa Caterina e San
Tommaso, i precedenti
proprietari, e il loro motto:
“Se arriverà ad un punto,
ricorderò” (per capire: farà
quello si ricorderà di me). I
soffitti esposti travetti,
detti “francesi” portano
le due C intrecciate Caterina
de ‘Medici. Il pavimento è
parzialmente ricoperto da
piastrelle in maiolica
policroma della fine del XIX
secolo, realizzate dallo
studio parigino di Léon
Parvillée. Questo pavimento
in maiolica è una
riproduzione del pavimento
cinquecentesco della chiesa di
Brou. La
stanza delle guardie - Sopra
la porta di quercia del XVI
secolo, nella forma dei loro
mecenati, Santa Caterina e San
Tommaso, i precedenti
proprietari, e il loro motto:
“Se arriverà ad un punto,
ricorderò” (per capire: farà
quello si ricorderà di me). I
soffitti esposti travetti,
detti “francesi” portano
le due C intrecciate Caterina
de ‘Medici. Il pavimento è
parzialmente ricoperto da
piastrelle in maiolica
policroma della fine del XIX
secolo, realizzate dallo
studio parigino di Léon
Parvillée. Questo pavimento
in maiolica è una
riproduzione del pavimento
cinquecentesco della chiesa di
Brou.
Il
camino porta le braccia di
Thomas Bohier mentre le pareti
sono decorate con una serie di
arazzi fiamminghi del XVI
secolo che rappresentano la
vita di un castello, una
proposta di matrimonio o una
scena di caccia. Il petto,
gotico e rinascimentale,
conteneva l’argenteria con
cui si muoveva la corte.
La
cappella - Entriamo nella
cappella dalla Guardia delle
Guardie, attraverso una porta
di quercia sormontata da una
statua della Vergine. Le sue
foglie rappresentano Cristo e
San Tommaso e ripetono le
parole del Vangelo secondo San
Giovanni: “Muovi il tuo dito
qui”, “Sei il mio Signore
e il mio Dio”.
La
signora Pelouze aprì le
finestre accoppiate, che erano
dotate di finestre di vetro,
secondo i disegni di un certo
Steinheil. Le vetrate
distrutte nel 1944 furono
sostituite da opere di Max
Ingrand nel 1954. Vediamo
nella loggia a destra una
Madonna col Bambino in marmo
di Carrara di Mino da Fiesole.
A destra dell’altare, una
credenza decorata adornata con
il motto del Bohier.
Nel
1890 il ceramista Edouard
Avisseau (1831-1911) fece un
bassorilievo per il castello,
La Vierge aux poissons.
Sul
muro, dipinti religiosi: La
Vergine con il velo blu di Il
Sassoferrato, Gesù che
predica davanti ad Alfonso e
Isabella di Alonzo Cano, un
Sant’Antonio di Padova di
Murillo e un’Assunzione di
Jean Jouvenet. Lo storico
Robert Ranjard precisa:
“L’oratorio conserva,
incisi nella pietra delle sue
mura, frasi scritte in vecchi
graffiti scozzesi lasciati da
padroni di casa sconosciuti ai
tempi di Diana di Poitiers”.
Entrando a destra, un premio
datato 1543: “L’ira
dell’uomo non realizza la
giustizia di Dio”, e
un’altra del 1546: “Non
essere sconfitto dal male”.
Affacciato
sulla navata, una piattaforma
reale che si affaccia sulla
“Sala delle Cinque Regine”
al primo piano, risalente al
1521.
Questa
cappella fu salvata durante la
rivoluzione, Madame Dupin ebbe
l’idea di fare una riserva
di legna da ardere.
Camera
di Diana di Poitiers - Il
camino di Jean Goujon e il
soffitto recano intrecciate le
iniziali di Enrico II e
Caterina de ‘Medici. Anche
la “H” e la “C”
formano maliziosamente la
“D” di Diane de Poitiers,
la preferita di King.
L’arredamento è composto da
un letto a baldacchino del
diciassettesimo secolo e
poltrone in pelle di Cordoba.
Sulla mensola del camino è un
ritratto del 19 °
rappresentante di Caterina de
‘Medici, di Sauvage.
A
sinistra della finestra, una
Madonna col Bambino, di
Murillo. A destra del camino,
una tela della scuola italiana
del diciassettesimo secolo,
Cristo spogliato dei suoi
vestiti da Ribalta.
Sotto
questa immagine, una
biblioteca con porte schermate
ospita gli archivi della
tenuta; un documento esibito
reca le firme di Thomas Bohier
e Katherine Briçonnet.
Sulle
pareti vi sono due arazzi
fiamminghi del XVI secolo, Il
trionfo della forza, montati
su un carro trainato da due
leoni e circondato da scene
dell’Antico Testamento. Nel
bordo superiore, la frase
latina si traduce come
“Colui che ama con tutto il
cuore i doni celesti, non si
ritira davanti agli atti che
la pietà gli impone”;
l’altro pezzo è Il trionfo
della carità, che, su un
carro, tiene nelle sue mani un
cuore e mostra il Sole,
circondato da episodi biblici;
il motto latino è: “Chi
mostra un cuore forte in
pericolo, riceve alla sua
morte, come ricompensa, la
salvezza”.

Gabinetto
verde - Questo è l’ex
ufficio di Caterina de
‘Medici, durante la sua
reggenza. Sul soffitto ci sono
due C intrecciate. In questo
pezzo è esposto un arazzo di
Bruxelles chiamato
“l’Aristoloche”, sia
gotico che rinascimentale. Il
suo colore verde originale è
sfumato al blu. Il tema è
ispirato alla scoperta delle
Americhe e rappresenta una
fauna e una flora esotica:
fagiani argentati del Perù,
ananas, orchidee, melograni e
piante sconosciute in Europa.
Libreria
- Questa
ex-piccola biblioteca di
Caterina de ‘Medici offre
una vista del Cher; il
controsoffitto in rovere di
bellissime scatole del 1525,
di stile italiano, con piccole
chiavi pendenti, è uno dei
primi di questo tipo
conosciuto in Francia; porta
le iniziali T, B, K, con
riferimento a Bohier.
Sopra
la porta c’è una Sacra
Famiglia dopo Andrea del
Sarto95. In questo dramma sono
conservate una scena della
vita di San Benedetto, di
Bassano, Un martirio di
Correggio, Eliodoro di
Jouvenet, e due medaglioni,
Hebe e Ganimede, le coppe
degli dei, portate
all’Olimpo della scuola
francese di il diciassettesimo
secolo.
Galleria
del piano terra - Tra
le tante novità giunte
dall’Italia una di quelle
destinate ai massimi fasti fu
la ‘galleria’. Fino ad
allora, le stanze dei castelli
e dei palazzi non erano –
per usare termini attuali –
disimpegnate: al contrario,
erano accostate tra di loro, e
la porta di una stanza si
apriva direttamente sulla
stanza vicina. Con quanta
intimità e con quale agio per
gli abitanti è facile capire.
Nel corso del Rinascimento si
diffuse in Italia
l’abitudine di allineare le
stanze lungo un corridoio di
disimpegno, in modo che per
andare da una stanza a
un’altra si potesse usare
tale spazio, senza disturbare
gli occupanti delle stanze
intermedie. Questo corridoio
portava il nome di
‘galleria’ e fu per lungo
tempo, aperto sul lato
esterno, finché nel corso del
Seicento, con il progredire
della tecnica vetraria, si
prese l’abitudine di
chiuderlo con ampi finestroni.
Poiché questo nuovo locale
era il primo che si incontrava
nella casa, e godeva di
abbondante luce, divenne
consueto esporvi i pezzi
pregiati della casa: statue,
quadri, arazzi, mobili. Così
il termine galleria acquisto
il significato di raccolta
d’arte che mantiene ancora.
A Chenonceaux si ha uno dei
primi esempi di galleria di
questo tipo: un lungo ambiente
senza più stanze da
disimpegnare, che ha in sé la
sua giustificazione, e poteva
essere usato per esporre opere
d’arte, passeggiare o
ammirare il panorama del
fiume.
La
galleria, lunga 60 metri,
larga 6 metri, con 18
finestre, ha un pavimento
piastrellato e ardesia e un
soffitto con travetti a vista,
che funge da sala da ballo, fu
inaugurato nel 1577 durante le
feste di Caterina de ‘Medici
e di suo figlio Enrico III. Ad
ogni estremità, ci sono due
camini in stile
rinascimentale, uno dei quali
è solo una decorazione che
circonda la porta sud che
conduce alla riva sinistra del
Cher.

La
facciata del Levante fu
dipinta dai decoratori
dell’Opera di Parigi per il
secondo atto degli Ugonotti.
La
serie di medaglioni
raffiguranti personaggi famosi
sulle pareti fu posta nel
XVIII secolo.
Casa
di Francesco I - Questa
sala contiene il più bel
camino del castello
(ricostruito nel XIX secolo,
le sue tre nicchie “con
baldacchini” erano adornate
con statue); sul suo cappotto
corre il motto di Thomas
Bohier, facendo eco alle sue
braccia rappresentate sulla
porta. L’arredamento è
costituito da tre credenze
francesi del XV secolo e un
armadio italiano del XVI
secolo, intarsiato con
madreperla e avorio inciso a
penna, offerto a Francesco II
e Maria Stuart per il loro
matrimonio.
Alle
pareti un ritratto di Diane de
Poitiers in Diane Chasseresse
di Le Primatice, che lo
realizzò qui nel 1556, i
dipinti di Mirevelt,
Ravenstein, un Autoritratto di
Van Dyck, il ritratto di una
nobildonna di Diane
Chasseresse di Ambrose
Dubois96 , Archimede di
Zurbaran, Due vescovi della
scuola tedesca del
diciassettesimo secolo e Le
tre grazie di Carle van Loo in
rappresentanza delle tre
sorelle di Mailly-Nesles, che
furono successivamente amanti
di Luigi XV.
 Questa
stanza era anche quella di
Madame Dupin nel XVIII secolo,
dove lei emette il suo ultimo
sospiro il 20 novembre 1799. Questa
stanza era anche quella di
Madame Dupin nel XVIII secolo,
dove lei emette il suo ultimo
sospiro il 20 novembre 1799.
Salone
Louis XIV - Questa sala
illuminata di rosso evoca il
ricordo del soggiorno di Luigi
XIV a Chenonceau il 14 luglio
1650. L’attuale ritratto
cerimoniale di Rigaud
sostituisce quello bruciato
durante la rivoluzione nel
1793. Il dipinto originale fu
donato dal re al duca di
Vendome nel 1697, in
riconoscimento dell’invio di
statue al parco della Reggia
di Versailles. La grande
cornice in legno intagliato e
dorato di Lepautre è composta
da solo quattro enormi pezzi
di legno, così come i mobili
rivestiti con arazzi di
Aubusson e una consolle in
stile “Boulle”.
Il
camino in stile rinascimentale
è adornato con Salamander e
Hermine, in riferimento al re
Francesco I e Claude di
Francia. La cornice che
circonda il soffitto a
travetto esposto reca le
iniziali di Bohier.
Sopra
la consolle Il bambino Gesù e
San Giovanni Battista di
Rubens fu acquistato nel 1889
per la vendita della
collezione di Giuseppe
Bonaparte, fratello di
Napoleone I ed ex re di
Spagna.
Il
salone ha una serie di
ritratti del diciassettesimo e
diciottesimo secolo francesi,
quelli di Luigi XV di Van Loo,
una principessa di Rohan,
Madame Dupin di Nattier,
Chamillard, ministro di Luigi
XIV, un ritratto di un uomo di
Netscher Philip V di La Spagna
di Ranc e quella di Samuel
Bernard di Mignard.
La
scala - Una porta di
quercia del XVI secolo dà
accesso alla scala, una delle
prime scale diritte, (rampa
d’accesso) costruita in
Francia sul modello italiano.
È coperto da una volta
chiamata “strisciante”,
con nervature che si
intersecano ad angolo retto.
Le scatole sono decorate con
figure umane, frutta e fiori
(alcuni motivi sono stati
martellati durante la
Rivoluzione).
Le
foglie scolpite rappresentano
l’antica legge sotto forma
di una donna bendata con un
libro e uno stendardo da
pellegrino, e la nuova legge,
con una faccia aperta che
regge una palma e un calice.
La
scala è tagliata da un
pianerottolo formando due
logge con balaustre che danno
sul Cher; sopra uno di essi,
un vecchio medaglione che
rappresenta un busto di donna
con i capelli sparsi, simbolo
abituale della follia.
Cucine
nel seminterrato - Le
cucine sono installate nel
seminterrato a cui si accede
da una scala situata tra la
galleria e “la stanza di
Francesco I”. Disposti nelle
pile del mulino che precedette
il castello che forma un
enorme seminterrato, sono
composti da diverse stanze,
tra cui l’ufficio, una
stanza bassa con due archi
attraversati testate con un
camino, il più grande del
castello. Accanto ad esso è
il forno per il pane.
L’ufficio
serve il personale della sala
da pranzo del castello, la
macelleria in cui sono esposti
i ganci per appendere il gioco
e i registri da tagliare, e la
dispensa. Un ponte si trova
tra la cucina e la cucina
stessa. I mobili del XVI
secolo furono sostituiti
durante la prima guerra
mondiale in un’attrezzatura
più moderna, per supportare
le necessità dell’ospedale.
Un
molo di scarico per portare le
merci direttamente in cucina
è chiamato secondo la
leggenda, il bagno di Diana.

PRIMO
PIANO
Il
vestibolo di Catherine Briçonnet
- Il vestibolo del primo piano
è pavimentato con piccole
mattonelle di terracotta
contrassegnate da un
fiordaliso attraversato da un
pugnale. Il soffitto è
travetti esposti. Sopra le
porte si trova una serie di
medaglioni di marmo riportati
dall’Italia da Caterina de
‘Medici, che rappresentano
gli imperatori romani Galba,
Claudio, Germanico, Vitellio e
Nerone.
La
serie di sei arazzi Oudenaarde
del XVII secolo raffigurano
scene di cacce e “picnic”
basati su cartoni di Van der
Meulen.
Casa
di Gabrielle d’Estrées
- Il soffitto a travetto a
vista, il pavimento, il camino
e i mobili sono in stile
rinascimentale. Vicino al
letto a baldacchino c’è un
arazzo delle Fiandre del XVI
secolo.
Le
altre pareti sono adornate con
l’impiccagione conosciuta
come i Mesi di Lucas, tra cui
giugno, il segno del Cancro
– La tosatura delle pecore,
luglio, il segno di Leone –
La caccia al falco, e agosto,
il segno della Vergine – La
paga di i mietitori; le
vignette di questi arazzi sono
Lucas de Leyden o Lucas van
Nevele.
Sopra
l’armadietto c’è un
dipinto della scuola
fiorentina del Seicento
raffigurante Santa Cecilia, il
santo patrono dei musicisti, e
sopra la porta, il Bambino
dell’Agnello di Francisco
Ribalta.
Casa
delle cinque Regine
- Questa sala rende omaggio
alle due figlie e alle tre
nuore di Caterina de
‘Medici: la regina Margot,
Elisabetta di Francia, Maria
Stuart, Elisabetta d’Austria
e Luisa di Lorena. Il soffitto
a cassettoni del XVI secolo
reca lo stemma delle cinque
regine.
L’arredamento
è costituito da un letto a
baldacchino, due credenze
gotiche sormontate da due
teste femminili in legno
policromo e un baule da
viaggio rivestito in pelle
borchiata.
Sulle
pareti, possiamo vedere una
serie di arazzi fiamminghi del
XVI secolo che rappresentano
l’assedio di Troia e il
rapimento di Elena, i giochi
del circo nel Colosseo e
l’incoronazione del re
David. Un altro evoca un
episodio nella vita di
Sansone. Sono anche esposti,
L’Adorazione dei Magi,
studio per la pittura di
Rubens (Museo del Prado), un
ritratto della duchessa di
Olonne Pierre Mignard, e
Apollo ad Admète argonaute,
dovuto alla scuola italiana
del diciassettesimo secolo.
La
stanza di Caterina de
‘Medici - La stanza di
Caterina de ‘Medici è
arredata con una serie di
archi del XVI secolo e le
Fiandre del XVI secolo
ripercorrono la vita di
Sansone, notevole per i loro
confini popolati da animali
che simboleggiano proverbi e
fiabe come gamberi e Ostriche,
o Skill è superiore a Ruse.
Il camino e le piastrelle del
pavimento sono rinascimentali.
Domina
la stanza, un dipinto su
legno, Educazione dell’amore
di Correggio.

Gabinetto
di stampe - Questi piccoli
appartamenti, decorati con un
camino della fine del XVIII
secolo nella prima sala, un
altro dal XVI secolo al
secondo, presentano
un’importante collezione di
disegni e stampe che
rappresentano il castello
risalente al 1560 per i più
antichi, del diciannovesimo
secolo per il più recente.
La
galleria del primo piano -
L’Alta Galleria sotto
Caterina de ‘Medici è
divisa in appartamenti da
tramezzi il cui probabile uso
è destinato ai servi del
castello. È collegato
direttamente alla galleria
principale al piano terra da
due scale a chiocciola,
situate all’estremità
opposta. L’unica decorazione
è quella dei due camini
scolpiti di schiavi
incatenati, uno di fronte
all’altro. Il castello
espone ogni anno in questa
galleria dal 1980, le opere di
artisti contemporanei.
Camera
Cesare di Vendome - Il
soffitto a travetto esposto è
sostenuto da una cornice
decorata con pistole. Il
camino rinascimentale fu
dipinto nel XIX secolo con le
braccia di Thomas Bohier. La
finestra che si apre a ovest
è incorniciata da due grandi
cariatidi di legno del
diciassettesimo secolo. Le
pareti sono tese con una
successione di tre arazzi di
Bruxelles del diciassettesimo
secolo che illustrano
l’antico mito di Demetra e
Persefone: Il viaggio di
Demetra, Persefone agli
inferi, Demetra dà frutti
agli umani, e Persefone che
torna a trascorrere sei mesi
all’anno in Terra.
A
sinistra della finestra, di
fronte al letto a baldacchino
cinquecentesco, c’è un San
Giuseppe di Murillo.
Dal
balcone del primo piano si
gode lo spettacolo più bello
di tutta la proprietà. A
sinistra c'è il giardino di
Caterina, sistemato ai bordi
del Parco. A destra ci sono
l'entrata del giardino di
Diane e la Cancelleria,
costruita alla fine del XVI
secolo. Il giardino di Diane
è particolarmente decorato
con alberelli e fiori rari. E'
a forma rettangolare,
suddiviso poi in tanti
spicchi. Il giardino di
Caterina è leggermente più
piccolo ma la sua bellezza è
caratterizzata dalla fontana
che si trova al centro.

SECONDO
PIANO
Si
sale al piano superiore
tramite una singolare scala
“rampa su rampa”, tipico
modello italiano, uno degli
elementi più insoliti della
costruzione. E’ una delle più
antiche scale a rampa
rettilinea costruite in
Francia e presenta diverse
caratteristiche, tra cui
quella di non avere neanche un
pianerottolo, la scala è
illuminata mediante un
passaggio a loggia tra il vano
della scala e la facciata
esterna.
Giungiamo
nella camera detta
"Delle Cinque
Regine", con un
camino rinascimentale ed
arazzi del XVI secolo, degna
di nota anche la stanza di
Cesare di Vendome e lo
studiolo delle stampe.
All’ultimo
piano c’è il vestibolo e la
"camera di Luisa di
Lorena''', vedova di
Enrico, chiamata la “regina
bianca”, poiché era
tradizione che i membri della
famiglia reale utilizzassero
tale colore per il lutto.
Proseguendo
la visita si scende nelle '''cucine''',
ingegnosamente collocate nei
basamenti dei primi due piloni
che sostengono il ponte, qui
si trova anche la
ricostruzione della sala da
pranzo riservata alla servitù
ed una macelleria con alcuni
utensili originali che si
possono osservare da vicino.
Per
descrivere Chenonceau Gustav
Flaubert scrisse:
“Un non so che di
singolare soavità e di
aristocratica serenità
traspira dal castello di
Chenonceau. Posto in fondo a
un grande viale alberato, a
una certa distanza dal
villaggio che si trova
rispettosamente in disparte,
costruito sull’acqua,
circondato da boschi, in mezzo
a un vasto parco con dei bei
prati, erge nell’aria le sue
torrette, i suoi comignoli
squadrati. Lo Cher passa
mormorando sotto le sue
arcate, i cui piloni appuntiti
frangono la corrente. La sua
eleganza è robusta e dolce,
la sua calma è malinconica
senza noia o amarezza”.

|
NUMERI
-
La galleria sul ponte
è lunga 60 metri,
larga 6 metri e ha 18
finestre. Fu
utilizzata come sala
da ballo, uno spazio
di ricevimenti unico
al mondo.
-
Il Giardino di Diane
ha una superficie di
12000 metri quadrati.
-
Il Giardino di Diane
è decorato con 8
triangoli di prato
verde e ciuffi di
santoline lunghi 3 km.
-
Il labirinto circolare
ha una superficie di 1
ettaro, ha 2000 taxus
alti 130 cm.
-
2 volte a settimana
vengono rinnovate le
decorazioni floreali
di ogni stanza del
castello, in modo che
i visitanti abbiano
l’impressione di
visitare una residenza
abitata.
-
La stanza delle 5
Regine è dedicata
alle 2 figlie e 3
nuore di Caterina
de’ Medici, tutte
incoronate: Marie
Stuart, Marguerite de
France, Louise de
Lorraine, Élisabeth
d’Austria,
Elisabetta di Francia. |

Pag.
8 
 Pag.
10
Pag.
10
|