Basterebbero
tutti i riconoscimenti
ricevuti da Montsoreau
(incluso nei più bei villaggi
di Francia, tra la Piccole
città di Carattere, tra i
Borghi Fioriti e classificato
tra i luoghi Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco) a
farne una tappa
imprescindibile durante un
soggiorno nella Valle della
Loira.Piccolo paese di
cinquecento abitanti,
Montsoreau è situato sulle
rive della Loira, tra Saumur e
Chinon, nel cuore del Parco
naturale regionale
Loire-Angers-Touraine. Prima
di ricevere tutte le etichette
che abbiamo visto, Alexandre
Dumas aveva esaltato le
bellezze di questo paese e del
suo castello nel suo romanzo La
dama di Montsoreau.
In
effetti il suo castello
rinascimentale, la cui
bianchezza immacolata si
riflette sulla Loira, le sue
viuzze fiorite come giardini,
le sue antiche case di tufo
bianco dai tetti d'ardesia
fanno di Montsoreau il
palcoscenico perfetto di un
romanzo storico. La storia di
questo villaggio di 500 anime
non si riduce, ciononostante,
al Rinascimento: proprio a
strapiombo suilla Loira, il
sito ''Le Saut aux Loups'' (il
salto dei lupi), racconta una
storia che risale alla notte
dei tempi, quando l'uomo vi
aveva già trovato la propria
dimora, così come il lupo.
Fu
l'estrazione del tufo,
iniziata nel Medio Evo a dare
al colle la sua forma così
particolare che ancora oggi lo
contraddistingue. Questa
attività terminò nel XIX
secolo, e fu allora che le
gallerie furono adibite alla
coltivazione dei funghi:
ancora oggi sono visitabili.
Come il terreno del Salto dei
Lupi ha riservato molte
ricchezze, anche il terreno su
cui riposa questo borgo è
ricco e prospero, con le sue
vigne da cui si producono
numerosi vini DOC come il
Saumur, il Saumur-Champigny e
il Crémant de Loire.
 Il
castello di Montsoreau sorge a
pochi metri dalla riva della
Loira ma, quando fu costruito
nel XV secolo, la fronte del
castello era direttamente
lambita dalle acque del fiume,
a cui nel 1820 fu ingrossato
l’argine. Il costruttore,
Jean de Chambes, personaggio
della corte di Carlo VII,
aveva inteso di farne un punto
di controllo sulle diverse vie
che toccavano la zona, tra cui
quella frequentata dai
pellegrini in marcia verso
l’abbazia di Fontevraud. Il
castello di Montsoreau sorge a
pochi metri dalla riva della
Loira ma, quando fu costruito
nel XV secolo, la fronte del
castello era direttamente
lambita dalle acque del fiume,
a cui nel 1820 fu ingrossato
l’argine. Il costruttore,
Jean de Chambes, personaggio
della corte di Carlo VII,
aveva inteso di farne un punto
di controllo sulle diverse vie
che toccavano la zona, tra cui
quella frequentata dai
pellegrini in marcia verso
l’abbazia di Fontevraud.
Il
nome Montsoreau appare per la
prima volta nella sua forma
latina Castrum Monte
Sorello o Mons
Sorello in un registro del
1086, in cui Mons o Monte si
riferisce ad un promontorio
roccioso. L'origine e
l'interpretazione del nome Sorello sono
ancora sconosciute ma secondo
Ernest Nègre il termine
significherebbe «fulvo» o «rosso».
Questa roccia deve certamente
la sua notorietà abbastanza
antica al fatto che si trovava
nel letto della Loira,
parzialmente circondata dalle
sue acque durante i periodi
delle alluvioni. Inoltre,
prima della costruzione della
fortezza, un edificio
amministrativo o di culto
occupava il sito già dal
periodo gallo-romano.
Costruito
in una posizione strategica,
su un promontorio roccioso nel
letto della Loira, immediatamente
alla confluenza dei fiumi
Loira e Vienne, si trova
all'incrocio di tre regioni
(Angiò, Poitou e Turenna),
nel cuore della Valle della
Loira. Il castello fu
costruito immediatamente sulle
rive della Loira, ai piedi
della collina, con una base di
tufo naturale costituita da
una roccia ancora visibile in
alcuni punti, in particolare
nel cortile del castello.
Questo
tipo di fondazione naturale è
abbastanza comune nella
costruzione di grandi edifici.
La sua posizione topografica
è piuttosto sfavorevole dal
punto di vista difensivo. Si
trova tra due piccole valli
che isolano una porzione
dell'altopiano di circa trenta
ettari, i cui bordi sono
piuttosto ripidi a est e a
ovest.
Il
sito, che si trova tra il
fiume Loira a nord e il
villaggio a sud, è costituito
da due gruppi distinti. L'aia,
alla quale si accede
attraverso un passaggio
coperto che costeggia la
cappella del castello, ospita
ancora due abitazioni. A est,
la parte signorile è protetta
su tre lati da un ampio e
profondo fossato. Un ponte
levatoio era l'unico modo per
attraversare questo fossato ed
entrare nel cortile superiore
del castello.
La
facciata nord dell'edificio
principale era originariamente
bagnata direttamente dal fiume
Loira prima della costruzione
della strada lungo il fiume
intorno al 1820. La
pianta dell'abitazione,
fiancheggiata da due torri
quadrate, è prolungata da tre
ali, due a sud e una nel
prolungamento occidentale
dell'edificio. Due torri di
scale si trovano agli angoli
dell'edificio principale con
le ali rivolte verso il retro.
Una porzione della cortina
muraria, che si è conservata
sul lato est, collega l'ala
est ai resti di una torre
abbandonata, impropriamente
chiamata «il maschio »,
ancora visibile alla fine del
XVII secolo. Un potente
bastione in terracotta,
scavato nell'estate del 2000,
in cui sono state rinvenute
parti del castello dell'XI
secolo, chiude il cortile a
sud.
Il
villaggio che oggi porta il
nome di Montsoreau era
originariamente composto da
due entità:
il
porto di «Rest», vicino al
torrente chiamato Arceau;
il
castello « Rest sous
Montsoreau », sulla
parte opposta, ai piedi della
collina, sulle rive della
Loira.
Il
nome «Rest» deriverebbe dal
latino Restis che
significa «rete» in
riferimento ai numerosi
pescatori stabilitisi nel
villaggio. Il castello è
costruito in una posizione
strategica, su un promontorio
roccioso nel letto della
Loira, a valle della
confluenza della Loira con la
Vienne. Fu costruito
immediatamente sulle rive
della Loira, ai piedi della
collina, sulla riva sinistra
del fiume, con una base di tufo naturale
costituita da una roccia
ancora visibile in alcuni
punti. Questo tipo di
fondazione naturale è
abbastanza comune nella
costruzione di grandi edifici.
La sua posizione topografica
sembra essere piuttosto
sfavorevole dal punto di vista
difensivo, ma l'ipotesi
secondo cui nel luogo chiamato
« La Motte » ci
fosse un castello monticello
potrebbe spiegare
l'invulnerabilità della
fortezza che precede il
castello nel corso della
storia. Infatti, solo Enrico
II Plantageneto riesce a
conquistare la fortezza
costruita da Folco III
d'Angiò durante i suoi
450 anni di esistenza. Si
trova tra due piccole valli
che isolano una porzione
dell'altopiano di circa trenta
ettari i cui bordi sono
abbastanza ripidi a est e a
ovest.
Il
castello di Montsoreau si
trova nel cuore della Valle
della Loira. A nord, la Valle
della Loira forma una pianura
alluvionale situata a circa 30
metri sul livello del
mare. Le banche sono spesso
soggette ad inondazioni. Sulla
riva destra, la geografia del
fiume Loira presenta numerose
isole: Isola aux Mignons,
Isola Drugeon, sola Ruesche e
Isola au Than, situate proprio
di fronte al castello. I
terreni che vi si trovano sono
molto fertili e adatti alle
colture. A sud del fiume, un
altopiano calcareo del Cretaceo domina
la Loira ad un'altitudine
media di 70 metri sul livello
del mare. Viene utilizzato
principalmente per la viticoltura.
Questo altopiano è composto
da tufo turoniano,
rinomato per le sue qualità
architettoniche. La valle
dell’Arceau, perpendicolare
alla Loira, attraversa questo
massiccio calcareo all'altezza
di Montsoreau. A sud, più a
monte, il suo spartiacque
forma il bacino di Fontevraud-l'Abbaye.
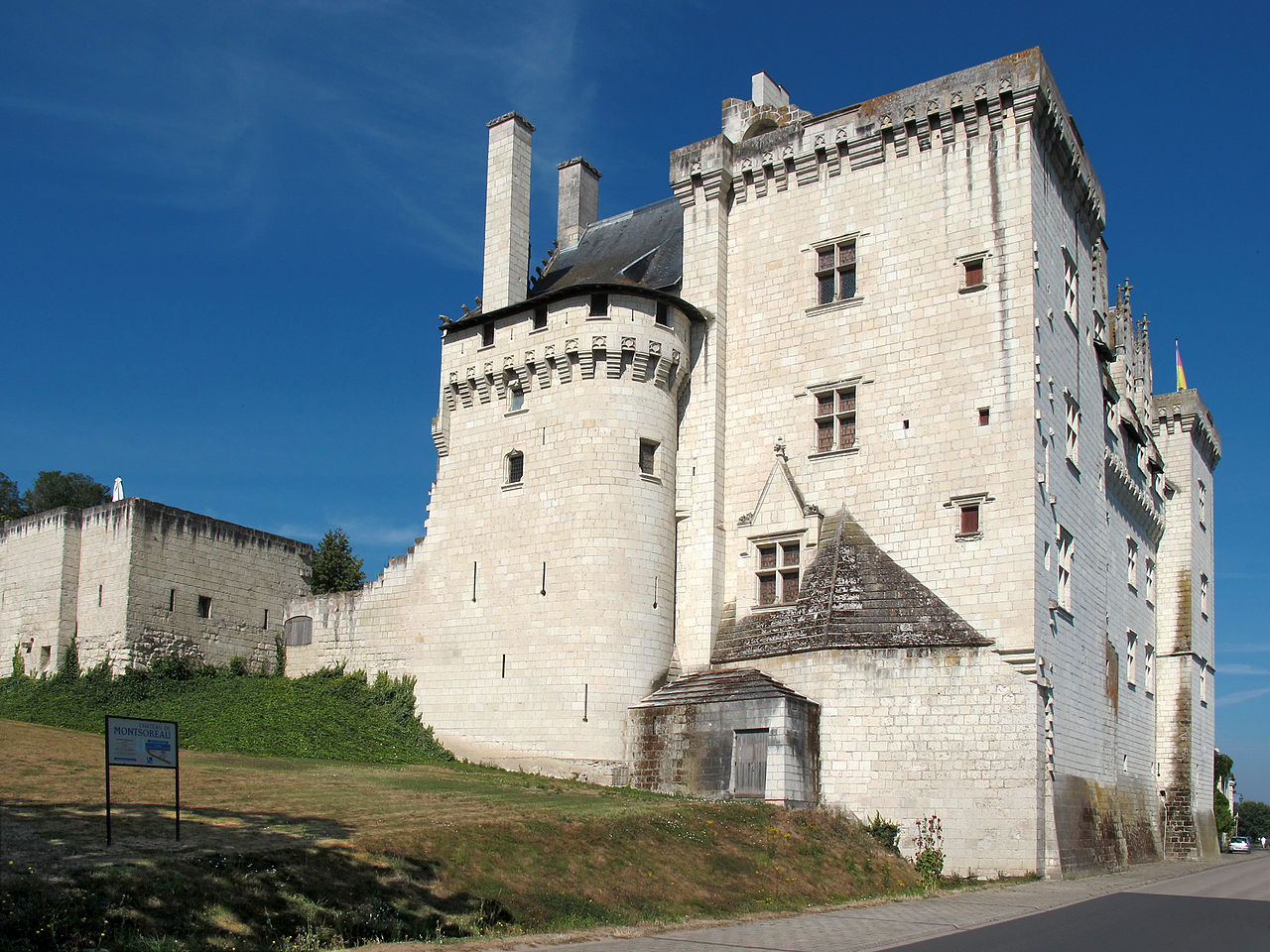
L'esistenza di un luogo
chiamato "La Motte",
leggermente arretrato rispetto
alla collina, potrebbe evocare
il ricordo di una
fortificazione che proteggeva
il basso castello. Tuttavia,
questa ipotesi non è
supportata da alcuna traccia
sul terreno, anche se va
notato che i campi circostanti
mostrano una dispersione di
frammenti di tegole su una
vasta area. Più in generale,
la presenza di mobili
gallo-romani sul sito
testimonia l'esistenza di un
sito antico, indubbiamente
importante ma ancora poco
conosciuto. Lo scavo del
terrapieno a sud del castello
ha restituito, tra l'altro, un
fusto di colonna scanalata
proveniente probabilmente da
un tempio o da un
edificio pubblico
dell'antichità. Alcune
ipotesi archeologiche possono
essere avanzate sull'edificio
che ha preceduto la fortezza
costruita da Oddone I di
Blois nel 990: la
presenza di un edificio
chiamato Villa di Rest-sous-Montsoreau è
attestata nel 541 come
proprietà di Hardearde,
vicario di Innocenzo, vescovo
di Le Mans. Nell'VIII e
IX secolo, questa Villa di
Rest-sous-Montsoreau
apparteneva ai canoni di San-Martino-di-Tours.
Nell'832,
l'imperatore Ludovico il
Pio, figlio di Carlo
Magno, poi in Aquitania
durante l'inverno di
San-Martino, si rifugiò in
Francia, al «Castello di Rest»,
per sfuggire ai rigori
dell'inverno. Il 5
gennaio 844 o 855, Carlo
II il Calvo confermò, in
una carta, ai monaci di
San-Martino-di-Tours il
possesso della villa di Rest-sous-Montsoreau.
Il
nome Castello di Montsoreau
rimane soprattutto legato al
Monte Soreau su cui è
costruito. In effetti, il
Monte Soreau conobbe tre
edifici nei duemila anni della
sua occupazione. Del primo
edificio non si sa nulla,
tranne una colonna scanalata
trovata nel fossato durante i
restauri del XX secolo. Il
Monte Soreau fu poi
fortificato da Oddone I
Conte di Blois e poco
dopo passò sotto la corona
angioina di Folco il
Nero. Questa fortezza fu
teatro di epiche battaglie tra
i Conti d'Angiò e i Conti di
Blois in prima istanza, e il Re
d'Inghilterra e il Re
di Francia in seconda
istanza. L'ultimo edificio è
ancora in funzione nel XXI
secolo e anche se è uno dei
primissimi edifici rinascimentali in
Francia, è comunque legato
allo zelo del suo proprietario
durante l'esecuzione del
massacro della San
Bartolomeo di Angiò.
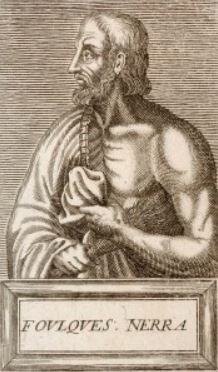 La
prima menzione scritta che
attesta l'occupazione del sito
da parte della tenuta di
Restis risale al VI secolo. Fu
trasformata in una roccaforte
intorno al 990 dal conte di
Blois Oddone I, poi passò
sotto il dominio angioino poco
prima del 1001. Il conte Folco
il Nero affidò la
guardia al cavaliere Gualtieri
di Montsoreau, che apparteneva
a una delle più prestigiose
famiglie d'Angiò. Così, il castrum
Monsorelli fa parte della
quarantina di roccaforti
d'Angiò ed è uno dei pochi
siti che già nelle prime ore
dell'anno Mille aveva lo
statuto di signoria
castellana. Un agglomerato si
sviluppa rapidamente intorno
al castello. Un luogo è
attestato nelle fonti scritte
a partire dall'XI secolo. La
prima menzione scritta che
attesta l'occupazione del sito
da parte della tenuta di
Restis risale al VI secolo. Fu
trasformata in una roccaforte
intorno al 990 dal conte di
Blois Oddone I, poi passò
sotto il dominio angioino poco
prima del 1001. Il conte Folco
il Nero affidò la
guardia al cavaliere Gualtieri
di Montsoreau, che apparteneva
a una delle più prestigiose
famiglie d'Angiò. Così, il castrum
Monsorelli fa parte della
quarantina di roccaforti
d'Angiò ed è uno dei pochi
siti che già nelle prime ore
dell'anno Mille aveva lo
statuto di signoria
castellana. Un agglomerato si
sviluppa rapidamente intorno
al castello. Un luogo è
attestato nelle fonti scritte
a partire dall'XI secolo.
All'epoca
dell'insediamento della
comunità fontevrista nel
1101, l'abbazia di Fontevrault
dipendeva da Gualtieri I di
Montsoreau, vassallo diretto
del conte di Angiò. La
suocera di Gualtieri, Hersende
di Champagne, è stata la
prima grande priore durante la
vita di Roberto
d'Arbrissel.
Nel
1150, Enrico II fu
nominato duca di Normandia all'età
di 17 anni e un anno dopo, nel
1151, ereditò la contea
d'Angiò alla morte del padre Goffredo
V d'Angiò. Nel 1152, Enrico
II sposò la duchessa Eleonora
d'Aquitania, divorziata otto
settimane prima dal re di
Francia Luigi VII, un
matrimonio che contravveniva a
tutti i costumi feudali.
Questo matrimonio, oltre
all'affronto e alla sfiducia
che rappresentava nei
confronti di Luigi VII,
creò un profondo risentimento
tra il re di Francia.
Così,
durante la rivolta organizzata
da Goffredo VI nel 1152 contro
il fratello per i suoi
possedimenti ad Angiò,
Goffredo VI trovò un alleato
d'elezione con Luigi VII.
Questa rivolta si concluse con
l'assedio e la cattura della
fortezza di Montsoreau,
costringendo Goffredo a
capitolare quando i suoi
principali alleati si erano già
arresi e Luigi VII si era
ammalato.
Enrico
II rimase conte d'Angiò, ma
le fortezze di Chinon,
Mirebeau, Loudun e
Montsoreau furono restituite a
Goffredo nel 1154, anche se
una disposizione del
testamento di suo padre
stabiliva che la contea d'Angiò
sarebbe tornata a Gofredo se
Enrico fosse diventato re
d'Inghilterra. Il
legittimo proprietario di Angiò, Normandia e
Aquitania in virtù della sua
alleanza con Eleonora, Enrico
II partì alla riconquista
dell'Inghilterra, allora
occupata da Stefano di Blois,
cugino di sua madre Matilde
d'Inghilterra, figlia del re
d'Inghilterra Enrico I.
Nel 1153 firmò il trattato
di Wallingford con il re
Stefano, dandogli in eredità
l'Inghilterra, e alla sua
morte, nel 1154, Enrico II
divenne re d'Inghilterra.
Nel
1156, Goffredo organizzò una
seconda rivolta contro il
fratello, che portò ancora
una volta alla cattura di
Montsoreau alla fine di agosto
del 1156, nonostante la cura
posta nella sua
fortificazione. Goffredo
e Guglielmo di Montsoreau sono
stati fatti prigionieri.
Goffredo riconquistò Loudun e Guglielmo
di Montsoreau quello del
suo feudo un po' più tardi,
tuttavia Enrico II tenne
Montsoreau per suo uso
personale, apparentemente fino
alla sua morte. Intorno
al 1168, Enrico II ordinò la
costruzione del primo argine
della Loira tra Langeais e Saint-Martin-de-la-Place su
oltre 45 km per proteggere la
valle. Questo ordine del
Re d'Inghilterra è stato
firmato da Guglielmo di
Montsoreau e da suo figlio
Guglielmo. Nel 1171,
quest'ultimo concesse ai
monaci di Turpenay il diritto
di costruire case libere da
ogni diritto d'autore
all'interno del recinto del
castrum.
Con
Gualtieri, suo figlio
maggiore, non avendo figli
maschi, la signoria passò
alla famiglia Savary di
Montbazon, in seguito al
matrimonio della figlia Ferrie
con Pietro II Savary, signore
di Montbazon nel 1213. La
famiglia Savary di Montbazon
possiede la terra di Montbazon
da una donazione fatta da Filippo
Augusto, una donazione del re
che li obbliga a mettere
questa terra nelle sue mani
ogni volta che ne fa richiesta
e proibisce loro di
fortificarla senza il suo
consenso. Dopo la sua vittoria
a Bouvines, Filippo Augusto lo
scelse nel 1214, insieme a
Guido Turpin, arcidiacono di Tours,
per fare pace con il re
d'Inghilterra Giovanni
senza terra.

La
seconda casa di Montsoreau si
estinse nel 1362, quando
l'unica figlia di Rinaldo VII
sposò Guglielmo II di Craon.
La famiglia di Craon (i
visconti di Chateaudun) ha
conservato la signoria fino al
1398. La quarta casa,
quella degli Chabot, durò poi
solo pochi decenni. Nel 1450,
per saldare vari debiti, Luigi
II Chabot vendette i suoi
possedimenti di Montsoreau e
della Coutancière al cognato, Giovanni
II di Chambes, che aveva già
intrapreso tra il 1443 e il
1453 la costruzione
dell'attuale castello di
Montsoreau. Discendente di
un'antica famiglia nobile
dell’Angoumois, Giovanni II
di Chambes entrò al servizio
di Carlo VII nel 1426 in
quanto scudiero, due anni
prima del famoso incontro tra Carlo
VII e Giovanna
d'Arco al castello
di Chinon.
Panettiere
nel 1438, consigliere e poi
ciambellano, divenne nel 1444
«primo maggiordomo» del re,
in quel periodo si unì a Giacomo
Coeur. Dopo la disgrazia di
quest'ultimo nel 1453,
Giovanni II de Chambes
ricevette una considerevole
somma di denaro che il
finanziere gli doveva. Carlo
VII gli affidò diverse
delicate missioni diplomatiche
e lo inviò come ambasciatore
presso la Repubblica di
Venezia nel 1459 per
preparare una nuova crociata a Roma e
in Turchia. Le sue
signorie di Montsoreau e di
Argenton, ma anche le sue
varie cariche - fu in seguito
governatore di La
Rochelle e anche
capitano-castellano e vicario
di Niort, Talmont-sur-Gironde e Aigues-Mortes -
gli assicurarono un reddito
considerevole.
Dal
1450 al 1460, Giovanni II de
Chambes svolse sempre più un
ruolo di ambasciatore; fu
spesso chiamato a rimanere
fuori da Angiò, mentre il suo
castello era in costruzione ;
questi dieci anni
rappresentarono un notevole
aumento della sua influenza
politica e finanziaria grazie
alla sua vicinanza a Carlo
VII. Meno vicino al suo
successore Luigi XI,
Giovanni II di Chambes si
ritirò gradualmente dalla
vita politica a partire dal
1461.
Giovanni
III successe a suo padre,
morto nel 1473, e sposò Maria
di Châteaubriant, che fondò
nel 1519 la collegiata di
Santa-Croce dall'altra parte
del fossato che circonda il
castello. Nel 1505, Anna
di Bretagna e sua figlia Claudia
di Francia soggiornarono per
un mese al castello di
Montsoreau prima di scendere
la Loira verso la Bretagna. In
seguito, Claudia di Francia si
fidanzò con Carlo di
Lussemburgo per facilitare la
conduzione della terza
guerra italiana rafforzando
l'alleanza spagnola. Luigi
XII fece annullare il
fidanzamento nel 1505 e ordinò
il suo matrimonio con
Francesco di Valois-Angoulême,
il futuro Francesco I.
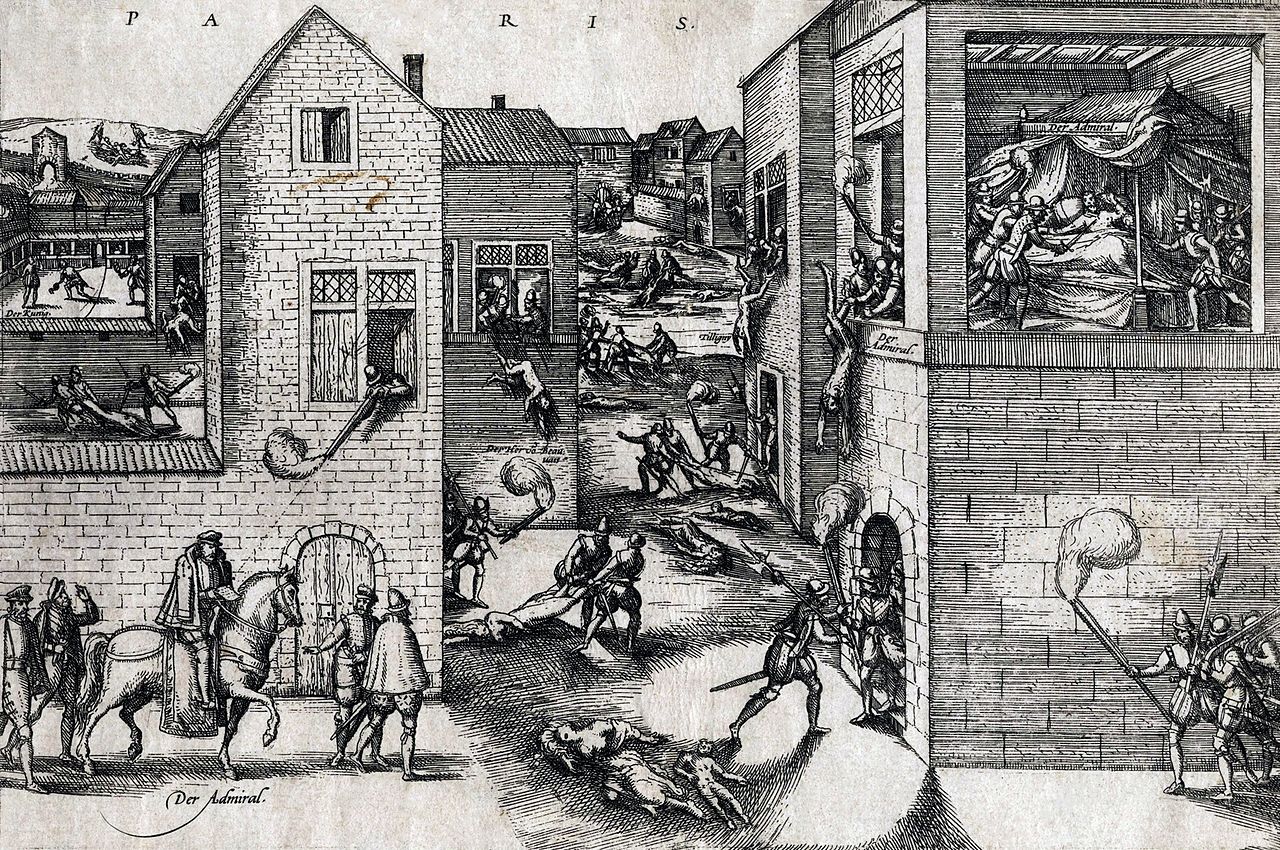
Giovanni
IV di Chambes è l'esecutore
della San Bartolomeo angioina.
Nel 1530, Filippo di Chambes,
che viveva a Montsoreau, sposò
Anna di Laval-Montmorency. Il
figlio maggiore, Giovanni IV
di Chambes, eredita Montsoreau
e il dominio della Coutancière
che diventa una baronia nel
1560. Montsoreau viene
saccheggiata dai protestanti nel
1568. La collegiata Santa
Croce e le fortificazioni
della città vengono
distrutte. Il 22 agosto 1572
l'attentato a Gaspard di
Coligny fu l'evento che
scatenò il massacro dei
protestanti a Parigi che
avvenne due giorni dopo, nel
giorno di San Bartolomeo.
Questo massacro durò diversi
giorni per poi estendersi a più
di venti città di provincia. Giovanni
IV di Chambes organizzò con
zelo la «San Bartolomeo» a Saumur e
a Angers i 28 e 29
agosto, nonostante il divieto
disposto dal re Carlo IX nel
28 agosto. La baronia di
Montsoreau fu istituita come
contea con lettere brevettate
del 1573 e del 1575. Dopo la
morte di Giovanni IV de
Chambes, avvenuta nel 1575, il
fratello Carlo di Chambes
divenne conte di Montsoreau e
sposò l'anno successivo
Francesca di Maridor, il cui
nome rimane legato
all'assassinio di Louis de
Bussy di Amboise.
Una
guarnigione di cinquanta e poi
venti soldati risiedeva nel
castello nell'ultimo decennio
del XVI secolo. Tuttavia, non
esiste più sotto il regno di Luigi
XIII: René de Chambes chiese
una guarnigione di truppe
reali, ma Richelieu rifiutò.
Secondo Tallement de Réaux
nelle sue Storiette,
Renato di Chambes sarebbe
stato condannato come falsario
per l'accusa di una delle sue
amanti. È condannato a
morte e deve fuggire in
Inghilterra da dove non tornerà
più. Dopo la morte del suo
successore Bernardo di
Chambes, il castello di
Montsoreau è occupato solo
raramente dai suoi vari
proprietari.
 Catherine
de Chambes, la figlia maggiore
di Bernardo di Chambes, sposò
Luigi-Francesco I del Bouchet,
morto nel 1716, lasciando
400.000 sterline di debiti. Il
figlio maggiore, Luigi I del
Bouchet, sposò Jeanne de
Pocholle du Hamel che gli portò
200.000 sterline di dote. Nel
1793 il castello di Montsoreau
è stato dichiarato proprietà
nazionale. Catherine
de Chambes, la figlia maggiore
di Bernardo di Chambes, sposò
Luigi-Francesco I del Bouchet,
morto nel 1716, lasciando
400.000 sterline di debiti. Il
figlio maggiore, Luigi I del
Bouchet, sposò Jeanne de
Pocholle du Hamel che gli portò
200.000 sterline di dote. Nel
1793 il castello di Montsoreau
è stato dichiarato proprietà
nazionale.
La
vedova di Luigi-Francesco II
del Bouchet de Sourches,
marchese di Tourzel, vendette
il castello nel 1804. In
seguito alla vendita della
proprietà, l'edificio è
stato occupato da 19
proprietari che hanno
ristrutturato il sito. Lo
stato esterno dell'edificio
principale è in parte noto
grazie a varie
rappresentazioni e descrizioni
effettuate nella seconda metà
del XIX secolo, che mostrano
lo stato fatiscente
dell'edificio.
Nel
1910 il castello si trovava in
pessimo stato, cosa che
preoccupava i membri della
Società Archeologica
Francese. Grazie alla
combattività del senatore de
Geoffre, che ha sensibilizzato
il Consiglio generale, il
Dipartimento del Maine-e-Loira
acquistò gradualmente le
varie proprietà a partire dal
1913 e i lavori di restauro,
iniziati nel 1923,
continuarono senza
interruzioni fino alla seconda
guerra mondiale.
Restauri
del XX secolo
Nel
1919, lo Stato e il Consiglio
generale del Maine-e-Loira,
sotto l'impulso di Giovanni di
Geoffre di Chabrignac,
lanciano una grande campagna
per restaurare il castello di
Montsoreau allora in rovina.
La prima fase consisté nel
proteggere l’edificio dalle
acque piovane con l'aiuto di
coperture temporanee.
Danneggiate le travi modanate
del XV secolo, Jean Hardion,
architetto capo dei monumenti
storici, decise di incorporare
cemento armato nel legno
originale.
Le
nuove parti in cemento vennero
dipinte per creare l'illusione
del legno da un artigiano
angioino di nome Leboucher. La
cornice originale in legno di
castagno viene consolidata e
completata. Il lavoro si
interrompe durante la e
riprese alla fine del
conflitto.
| Data |
Restauri |
|
1923
- 1928
|
I
primi consolidamenti e
la protezione
dell'edificio dalle
acque vengono
effettuati
dall'architetto capo
J. Hardion e da
Bricard, architetto
del dipartimento di
Maine-e-Loira. |
| 1923 |
Riparazione
dell'attico centrale e
dei lucernari.
|
| 1924 |
Consolidamento
delle volte della
parte occidentale;
consolidamento
mediante la posa di
travi in calcestruzzo
nell'asse
trasversale
del corpo centrale del
castello. |
| 1925 |
Riparazione
della copertura della
parte orientale;
consolidamento del
frontone sud e dei
ceppi del camino. |
| 1926 |
Restauro
della torre di scala
rinascimentale. |
| 1927
- 1928 |
Completamento
del restauro della
struttura del tetto e
della copertura
dell'edificio centrale
e del suo piano
superiore in travi e
soletta in cemento
armato. |
| 1929
- 1931 |
Restauro
della falegnameria
esterna; restauro del
pavimento dell'ultimo
piano del padiglione
ovest con travi e
soletta in
calcestruzzo. |
| 1933
- 1934 |
Creazione
di un accesso sul lato
est sotto la direzione
dell'architetto capo
M. Lotte; demolizione
delle costruzioni
parassitarie del XIX
secolo nel cortile
principale. |
| 1935 |
Sistemazione
dei locali al piano
terra del castello e
parziale restituzione
del pavimento al 1º
piano. |
| 1936 |
Consolidamento
del ponte di accesso
al castello sul lato
ovest (accesso Piazza
delle diligenze). |
| 1937 |
Completamento
del restauro della
torretta della scala
occidentale nota come
Scala Medievale. |
| 1939 |
Copertura
temporanea del
padiglione est;
restauro delle mura
del castello. |
| 1948
- 1949 |
Riparazioni
puntuali a cura
dell'architetto capo
B. Vitry. |
| 1951
- 1954 |
Impermeabilizzazione
delle terrazze dei due
padiglioni,
regolazione della
muratura. |
| 1955
- 1956 |
Installazione
del museo dei Goums
marocchini nelle sale
del castello. |
| 1957
- 1964 |
Riparazione
dei telai e dei tetti
della scala ovest;
restauro della
muratura della
latrina;
consolidamento esterno
e sostegno ad ovest;
la scala in legno che
porta ad est è
ricostruita in pietra.
|
| 1993 |
Installazione
di un parcheggio sulle
rive della Loira e
trattamento del
conglomerato
bituminoso a livello
del molo
Alexandre-Dumas da
parte dei servizi
stradali del
dipartimento. |
| 1994 |
Rapporto
di studio archeologico
di Dominique Prigent
del Servizio
dipartimentale
dell'Archeologia.
Studio preventivo al
restauro degli edifici
e del muro di cinta
dal capo architetto G.
Mester di Parajd. |
| 1994
- 2001 |
Lavori
di restauro degli
edifici e del muro di
incinta del castello:
consolidamento delle
strutture,
restituzione delle
parti alte. Apertura
alla visita 6 luglio
2001 di un percorso di
visita suoni e luci
intitolato. |
Museo dei goum marocchini e degli affari indigeni del Marocco
Dal
1956 al 1999, il castello di
Montsoreau ospitata il Museo
dei goum marocchini e degli
affari indigeni del Marocco. Nel
1956, quando il Marocco diventa
indipendente e i goum marocchini
- unità di fanteria leggera
dell'esercito africano
composte da truppe marocchine
native sotto la supervisione
francese - costituiscono il
nucleo dell'Esercito reale
marocchino, il colonnello
Aunis ottiene dal Consiglio
generale del Maine e Loira
l'autorizzazione ad utilizzare
le sale al primo piano del
castello di Montsoreau per
allestire il Museo dei goum
marocchini e degli affari
indigeni del Marocco con lo
scopo di ricordare questo
periodo.
Questa
autorizzazione è stata
ratificata con la firma di un
contratto di locazione
enfiteutica di 99 anni tra la
Koumia (Associazione degli ex
goum marocchini e degli affari
indigeni del Marocco) e il
Consiglio generale del Maine e
Loira. L'inaugurazione avvenne
nell'agosto 1956 alla presenza
del maresciallo Juin e del
colonnello Mac Carthy. Terminatosi
prematuramente il contratto
enfiteutico, il museo chiuse
il 1º marzo 1997.
Museo
di arte contemporanea dal 2016
Nel
gennaio 2016, il Consiglio
dipartimentale del
Maine-e-Loira ha consegnato il
castello a Philippe Méaille tramite
un contratto d'affitto
enfiteutico di 25 anni. Da
aprile 2016, Philippe Méaille
vi presenta la sua collezione
d'arte contemporanea incentrata
su Art & Language. Si
tratta della più grande
collezione al mondo di opere
di Art & Language,
collettivo di artisti inglesi,
americani e australiani
considerati gli inventori
dell'arte concettuale. Il
museo, denominato Castello
di Montsoreau-Museo di arte
contemporanea, ha aperto in
aprile 2016.
La
collezione Philippe Méaille
viene regolarmente prestata a
musei internazionali e
nazionali (Centre
Georges-Pompidou a Parigi,
MACBA a Barcellona, Guggenheim
Museum a Bilbao,
Centre de création
contemporaine Olivier Debré
(CCCOD) a Tours e per mostre
tematiche (nel maggio 1968 con Sollevamenti alla Galleria
nazionale dello Jeu de Paume a
Parigi e Luther und
die Avant Garde a Wittenberg).
Nell'anno
della sua apertura, il museo
ha accolto 35.000 visitatori.
Quell'anno ha edicato una
mostra temporanea
all’artista Agnès
Thurnauer e per due volte
ha reso omaggio all'artista
minimalista François
Morellet. Primo omaggio fu la
creazione, l'8 aprile 2016,
del Premio François Morellet,
che ogni anno ricompensa un
autore per il suo impegno
nell'arte contemporanea. Il
premio est remis durante le
Giornate nazionali del libro e
del vino a Saumur. La
prima edizione del Premio François
Morellet ricompensò Catherine
Millet. Il Castello di
Montsoreau – Museo di arte
contemporanea rese omaggio a
François Morellet una seconda
volta installando una delle
opere di François Morellet
sulla facciata del castello
nel dicembre 2016 mentre François
Morellet era morto 9 mesi
prima, il 10 maggio 2016.
Architettura
La
scala con la quale si entra
nel castello termina in un
cortile quadrangolare. A nord,
sul lato della Loira, sorge
l'edificio principale, situato
tra due alti padiglioni
affiancati, a est e a ovest,
da due piccole ali ad angolo
retto. A est rimane una torre
rettangolare in rovina,
impropriamente chiamata
mastio, che nel secolo scorso
è stata spianata a pochi
metri dal livello del suolo.
Sul lato opposto, anche il
padiglione d'ingresso è stato
distrutto per recuperare
materiali da costruzione. A
sud rimane solo un grande
bastione di terra battuta,
trafitto da cantine, che ha
raddoppiato il muro di
cinta.
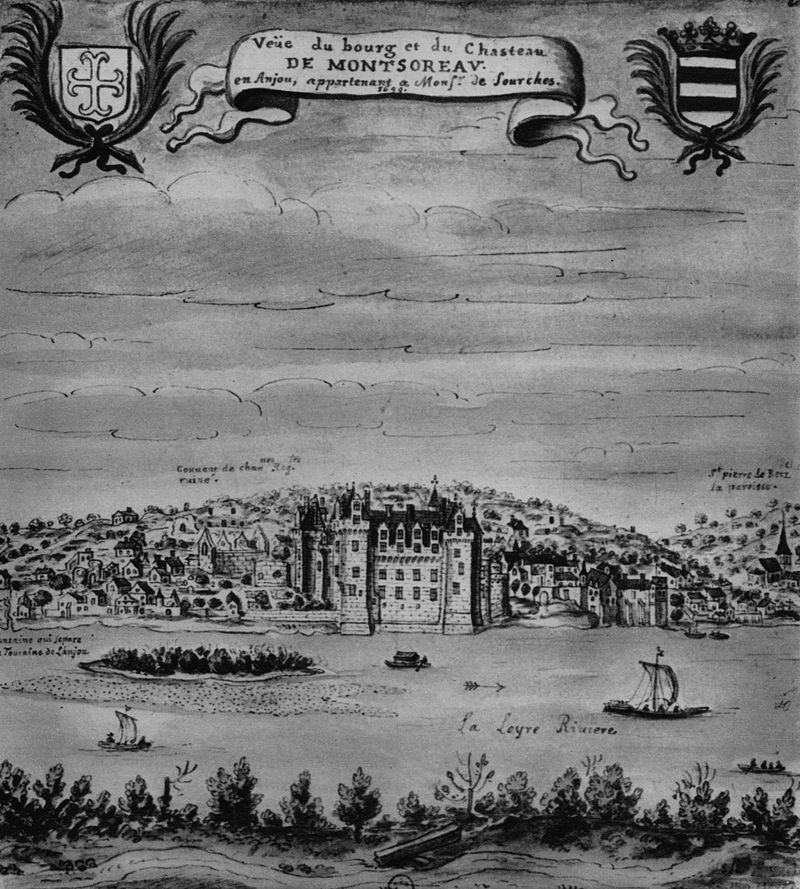 Al
di là del fossato si trova la
chiesa castrale di San
Michele, ora trasformata in
abitazione. Il fossato
difensivo, largo una ventina
di metri e originariamente
molto profondo, circonda il
castello su tre lati. Durante
gli alluvioni veniva
periodicamente invaso dalle
acque del fiume Al
di là del fossato si trova la
chiesa castrale di San
Michele, ora trasformata in
abitazione. Il fossato
difensivo, largo una ventina
di metri e originariamente
molto profondo, circonda il
castello su tre lati. Durante
gli alluvioni veniva
periodicamente invaso dalle
acque del fiume
L'intero
edificio è costruito in
pietra di tufo bianco. Questo
calcare morbido e poroso, così
comune in Angiò e Turenna,
qui è di ottima qualità. È
stato estratto da profonde
cave sotterranee scavate nella
roccia, nelle immediate
vicinanze del cantiere, e
tagliato in pietre di
dimensioni piuttosto modeste,
non molto diverse da quelle in
uso prima della Guerra
dei Cent'anni. I segni
lapidari - numeri romani
incisi sulla maggior parte
delle pareti interne - non
corrispondono all'identità
degli operai, ma indicano
l'altezza precisa delle
pietre, a testimonianza di
un'organizzazione del cantiere
molto elaborata.
I
tetti sono in ardesia di
Angers, come era consuetudine
in tutta la valle. La
facciata sulla Loira, con i
suoi due padiglioni
rettangolari leggermente
aggettanti e massicci, ha un
aspetto severo, anche se
questo è chiaramente
attenuato dalle
grandi bifore e
traverse. Ciò che la
differenzia dalla facciata del cortile -
che è comunque sobria - è
l'importanza della parte
inferiore del muro, che è
semplicemente traforata da
piccole aperture; questo
infatti riflette un'intenzione
architettonica massiccia volta
a lasciare un forte segno nel
paesaggio. Nessuna
materializzazione delle
campate sottolinea le linee
verticali; d'altra parte, la
camminata del parapetto mostra
una chiara linea
orizzontale.
Il
sistema difensivo del castello
è limitato al profondo
fossato, a qualche feritoia e
al camminamento a parapetto
coronato da caditoie.
Questi sono sostenuti da
staffe sagomate; il parapetto
è decorato con archi a
trifoglio di varie forme, che
rivelano un'interessante
preoccupazione estetica da
parte dei costruttori.
L'interno dell'edificio ha -
ed era già così al momento
della costruzione - diversi
elementi che riflettono un
desiderio di comfort, come le
grandi finestre che forniscono
una ottima illuminazione delle
stanze e sono dotate di sedili
(panca di pietra nel vano
della porta), o la presenza di
25 caminetti. D'altra
parte, i resti di decorazioni
dipinte che compaiono su
alcune ciminiere sono
post-costruzioni - devono
risalire al XVI secolo - e
sono poche le sculture.
Per
quanto riguarda le strutture,
le latrine sono state disposte
in cubicoli all'angolo dei
padiglioni e distribuite dal
piano terra al secondo piano.
L'evacuazione è stata
effettuata direttamente nella
Loira, attraverso semplici
tubi verticali. L'ala a est è
stata costruita più tardi e
ha un sistema più elaborato.
Gli
edifici del castello
EDIFIFI
DI SERVIZIO
Portico
d'ingresso -
Il
passaggio coperto all'ingresso
del sito castrale, che
assomiglia a un portico,
corrisponde all'edificio della
corte signorile di Montsoreau.
Segna l'accesso al cortile del
castello.
Corte
signorile -
La
corte di giustizia signorile
costituisce anche il portico
d'ingresso all'intero sito
castrale. L'edificio risale
alla fine del XV o
all'inizio del XVI
secolo. Ha elementi notevoli,
in particolare la sua facciata
in legno riccamente decorata.
Infatti, come Giovanna Chabot,
signora di Montsoreau, ammise
al re René nel 1480, la
baronia di Montsoreau ha i «diritti
di giustizia trainata, bassa e
media » esercitati dagli
ufficiali signorili.
Probabilmente ha mantenuto il
suo uso fino alla fine
dell'Antico
Regime. Durante
la Rivoluzione, quando
furono aboliti i diritti di
giustizia signorile,
l'edificio fu trasformato in
abitazioni e negozi. Oggi è
un'abitazione privata. Ad
ovest collega l'aia alla corte
signorile del castello. Nel
XVII secolo il ponte levatoio
fu sostituito da un ponte di
pietra dormiente.
Siniscalcato
e prigione -
L'alloggio
del Siniscalco è da
associare al tribunale
signorile situato a pochi
metri di distanza. Il
palazzo del Siniscalco fu
ristrutturato nel XVIII
secolo.
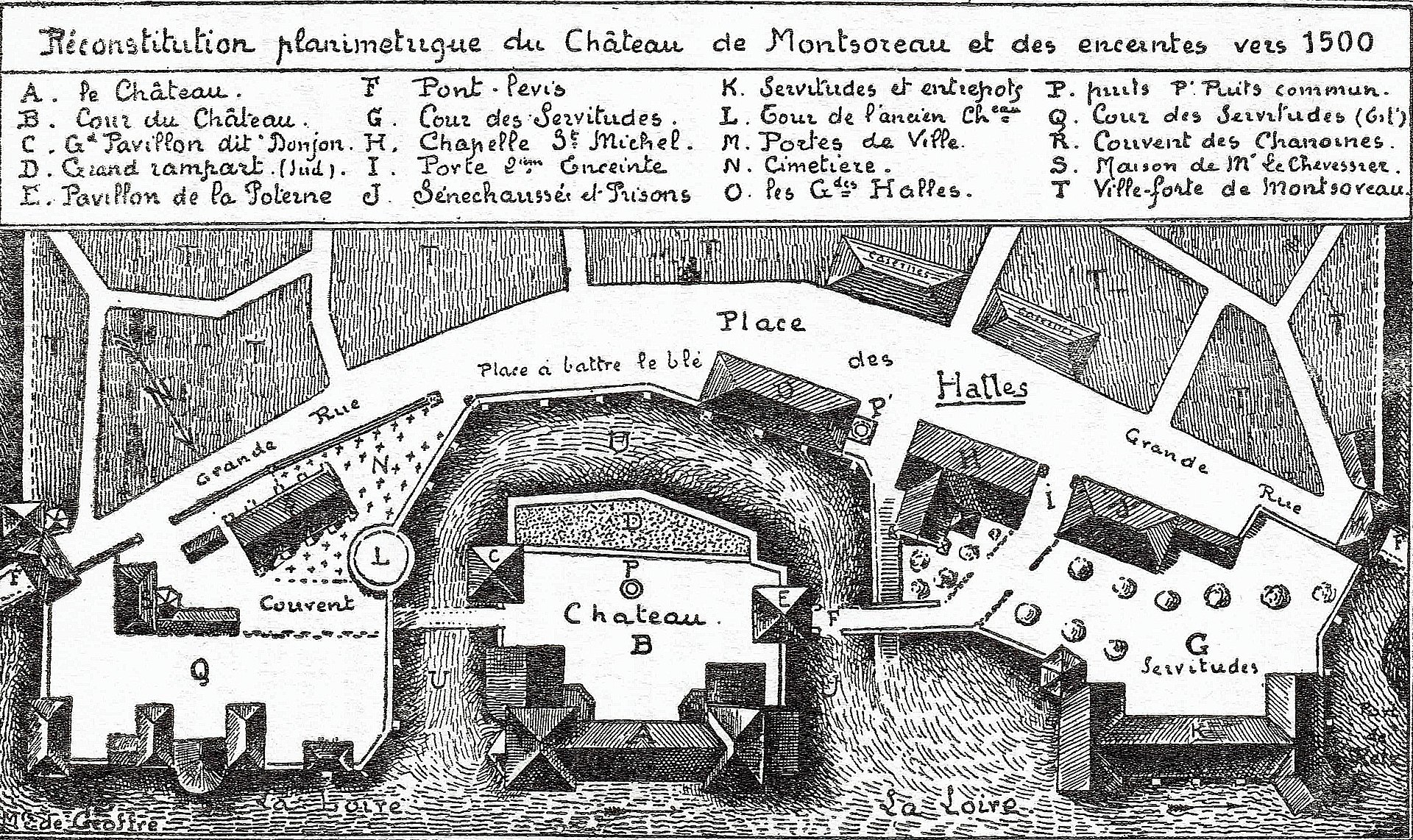
Chiesa
castrale di Nostra-Dama del
Boile -
La
chiesa castrale e parrocchiale
di Nostra-Dama del Boile e poi
San-Michele del Boile, nota
come cappella San-Michele, fu
fondata nel 1219 da Gualtieri
di Montsoreau e fu costruita
all'incrocio tra l'aia
castrale e la piazza del
mercato. Il termine «boile»
o «baile» si riferisce al
cortile del castello. Era uno
degli elementi principali del
complesso castrale dei signori
di Montsoreau. Svolgeva la
funzione di chiesa della
parrocchia del castello,
formando un'enclave
all'interno della parrocchia
di San-Pietro di Rest. I
parrocchiani erano la famiglia
signorile, gli ufficiali e la
servitù. Lo stemma della
famiglia de Chambes è
visibile sulla chiave di
volta della cappella.
Durante
il Medioevo e il Rinascimento,
la chiesa aveva cinque
cappelle:
-
una
cappella in onore della
Maddalena. Fondata da Rinaldo
VII Savary di Montbazon e da
sua moglie Eustachie
d'Anthenaise nel XIV secolo.
-
Cappella di San Nicola
-
Cappella Les Perrins
-
Cappella di San Michele
-
Cappella Nostra-Dama del Boile
La
chiesa servì anche come luogo
di sepoltura e necropoli
dinastica tra la fine del XV
secolo e l'inizio del XVI
secolo per i signori di
Montsoreau. Nel 1520, Maria di
Châteaubriant, signora di
Montsoreau, ne segnalò le
sepolture. Tra questi, quelli
di Giovanni III de Chambes,
Giovanni II de Chambes, Giovanna
Chabot. Ha contribuito a far sì
che il vecchio villaggio di
Rest venisse soppiantato dal
villaggio castrale. Con
l'arrivo della famiglia di
Chambes, la chiesa ha subito
importanti trasformazioni,
come testimonia il campanile.
Dal XVII secolo, la chiesa
prese il nome di Chiesa di
San-Michele, probabilmente
perché Filippo e Carlo di
Chambes furono fatti cavalieri
dell'Ordine di San-Michele. I
canoni del capitolo canonico
di Santa Croce occuparono
questa chiesa nei secoli XVII
e XVIII dopo la distruzione
della collegiata di Santa
Croce.
Oggi
l'edificio è un'abitazione
privata.
Porto
del castello
-
Il
porto del castello di
Montsoreau è un porto
importante nel Rinascimento,
con una grande attività
legata al pedaggio della Loira
che prevaleva al castello. Nel
1493 una decisione del
Parlamento regolò i diritti
che dovevano essere raccolti a
Montsoreau. Nel 2017 il porto
è stato riaperto alla
navigazione sotto l'impulso di
Philippe Méaille, l'attuale
proprietario del castello.
Sono state allestite navette
fluviali da Saumur.
Lasciano i turisti
direttamente ai piedi del
castello.

Collegiata
di Santa Croce
-
Durante
la sua vita, Giovanni III
di Chambes si impegnò a
fondare una cappellania laica,
ma morì prima di poter
completare il suo progetto. La
collegiata di Santa Croce fu
fondata postumo dalla sua
vedova, Maria di Châteaubriant,
signora di Montsoreau, il 31
marzo 1520, dove aveva fondato
un capitolo composto da un
decano e quattro canonici, a
ciascuno dei quali aveva
attribuito 150 l.t. di
reddito. Lo studio della
documentazione conservata
permette di localizzare la
collegiata proprio nel luogo
dove oggi sorge la casa al 10
di rue Giovanna d’Arco.
La
Collegiata della Santa Croce
è utilizzata come luogo di
sepoltura dal 1520 e ha un
piccolo cimitero annesso. Le
vedute del 1636-40 e del 1699
non mostrano un chiostro, ma
il nome della casa canonica
che fu eretta sulle sue
rovine, «Les Cloistres »
potrebbe far pensare che ce ne
fosse uno. Dopo alcuni
decenni, la collegiata fu
saccheggiata e rovinata
durante le guerre di
religione. Nel 1568 le truppe
protestanti comandate dal
conte di Montgommery
saccheggiarono e rovinarono la
chiesa. Ulteriori danni
potrebbero essersi verificati
nel 1587 quando Enrico di
Navarra, il futuro Enrico
IV, passò più volte
Montsoreau prima e dopo la sua
vittoria a Coutras.
Durante la Rivoluzione
Francese, la proprietà e i
suoi annessi furono
sequestrati e venduti come
proprietà nazionale l'11
novembre 1790. Il
cimitero è annesso alla
Collegiata di Santa Croce nel
1520.
Bassa-corte
-
Al di là del fossato si
trovava l'aia, divisa in due
parti precedentemente
circondate da muri. A ovest il
cortile è collegato al
castello da un ponte
levatoio.
Alloggi
e aree comuni
-
Questi
edifici della seconda metà
del XV secolo sono gli
elementi principali dell'aia
del castello. Essi formano un
insieme coerente di annessi
destinati all'alloggio e al
deposito: magazzino, granaio
del sale, stalle, alloggi,
struttura collegata al casello
della Loira. Una parte di
questi annessi ospita ora la
scuola pubblica di Montsoreau.
Gloriette
-
Costruita
nel XVIII o XIX secolo, questa glorietta sulle
rive della Loira è una
testimonianza del periodo neoclassico,
che vide la costruzione di
templi nell'antichità spesso
dedicati alle muse, Venere o Apollo,
nella corrente del
romanticismo e della poesia
elegiaca che ne deriva. A
volte servono anche come
belvedere per ammirare la
bellezza della natura, come
qui dove la glorietta si
affaccia sulla Loira. Questo
padiglione è stato decorato
con una carta da parati
panoramica prodotta nel 1853
dalla fabbrica Pignet, che
rappresentava Roma, Parigi e Londra,
per far dialogare il fiume
Loira con la Senna, al Tevere e
al Tamigi.

Cantine
-
Nella parte meridionale del
fossato si trova una profonda
cantina coperta da una doppia
volta a botte. Doveva essere
usato come magazzino. Questa
cantina è probabilmente da
associare al pedaggio che i
signori di Montsoreau
riscuotevano fino al 1631.
I
giardini e orto
-
Giardini
selvaggi installati nel 2017
in omaggio a Miriam
Louisa Rothschild. Nel XV
secolo, vicino alle cucine del
castello si trovava un vasto
orto che forniva verdure ed
erbe aromatiche. Il
fossato difensivo che oggi
corrisponde ai giardini, era
largo circa 20 metri e
circondava il castello su tre
lati. Nel 1450 il fossato era
più profondo di quello che
vediamo oggi. A secondo delle
stagioni, il fossato era sia
asciutto sia in acqua quando
la Loira è stata allagata.
Economia
della pietra e del piombo
-
Il
Servizio Archeologico
Dipartimentale del
Maine-e-Loira stima che 92.000
conci siano stati utilizzati
per costruire le mura
dell'edificio principale. Se
aggiungiamo i conci delle
volte e le pietre di tufo del
pavimento, la stima raggiunge
i 105.070 blocchi. L'edificio
principale ha un totale di
2.576 m3 di tufo per i
rivestimenti, 157 m3 per le
volte e 72,5 m3 per la
pavimentazione. La costruzione
dell'abitazione ha richiesto
5.223 m3 di tufo, di cui 2.805
m3 sotto forma di pietra
lavorata e 2.418 m3 sotto
forma di macerie, pari a 7.573
tonnellate di pietra. Il
volume totale delle pietre
estratte rappresenta 8.000 m3
, ovvero circa 15 anni di
attività per un cavatore.
Il
piombo è stato utilizzato per
creste, grondaie, pennelli e
vetrate. Tra il tetto del
volume centrale, i padiglioni
delle torri e i dormitori,
l'edificio principale ha un
totale di 300 metri lineari di
creste, valli e articolazioni
dell'anca. Sono stati
utilizzati 400 quintali (19,58
tonnellate) di piombo, che
hanno permesso di produrre tra
350 m2 e 450 m2 di tavole di
piombo di 4-5 mm di spessore. Giovanni
II de Chambes ha ottenuto dal
re Carlo VII la
libera circolazione di questo
piombo da Lione, che ha
trasportato via terra fino a
Roanne e poi lungo la Loira
fino a Montsoreau. È
probabile che questo piombo
provenisse dalla miniera di
Pampailly, allora di proprietà
di Giacomo Coeur, poiché
anche per una miniera così
importante (Pampailly nel 1455
è considerata una delle
miniere più importanti del
regno) queste quantità
rappresentano circa 6 mesi di
estrazione/produzione.

SPAZI
INTERNI
Composizione
-
L'edificio
è situato parallelamente al
fiume, sul bordo
settentrionale della riva che
funge da base. È costituito
da un edificio principale
fiancheggiato a nord da due
alte torri quadrate e a sud da
due torri di scale che si
inseriscono negli angoli
iniziati da due brevi ali. A
est, un muro collega questo
complesso ai resti di un'altra
torre quadrata, un tempo alta
quanto le precedenti. A ovest
si trovava l'ingresso del
cortile: un documento degli
anni 1636-1640 mostra uno
stretto passaggio coperto a
forma di padiglione, preceduto
da un ponte levatoio,
collegato all'abitazione da
una cortina merlata. Il
cortile ha un pozzo centrale.
Una visita al fossato rivela i
resti di un muro medievale in
gran parte crollato,
appoggiato su un terrapieno di
terra. Nella parte posteriore,
il muro è anche baluardo di
una massa solida di terra che
è stata trafitta da cantine
che hanno alterato la stabilità
della proprietà.
Oltre
il fossato, verso ovest,
rimangono alcuni elementi
dell'aia, tra cui l'edificio
d'ingresso. Si affaccia sulla
piazza del paese e si
distingue per una bella
sezione in legno del XVI
secolo, vicino a un'abitazione
costruita nella seconda metà
del XV secolo innestata su un
edificio più antico. Un lungo
edificio, anch'esso risalente
al tardo Medioevo, è
sostenuto a nord da solidi
contrafforti: in origine
conteneva stalle,
un'abitazione e un fienile che
è stato trasformato in una
scuola e in una casa. I
prospetti includono alcune
caratteristiche notevoli. Il
principale è senza dubbio la
disposizione delle caditoie
che corrono lungo lo sbalzo
del corpo centrale e delle
torri su tutti i lati
dell'abitazione, compreso il
cortile.
Continua
sulle due torri, la camminata
parapetto del corpo principale
è interrotta dagli abbaini ed
è così suddivisa in segmenti
isolati, a volte molto corti
(da 1,7 a 7 m). Gli abbaini
impongono questa disposizione
originale. La ricerca della
luminosità e dell'ordine
della facciata ha avuto la
precedenza sull'aspetto
puramente difensivo e
funzionale del parapetto. Di
fronte al fiume, la facciata
nord sembra più imponente e
severa, poiché è sostenuta
da un piano interrato
traforato dalla luce del
giorno. Tuttavia, è aperto su
ogni piano da sei grandi
traverse, organizzate
approssimativamente in baie.
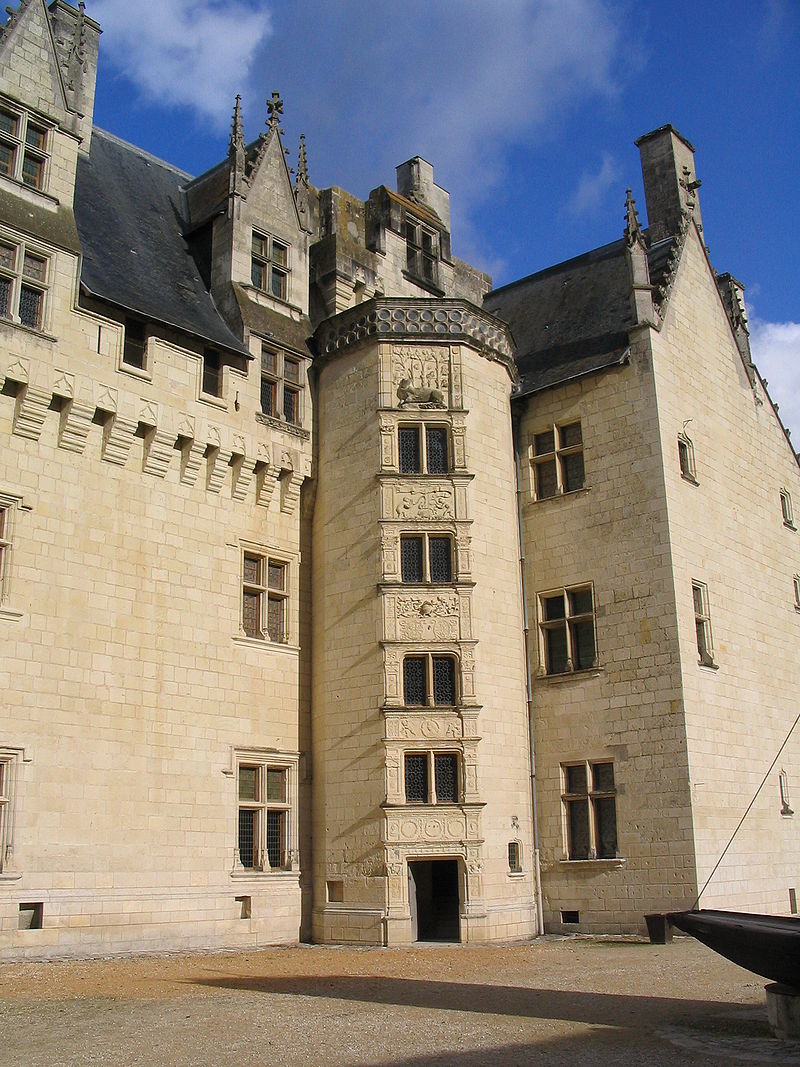 Un
grande seminterrato a volta
occupa l'intera superficie
dell'abitazione e delle torri.
Si trova a pochi metri sopra
il livello medio del fiume, al
livello della strada
dipartimentale. Il
seminterrato ha un'apertura
che un tempo si affacciava
sulla Loira e permetteva lo
scarico delle merci
trasportate dalle
imbarcazioni. Diverse scale
servono il piano terra
dell'edificio. Il passaggio a
nord, realizzato nel muro,
comprendeva una piccola stanza
di sorveglianza forata con feritoie. Un
grande seminterrato a volta
occupa l'intera superficie
dell'abitazione e delle torri.
Si trova a pochi metri sopra
il livello medio del fiume, al
livello della strada
dipartimentale. Il
seminterrato ha un'apertura
che un tempo si affacciava
sulla Loira e permetteva lo
scarico delle merci
trasportate dalle
imbarcazioni. Diverse scale
servono il piano terra
dell'edificio. Il passaggio a
nord, realizzato nel muro,
comprendeva una piccola stanza
di sorveglianza forata con feritoie.
La scala
a chiocciola medievale è
ben traforata e serve i vari
piani del castello, dalle
cantine alla soffitta. Si
accede alla grande sala e ai
vari livelli del padiglione
ovest; una parte dell'edificio
è accessibile solo
attraversando le stanze una ad
una. L'edificio principale
poggia su imponenti cantine,
sotterranee verso il cortile e
traforate da piccole baie sul
lato della Loira.
L'edificio
principale è costruito su
imponenti cantine, interrate
verso il cortile e traforate
da piccole finestre sul lato
della Loira. Si susseguono
quattro stanze con volte a
semicerchio di varie
dimensioni. L'apertura
originale, protetta da un
sistema difensivo, si apre a
ovest, verso il fiume; situata
a pochi metri dal livello
della Loira, permetteva ai
barcaioli di scaricare il loro
carico. L'accesso attuale
risale solo al secolo scorso,
quando un occupante, un
commerciante di vino, voleva
conservare più facilmente le
sue botti.
Al
piano terra, come al primo
piano, l'edificio principale
centrale è diviso in due
stanze di dimensioni
disuguali. Il più grande è
riscaldato da due caminetti,
uno a nord, rivolto verso la
Loira, l'altro verso est,
mentre il più piccolo ne ha
uno solo. I due padiglioni
sono costituiti ciascuno da un
unico locale, anch'esso
riscaldato. Senza corridoi, le
stanze comunicano tra loro su
ogni piano, dal padiglione est
al padiglione ovest.
La
porta d'ingresso di ogni
stanza può essere chiusa a
chiave con una o due sbarre di
legno. Una stretta scala a
chiocciola occupa l'angolo
nord-est e serve i diversi
piani del padiglione est. Al
primo piano, la piccola stanza
di questo padiglione è
coperta a volta con testate,
il che fa pensare che sia
stata utilizzata come
oratorio.
Al
secondo piano, la pianta è
ridotta alle stanze
dell'edificio principale e a
quelle dei due padiglioni e
dell'ala sud-est. Rimangono
tuttavia elementi difensivi,
l'organizzazione degli abbaini gotici a
due piani sulle facciate nord
e sud meritano una menzione
speciale. Mentre le finestre
dell'abbaino superiore
illuminano la mansarda, quelle
inferiori, a livello del
sottotetto, sono inserite nel
punto di camminamento del
parapetto per illuminare le
stanze dell'abitazione. Il
percorso del parapetto,
intervallato da abbaini,
è così suddiviso in sezioni. Il
padiglione orientale conserva
ancora una parte del terzo e
quarto piano, oltre a una
disposizione originale della
passeggiata del parapetto; da
qui si potevano osservare i
passaggi principali alle porte
di Angiò. Le due terrazze ora
disposte nella parte superiore
dei padiglioni permettono di
abbracciare un vasto paesaggio
e di comprendere meglio il
ruolo di vigilanza del
castello: a est, la confluenza
della Loira e della Vienne; a
nord, l'ampia valle del
fiume; a sud, la piccola città
fortificata.
Nascita
dell'architettura
rinascimentale
-
Il
Castello di Montsoreau è uno
dei più antichi esempi di
questa architettura di
abitazione, insieme al palazzo
Giacomo Cœur di Bourges (1443
circa) e al Castello di
Châteaudun (1460 circa). In
effetti, l'edificio principale
è facilmente databile in
quanto due passaporti reali
del 1455 menzionano il
trasporto di piombo e assi di
legno durante i lavori. La
priorità data
all'illuminazione e
all'organizzazione interna
della residenza a scapito di
una razionale circolazione
difensiva, così come
l'originale sistema di
abbaini, testimoniano la
volontà di trovare un
equilibrio tra comfort interno
ed estetica. La torre
rinascimentale è un altro
punto di forza del castello.
La struttura della decorazione
con le sue suggestive cornici,
le massicce lesene tagliate da capitelli e
il trattamento dei motivi in
cornici nude non si avvicinano
molto agli esempi noti del
primo Rinascimento francese.
Inserita
nell'angolo retto della
facciata del cortile, la
torretta di forma ottagonale,
che costituisce un passaggio
tra il gotico e l'arte del
primo Rinascimento, è
caratteristica dello stile
tardo Luigi XII. La sua scala
a chiocciola serve il primo e
il secondo piano del castello.
È coronata da una balaustra
composta da due file di corone
di tufo, chiuse da lastre
circolari di ardesia, e
termina con una bella volta a
palma, le cui otto costole
cadono su una colonna centrale
che prolunga il nucleo della
scala. È uno dei soli quattro
esempi di questo tipo di volta
conosciuti in Angiò, insieme
al castello del re René a Baugé,
alla dimora Barrault ad Angers
e al municipio di Saumur.
All'esterno, la porta, a forma
di maniglia di cestino, è
sormontata da quattro finestre
sovrapposte i cui stipiti,
incorniciati da lesene
decorate, mostrano lo slancio
verticale. La decorazione di
ispirazione italiana comprende
medaglioni e motivi talvolta
complessi. La trabeazione che
sormonta la finestra inferiore
presenta un volto a forma di
medaglione, incorniciato da
putti. Sopra la seconda
finestra un elmo è circondato
da pergamene; uno stendardo
reca la scritta «Chambes crie»
allusione al costruttore del
castello. La trabeazione della
terza finestra presenta una
scena particolarmente curiosa:
sotto un'ampia fascia che si
dispiega sulla parte
superiore, due scimmie si
fronteggiano ai lati di
un'enigmatica
rappresentazione: uno degli
animali solleva, con l'aiuto
di una catena, una pietra su
cui è posta una scimmietta.
Sulla striscia si legge il motto degli
Chambes «Je le feray ».
Infine, la finestra alta porta
sopra il cornicione un cervo a
riposo, simbolo di caccia.
 È
stata sottolineata la presenza
di conchiglie sul cordone e
sui pilastri,
sottolineando che lo stemma
della casa di Laval-Loué, da
cui discendeva Anna di Laval,
moglie di Filippo di Chambes,
aveva cinque conchiglie
d'argento. La scala avrebbe
potuto quindi essere costruita
in occasione del loro
matrimonio, celebrato nel
1530, ma le analogie osservate
con la decorazione del
padiglione d'ingresso del
Castello di Gaillon
preferirebbero una data
leggermente anteriore. In
ogni caso, la costruzione
della torretta ha portato
all'apertura di nuove porte e,
soprattutto, ad una
ridistribuzione dei locali più
in linea con le nuove tendenze
dell'edilizia abitativa
signorile. Nonostante
l'assenza di un corridoio di
distribuzione, ogni stanza, ad
eccezione di quella più
occidentale, potrebbe ora
essere isolata e comunicare
direttamente con una scala. È
stata sottolineata la presenza
di conchiglie sul cordone e
sui pilastri,
sottolineando che lo stemma
della casa di Laval-Loué, da
cui discendeva Anna di Laval,
moglie di Filippo di Chambes,
aveva cinque conchiglie
d'argento. La scala avrebbe
potuto quindi essere costruita
in occasione del loro
matrimonio, celebrato nel
1530, ma le analogie osservate
con la decorazione del
padiglione d'ingresso del
Castello di Gaillon
preferirebbero una data
leggermente anteriore. In
ogni caso, la costruzione
della torretta ha portato
all'apertura di nuove porte e,
soprattutto, ad una
ridistribuzione dei locali più
in linea con le nuove tendenze
dell'edilizia abitativa
signorile. Nonostante
l'assenza di un corridoio di
distribuzione, ogni stanza, ad
eccezione di quella più
occidentale, potrebbe ora
essere isolata e comunicare
direttamente con una scala.
Nel
complesso, Montsoreau rimane
un bellissimo e raro esempio
di castello realizzato durante
il regno di Carlo VII. Ha così
beneficiato di importanti
lavori di restauro, che
permettono ai visitatori di
oggi di contemplare tutto lo
splendore di questo monumento
reale. Questi restauri
sono stati eseguiti
principalmente tra il 1923 e
la seconda guerra mondiale per
la prima, e tra il 1997 e il
2002 per la seconda. Spesso
rimangono molto discreti, ad
eccezione delle finestre,
delle baie e della parte
superiore del padiglione
occidentale. Le travi di
cemento che sostituiscono la
maggior parte dei pezzi del
soffitto in legno sono
perfettamente imitate, e ci
vuole un occhio attento per
distinguere gli originali
dalle copie. Tuttavia, nella
sala ovest del secondo piano,
si possono osservare le
diverse fasi dell'elaborazione
di questi elementi in calcestruzzoca. Anche
la parte superiore della
torretta della scala medievale
è stata ricostruita per
consentire l'accesso alla
parte superiore del padiglione
occidentale.
DESCRIZIONE
Caminetti
-
Al
piano terra, come al primo
piano, l'edificio principale
centrale è diviso in due
stanze di dimensioni
disuguali. Il più grande è
riscaldato da due caminetti,
uno a nord, rivolto verso la
Loira, l'altro verso est,
mentre il più piccolo ne ha
uno solo. I due
padiglioni sono costituiti
ciascuno da un unico locale,
anch'esso riscaldato. Intorno
al 1450 il castello aveva
circa 25 camini. Il caminetto
di una delle sale a volta del
piano terra presenta un
affresco del XVI secolo. In
un medaglione circondato da
fogliame e frutta legata con
nastri, c'è un guerriero
sdraiato sulla schiena. Una
figura in costume da pastore
sta per colpirlo.
Probabilmente è una
rappresentazione di Davide
e Golia. Sopra di esso si
trovano le braccia della
famiglia de Chambes: il leone
d'argento, ornato e
incoronato, e la collana
di San Michele con il
motto «Lenitate vel vi ».
Nel 2016, durante i lavori di
ristrutturazione effettuati
nell'ambito dell'apertura del
Museo d'Arte Contemporanea, in
una delle sale al piano terra
del castello è stato
rinvenuto un camino del XV
secolo.
Torre
delle scale rinascimentale
-
Intorno
al 1515-1530 fu aggiunta,
nell'angolo est, una torre di
scale poligonale con una cima
a vite a palma. Serve gli
appartamenti signorili e
riflette l'evoluzione
dell'edilizia abitativa verso
una maggiore attenzione agli
spazi privati. Inserita
nell'angolo destro della
facciata del cortile, la
torretta di forma ottagonale,
che costituisce un passaggio
tra il gotico e l'arte del
primo Rinascimento, è
caratteristica dello stile
tardo Luigi XII. La sua scala
a chiocciola conduce al
primo e al secondo piano del
castello.
È
coronata da una balaustra composta
da due file di corone di tufo,
chiuse da lastre circolari di
ardesia, e termina con una
bella volta a palma, le cui
otto costole cadono su una
colonna centrale che prolunga
il nucleo della scala. È uno
dei soli quattro esempi di
questo tipo di volta
conosciuti ad Angiò, insieme
al castello del re René a
Baugé, alla dimora Barrault
ad Angers e al municipio di
Saumur. All'esterno, la porta,
a forma di maniglia di
cestino, è sormontata da
quattro finestre sovrapposte i
cui stipiti, incorniciati
da lesene decorate, mostrano
lo slancio verticale. La
decorazione di ispirazione
italiana comprende medaglioni
e motivi talvolta complessi.
Si presume che i medaglioni
rappresentassero i signori di
Montsoreau: Giovanni III di
Chambes e sua moglie Maria di
Châteaubriant.
La trabeazione che
sormonta la finestra inferiore
presenta un volto in
medaglione, incorniciato da
putti. Sopra la seconda
finestra un elmo è circondato
da pergamene; uno stendardo
reca la scritta «Chambes
grida », allusione al
costruttore del castello. La
trabeazione della terza
finestra presenta uno schizzo
particolarmente curioso: sotto
un'ampia fascia distesa sulla
parte superiore, due scimmie
si fronteggiano ai lati di
un'enigmatica
rappresentazione: uno degli
animali solleva un peso con
una catena, su cui è posta
una scimmietta. È un
dispositivo di sollevamento
chiamato anche
"scimmia". Sul
nastro si può leggere il
motto delle Camere «Je le
feray » (lo farò io). Infine,
la finestra alta porta sopra
il cornicione un cervo a
riposo, simbolo di caccia.
La
presenza di conchiglie sul
cordone e sui pilastri è
stata sottolineata,
sottolineando che lo stemma
della casa di Laval-Loué, da
cui discendeva Anna di Laval,
moglie di Filippo di Chambes,
conteneva cinque conchiglie
d'argento. La scala avrebbe
potuto quindi essere costruita
in occasione del loro
matrimonio, celebrato nel
1530, ma le analogie osservate
con la decorazione del
padiglione d'ingresso del Castello
di Gaillon preferirebbero
una data leggermente
anteriore. In ogni caso,
la costruzione della torretta
ha portato all'apertura di
nuove porte e soprattutto ad
una ridistribuzione dei locali
più in linea con le nuove
tendenze dell'edilizia
abitativa signorile.
Nonostante l'assenza di un
corridoio di distribuzione,
ogni stanza, ad eccezione di
quella più occidentale,
potrebbe essere isolata e
comunicare direttamente con
una scala. La scala
rinascimentale termina su una
magnifica volta a palma le cui
otto costole cadono su una
colonna centrale che prolunga
il nucleo della scala. Ce
n'è una anche ad Angers al
Logis Barrault, al Castello di
Baugé e alla vicina
collegiata di Candes-saint-Martin.

Torre
medievale -
La
scala a chiocciola medievale
è ben traforata e serve i
diversi piani del castello,
dalle cantine alla soffitta. Dà
accesso alla grande sala e ai
vari livelli del padiglione
ovest; parte dell'edificio è
accessibile solo attraversando
le stanze da uno a une.
Cantine
-
L'edificio
principale poggia su imponenti
cantine di 310 m2, interrate
verso il cortile e traforate
con piccole baie sul lato
della Loira. La presenza della
roccia di Montsoreau ha
costretto gli architetti ad
alzare il livello del suolo
delle cantine situate sotto le
estensioni est e sud-ovest.
Quattro sale a volta ad arco
tondo di varie dimensioni si
sono susseguite. L'apertura
originale, protetta da un
sistema difensivo, si apre a
ovest, verso il fiume; situata
a pochi metri dal livello
della Loira, permetteva ai
barcaioli di scaricare il loro
carico. L'accesso attuale
risale solo al secolo scorso,
quando un occupante, un
commerciante di vino, volle
conservare più facilmente le
sue botti.
Facciata
nord -
A
nord, sul lato della Loira, si
trova l'edificio principale
situato tra due padiglioni
affiancati a est e a ovest da
due piccole ali ad angolo
retto. La facciata è ornata
da ampie bifore e traverse.
Padiglioni
d'angolo -
Fotografia
che rappresenta la confluenza
del fiume Loira con il fiume
Vienne vista dalla terrazza
est del castello.
Il
padiglione orientale ha ancora
parte del terzo e quarto
piano, oltre a una
disposizione originale del
percorso coperto; da qui si
potevano osservare i passaggi
principali alle porte di Angiò. Le
due terrazze ora disposte
nella parte superiore dei
padiglioni permettono di
abbracciare un vasto paesaggio
e di comprendere meglio il
ruolo di vigilanza del
castello: a est, la confluenza
della Loira e della Vienne; a
nord, l'ampia valle del fiume;
a sud, la piccola città
fortificata.
Soffitta
-
Sono
stati tagliati circa 630
alberi per realizzare la
struttura e 329 per i
pavimenti. Al piano
mansardato, oggi la grande
sala ha conservato parte
dell'intelaiatura originale;
è in legno di quercia detto a
spina di pesce, in quanto
l'intelaiatura in legno non ha
grandi stanze ed è costituita
da travi abbastanza
ravvicinate, le stecche che
permettono di tenere insieme
le capriate. La
piccola stanza che si affaccia
sull'attuale terrazza ha una
struttura in cemento armato.
 Abbaini Abbaini
-
Una
menzione particolare merita
l'organizzazione degli abbaini
gotici a due piani sulle
facciate nord e
sud. Sono
dodici. Gli abbaini superiori
illuminano le mansarde mentre
quelli inferiori sono inseriti
al posto del camminamento del
parapetto per illuminare le
stanze dell'abitazione. I
pennacchi degli abbaini sono
decorati con ganci gotici e le persiane interne
in legno, presenti in tutte le
stanze del castello, sono
decorate con motivi intagliati
in pieghe di asciugamani,
caratteristici dello stile
gotico.
Cammino
di ronda -
Il
cammino di ronda è diviso in
sezioni, con abbaini in mezzo.
Ogni sezione, di lunghezza
variabile da 2,1 a 7 m, è
accessibile solo da una
stanza. Solo
le due stanze dell'edificio
principale sono collegate dal
parapetto a nord. Forse è
questo il motivo per cui la
ciminiera nord della stanza
delle guardie è stata
spostata ad ovest. Nelle torri
che incorniciano l'abitazione
sembra che le finestre del
parapetto fossero aperte, come
nel castello
di Azay-le-Rideau. Il
cammino di ronda presenta
delle caditoie visibili dalla
facciata sud del castello.
Tuttavia, va notato che
l'accesso alla caditoia,
alle merlature e
agli organi di cottura avviene
in un percorso costantemente
ostruito dalle campate degli
abbaini alti.
Cucine
-
Le
cucine del castello si trovano
al livello della torre est.
Sono separati dall'edificio
principale, come nella
tradizione medievale. Le
cucine sono dotate di due
caminetti a muro. Ci sono
anche aree annesse: salsiere,
orto. Un anno dopo
l'apertura del Castello
di Montsoreau- Museo
di arte contemporanea, un
ristorante chiamato "Jean
2" in riferimento a
Giovanni II de Chambes, ha
aperto le sue porte nel 2016
nelle ex cucine del castello.
Sedili
-
Fin
dal momento della sua
costruzione, l'interno
dell'edificio è
caratterizzato da elementi che
riflettono il desiderio di
comfort, come le grandi
finestre che garantiscono una
grande quantità di luce nelle
stanze e le panche in pietra
che si integrano nella
muratura nelle loro
rientranze.
Le
ampie vetrate sono
fiancheggiate da doppi posti a
sedere rivolti l'uno verso
l'altro. A seconda delle sale
del castello, si trattava di
"banchi di guardia"
per la sorveglianza o di
luoghi privilegiati per
approfittare della luce
naturale all'esterno per
leggere e scrivere.
Pag.
15

 Pag.
17
Pag.
17
|