|
Tra
la Francia, la
Svizzera e il
Piemonte, nella
zona nord
occidentale
dell'Italia, si
trova La Val
d'Aosta.
Un'immensa
riserva naturale
con le sue alte
vette, le sue
ampie valli, i
borghi arroccati
e i suggestivi
castelli
medievali.
La
Valle d'Aosta è
situata ai piedi
del Monte
Bianco,
la più alta
vetta d’Europa
con i suoi 4810
metri. Maestoso
confine tra
Svizzera Valle
d'Aosta e in
Piemonte è il Monte
Rosa,
seconda vetta
d’Europa. Il
parco nazionale
del Gran
Paradiso ospita
nei suoi
meravigliosi
boschi le specie
più nobili
della fauna
alpina:
marmotte,
camosci, aquile
reali,
stambecchi. Nel
parco
l'incantata Cogne
e le
spettacolari
cascate
d’Ayas, che
regalano uno
spettacolo di
incommensurabile
bellezza.
Immerse
in questa
meravigliosa
natura, Cervinia
e Courmayeur
che custodisce
nel suo nucleo
antico la torre
medievale
Malluquin e il
campanile
romanico della
Chiesa
parrocchiale.
San
Vincent,
celebre per il
Casino de la
Vallée e luogo
di ritrovo della
mondanità
nazionale ed
internazionale.
A
Fénis
si può ammirare
il pittoresco e
scenografico
castello che,
con le numerose
torri e le mura
merlate, si
fonde in un
assieme
armonioso tipico
dell'architettura
medievale.
Aosta,
da cui la
regione prende
il nome, è di
origine romana.
Augusta Pretoria
associa la
ricchezza
storico
culturale alla
bellezza del
paesaggio.
Imponente,
l'arco di
Augusto del 25
a.C. edificato
per celebrare la
vittoria romana
sul popolo dei
Salassi. Tra le
diverse opere
dedicate
all'imperatore e
ancora
conservate,
l'anfiteatro e
il
criptoportico.
La
cucina
valdostana è un
insieme di
antichi piatti
tramandati nei
secoli: il
gustoso lardo,
la celebre
fonduta a base
di fontina, il
formaggio locale
per eccellenza,
dolci tipici
come le tegole e
i torcetti.
Fiore
all'occhiello
della Val
d'Aosta sono le
rinomate grappe
e i pregiati
vini.
Terra
dai maestosi
paesaggi, dagli
orizzonti
sconfinati,
dalle valli e
dai laghi
incantati, la
Valle d'Aosta
seduce, con la
sua dimensione
da fiaba, chi
decida di
percorrere i
suoi
meravigliosi
sentieri.
Patrimonio
architettonico
Nel
territorio
valdostano sono
tuttora presenti
molti segni
della sua storia
millenaria: una
storia che non
può
essere
ricostruita solo
attraverso i
monumenti
(castelli e
chiese), ma
anche tramite i
resti degli
insediamenti
antichi, delle
case rurali,
delle strade,
dei
terrazzamenti,
che
costituiscono il
monumento corale
di questa civiltà
alpina.
Tali
segni risultano
però
sempre più
compromessi
dalle
trasformazioni
degli ultimi
decenni, che
hanno prodotto
insediamenti e
infrastrutture
troppo spesso
disattenti ai
valori
storico-culturali
dei nuclei
antichi e del
paesaggio. In
molti casi si
deve pertanto
operare una
ricomposizione
mentale dei
lacerti tuttora
esistenti, se si
vuole leggere la
storia vera del
territorio.
È
necessario
rifarsi al
periodo del
basso Medioevo
per poter
leggere le
testimonianze
materiali dei
sistemi
insediativi che
più hanno
connotato la
valle sino
all'età
moderna: le
architetture
militari e
religiose e le
infrastrutture.
Prototipi
dei castelli
sono da
considerare le
torri di Aosta;
delle 20 facenti
parte della
cinta romana
solo quelle del
Pailleron e del
Lebbroso
conservano
l'aspetto
originario,
mentre le altre
sono
riplasmazioni o
costruzioni
medievali, nelle
quali tra l'XI e
il XII secolo si
insediarono le
antiche famiglie
feudali (quella
che assumerà
il nome di
Challant aveva
come residenza
la torre di
Bramafam). Nello
stesso periodo
venivano
sorgendo nel
territorio le
prime "torri
castellate",
in posizione
strategica su
promontori
rocciosi che con
i loro
strapiombi
risultavano il
principale
strumento di
difesa,
costituite da
una cinta murata
e da un torrione
(il «donjon»)
di forma
preferenzialmente
quadrata o
poligonale e con
accesso
praticabile solo
con scale porta,
rialzato di
circa 7 metri
dal terreno.
I
"castra"
di tipo
altoromanico
assumevano
caratteristiche
di complesso con
il sorgere,
entro un
perimetro di
mura merlate
adattato alla
conformazione
del terreno, di
altri edifici,
tra i quali la
cappella. Tipico
e
particolarmente
suggestivo per
la sua posizione
su uno
strapiombo, è
il castello di
Graines nella val
d'Ayas, con
donjon quadrato
e cappella
absidata. Altri
esempi tuttora
ben leggibili,
legati anche
alla fase di
emigrazione
delle casate
urbane dopo i
patti sabaudi
del 1191, sono
il castello di
Cly
(Saint-Denis),
con torrione
quadro e
cappella, e le
parti più
antiche del
castello di
Introd (il
maschio entro il
rimaneggiato
perimetro
tondeggiante) e
del castello di
St-Germain a
Montjovet (il
donjon quadrato
e la cinta a
nord-est), poi
ampliato e
rifortificato
"alla
moderna" in
età
rinascimentale.
Un'ulteriore
evoluzione delle
tecniche
militari di
difesa si
consolida nel
XIII secolo,
riconoscibile
dal donjon
cilindrico,
dagli archi di
scarico nelle
murature e dalla
migliorata
tecnica muraria,
con
apparecchiature
più regolari e
maggior impiego
di malta. È il
caso dello Chàtel-Argent
a monte di
Villeneuve, nel
quale l'abside
della cappella
emerge dalla
cinta murata, e
dei castelli di
Montmayeur
all'innesto
della
Valgrisenche e
di Chàtelard
sopra La Salle.

Lo
schema dei
castelli
primitivi
perdura sin
quasi alla metà
del Trecento. Più
tardi, sedatesi
le lotte tra
feudatari e per
la sempre
maggior
influenza dei
Savoia, i
castelli vengono
perdendo la loro
esclusiva
funzione
militare, sono
localizzati in
siti più
accessibili e più
prossimi ai
borghi, e
assumono una
configurazione
atta a
migliorarne
l'abitabilità.
In molti casi si
ristrutturano
torri o
complessi più
antichi,
integrando i
masti in nuovi
corpi di
fabbrica, con
cura per
l'architettura e
per le tecniche
costruttive. Tra
gli esempi più
significativi
ritroviamo il
castello di
Aymavilles, con
le quattro torri
rotonde intorno
al donjon
centrale, quello
di Quart, il
Sarriod de La
Tour a
Saint-Pierre. Il
più noto tra
questi manieri
è certamente
quello di Fénis,
a pianta
pseudopentagonale
su impianto
trapezio e
inglobante il
mastio antico,
che conservava
nel doppio
recinto un
apparato bellico
inusitato, forse
dovuto alla
posizione
indifesa. Il
castello verrà
ulteriormente
arricchito nei
primi decenni
del XV secolo,
ingentilendone
l'architettura
con le finestre
a croce,
sistemando il
cortile e le
sale,
impreziositi
dalle pitture
jaqueriane.
Vertici
assoluti
dell'architettura
militare
valdostana
sono due
castelli
monoblocco
costruiti ex
novo: Ussel,
della metà del
Trecento, in
posizione
spettacolare
sullo sperone
roccioso che
domina
l'anfiteatro di
Chàtillon e
Saint-Vìncent,
e Verrès,
terminato nel
1390, in
posizione
emergente
all'innesto
della val
d'Ayas. Il primo
conserva
unicamente le
murature esterne
dell'imponente
massa
parallelepipeda
e resti
dell'assetto
interno,
sufficienti
tuttavia a
evidenziare una
cura costruttiva
fino ad allora
impraticata ed
elementi
architettonici -
bifore,
coronamento a
fascia di
archetti ciechi
- dovuti a una
ricerca estetica
atta a celebrare
il fasto della
casata. Il
castello di Verrès
si presenta come
un enorme cubo
concluso da una
imponente
cornice di
caditoie su
beccatelli con
bande decorate
sotto la
merlatura e
scandito da
grandi bifore
variamente
scolpite e
ornate. Una
eccezionale unità
compositiva, su
di una maglia a
doppia simmetria
con cortile
centrale,
l'arditezza
dello scalone su
archi rampanti,
la maestosità
delle volte, la
raffinatezza dei
particolari
architettonici
ne fanno il
monumento
militare più
prestigioso
dell'intera
valle,
conservatosi
nelle condizioni
tardo-trecentesche,
con alcuni
elementi
difensivi
esterni - cinta
e antiporta con
ponte levatoio,
del 1536 -
"alla
moderna".
Non
più
residenza
fortificata, ma
elegante dimora
in
rappresentanza
del prestigio
europeo degli
Challant è il
castello di
Issogne, eretto
a fine
Quattrocento
inglobando in
modo
irriconoscibile
le
strutture
fortificate
preesistenti. Sì
tratta di un
palazzo
concepito
secondo ideali -
se non forme -
ormai
rinascimentali,
gravitante
sull'ampio
cortile a
loggiati, con
ricchi ambienti
interni, reso più
prezioso dalle
pareti
affrescate.
Accanto
alle
architetture
militari, nel
Medioevo il
territorio
contava molte
case-forti di
tipo monoblocco,
presidi o sedi
di signorotti
locali, ora in
gran parte
distrutte o
pesantemente
trasformate.

Popolazione
Vista la
natura montuosa
del territorio,
la Valle d'Aosta
risulta essere
non solo la
regione meno
popolata
d'Italia, ma
anche quella con
minore densità
di popolazione.
La distribuzione
degli abitanti
è assai
irregolare: più
di un terzo si
concentra nella
piana di Aosta
("Plaine
aostoise")
e nei comuni
limitrofi. Buona
parte della
popolazione
abita nei
maggiori centri
della media e
bassa valle,
mentre le valli
minori si sono
notevolmente
spopolate,
eccetto i centri
turistici
principali.
Data la
comunanza
linguistica, la
Valle d'Aosta è
stata
storicamente
terra di
emigrazione
verso la Francia,
specialmente a Parigi
(il comune
parigino di Levallois-Perret
conta ancora
oggi una nutrita
comunità di
emigrati
valdostani) e la
Svizzera
romanda
(soprattutto a Ginevra).
Questo flusso,
dapprima
stagionale,
divenne stabile
a partire dagli anni
Venti,
quando a questo
fenomeno si
affiancò
l'immigrazione
dal resto d'Italia,
legato
all'installazione
dell'industria
siderurgica a Cogne
ed Aosta, e
all'aumentato
sfruttamento
delle miniere di
ferro a Cogne
e di carbone a La
Thuile.
La
politica di italianizzazione
voluta dal
governo fascista
spinse in
particolare
numerosi piemontesi,
veneti
e calabresi,
dal secondo
dopoguerra sino
agli anni
Settanta. I valdostani,
sentendosi
privati della
loro terra,
emigrarono in
massa verso le
destinazioni
sopra citate, e
questo doppio
flusso
interconnesso ha
lasciato tracce
ancora oggi: da
notare, ad
esempio, che il
4% dell'attuale
popolazione è
originaria del
comune di San
Giorgio Morgeto
(RC),
e che la
popolazione
autoctona (di
origine
valdostana)
nella regione è
stimata intorno
al 50%,
scendendo a
percentuali
assai basse a
Aosta e nei
maggiori centri
abitati.
La
lotta partigiana
e varie
iniziative
politico-diplomatiche
di intellettuali
antifascisti,
come Federico
Chabod, valsero
a scongiurare il
pericolo di una
scissione
dall'Italia e
favorirono
l'attuazione
della tanto
desiderata
autonomia
regionale. La
Regione
Autonoma,
istituita con
legge
costituzionale
il 26 febbraio
1948, ha come
suoi organi un
Consiglio
composto da
trentacinque
consiglieri e
una Giunta
composta da
sette assessori
e dal
Presidente.
La Regione, nei
limiti
dell'ordinamento
giuridico dello
Stato, ha potestà
legislativa su
numerose
materie,
nonché ampia
potestà
integrativa su
altre; le sue
competenze sono
essenzialmente
preordinate alla
realizzazione
della autonomia
amministrativa
nei più
importanti
settori della
vita
socio-economica.
Religione
La
maggioranza
della
popolazione, sia
italofona che
francofona, è
di religione cattolica
romana. La
messa viene
celebrata in
lingua italiana
o francese (la
liturgia in dialetto
valdostano
non è nota),
come effetto del
separatismo
linguistico. La
comunità
giudaica più
importante è
quella di Aosta
(falcidiata
negli ultimi
anni della
seconda Guerra
Mondiale dai
nazisti,) dove
è presente una sinagoga
e alla quale
fanno capo tutte
le famiglie
giudaiche della
regione. Ad
Aosta si trova
invece il più
grande cimitero
giudaico della
regione.
Con
l'immigrazione
sono giunte
anche persone di
fedi orientali e
cristiano-ortodosse
(una comunità
russo-ortodossa
storica è
presente ad
Aosta), ma la
parte più
rilevante è
costituita dagli
islamici
magherbini che
probabilmente
superano le 500
unità rendendo
la comunità
islamica la più
numerosa tra le
fedi
minoritarie. Non
sono ancora
presenti luoghi
di culto stabili
per musulmani.

Lingue
Le lingue
autoctone
della Valle
d'Aosta sono il francese,
il francoprovenzale
valdostano,
l'italiano,
inoltre nella
bassa valle
(soprattutto a Pont-Saint-Martin)
è conosciuto il
piemontese
e a Issime, Gressoney-La-Trinité
e Gressoney-Saint-Jean
si parla il dialetto
walser. Le
lingue ufficiali
sono l'italiano
dal 1861
e il francese,
unica lingua
ufficiale dal 1561
fino al 1861
e lingua
co-ufficiale
assieme
all'italiano dal
1946. Il francoprovenzale
è in stragrande
maggioranza
usato e diffuso
nei paesi e
nelle valli
laterali ove
gode di una
grande vivacità
mentre ad Aosta
e nei centri più
grandi prevale
l'italiano anche
per via della
forte
immigrazione da
altre regioni
italiane
avvenuta a
partire dal
periodo
fascista. Il
francese è
usato
prevalentemente
nelle attività
culturali e
nell'ambito
politico.
Il francese
divenne lingua
ufficiale nel 1561.
È a seguito di
questo atto che
in Valle d'Aosta
si sviluppa il
bilinguismo
francese-francoprovenzale;
essendo la prima
lingua quella
ufficiale e la
seconda quella
del popolo,
seppur
frammentata in
una moltitudine
di dialetti.
Questo fenomeno
si riscontra
anche nei
territori
d'oltralpe che
insieme alla
Valle d'Aosta
costituirono il
Regno di
Borgogna, (Savoia,
Svizzera
francofona
ed altri
territori a
nord-ovest).
Il bilinguismo
francese e
francoprovenzale
continuò
immutato fino al
1861
quando, con
l'Unità
d'Italia e
l'annessione del
territorio di
Nizza e della
Savoia alla
Francia, la
Valle d'Aosta si
ritrovò a
essere l'unica
regione
francofona di un
regno
interamente
italofono.
Durante il
periodo fascista
fu proibito
l'uso del
francese ed
avviato un
processo forzato
di
italianizzazione,
che incoraggiava
l'immigrazione
in massa di
forza lavoro da
tutte le regioni
italiane e
l'emigrazione di
parte degli
abitanti
francofoni
autoctoni verso
la Francia e la
Svizzera.
Dopo la
seconda guerra
mondiale le cose
cambiarono in
maniera
sensibile. Il 26
febbraio 1948
la Valle
d'Aosta, già
"Circoscrizione
autonoma"
dal 7
settembre 1945,
fu costituita in
Regione Autonoma
a Statuto
Speciale,
ottenendo il
riconoscimento
del diritto di
espressione
nella propria
lingua con
l'ufficializzazione
del bilinguismo
Italiano-francese
e la
soppressione dei
toponimi in
italiano.
Oltre
all'adozione
ufficiale del
bilinguismo, lo
Statuto Speciale
riconosce, dopo
le ultime
modifiche, anche
i diritti di una
minoranza di lingua
tedesca, i Walser,
i cui antenati
giunsero intorno
al 1200 nelle
zone dei tre
comuni di Gressoney-Saint-Jean,
Gressoney-La-Trinité
e Issime.
Itinerari
culturali
L'odierna
città conserva
l'impianto
urbanistico a strade
ortogonali
all'interno della
rettangolare cinta
muraria romana, con
la Porta Pretoria e
le torri in parte
medievali. Nel Parco
archeologico del
Teatro Romano vi si
trovano gli
imponenti resti
dell'Anfiteatro, il
Museo archeologico
regionale e la
Cattedrale,
edificata fra l'XI e
il XVI secolo, con
facciata neoclassica
e le Terme pubbliche
romane, situate su
un'area dietro il
Municipio e
comprendono vani
absidali, calidarium
e tepidarium .
All'esterno della
cinta si trovano
l'Arco di Augusto,
del 25 a.C. (oltre
il torrente Buthier,
un ponte romano
interrato) e il
complesso medievale
di Sant'Orso, con la
Collegiata dei
secoli X-XV, il
campanile del 1131 e
il bel chiostro del
XII secolo, nei
pressi del quale è
situato il Priorato
di Sant'Orso (1506).
Il Museo del tesoro
comprende parti
architettoniche e
opere d'arte della
Cattedrale,
reliquari
(reliquario in
argento di S. Grato
del XV secolo),
sculture in pietra e
legno, oreficerie,
cristalli, smalti,
ecc.
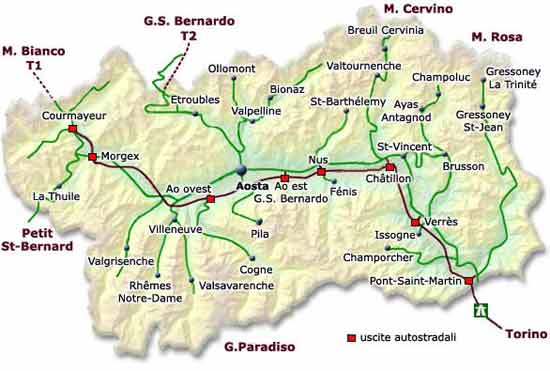 Il
30 e il 31 gennaio,
si svolge la Fiera
di Sant'Orso. Il
Santo così popolare
è, in realtà, una
figura avvolta nel
mistero; sembra che
sia vissuto tra il
VI e il IX secolo e
le fonti lo danno
addirittura per
scozzese o
irlandese. A
raccontarci la sua
storia è un
capitello della
chiesa a lui
dedicata: l'anonimo
artista del XI
secolo, ha scolpito
alcuni episodi della
vita del Santo
commentandoli con
espressioni latine.
L'artigianato locale
è l'indiscusso
protagonista della
Fiera; tessuti,
pizzi, calzature, e
oggetti artistici
testimoniano la
fedeltà alle
antiche tradizioni. Il
30 e il 31 gennaio,
si svolge la Fiera
di Sant'Orso. Il
Santo così popolare
è, in realtà, una
figura avvolta nel
mistero; sembra che
sia vissuto tra il
VI e il IX secolo e
le fonti lo danno
addirittura per
scozzese o
irlandese. A
raccontarci la sua
storia è un
capitello della
chiesa a lui
dedicata: l'anonimo
artista del XI
secolo, ha scolpito
alcuni episodi della
vita del Santo
commentandoli con
espressioni latine.
L'artigianato locale
è l'indiscusso
protagonista della
Fiera; tessuti,
pizzi, calzature, e
oggetti artistici
testimoniano la
fedeltà alle
antiche tradizioni.
In
località Saint
Martin de Corlean,
presso la chiesetta
di S. Martino, vi si
trova un parco
archeologico coperto
con tombe
megalitiche,
allineamenti di
stele antropomorfe e
arature di
consacrazione
riferibili al III
millennio a.C. (età
del Rame); mentre a
nord della città,
in regione
Consolata, vi si
trova un'area
archeologica
comprendente resti
di strutture murarie
di una villa d'età
augustea.
Nei
dintorni si può
visitare Pila,
rinomata località
estiva e stazione
sciistica; Sarre,
con il castello
sabaudo e nelle
vicinanze il
castello di
Aymavilles e il
ponte-acquedotto
romano detto Pondel
sul torrente Grand'Eyvia;
Saint-Pierre col
pittoresco castello
medievale e il
castello Sarriod de
la Tour (sec. XIV);
Villeneuve, località
di villeggiatura
sovrastata dai
ruderi dello
Châtel Argent del
XIII secolo e una
cappella del XI-XII
secolo.
Fénis, piccolo
centro nella media
valle della Dora
Baltea è famoso per
il castello,
perfetta immagine
medievale. prototipo
di castello
valdostano,
destinato ad
abitazione e
fortificato, ha
pianta pentagonale
con torri agli
angoli. Fu eretto
dagli Challand tra
il XIII e il XV
secolo e ampliato
successivamente ed
è ricco di
affreschi (1425) che
ornano ballatoi,
scale, sale e
cappella.
Cogne
ha di fronte il
grande prato di S.
Orso, in vista dei
ghiacciai del Gran
Paradiso. Nella
parte vecchia
dell'abitato, il
modesto castello che
Vittorio Emanuele II
abitava, quando si
recava per le sue
battute di caccia.
Il Parco Nazionale
del Gran Paradiso
comincia appena
fuori dal paese, che
è anche un luogo di
villeggiatura estivo
ed invernale molto
frequentato. Da
visitare è l'antica
parrocchia di S.
Orso e la Mostra
permanente del
merletto.
Le dentelles (i
merletti) di Cogne,
con i loro preziosi
motivi, raccontano
almeno quattro
secoli di storia;
nel 1665, alcune
monache benedettine
del monastero di
Cluny, si
rifugiarono in Valle
d'Aosta. Durante il
loro soggiorno le
monache insegnarono,
alle donne della
valle, l'arte del
pizzo e del tombolo. La seconda domenica
di febbraio si
svolge la
"Marcia Gran
Paradiso", gara
internazionale di
sci da fondo con
partecipazione
aperta a tutti.
Il
paese medievale di
Bard è serrato
contro il monte e ai
suoi piedi vi scorre
la Dora Baltea.
L'antica fortezza,
che rende famosa
questa cittadina,
bloccò per 13
giorni, nel maggio
del 1800, il corpo
di spedizione di
Napoleone diretto in
Pianura Padana e fu
per questo che fu
demolita per ordine
di Napoleone stesso.
L'attuale fortezza
è il rifacimento
voluto da Carlo
Alberto. È qui che
vi fu rinchiuso, per
qualche tempo,
Camillo Benso di
Cavour per le sue
idee liberali.
Il
territorio è
totalmente montuoso
e il turismo occupa
una posizione di
rilievo grazie ai
numerosi centri di
soggiorno estivo e
invernale.Tra le
specialità della
cucina tradizionale,
che sono a base di
formaggio Fontina,
troviamo: "Fonduta";
costolette alla
valdostana; "polenta
concia",
"soup
valpellineitze";
i "civet";
camosci
in salmì;
"carbonade".
Nella pasticceria
troviamo: tegole;
"blanc manger".
Tra i vini abbiamo:
Chambave Moscato,
Nus Pinot grigio,
Nus Pinot grigio
passito, Torrette,
Enfer d'Arvier,
Arnad-Montjovet e
Dannas.

Patrono
Grazie
a uomini come lui,
l’Europa ha
rialzato la testa
mille anni fa, dopo
aver preso schiaffi
per secoli un po’
da tutti: Arabi,
Normanni, Slavi,
Ungari... Alcuni lo
dicono nativo di
Mentone. Da
documenti vicini al
suo tempo risulta di
famiglia valdostana:
e ad Aosta egli
diventa arcidiacono
della cattedrale,
noto anche come
predicatore. Di lui
è più ricordata
tuttavia l’opera
di rianimatore della
vitalità europea in
uno dei suoi punti
più colpiti: il
passo di Monte Giove
(detto poi in suo
onore Gran San
Bernardo). 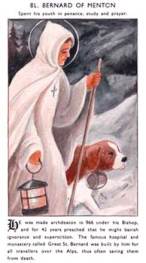
E’
l’importantissimo
valico che consente
il viaggio lineare
da Londra alla
Puglia, per merci,
persone, idee. Dice
una preghiera in suo
onore: "Il
miracolo di Monte
Giove, o Bernardo,
mostrò la tua
santità. Qui tu hai
distrutto un inferno
e costruito un
paradiso".
Alla fine del IX
secolo, forze arabe
partite dalla loro
base di La Garde
Freinet (Costa
Azzurra) hanno
occupato con altri
valichi quello di
Monte Giove e i
villaggi dei due
versanti. Qui si
sono poi dedicati a
rapimenti,
sequestri,
uccisioni, incendi
di monasteri,
chiese, paesetti. Ci
sono poi signorotti
locali, cristiani,
che li assoldano
volentieri per le
loro contese; e non
manca chi si spinge
fino a imitarli
nelle estorsioni.
Questo è
l’“inferno”. E
finisce dopo che nel
973 Guglielmo di
Provenza distrugge
la base araba di La
GardeFreinet,
provocando il ritiro
delle bande dai
monti. Per l’alto
valico (a 2.473
metri) riprendono i
passaggi, con gravi
disagi per ciò che
è stato distrutto o
bruciato.
E
qui arriva Bernardo.
Che non porta subito
il “paradiso”.
Anzi: il suo lavoro
inizia nella prima
metà dell’XI
secolo con molte
difficoltà e pochi
mezzi. Ma con
un’idea
innovatrice:
tagliare a metà la
consueta tappa St.Rhémy
(Val d’Aosta)
BourgSt. Pierre
(Vallese) e
stabilire una tappa
intermedia proprio
sul valico. Intorno
all’idea, per
opera sua e dei
continuatori, si
sviluppa
l’organizzazione.
Invece di un
semplice rifugio, i
viaggiatori, i
cavalli, le merci,
troveranno
accoglienza
organizzata,
servizio efficiente,
sotto la direzione
di una comunità
monastica impiantata
da lui, e cresciuta
dopo di lui, con lo
sviluppo di edifici
e servizi dalle due
parti del valico. A
Bernardo si
attribuisce anche la
fondazione
dell’ospizio
sull’Alpe Graia
(Piccolo San
Bernardo), ma la
cosa non è certa.
E poi c’è
l’altro Bernardo:
il predicatore, non
solo nella Vallée;
anche nella zona di
Pavia, ad esempio. E
nel Novarese: in
sintonia con la
riforma della
Chiesa, Bernardo si
batte contro
l’ignoranza e i
cattivi costumi del
clero, l’abbandono
dei fedeli, il
commercio delle cose
spirituali. E’ la
parte meno nota
della sua vita, ma
è anche quella che
impegna tutte le sue
forze. Anzi:
Bernardo muore
appunto facendo
questo lavoro,
mentre si trova a
Novara, la cui
cattedrale custodirà
poi le sue
spoglie.
Cultura
e tradizioni
Oggi
il grande
traffico
transalpino
attraverso
l'itinerario
valdostano è
favorito
dall'apertura
dei trafori del
Monte Bianco e
del Gran San
Bernardo, ma
anche
nel passato, ai
tempi dei
traffici
pedonali, la
Valle d'Aosta
rappresentò
sempre una via
naturale di
comunicazione
con I versanti
transalpini non
solo attraverso
il Colle del
Gran San
Bernardo (m
2473) e quello
del Piccolo San
Bernardo (m
2188), ma anche
attraverso
molti altri
valichi ora
quasi
dimenticati: il
Colle della
Seigne, il Col
Ferret, la Fenètre
de Durand,
Bettaforca, il
Col du Mont, la
Fenètre de
Champorcher, il
Col d'Olen, ecc.
Si
tratta di
profonde selle
di transfluenza scavate dai
ghiacciai
dell'era
quaternaria,
dette dai
montanari fenètre
nei dialetti
franco-provenzali,
furka in quelli
walser, che per
secoli permisero
i traffici
commerciali e
gli scambi
culturali fra i territori
a cavallo del
monte Bianco,
delle Alpi
Pennine e del
monte Rosa.
Attraverso le
"finestre",
nel corso della
storia, è
passato il
flusso delle
relazioni che
hanno
contribuito a
formare
l'identità
etnica e
culturale della
Valle d'Aosta.
L'uso
del francese
invece del
latino negli
atti
amministrativi
della Valle
d'Aosta risale
al 1561, quando
il duca sabaudo,
Emanuele
Filiberto, lo
impose accanto
al patois
franco-provenzale
che veniva
comunemente
usato nella
comunicazione
orale. Tale
prescrizione
non faceva che
sancire una
situazione ormai
stabilita di
fatto. I pochi
documenti
superstiti
attestano,
infatti, che
nella cultura
ecclesiastica e
laica il
francese era già
presente da
secoli. I testi
religiosi che
circolavano
nella valle
erano per lo più
in francese e
in francese
erano ì testi letterari
più
conosciuti, come
i fabliaux, Li livres dou tresor
di Brunetto
Latini, i romanzi del
ciclo di re Artù.
Da fonti
francesi
derivano pure i proverbi che
accompagnano
gli affreschi
nel castello di
Fénis. In
lingua francese
e ricalcata su
modelli
d'oltralpe è
pure la
Chronique de la
Maison Challant
scritta da
Pierre Dubois
intorno alla metà
del '400, prima
di una lunga
serie di prose
storiche che nei
secoli offrirono
il meglio della
letteratura
valdostana. Si
tratta di un
filone di opere
erudite di
carattere
storiografico
che conobbe una
particolare
fioritura nel
'600 e culminò
nella Histonque
de la Vallee d'Aoste
di Jean-Baptiste
Tillier
(1678-1744). Da
lui si sviluppò
in seguito,
fino all'Ottocento e
al Novecento,
una fiera
polemica
autonomistica
pervasa di uno
spirito
regionalistico
tenacemente
abbarbicato alle
sue tradizioni e
alla sua Storia.
Tale polemica fu
particolarmente
vivace nello
scontro con la
politica
accentratrice
della dinastia
sabauda durante l'assolutismo,
con il governo
rivoluzionario francese,
con
Napoleone, con
il regno
d'Italia
dopo l'unificazione, ma
trovò i più
alti accenti nei
confronti della
forzata
italianizzazione
tentata dal regime
fascista. In
questa fase sono
da segnalare per
la loro
combattività
le figure di
Joseph Trèves,
Joconde Stévenin
e Emile Chanoux,
che morì ucciso
dai nazisti nel
1944.
Oggi
la Valle
d'Aosta, pur
assistendo al
rapido mutare
delle sue
caratteristiche
etniche e
sociali, non ha
rinunciato al
proprio spinto
particolaristico
che, anche se
attenuato, non
si è
spento e resiste
nella tenace
difesa delle
proprie
tradizioni
culturali. La
Valle d'Aosta fa
parte dell'area
linguistica
francoprovenzale,
a cui
appartengono
anche alcune
valli
piemontesi, la
Savoia, il
Lionese, il
basso Vallese e
il Ginevrino. La
compagine
culturale
valdostana è,
pertanto,
uniformemente
franco-provenzale
e le sue
tradizioni
popolari
presentano
strette analogie
con quelle
esistenti nel
resto dell'area,
fatta eccezione
per alcune
comunità walser
dell'alta valle
del Lys,
strettamente
legate all'area
culturale e
linguistica
svizzero-tedesca.
Proverbi,
indovinelli,
filastrocche e
canti popolari
sono
per lo più
comuni a tutta
l'area
provenzale, con
qualche
contaminazione
di derivazione
piemontese.
Riferimenti
diretti a
elementi locali
si rinvengono,
invece, in
alcuni detti
tradizionali
connessi alle
condizioni
atmosfenche o in
certe leggende
legate a
edifici,
personaggi,
luoghi, in cui
compaiono
folletti,
fate, streghe e
spesso il
demonio in veste
di vittima
burlata. Valga
per tutte la
beffa legata
alla costruzione
del ponte di
Pont-Saint-Martin,
che sarebbe
stato edificato
dal diavolo in
una sola notte,
in cambio
dell'anima del
primo che
l'avesse
attraversato. L'astuto san
Martino, che
aveva fatto il
patto con
Satana,
a opera ultimata
si presentò in
compagnia di un
cane, al quale
fece passare il
ponte gettando
un pezzo di
pane.
Fra
i giochi più
caratteristici
della Valle
d'Aosta sono
da segnalare lo
tzan e il fiollet
che per certi
aspetti possono
ricordare
l'americano
baseball.
Largo
interesse
riscuotono
ancora le "battaglie
delle rèine",
una tradizione
che, del resto,
esiste anche
nella Savoia e
nel Vallese.
Alla fine
dell'alpeggio,
quando le mucche
ridiscendono a
valle, si
organizzano ad
Aosta e a
Chatillon degli
scontri fra le
bestie più
combattive di
ogni mandria. La
vincitrice del
torneo viene
nominata regina
(rèine) e, in
compagnia delle
altre mucche
vivacemente
inghirlandate,
viene fatta
sfilare per le
strade al suono
della banda.
Qualcosa di
analogo avviene
a Perloz, un
piccolo centro
sulla destra del
torrente Lys,
dove, anziché
mucche,
a scontrarsi in
furibondi e
incruenti
combattimenti
a colpi di corna
sono capre. Si
tratta della
Bataille de tchévre
che si svolge
ogni anno ad
autunno
durante l'estate
di san Martino.
Alla
campionessa,
in segno di
riconoscimento,
viene assegnato
un collare di
legno
intagliato. È
questo uno dei
tipici oggetti
di un
artigianato che
ancora vive
nella valle. Si
tratta di
un'arte rustica
che si esercita
nella creazine
di scrigni,
contenitori per
ogni uso,
tabacchiere,
giocattoli,
culle e
soprattutto
"grolle",
le
caratteristiche
coppe da vino in
legno di melo.
Feste
Foire
de Saint Ours - Ad
Aosta, il 30 e il 31
gennaio di ogni
anno, si tiene una
fiera in cui tutti
gli artigiani della
regione, falegnami,
fabbri, ricamatrici
e scalpellini della
pietra ollare,
espongono i loro
raffinati lavori.
Vengono quindi
esibiti mobili in
noce maestosamente
decorarti, attrezzi
per lavorare i
formaggi, utensili
per la cucina,
splendidi
bassorilievi, i
tradizionali "sabot"
(zoccoli), e
preziosi pizzi di
Cogne. La fiera si
costituisce intorno
ai visitatori, a cui
è offerto di bere
in allegria dalla
"grolla",
il particolare
contenitore di legno
in cui si miscelano
vino rosso caldo e
spezie, e a tutti si
augura "salu e
que bien vo fasse",
salute e che vi
faccia del bene!
Festa
della Madonna delle
nevi - Il
5 agosto, a
Camporcher,
splendida valle nei
pressi di Aosta,
sulle sponde del
lago Miserin, tutti
montanari della zona
si incontrano a 2600
m. Lo scopo è
onorare la Madonna
delle nevi,
pregandola di
vegliare sullo stato
della montagna nella
prossima stagione
invernale. Oggi,
questo evento è
seguito anche da una
folla di curiosi e
villeggianti, ma
mantiene un sapore
antico, ricordando
che, nonostante il
progresso
tecnologico, l'uomo
si trova ancora in
posizione precaria
di fronte alla
potenza della
natura.
Fête
des bergers - La
domenica successiva
a Ferragosto, a La
Thuile, si svolge
una importante festa
tradizionale. Presso
il Colle del Piccolo
San Bernardo, luogo
in cui anticamente
si riunivano i
pastori della valle,
sia francesi che
italiani, si tiene
una singolare gara
atletica, in cui
viene eletta la
"regina del
colle". La
particolarità
dell'evento sta nel
fatto che le
partecipanti non
sono ragazze, come
si potrebbe pensare,
ma mucche, o meglio
le "reines".
Lo scontro tra le
partecipanti è
accanito e si svolge
attraverso gare di
lotta, strutturate
in un vero e proprio
campionato, che vede
scontrarsi più di
cento esemplari. La
mucca che superi
tutte le sue
avversarie e che
riesca a sconfiggere
l'ultima avversaria,
nel temibile testa a
testa, vince. Gli
scontri sono così
agguerriti e
stancanti che il
concorso, iniziato
ad agosto, si
conclude la terza
domenica di aprile,
con l'incoronazione
a Croix Noire della
regina del colle.

Fonte
Pag.
1 
|